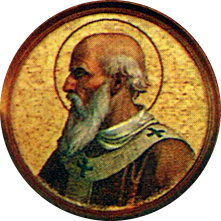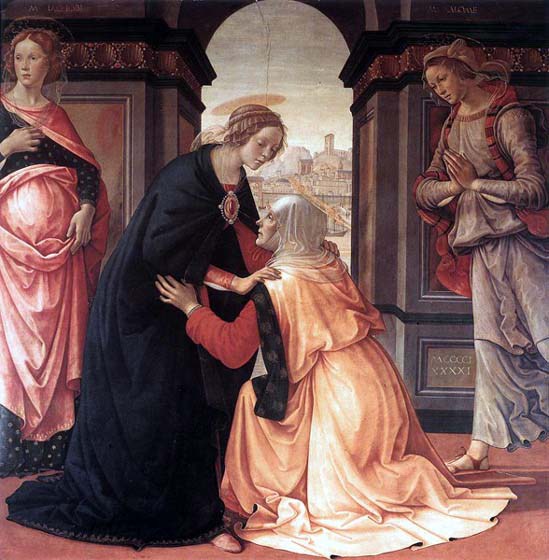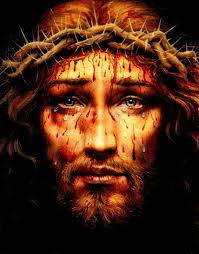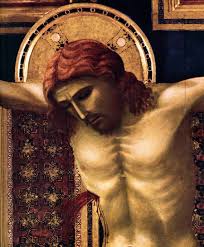LE BEATITUDINI EVANGELICHE (1B)
[A. Portaluppi: Commento alle beatitudini; S.A.L.E.S. –ROMA, 1942, imprim. A. Traglia, VIII, Sept. MCMXLII]
CAPO PRIMO
Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum cœlorum
[Beati i poveri di spirito perché di essi è il Regno dei Cieli]
II
LIBERI SONO I POVERI COME GLI UCCELLI
Anche qui « poveri » sono, non quelli che si trovano sprovvisti di beni, ma tutti coloro i quali, se privi si tengono esenti da invidie, se provvisti si tengono indipendenti e sciolti da ogni oggetto terreno e sono del tutto pronti a disfarsene come la Provvidenza mostri di volere. Veramente liberi sono questi poveri. Essi non subiscono nessuna soggezione da parte di codesti averi. Non fanno loro gola. Non li attirano. Non ne sognano. Neppure allorché essi abbiano nell’animo di condurre a termine opere di utilità del prossimo e occorra il denaro. Si trovano in una condizione di piena indipendenza dalle cose esterne. Ne sanno usare e sanno farne a meno. Sciolti come uccelli, volano su cose e vicende, e nessun vischio le avvince. Neppure ne subiscono alcun fascino, poiché ne hanno visto e conoscono con l’utilità anche il peso e il disagio. Il loro cuore è esente dall’intorpidimento, che le preoccupazioni materiali inducono persino negli spiriti più agili. Certamente non gustano questa benedetta libertà quelli che, essendo privi dei mezzi di fortuna agognati, si tormentano della loro sorte. Né hanno nulla della gelosia con cui altri guardano le altrui comodità e ricchezze. Neppure assomigliano a chi, per una volontà di rinuncia orgogliosa, vede la tavola imbandita e s’allontana dichiarando la propria superiorità: subendone la cupidigia. La libertà evangelica, più che di rinuncia, sa di conquista. San Francesco non ebbe gesti di disprezzo, non tolse via lo sguardo con dispetto dal sottile fascino del possesso ma volò verso la sua indipendenza lieto, del tutto agile, di fronte ai legami di una soggezione fastidiosa e seccante. Non è questo lo stato dell’uomo comune, di certo. L’esempio di alcuni Santi non è per tutti. Esso nondimeno ha un alto valore di monito e di richiamo. Ci dice chiaro come siano saggi soltanto coloro che sanno mirare all’intimo delle cose, e a possedere questo piuttosto che l’esterno. La proprietà esterna disturba pensieri e determinazioni; l’interna, vale a dire il possesso di noi medesimi, ci porta verso il vasto cielo della libertà dello spirito.
LA LIBERTA’
Occorre fare un’osservazione. La rinuncia di San Francesco e di chiunque lo imiti, sia pure nella comune vita di famiglia, e non abbandonando nessuno dei suoi impegni, raggiunge questa interiore proprietà e libertà. Non ha il fine di arrivare ad altro possesso di maggior prezzo. Ecco un uomo, che si spoglia delle sue vesti, si getta nel fiume per trarne un oggetto prezioso. Un altro impiega in un rischio tutta la sua sostanza, nella speranza che gli serva a guadagnare assai più di quello che sacrifica rinunciandovi. Costoro non hanno rapporto con la disposizione d’animo, che intendo presentare. Questa intende semplicemente disfarsi d’un impaccio. Se mai chi vuole vivere il consiglio evangelico ha di mira la conquista della vita eterna con un passo più spedito e con un risultato più sicuro. Ma anche in tale caso intende dirigersi con assoluto distacco e per amore di esso. Egli è convinto così di provvedere al proprio interesse e consapevole del valore della conquista raggiunta con la libertà dello spirito. E lo vorrebbe altresì nella ipotesi che la sua risoluzione non gli servisse per il fine supremo, soltanto per il pregio con cui esso gli si presenta. Un padre o una madre di famiglia può apprezzare questo stato d’animo e anche viverne. Non sembri assurdo. Procuri di dare al suo lavoro, per le comuni necessità, il valore di un mezzo imprescindibile e giusto; tenga lungi dal cuore l’avida brama d’una prosperità, la quale in sé è inceppante, cagione di noie e tale da dissipare lo spirito al di là d’ogni sollecitudine sana e atta a facilitare il raggiungimento dei fini della vita. «È certo, che la sola virtù è il sommo bene, scrive sant’Ambrogio, e essa sola è bastevole al frutto della vita beata. La felicità non si consegue con i beni esteriori o del corpo, ma con la sola virtù, mediante la quale s’acquista la vita eterna. Poiché la vita beata è il frutto delle cose presenti e la vita eterna è la speranza delle future. « Nondimeno molti pensano impossibile la vita beata in questo corpo infermo e tanto fragile, nel quale bisogna affannarsi, dolersi, piangere, sopportar malattie. Ma io non dico che la vita beata consiste in una certa allegrezza del corpo e non nell’altezza della sapienza, nella soavità della coscienza e nella altezza della virtù. Infatti felicità è non star con le passioni, ma vincerle e non lasciarsi sopraffare dalla perturbazione del dolore temporale ». (De Off., II, 5). Ed ecco una bella pagina di Ozanam sul concetto di povertà nel Cristianesimo e nel paganesimo: « Nei tempi antichi i poveri erano stati cacciati sotto i piedi; il genio antico li guardava come colpiti dalla riprovazione divina. Ancora ai tempi di sant’Ambrogio i pagani e i cattivi Cristiani solevano dire: Non ci diamo pensiero di far elemosina a persone che Dio ha maledette, poiché le lascia nella penuria e nell’indigenza. Conveniva cominciare con l’onorare la povertà, il che fece dandole il primo posto in chiesa e nelle comunità dei Cristiani. Lo dice san Giovanni Crisostomo: — Come le fonti sono disposte in vicinanza dei luoghi di preghiera per l’abluzione delle mani, che dobbiamo tendere al cielo, così i poveri furono dai nostri predecessori collocati vicino alla porta delle chiese per purificare le nostre mani con la beneficenza, prima d’innalzarle al Signore. — I poveri, più che rispettati erano ritenuti necessari. Ed ecco la gran parola, spesso incompresa e più spesso bestemmiata: — Ci saranno sempre poveri. — Non fu detto che ci saranno sempre ricchi, ma che era necessario che ci fossero sempre poveri, e, in mancanza di povertà forzata, ci fosse la povertà volontaria; che ci fossero istituti nei quali ciascuno facesse volontaria abnegazione della proprietà personale. Ecco come la povertà veniva prendendo il posto che era segnato nell’economia divina; essa diventava il perno della società dei Cristiani ».
LO SBOCCO DELL’AMORE
Sicché è si lecito affermare, che la elemosina, che ora vien quasi malfamata da chi ignora i l cuore umano e gli umani bisogni, non è tanto un dovere, quanto il diritto del Cristiano. Poiché questi è ben lungi dall’umiliare i poveri con i controlli, le inchieste burocratiche, le lunghe attese ufficiali, ma dà senza orgoglio per amore di Dio ein penitenza dei propri peccati. Ci fu un tempo quando si parlava di Gesù Signore e di san Francesco come di due epigoni del comunismo. Ma l’equivoco appariva chiaro a chiunque fosse Cristiano informato. Questa dottrina era un mezzo per appropriarsi dei beni terreni, non per liberarsene. Era la risultante d’una avidità, che passava i confini del puro lamento per la ingiustizia e arrivava a odiare chi n’era esente e a tentare la strada di sostituirlo nel godimento di beni non guadagnati legittimamente. Gesù invece predicò il contrario. Disse : « Non vincolate i vostri desideri a codeste cose passeggere e ingannatrici; non permettete che un quadrato di terra o una borsa d’oro vi assorba talmente il pensiero da non concedervi pace; siate liberi da tutto ciò, conquistate la vita eterna ». – Chi ha responsabilità di famiglia o comunque è tenuto a vivere non nella solitudine, ma in società, deve curare i mezzi di sussistenza di sé edei suoi, ma nondimeno non deve tendere con ansia tutte le sue facoltà verso il possesso di ciò che non corrisponde ai profondi e veri bisogni della vita umana. Gli avidi sono degni di commiserazione e non meritevoli d’invidia. Bisogna predicare ai poveri effettivi, che spezzino anche i l vincolo spirituale verso gli averi e facciano sì, che la loro libertà sia pienamente raggiunta. Bisogna ricordare ai ricchi di diventare poveri in spirito, di acquistare lo spirito della povertà. Così una madre di famiglia è in grado di far balenare alla coscienza dei suoi figli la bellezza del consiglio evangelico, senza timore di sospingerli alla trascuratezza dei loro futuri doveri di lavoro e di responsabilità. Per soddisfare ai doveri comuni della vita, non occorre la schiavitù, né la soggezione alla materia. Tutto è possibile provvedere con piena libertà e indipendenza di spirito. È la condizione di tanta tranquillità e di tanta pace. I figli saranno ben grati per averne conosciuta la bellezza e la via d’arrivo e canteranno le lodi dei loro cari per tutta l a vita, poiché avrebbero battuto il torturante sentiero dell’avidità e invece per loro merito han potuto salire quello libero e solare che conduce alla libertà e al vero benessere.
III
LE GARANZIE DELL’INDIGENTE IL RICCO LADRO
Rifletti alle preoccupazioni del ricco del Vangelo, Egli, prevedendo un raccolto assai abbondante, s’avvide di non avere abbastanza capacità di granai e di cantine. Non soltanto non si trovava soddisfatto d’aver molta merce da gettare in mercato, ma intendeva conservarla più che gli riuscisse, per cavarne un utile più alto allorché il bisogno del pubblico fosse maggiormente cresciuto. Pensa e ripensa, decide di abbattere e ricostruire con criteri più previdenti. L’avarizia, senza che s’avverta, giunge persino a corrompere il giudizio e induce all’ingiustizia. Si ricordi Aman, che voleva impossessarsi della vigna di Nabot. Ne ha una vera passione: e alla ripulsa rispettosa del legittimo proprietario si sente venir meno dalla rabbia. Non mangia, non dorme. Finché la moglie suggerisce l’astuzia che doveva coprire il furto. Anche nelle minori vicende della giornata l’avidità tende a misconoscere la giustizia e a giustificare la frode, commettendo il male contro il diritto del prossimo. In un ufficio, maneggiando le minuscole cose che servono, l’avarizia acceca e sospinge alla sottrazione dell’altrui. L’istinto di appropriarsi della roba d’altri riesce a stimolare ad indelicatezze puerili, ma che sono sintomo di una vera corruzione del criterio del giusto e dell’ingiusto. Chi è povero in spirito sorride ad ogni forma di tentazione d’avarizia, poiché, non ha presa su lui, né può allentare il gusto della libertà di cui gode. Sente il valore della serenità che gli viene da questa indipendenza dalla concupiscenza del possesso, né intende rinunciarvi. Sa che ogni avere è dolore, che ogni possesso è decesso. San Paolo dice l’avarizia, « simulacrorum servitus — schiavitù degli idoli » (Col., III, 5). E di forma speciale. La maggiore battaglia del Signore fu contro l’avarizia dei capi del popolo; il tema principe dei sermoni popolari di San Francesco fu il distacco dalla passione della roba; i Santi senza distinzione offrono al mondo l’esempio della libertà assoluta dell’animo, pur maneggiando sovente molti beni. È proprio chiaro che la santità si tiene in una posizione opposta a quella dell’uomo preoccupato di ammassare. E poiché essi sono anche gli esemplari della letizia e dello spirito sorridente dobbiamo dedurne, che l’avarizia generalmente opprima e soffochi il cuore dell’uomo. È pertanto una passione riprovevole anche per una considerazione esclusivamente umana.
LOTTE SENZA FINE
Non è per causa degli averi, forse, che accadono i maggiori urti fra individui e fra i popoli? Quando un individuo comincia a riflettere, che il suo vicino ha questo e quest’altro e che egli ne è privo, studia il modo come entrarne in possesso lui pure; considera le diverse possibilità; pesa i vari sforzi, che offrono qualche speranza; si decide infine ad affrontare anche quelli meno leciti o del tutto ingiusti. Entra in lui come una suggestione, e vede ogni cosa sotto il prisma di quel sogno, di quello stimolo, di quella passione. Finché si persuade di poterla legittimamente soddisfare. Né è detto, che decisa la questione, tutto sia pacificato. Nell’altro permane il senso dell’umiliazione edella disdetta. Bisogna pensare alla rivincita. Per tal modo vi son famiglie che si fan divorare dalla pubblica amministrazione della giustizia ogni avere. È al contrario chiarissimo, che la intelligenza, la parsimonia, la tenacia del lavoro conducono al benessere assai meglio e con maggiore vantaggio. Soprattutto con onore e vera gloria. La Provvidenza ha distribuito i beni di natura con prodigalità, ma anche con criteri tali da indurre gli uomini a riconoscere una certa interdipendenza fra loro. Chi difetta d’un genere lo potrà trovare presso altri dietro lo scambio di ciò che possiede. Non è forse provvido anche questo bisogno, che tutti urge gli uni verso gli altri, affinché tutti sentano il dovere di ricorrere ai propri simili senza odio, senza avidità?
COMPOSTEZZA DI DESIDERI
I doni di Dio vengono per tal modo valutati secondo verità. Come non riconoscere la volontà del Signore, che vuole l’armonia fra tutti eil rispetto dei particolari diritti? Dio tutela il carattere dell’individuo edel popolo. Lo favorisce ebenedice. L’uomo che esce, per sola cupidigia, dall’ordine fissato dalla natura e che ambisce di valicare le linee di confine segnate dalle capacità congenite, sovente si trova privo delle energie, delle luci, degli accorgimenti necessari alla riuscita. È quindi la povertà in spirito la condizione più propria per arrivare alle mete naturali. Le quali tendono sempre ad elevarsi, ma nell’armonia delle circostanze e delle condizioni. Qui sta il privilegio delle coscienze ordinate e degli spiriti prudenti. E vivono « beati », vale a dire sereni e placati dentro se stessi. Le loro intraprese si svolgono senza le gravi scosse dell’ambizione, senza i contrasti della gelosia. Non turbano la boria d’alcuno. Hanno un tono così spontaneo e schietto, che — a meno di temperamenti malvagi — lavorano circondati dal riconoscimento o almeno dal rispetto. Come non assalgono alcuno, così da nessuno vengono assaliti. E filano tranquilli per la loro ascesa, guadagnando tempo e lavorando in pace, con tanto maggiore successo. – Don Bosco ebbe in alto grado la povertà in spirito eppure fu assai tormentato e turbato nello svolgimento della sua mirabile attività. Ma questo non veniva da invidia o gelosia; si temeva da spiriti miopi per i riflessi politici della sua azione popolare giovanile. Infatti non mancarono le dimostrazioni della violenza politica di chi vedeva nel santo sacerdote una minaccia contro le istituzioni. Ma la sua condizione spirituale, che lo teneva in una perfetta libertà di movimento, costituiva la sua forza; sicché o in un verso o nell’altro egli trovò modo di perseverare o di vincere. Nessun vincolo o peso lo costrinse a tener in conto gli interessi materiali. La libertà lo fece agile e gli diede la vittoria. Ha verificato in pieno la povertà e s’è conquistato « il Regno de’ cieli » sin da quaggiù. Quale efficacia di bene nell’ambito stesso della Gerarchia ecclesiastica! La sua santità fu riconosciuta ancor vivo e la sua abilità nel condurre gli affari fu messa a profitto dalla fiducia dei Papi.
IV
I GODIMENTI DEI POVERI DI SPIRITO
BENI SCONOSCIUTI
Nella rinuncia, che è base della vita ascetica, sta un merito indubbio. È intanto una dimostrazione ben chiara dell’amore di Colui per il quale la rinuncia vien concepita e fatta. Se la morte è il medesimo segno di amore, l’accettazione d’una astinenza per amore è una prova sicura di esso. Quando si parla di rinuncia occorre tener presente che in essa vengono comprese tutte le cose le quali alla vita esteriore ci legano e ce ne fanno schiavi. Si considera « ricco » nel senso del Vangelo anche colui che ambisce gli onori, la vanità, i titoli onorifici e i primi posti. – È una umiliazione vedere gli uomini d’ogni grado e classe affannarsi per fregiarsi di segni convenzionali e di dati colori alle vesti, per cui la esistenza loro assomiglia ad una « fiera delle vanità ». È vero, che si intende onorare il grado non la persona… Ma che bella opportunità per la mamma avveduta, di far rilevare il poco conto da fare di codeste forme di angusta visione. Esse di solito nella realtà sono in proporzione inversa del merito. Sta bene: lo spirito di distacco, che agli inizi può essere frutto di superamento della naturale inclinazione alle cose di quaggiù, in seguito diventa senso di sollievo e di liberazione; sicché non pesa la rinuncia, ma soddisfa e piace la agilità e levità che rappresentano un vero godimento dell’animo. In tali condizioni non si avverte nessun sacrificio, ma si entra nel vestibolo della piena libertà dei figli di Dio. Il quale poi riconosce l’amore e premia. E il premio nella linea stessa della volontà del fedele è un accostarsi tranquillo e calmo alla realtà sostanziale della vita. Lo spirito libero di seduzioni inferiori riacquista una giovinezza nuova nella sensibilità e nel gusto. Vede la stessa natura con occhio puro e la interpreta. L’occhio che suggeriva al divino Maestro quelle similitudini pregne di bellezza e di significazione. Nella sua visione della natura era la freschezza dell’occhio vergine, che scorge l’opera del Signore, il dono all’umanità, il simbolo delle cose del Cielo. I prati ondeggianti delle colline di Galilea gli servivano come tappeti per la folla avida della sua parola; i laghi erano il quadro pieno di leggiadria delle sue ammonizioni e dei suoi significativi prodigi; i campi lavorati gli suggerivano cento brevi racconti di padroni e di servi, di coloni e di disoccupati, di fedeli agricoltori e di ignavi pronti a sfruttare chi offrisse loro il modo di provvedersi senza travaglio la vita. E le messi dicevano al suo animo tante cose dell’anima, del lavoro spirituale, del raccolto al termine della esistenza di quaggiù; suggerivano la proporzione con cui produce una volontà bene saldata al dovere e decisa di raggiungere il massimo profitto dalla fatica e dal sacrificio per Dio. Gli uccelli dell’aria gli suggerivano l’immagine del ladro dell’anima, ma anche quella della rapidità della vita presente e della cura con cui dobbiamo procurarci i beni, che hanno valore nell’altra.
CANTI DI LETIZIA
I Santi, che vissero nelle forme più prossime a quelle del Signore Gesù, ebbero essi pure questa verginità di visione e seppero esprimerla e viverla. San Francesco sta al primo posto. Ma anche l’aria della sua prima comunità dovette avere questo profumo di spontaneità e di godimento dei doni naturali di Dio. Che cosa dice l’Inno alle creature? Da quale atmosfera spirituale esso è sbocciato, se non da questa vista giusta delle semplici e caste bellezze di cui il Signore ha arricchito la sua opera fisica a servizio dell’uomo? Ciascuna di queste espressioni della sua bontà deve cantare le lodi del Creatore. E Francesco ne dice l’invito. Laudato si, mi Signore. Ogni opera di lui ha una voce, ha un profumo, un suono con cui viene esaltato l’essere da cui ebbe origine. Una simile concezione della esistenza terrena non nasce certo da una dilezione interessata e da un padrone cupido; ma soltanto dalla intuizione immediata e delicata della funzione delle cose, che Dio ci mise paternamente intorno. E sono, si noti, i beni di tutti. Quanto più un Cristiano è spoglio di beni personali, a cui dedicare le proprie attenzioni esclusive e gelose, e meglio sa penetrare il valore di esse, come offerta di Dio alla sua povertà e al suo diritto di godere. – Da questa visione della natura vengono i migliori « Fioretti ». Dove il gusto dell’uva che viene incoraggiato nel bisognoso di cura e il pasto di pane e di acqua attinta alla sorgente viva, accanto alla quale stanno seduti giocondamente Francesco e Masseo, sono i documenti d’una letizia mai gustata dagli schiavi della gola, quali sono comunemente coloro che possiedono. « E vedendo San Francesco, che li pezzi del pane di frate Masseo erano più belli e più grandi che li suoi, fece grandissima allegrezza e disse così — O frate Masseo, noi non siamo degni di così gran tesoro; e ripetendo queste parole più volte, rispose frate Masseo: — Padre come si può chiamare tesoro dove è tanta povertà e mancamento di quelle cose che bisognano? Qui non è tovaglia, né coltello, né tagliere, né scodelle, né mensa, né fanti, né fancelle. — Disse San Francesco — E questo è quello che io reputo grande tesoro, ove non è cosa veruna apparecchiata per industria umana; ma ciò che ci è, si è apparecchiata dalla provvidenza divina, siccome si vede manifestamente nel pane accattato, nella mensa della pietra così bella e nella fonte così chiara; e però io voglio che preghiamo Iddio, che il tesoro della santa povertà così nobile, il quale ha per servitore Iddio, ci faccia amare con tutto il cuore ». Questa pagina dei « Fioretti » è davvero efficace. Il piacere di cui parlammo dianzi vi è espresso in forme plastiche e con parole splendenti. È come un ritornare del gusto allo stato primitivo. Èun rinverdire della sensibilità alle sue esperienze più ingenue, è superare le abitudini esigenti della saturazione e quindi arrivare alla semplicità primitiva e schietta.
ECCO IL PIACERE
La capacità d’ammirare è segno d’intelligenza e di valore morale. Più l’animo si sveglia alle scintille di bellezza e di bontà, distribuite da Dio nelle sue creature, più gli dimostra di non subire l’influsso delle gelosie e delle invidie, che fanno piccolo il cuore. Chi è del tutto sano dal lato morale ha uno spirito che possiamo dire ecumenico, universale. È degno delle compiacenze divine e segna un alto livello di nobiltà del sentimento. Questa attitudine è opposta allo stato d’animo angusto di colui che, avendo goduta la terra, è ormai nauseato e stanco e nessuna cosa piùlo allieta. Così son certi ragazzi viziati dai genitori senza criterio educativo, che tutto hanno concesso e ad ogni richiesta hanno ceduto. Per questo motivo il povero, colui che non fu secondato, ma contrariato nella sua giovinezza e lungo tutta la sua strada brutta e deserta, se mantiene la castità dei desideri, arriva a quella ingenuità e purità, che consentono le più intime gioie dello spirito. Nella famiglia cristiana il culto della semplicità dei desideri educa e prepara il tono giusto della vita. I figli imparano a dominare le voglie disordinate e ad amare i modesti piaceri della virtù. Sono questi che rendono l’esistenza amabile e serena e che mantengono all’uomo il tono consapevole dei beni di Dio. Gustano la passeggiata tra il verde, apprezzano la conversazione ilare, amano la lettura onesta, si allietano all’osservazione d’un panorama luminoso, ricercano il gioco senza complicazione e lo scherzo innocente, tributano la lode senza accentuazioni adulatorie, fanno sacrificio per il lavoro normale e per il dovere che corrisponde alla propria condizione. Tutto questo complesso di cose che respirano la pace, che danno la serenità, che incoraggiano nei giorni grigi, che rasserenano nelle ore del dolore e stimolano a perseverare fiduciosi sulla propria strada, mostra la bontà del Signore e consola delle pene inevitabili. «Beati» si dicono pertanto costoro i quali hanno scoperto, sotto la cenere delle miserie e delle deviazioni morali, il fuoco sacro, che scalda gli spiriti sacri a Dio.
V.
LO SPIRITO DI POVERTÀ COME FATTORE EDUCATIVO
VASTO RAGGIO D’AZIONE
Ad osservare queste stupende espressioni del Divino Salvatore, qualcuno può sentirsi indotto a concludere, che non vi siano lì motivi veramente utili alla formazione spirituale dei figlioli in famiglia e dei discepoli nella scuola. E per verità la forma ostentatamente paradossale le fa apparire più atte a svegliare uno stato di esaltazione mistica che non a indicare una strada piana e possibile alla totalità degli uomini. – Ma l’apparenza non corrisponde alla realtà. Tutte le difficoltà opposte all’applicazione delle « beatitudini » sono agevolmente eliminate da osservazioni perspicue e definitive. La parola del Signore non è divisibile. Ci sono i comandamenti e i consigli è vero, ma questa distinzione di graduatoria è ben lungi dal rappresentare differenza di sostanza nel suo insegnamento. Nessun esoterismo nelle sue parole. Tutti i suoi seguaci sono tenuti a conoscere tutta la sua dottrina e ad osservarla. Tutti, si deve intendere, secondo le proprie vocazioni e condizioni. Ma veniamo alle difficoltà. Si dice che lo spirito di povertà e di distacco sta bene in quegli individui, i quali, lasciato il mondo, vivono nella solitudine o sotto una regola che a tutto provvede. Ed è una obiezione, che ha un suo motivo solo apparente di giustezza. È principalmente per coloro che fuggono anche il precetto; ma, se questo è inteso nella sua compiutezza e nello splendore della sua forma a tutti viene imposto, sia pure in misura diminuita e in forme, se mai, interiori. Poiché l’attacco è schiavitù; e i seguaci di Cristo sono figli della libertà, alla quale Egli li ha generati. L’attacco è prostituzione dell’uomo alla materia, mentre Cristo ha sollevato l’uomo alle promesse eterne per una vita soprannaturale. L’attacco è sorgente di mali stimoli e incitamenti al peccato, siano essi il piacere, l’orgoglio, l’avarizia, mentre noi siamo chiamati al superamento di codeste passioni, madri di rovina e di disperazione.
MAGGIOR RENDIMENTO
Come può l’uomo, svincolato dall’amore al denaro, amare il lavoro sino a farlo oggetto di tutti i desideri e termine di ogni sforzo? Questa obiezione contiene due difficoltà, da noi considerate a parte. Che il distacco spirituale dall’oro renda indolente l’uomo e diminuisca il suo rendimento sul lavoro, non è vero. Dal lato spirituale il Cristiano — ed è in esso che noi osserviamo il fenomeno — sa di dover lavorare e produrre per la volontà di Dio. Il lavoro è dovere. Ha annesso è vero il piacere del guadagno e del benessere, che lo fa utile e immediatamente efficace sulla vita; e sta bene. Dio ci accarezza sempre così: un dovere e un piacere, perché gli è ben nota la nostra fragilità. In questo piacere, poi, non v’è nulla di riprovevole. È nella legge della vita, che noi si debba lavorare per provvederci quanto occorre alla esistenza fisica e spirituale. Un ragionamento come questo appare chiaro anche al ragazzo, al quale la madre o l’educatrice si volge. Lavora, perché Dio vuole così. Da principio il lavoro ebbe un senso di condanna e di castigo del peccato; ma quando il Verbo di Dio si fece uomo e lavorò fra noi, da allora il lavoro assunse il significato di un gradito dovere, per mezzo del quale, pur guadagnandoci la vita, secondiamo quell’esempio preclaro e stimoliamo le naturali abitudini, producendo e somministrando ai prossimi i frutti dell’ingegno e della forza ricevuti dal Creatore. Quest’altra è una soddisfazione, che sospinge la volontà e la fa alacre e preziosa a tutta la compagine umana. – Volontà di Dio e utile dell’uomo. Sono due ordini di stimoli i quali non esigono affatto l’avidità, ma piuttosto la superano. Ai giovanetti è facile inculcare il lavoro per codesti fini superiori. Ma è anche agevole mostrarlo come fonte di un guadagno ben prezioso per la vita dello spirito. Il servizio del corpo e delle necessità materiali appare chiaro. Ma quello compiuto a servizio delle necessità del cuore, che sente lo stimolo verso il soccorso del prossimo, ha alcune sue radici nella buona educazione e la favorisce. Non è forse di comune uso, la carità al povero incontrato per la strada? Non è questo un efficace modo di sviluppo del sentimento e una rappresentazione concreta delle capacità di ognuno a sovvenire l’indigente, il disgraziato, il fratello colpito da una sventura che esiga soccorso in denaro? Perché non rivelare ai piccoli le condizioni lagrimevoli e commoventi di certi compagni di scuola, che non sono circondati dalle carezze della Provvidenza e non trovano intorno a sé la solidarietà di aiuto e la simpatia, che medica le ferite e raddolcisce gli spasimi? Un cuore giovanile indirizzato su questa via non fallirà nella sua esperienza e saprà trovare dentro di sé gli efficaci sostegni concessi dalla stessa natura il di delle non desiderabili sorprese, che lo studio, il lavoro, le vicende della famiglia, i contatti con i compagni, e lo svegliarsi improvviso di sentimenti in contrasto, sono in grado di provocare.
NASCE L’UOMO D’AZIONE BENEFICA
Vi sono istituzioni da sostenere, iniziative provvide da appoggiare con l’azione e i mezzi di fortuna. Se il giovine sa di possedere secondo il principio evangelico, e di essere perciò depositario di beni, che devono essere considerati come propri del povero, non ne abuserà per il capriccio personale, ma saprà studiarne una destinazione, che apparisca degna di un depositario consapevole e sensibile alla voce dell’alto e della retta e cristiana coscienza. Nel lavoro e nel guadagno i giovani trovano uno stimolo valido, un appoggio chiaro e nobile, un incitamento diuturno ed elevante. Sanno di entrare per tal modo dentro un congegno la cui forza motrice nasce nel cuore stesso di Dio e avvertono nella fatica e nei suoi frutti un sapore divino. Strumenti di Dio Padre sentono di diventare così volontà destinate a potenziare le intenzioni di misericordia del Signore. Le madri e le educatrici non troveranno difficile indugiare dentro questo solco di bontà e scaldarvi i germi di bellezza per la vita avvenire dei loro cari. Dilatare i loro cuori nel respiro d’una generosità attiva e vasta, è creare in essi una tendenza aderente al precetto divino e spegnere i fomiti della passione. Splendono i cuori materni nella visione della generosità dei loro piccoli e sono incoraggiati dalla pronta risposta dell’istintivo entusiasmo di essi per la virtù, che apparisce frutto della diretta azione, del sacrificio pronto, della rinuncia risoluta. – « Beati i poveri in spirito ». Da codesta povertà non è a dire quanta ricchezza potrà emanare, quale generosità sgorgare. Ed esse, le buone mamme cristiane, ne saranno il primo oggetto. Beate esse, perché avranno usato della loro autorità secondo il comandamento divino; beate per avere sotto gli occhi, commosse e colme di intimo gaudio, l’espressione vivente della fatica e del sacrificio compiuto. Ma quella dei figli sarà una « beatitudine » ineffabile e perenne, poiché tutta la vita e nell’aldilà essi benediranno l’opera saggia della madre, dalla quale hanno imparato ad essere liberi e sciolti da vincoli terreni di passioni e di ansie, per raggiungere una condizione tanto sicura dal lato materiale quanto onorevole da quello dello spirito. L’agire infatti secondo la volontà di Dio è operare con vasto cuore ad attuare il comandamento della indipendenza, della libertà, della collaborazione all’azione della sua Provvidenza paterna.