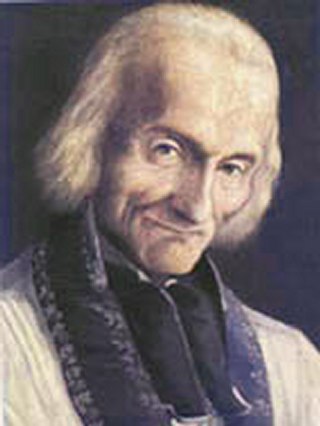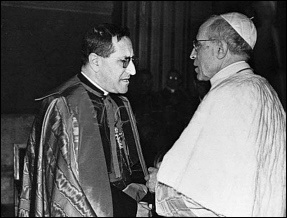Beato de Liébana:

COMMENTARIO ALL’APOCALISSE (1)
Migne, Patrologia latina, P. L. vol. 96, col. 893-1030, rist. 1939, I, 877
[Dal testo latino di H. FLOREZ – Madrid 1770] (*)
(*) Codici anastatici tra cui: A. Sanders Beati in Apocalypsin in duodecim, Papers and Monographs of American Academy in Rome, vol. VII, – Roma 1930;
.-Obras completas y complementarias de Beato de Liébana, ed. bilingue di J. G. Echegaray, A. Del Campo y Leslie G. Freeman; B. A. C. Madrid. 2004]
Non abbiamo a nostra conoscenza, traduzioni in italiano; la versione qui proposta è di tipo redazionale e preparata con grande impegno dal Circolo Cristo Re-Rex regum per il blog ExsurgatDeus.org. Si è cercato di comporre una traduzione in un idioma italico attuale comprensibile ai più. Si è cercato di tradurre ancora in modo quanto più aderente possibile al senso del testo originale, con tutti gli inconvenienti e le imprecisioni che ogni traduzione dal latino ecclesiastico medioevale comporta. Ce ne scusiamo anticipatamente e, ringraziandoli i cuore, invitiamo nel contempo tutti i lettori competenti a segnalare errori – del tutto involontari, ma possibili – onde eliminarli ed apportare le eventuali necessarie correzioni.
COMMENTARIO ALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI
(DEDICA DEL LAVORO AD ETERIO)
[1] Ho pensato di esporre alcune cose, spiegate con brevità di frasi, circa quello che è stato annunciato in diversi momenti nei libri dell’Antico Testamento sulla nascita di Nostro Signore e Salvatore secondo la Sua divinità od il Suo corpo, della Sua passione e morte, della Sua risurrezione, del Suo regno e del Suo giudizio, da uomini di scienza, da innumerevoli libri e dai più noti Santi Padri, cosicché l’autorità dei Profeti confermi la grazia della fede e dimostri l’ignoranza degli infedeli. E sebbene questo sia noto a tutti coloro che si occupano del vasto campo delle Scritture, può comunque essere ricordato con maggior facilità se letto in un breve trattato. Queste cose, che non sono esposte da me, ma dai Santi Padri, sono state raccolte in questo piccolo libro, e approvate dai loro autori: Girolamo, Agostino, Ambrogio, Fulgenzio, Gregorio, Ticonio, Ireneo (Vittorino), Apringio, ed Isidoro, di modo che, ciò che non si è capito leggendolo in altri, lo si comprenda in questo libro, scritto con linguaggio popolare, per certi aspetti derivato da essi, ma interpretato in piena conformità con la fede e la devozione. Considerate quindi questo libro come il chiavistello di tutta una biblioteca. E se ho errato in qualcosa, possa indulgere la carità, che vince su tutto. Queste sono una piccola parte delle tante dottrine che sappiamo essere state raccolte da persone degne di ogni credibilità, le cui parole, come vedremo, sono state da noi introdotte in alcuni luoghi, in modo che il nostro studio sia confermato dalle sentenze dei Padri. Tutto questo, dunque, ho dedicato a voi, Santo Padre Eterio, su vostra richiesta, ad edificazione dello studio dei fratelli, affinché io faccia di colui con cui condivido la gioia di essere religioso, coerede della mia opera.
TERMINA
IL PROLOGO DI SAN GIROLAMO
[2] L’Apostolo ed Evangelista S. Giovanni, scelto e diletto da Cristo, era considerato così superiore per il tanto amore di predilezione, che nella Cena riposava sul suo petto, ed al quale – in piedi da solo presso la croce – era stata affidata la sua stessa Madre; e così, a colui che volendo essere sposato aveva saputo abbracciare la verginità, fu concesso di custodire la Vergine. Ora, avendo avuto in sorte di patire l’esilio sull’isola di Patmos a causa della Parola di Dio ed a testimonianza di Gesù Cristo, è stata da lui scritta l’Apocalisse precedentemente mostrata; e così come all’inizio dei libri canonici – la Genesi – si è annunciato un “inizio incorruttibile”, anche con l’Apocalisse si ritorna ad un “fine incorruttibile” per mezzo di uno che è vergine, come è detto: « Io sono l’Alfa e l’Omega » (Ap. I, 8), cioè l’inizio e la fine. Questi è Giovanni che, conoscendo il giorno in cui sarebbe sopraggiunta la sua dipartita dal corpo, riuniti i suoi discepoli ad Efeso, scese nel luogo dove sarebbe stato sepolto e, dopo aver pregato, rese il suo spirito. Fatto così estraneo al dolore della morte, si considera alieno dalla corruzione della carne. La disposizione della Scrittura o l’ordine del libro non sarà da noi esposta in dettaglio, cosicché, in chi non la conosce, sia il desiderio di indagare a dargli una struttura.
UN ALTRO PROLOGO DELLO STESSO
[Questa prologo fu composta per il Commento di Vittorino]
[3] I diversi naviganti che attraversano l’immensità del mare incontrano vari pericoli. Si è colti da paura quando il turbinare del vento diventa più furioso. Si temono minacce (dai pirati) se la brezza moderata, non fa che increspare la superfice dell’elemento esteso. Così mi sembra che avvenga in questo libro che mi avete inviato che contiene la spiegazione dell’Apocalisse di Vittorino: infatti è pericoloso ed esposto ai latrati dei detrattori, il giudicare le opere di un uomo così egregio. E così già in precedenza, Papias, Vescovo di Gerapoli, e Nepote, Vescovo della regione d’Egitto, erano in accordo con Vittorino circa il “regno dei mille anni”. E poiché me ne avete supplicato per iscritto, non ho voluto differire, e per non disprezzare colui che lo richiede, ho subito consultato i libri dei nostri maggiorenti, e quanto ho trovato nei loro commenti dei “mille anni” l’ho unito all’opera di Victorino. Soppresso da questa ciò che si è trovato in calce alla lettera, dall’inizio del libro al segno della croce, abbiamo corretto ciò che è stato contaminato da parte di scrittori inesperti; ci rendiamo così conto di ciò che sia stato aggiunto da lì fino alla fine del libro. Il vostro compito è così quello di discernere e di corroborare ciò che vi aggrada. Se la vita ci accompagnerà (e Dio ci dà salute) – Anatolio carissimo – il nostro ingegno lavorerà con abilità per voi in questo libro.
UN’INTERPRETAZIONE DI QUESTO LIBRO
[Padre Florez chiama questa ampia introduzione summa dicendorum].
[4] Non c’è da stupirsi che Giovanni abbia ricevuto questo nome che costituisce come una specie di profezia, dal momento che in latino significa “grazia di Dio”. Infatti, nell’attimo in cui gli viene ordinato di scrivere alle sette Chiese l’Apocalisse, che è Rivelazione del Signore, egli vede il Figlio dell’uomo seduto sul trono, cioè il Cristo nella Chiesa, ed i ventiquattro Vegliardi, che sono i dodici Profeti ed i dodici Apostoli. Le sette chiese, i sette candelabri d’oro, le sette stelle, rappresentano l’unica Chiesa, unita in matrimonio con Cristo mediante la grazia septiforme. Dopo questo ho visto una porta aperta in cielo (Ap. IV, 2). La porta aperta si riferisce a Cristo, che è nato ed ha sofferto, mentre “cielo” è la Chiesa. Dopo questo ho visto un trono eretto in cielo, cioè che sono i Sacerdoti della Chiesa, servendosi dei quali Cristo presiede e giudica ogni giorno. E colui che sedeva su questo trono era di aspetto simile al diaspro e alla cornalina: questo allude ai due giudizi, uno per mezzo dell’acqua e l’altro attraverso il fuoco. Dopo questo vidi quattro animali prostrarsi davanti al trono, cioè i quattro Evangelisti, ed ognuno di essi aveva un aspetto distinto: il primo come di uomo, cioè razionale; il secondo come di leone, forte e combattivo; il terzo come di bue, immolato in sacrificio; il quarto come di aquila in volo, che con tutto l’ardore della mente, deve rimanere sempre in contemplazione. Questi quattro animali ne sono uno solo, che cioè è la Chiesa. Dopo questo ho visto nella mano destra di colui che siede, un libro sigillato con sette sigilli (Ap. V), nel quale sono annotati la guerra, la fame, la morte, il clamore di coloro che sono stati uccisi, ed anche la fine del mondo e dei tempi. Enumerando questi stessi sigilli parliamo (Ap. VI), dei quattro cavalli: il primo bianco, che è la Chiesa, con il suo cavaliere Cristo; il secondo rossastro, che è il popolo che combatte contro la Chiesa, e il cui cavaliere è il diavolo sanguinario; il terzo nero, che è la fame spirituale all’interno della Chiesa, e il suo cavaliere lo pseudo-profeta; il quarto pallido, e il suo cavaliere è la morte, a cui è stato dato il potere di uccidere con la spada, la fame, la morte e le bestie della terra, comprendendo anche le eresie nella Chiesa. Il quinto (sigillo) si riferisce alle anime di coloro che sono stati uccisi a causa della Parola di Dio. Nel sesto, con il sole nero come un panno di crine, e con la luna tutta come sangue, e con le stelle cadenti, si allude agli increduli, a coloro che saranno oscurati dalla luminosità della dottrina. La luna diventata tutta di sangue, è la Chiesa dei Santi, che alla fine appaiono versare il loro sangue per Cristo. La caduta delle stelle, che turba i fedeli, conclude il sesto sigillo, nel quale a causa dell’ultima lotta dell’Anticristo, come una ficaia sbattuta dalla bufera lascia cadere i fichi immaturi, così i santi, quelli che sembrano santi, vengono scossi dalla Chiesa. E il cielo che è stato portato via come un rotolo di libro, sono i Santi, che in quel momento non presentano altra virtù se non lo spargimento del loro sangue. Ed ogni montagna ed ogni isola viene rimossa dal loro posto; i re della terra, i giudici e i tribuni, i potenti e tutti, sia schiavi che liberi, si nascosero nelle grotte e nelle rupi dei monti. E dicono alle rupi e ai monti: Cadeteci addosso e nascondeteci alla vista di colui che siede sul trono e dalla collera dell’Agnello, perché il grande giorno della sua strage è arrivato e chi potrà sostenersi? Tutto questo avverrà al tempo dell’Anticristo. Perché con i re della terra, i governanti ed i potenti, come si dice, noi intendiamo i Santi, che in quel momento vincono l’Anticristo. Essi cercano di nascondersi nelle grotte e nei dirupi della montagna, cioè cercheranno l’aiuto dei Profeti, degli Apostoli e dei martiri. Dopo questo ho visto quattro Angeli in piedi ai quattro angoli della terra, che reggono i quattro venti (Ap. VII), che sono le quattro parti del mondo. Gli Angeli ed i venti sono la medesima cosa, ma sono bipartiti, tra il bene ed il male: cioè la Chiesa ed i regni del mondo; ed infatti il mondo odia la Chiesa, nella quale si trovano i falsi fratelli. E a questi venti fu detto di non soffiare sulla terra, né sul mare, né su alcun albero. Tutto questo si riferisce agli uomini, di modo che essi non piangano, cioè non venga meno il loro spirito e non rendano gli altri simili a loro, onde evitare che le persone alla sinistra oltraggino quelle che sono alla destra. Dopo questo ho visto dodicimila servitori di Dio – cioè la Chiesa costituita dal numero dodici – segnati con il sigillo sulla fronte, cioè con la consapevolezza del loro operato. Il settimo sigillo completa, in questa serie, il libro segnato dai sette sigilli. Si fa silenzio in cielo, come per una mezz’ora. (Ap. VIII): questo si riferisce ai servi di Dio, che si riposano da ogni attività secolare e iniziano qui la contemplazione per gustare la vita eterna. Dopo di ciò vidi sette Angeli che suonarono sette trombe, cioè le sette chiese che ricevono la predicazione perfetta, come diceva il profeta: “Come una tromba proclami la tua voce” (Is. LVIII,1). Il primo Angelo suonò la tromba, e si produssero pietre e fuoco mescolati al sangue, e questa è l’ira di Dio, che trascinava molti alla morte, affinché i santi potessero essere provati come oro nel crogiolo. E il secondo Angelo suonò la sua tromba, e fu gettata nel mare un’enorme montagna in fiamme: questo è il diavolo gettato sul popolo. E il terzo Angelo fece risuonare la tromba, e cadde dal cielo una grande stella ardente come una fiaccola, il che si riferisce agli uomini che cadono dalla Chiesa e che sono stati considerati dagli altri come santi e grandi, mentre che per il loro tipo di predicazione e di vita trascinano altri alla morte. E il quarto Angelo suonò la tromba: e fu colpita la terza parte del sole, la terza parte della luna, e la terza parte delle stelle, così che si oscurò e si perse la terza parte del giorno e la terza parte della notte: i Santi cioè furono separati dai malvagi. Dopo questo ho visto e sentito una grande aquila volare in mezzo al cielo, dicendo a grande voce: « Guai, guai, guai agli abitanti della terra quando suoneranno le restanti trombe dei tre Angeli. » L’aquila ed il cielo sono la Chiesa. Quando dice che questa va da una parte all’altra, intende affermre che annuncia a gran voce le piaghe degli ultimi tempi. – Il quinto Angelo suonò la tromba, e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell’Abisso; ed aprì il pozzo dell’Abisso (Ap. IX), cioè il popolo si allontanò dalla Chiesa con il suo pseudo-profeta. Ha aperto il pozzo, perché ha manifestato il suo cuore con le parole. Si chiama abisso perché si nascondeva nell’occulto. E dal pozzo è uscito un fumo come quello di un grande forno. E il sole e l’aria si oscuravano con il fumo del pozzo. Il sole è la Chiesa e il fumo sono le parole degli uomini empi. Come il fumo precede il fuoco, così essi oscurano la Chiesa e la confutano con parole, facendo sì che alcuni diventino ciechi. E dal fumo del pozzo uscirono cavallette, cioè una moltitudine di demoni, che erano legati nei loro cuori (degli empi) come in un pozzo, e insieme agli uomini da essi posseduti, si sollevano contro la Chiesa. E ad essi fu dato un potere come quello degli scorpioni della terra. Lo scorpione infatti tocca con la bocca e ferisce con la coda, proprio come fanno questi. E le cavallette erano come cavalli preparati per la guerra. Sulle loro teste avevano corone che sembravano d’oro: questo perché sotto il loro manto di cristianità (le corone d’oro) erano come dei cavalli furiosi che correvano verso il male. E i loro volti erano come le facce degli uomini, considerati cioè razionali. Avevano i capelli come quelli delle donne, cioè sciolti e da effeminati. Avevano denti come quelli di un leone, cioè tanto forti da poter stritolare. Ed avevano code simili a quelle degli scorpioni, con pungiglioni nella coda, per mostrarsi su quel cavallo, popolo avversario della Chiesa, e per significare che in un solo corpo vi fossero molte membra. Nella testa, ecco i principi della terra; nella coda, i falsi sacerdoti che, affettando una regale devozione, opprimono la Chiesa e promettono al popolo sicurezza. Essi hanno sopra di loro, come re, l’angelo dell’abisso, cioè il diavolo o il re del mondo, perché l’abisso è il popolo. In ebraico il suo nome è “Abaddon”, in greco “Appolyon”, in latino “Perdens” (il perdente) o colui che stermina. Il primo Guai! è passato. Ma ecco che dopo ce ne sono altri due. Ecco che noi chiamiamo “pozzi” gli uomini che sono ignoranti; e chiamiamo cavallette i demoni o la moltitudine di uomini che ricevono il potere di nuocere a coloro che non sono segnati col sangue dell’Agnello. E il sesto Angelo suonò la tromba: qui iniziò l’ultima predicazione. – E udii una voce dai quattro angoli dell’altare d’oro che si trova davanti a Dio, che diceva al sesto Angelo che aveva la tromba: “Liberate i quattro Angeli che sono legati dal grande fiume Eufrate“. “Una voce dai quattro angoli” designa il popolo della circoncisione, il solo che in tutto il mondo conoscesse Dio. L’altare d’oro è la Chiesa, che proviene dalla circoncisione. Liberate i quattro Angeli, quindi dall’Oriente e dall’Occidente, dal Settentrione e dal Mezzogiorno: questo significa che la Chiesa diventa universale e che il Nome del Signore è conosciuto nelle quattro parti del mondo. Questo Angelo con la tromba, a cui viene comandato di liberare, è da interpretare come la predicazione di tutta la Chiesa. L’Eufrate è il fiume di Babilonia, e con Babilonia si intende il mondo intero. Dopo di che ho visto nella visione i cavalli e coloro che li cavalcavano: avevano pettorali del colore del fuoco, del giacinto e dello zolfo, e le loro teste erano come leoni. Non sono gli stessi che abbiamo descritto sopra, ma sono simili a loro. Quando diceva di loro così, descriveva la stessa cosa ma in modo diverso. Dalla loro bocca uscirono fuoco, fumo e zolfo. Per fumo si intende il giacinto, cioè le parole di questi uomini. Da queste tre piaghe, cioè il fuoco, il fumo e lo zolfo, che uscivano dalle loro bocche, fu uccisa la terza degli uomini. Il potere dei cavalli sta nelle loro bocche e nelle loro code, che sono cioè i principi del mondo ed i sacerdoti, e con loro fanno del male, perché senza di loro non possono nuocere. Ho visto anche un altro Angelo potente scendere dal cielo, avvolto in una nuvola e con un arcobaleno sul capo (Ap. X): questi è il Signore rivestito della Chiesa. L’arcobaleno sopra il suo capo, è la perseveranza della Chiesa. Le nuvole, sono i predicatori che producono pioggia per mezzo dei miracoli. Il suo volto come il sole e le sue gambe come colonne di fuoco. Sul suo volto c’è la conoscenza di Cristo; sulle sue gambe c’è la sofferenza dell’ultima persecuzione. Nella sua mano teneva un libro aperto: cioè attraverso la Legge ed il Vangelo si conosce Cristo. Mise il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra. Il piede destro sul mare, rappresenta le membra più forti nei maggiori pericoli. Il piede sinistro sulla terra, sono le membra più deboli in ciò che è di propria competenza. E gridò a gran voce come ruggisce il leone, cioè comandò di predicare con veemenza. E mentre gridava, sette tuoni fecero udire il loro fragore. Appena i sette tuoni fecero udire la loro voce, e mi disponevo a scrivere, ho sentito una voce dal cielo che diceva: « … sigilla ciò che i sette tuoni hanno detto, e non lo scrivere ». Ha detto questo nella prima parte del libro, mentre nell’ultima parte ordinerà di non sigillarla (Ap. XXII, 10), e questo perché ciò che la Chiesa non conosceva pienamente all’inizio, alla fine lo mostri ogni giorno. Allora l’Angelo che avevo visto in piedi sul mare e sulla terra alzò la mano al cielo, giurò per Colui che vive nei secoli dei secoli, che non ci sarà più tempo; ma nei giorni in cui si sentirà la voce del settimo Angelo suonare la tromba, non ci sarà più tempo se non quello della purificazione: questa è la futura risurrezione della pace, in cui la Chiesa si affermerà, così come dice l’Apostolo: « L’ultima tromba » (1 Cor. XV, 52), ed in essa il mistero di Dio sarà stato consumato, come Egli aveva evangelizzato attraverso i suoi servi. E ho sentito la voce del cielo che mi parlava e mi diceva: “Vai, prendi il libro che è nelle mani dell’Angelo e ingoialo; sarà nella tua bocca dolce come il miele, ma renderà le tue viscere amare come il fiele“. Questo libro è la Legge ed il Vangelo. Quando si comincia a leggerlo è dolce in bocca, ma se ne sentirà l’amarezza appena si comincerà a predicare ed a mettere in pratica quanto capito. E quando si sarà manifestata la dolcezza nella bocca e l’amarezza nelle mie viscere, dice: … devi predicare di nuovo. Nel dire questo, è chiaro che ai primordi la Chiesa ha compiuto la profezia pienamente, perché ha annoverato tanti martiri; ed una volta che la fede abbia fatto il giro del mondo, la profezia è chiusa. È questo ciò che dice: … dovete predicare di nuovo; con ciò si riferisce al fatto che alla fine dei tempi, quando ci sarà l’arrivo dell’Anticristo, la profezia riaprirà la sua bocca. Addolcire la bocca e rendere amare le viscere: questo è quando si inizia a predicare ed a porre in opera. – Poi mi fu data una canna di misura come un’asta, e l’Angelo mi disse: “Alzati e misura il santuario di Dio e l’altare, e quelli che in esso adorano” (Ap. XI). Non si riferiva a lui, nel dire alzati, ma al peccatore: … alzati per fare penitenza. Misurare il Santuario significa confessare al Padre onnipotente e a Gesù Cristo suo Figlio, nato per opera dello Spirito Santo dalla Vergine Maria; e quel che viene annunciato dai profeti è la mano di Dio, il Verbo del Padre e Creatore del mondo. Questa è la canna e la misura della fede. Ma nessuno adora il santo altare se non coloro che abbiano rettamente professato questa fede. Solo questi adorano, non tutti quelli che sembrano adorare. E mi dice: … l’atrio fuori dal Santuario, lasciatelo fuori. Il Santuario si riferisce ai servi di Dio, mentre il cortile è il cattivo Cristiano: ed infatti il cortile sembra appartenere al Santuario, ma non è il Santuario. E i Cristiani malvagi sembrano che appartengano ai Santi, ma non sono Santi. Per questo saranno cacciati via, perché ai tempi dell’Anticristo calpesteranno la città santa, cioè la Chiesa. I miei due testimoni profetizzeranno 1.290 giorni, coperti da tela di sacco. Questi due testimoni sono la Legge ed il Vangelo. Sono vestiti di sacco perché predicano la penitenza. In realtà, qui ci si riferisce ad Elia ed a colui che verrà con lui: io manderò i miei due testimoni ed essi profetizzeranno per mille e duecentonovanta giorni, cioè tre anni e sei mesi, che saranno i giorni della loro predicazione, ed il regno dell’Anticristo (durerà) altrettanto. Essi sono i due ulivi e i due candelabri. Questo, in senso letterale, si riferisce ad Elia ed a colui che deve venire con lui; ma si fa riferimento, in senso spirituale, ai due Testamenti, che sono la Legge ed il Vangelo. Questi sono i due ulivi e i due candelabri. Un tale candeliere, che viene descritto da Mosè come dotato di sette braccia (Num. VIII, 2), è la septiforme Chiesa ripiena dello Spirito. E i due olivi sono la Legge ed il Vangelo. L’olio deve essere versato sul candeliere, cioè sulla Chiesa. Questa è la Chiesa con il suo olio che non si esaurisce, ma che essa fa bruciare per illuminare il mondo. Se qualcuno cerca di farle del male, il fuoco uscirà dalla sua bocca e divorerà i suoi nemici: vale a dire che se qualcuno non vuole ascoltare la Legge ed il Vangelo, sarà bruciato dal fuoco divino. Questo è il fuoco, cioè la parola della predicazione, che Gesù è venuto a portare sulla terra (Lc. XII, 4) per il nostro corpo, e vuole che bruci in tutti. – Questi due hanno il potere di chiudere il cielo in modo che non piova, hanno cioè il potere di legare e di sciogliere, hanno il potere di trasformare l’acqua in sangue. L’acqua è la Scrittura. Si serra il cielo quando le parole della predicazione si infrangono su di un cuore indurito, ed a causa delle sue azioni malvagie, ciò che sembra cristiano gli risulta inutile. … Li vincerà e li ucciderà. Questo viene fatto spiritualmente nella chiesa dall’Anticristo con i suoi ministri. Li vincerà … saranno quelli che compiono azioni malvagie. Ucciderà … coloro che predicano Cristo e si allontanano dal male; perché è chi non osserva la Legge ed il Vangelo, come l’Anticristo, che ucciderà Elia ed Enoch. E il suo corpo sarà gettato nella piazza della città. Qui ha indicato un solo corpo dei due, perché la Legge e il Vangelo sono una cosa sola, ed insegnano che uno solo è il corpo della Chiesa. Da parte sua, quanto ha detto: sarà gettato nella “piazza” della città (“platos” in greco, che significa in latino “latitudo”, larghezza), si riferisce al fatto che, seguendo la via ampia e spaziosa, si gettano i corpi dei Testamenti, cioè la Legge e il Vangelo, in mezzo alla città; … corpo che è la Chiesa, così come è scritto: « tu che detesti la disciplina e che le mie parole te le getti alle spalle? » (Psal. XLIX,17). – Persone, razze, lingue e nazioni contempleranno i loro cadaveri per tre giorni e mezzo, cioè trecentocinquanta giorni, cioè tre anni e sei mesi. Questo deve essere compreso spiritualmente: dalla Passione del Signore al tempo dell’Anticristo, si contano tre anni e sei mesi. Per un anno, cento anni, e per tre anni, trecento, e per cinquanta anni, sei mesi: si mescola, allora, il tempo presente ed il futuro, come dice il Signore nel Vangelo: « Verrà l’ora in cui tutti coloro che vi uccideranno penseranno che stanno servendo Dio » (Gv. XVI, 2). Non separa mai il tempo presente da quello finale in cui l’Anticristo si manifesterà, perché ciò che accadrà allora in modo visibile sta accadendo già ora nella Chiesa in modo invisibile. Non è permesso seppellire i loro cadaveri, e questo è detto della promessa di coloro che seguono Cristo, nel senso che non è permesso loro di fare penitenza con tranquillità, come è scritto: « Guai a voi, scribi e farisei, ciechi e ipocriti, che chiudete il regno dei cieli, e questo è la Chiesa, perché non entriate voi né lasciate entrare altri » (Mt. XXIII, 13). Gli abitanti della terra gioiscono ed esultano a causa loro, e si scambiano doni: questo avviene quando, trovandosi i giusti nell’afflizione, gli empi ne gioiscono ed esultano. E la stessa loro visione è molto pesante per gli ingiusti, così come quando hanno detto di Cristo: « la sua stessa presenza ci è insopportabile » (Sap. II, 15), e non solo è loro di aggravio, ma li sgomenta, come è scritto: « L’empio vede e si adira, digrigna i denti e si consuma. » (Psal. CXI, 10). Si rallegreranno, quindi, quando non avranno più nulla da soffrire, quando i giusti saranno perseguitati ed uccisi e la loro eredità sarà posseduta. Perché diranno: questi due profeti hanno tormentato gli abitanti della terra, come a dire: sono loro che vivevano secondo la Legge ed il Vangelo, e ci hanno costretti a vivere così; rallegriamoci nel vederli dispersi dalla persecuzione e sterminati. Ma dopo tre giorni e mezzo un soffio di vita da Dio entrò in loro e si alzarono in piedi, e un grande timore si abbatté su coloro che li guardavano. E udirono una voce forte dal cielo: Salite qui, e saliranno in cielo in una nuvola. Di questi tre giorni e mezzo abbiamo già parlato prima nel senso spirituale, comprendendoli tra la prima e fino alla seconda venuta. Ciò che ha detto: si sono alzati in piedi, appartiene alla futura resurrezione; e quel che dice: un grande timore si è abbattuto su coloro che li hanno contemplati, lo dice di tutti gli uomini. E quando la loro sorte sarà mutata, coloro che erano felici in questo mondo saranno tormentati senza fine, e coloro che erano afflitti nel mondo gioiranno senza misura. Quel che ha detto: “Salite qui e saliranno in cielo in una nuvola; è quanto diceva già l’Apostolo: « Saremo presi dalle nuvole per incontrare Cristo » (1 Tess. IV,16). Infatti prima della venuta del Signore non poteva accadere che un uomo, se non il Cristo, potesse salire in cielo nel suo corpo; come sta scritto: « prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo » (1 Cor XV, 23), ma alla sua venuta, saranno presi nelle nubi ed usciranno per incontrarlo. Se questo si dicesse solo di Elia e di colui che deve venire con lui, come potrebbero gli abitanti di tutta la terra gioire per la morte violenta di due persone che muoiono in una determinata città? O quando si possono inviare doni, essendoci solo tre giorni e mezzo per gioire della morte, prima di essere rattristati dalla risurrezione? O quali feste ci potrebbero essere, se per tre giorni i cadaveri umani emanano fetore? È chiaro infatti che in questi due personaggi sono rappresentatila Legge ed il Vangelo, e che “tre giorni e mezzo” si riferiscono al tempo che intercorre tra la prima e la seconda venuta del Signore. – E grande timore si è abbattuto su coloro che li hanno osservati, questo lo ha detto di uomini viventi, perché anche i giusti, che il giorno del giudizio troverà vivi, avranno grande paura alla risurrezione dei morti. … E i loro nemici li vedranno. Qui separerà i giusti da coloro che aveva detto in generale essere pieni di paura. In quella ora si è verificato un violento terremoto, e questa è la persecuzione alla venuta del Signore. E in quell’ora che è detta, significa tutto il tempo, affinché chi è sul tetto, non scenda a prendere nulla dalla casa (Mt. XXIV, 17), cioè chi vive per il Vangelo non vada più a rivestirsi dell’uomo vecchio, e non desideri avere ciò a cui una volta aveva rinunciato. E la decima parte della città è crollata nel terremoto, e settemila persone sono morte, cioè nella persecuzione dell’Anticristo si dice che ne siano morte settemila. Settemila e diecimila sono interpretati come un numero perfetto. Due sono gli edifici della Chiesa, uno è fondato sulla roccia, che è Cristo; l’altro sulla sabbia, che è l’eresia. Si dice che l’uno sia incorso nella persecuzione, ed altri abbiano temuto e dato gloria al Dio del cielo. Questi sono quelli fondati sulla pietra; infatti quando i giusti che temono, vedranno i malvagi morire nel terremoto, saranno sollecitati alla confessione della loro anima, saranno più coraggiosi nell’osservare i comandamenti, e daranno con gioia gloria a Dio, come sta scritto: « Vedendo il malvagio punito, egli diventa più astuto » (Prov. XV, 5). Terminata la ricapitolazione premessa al settimo Angelo, ripete l’ordine dicendo: Il seconda “guai” è passato; infatti il primo si diceva fosse passato nella battaglia delle cavallette; e il secondo era giunto con i cavalli visti in visione. – Non ha detto là che il secondo “guai” sia passato, per non descrivere subito il terzo, perché, sia per quanto riguarda le cavallette che i cavalli, il “guai” si è ricapitolato in due modi. Ora, dopo questa ricapitolazione, si dice che il secondo “guai” sia passato. Quindi, il secondo “guai” che è passato è quella dei cavalli, seguito dal terzo “guai” e dal settimo angelo con il quale si descrive la fine. Sembra che qui abbia fatto due finali successivi, uno di ricapitolazione e l’altro di ordine. Infatti ha raccontato una fine nella resurrezione dei testimoni, cioè della Legge e del Vangelo, che abbiamo commentato sopra e che l’ha presentata fuori dall’ordine (sequenziale), e ne ha poi introdotta una seconda che mancava, quella che si riferisce alla lotta dei cavalli, dicendo: Il secondo “guai” è passato: ecco, sta arrivando il terzo. Il settimo Angelo suonò la sua tromba, e c’erano voci forti in cielo che dicevano: Il regno di nostro Signore e del suo Cristo è venuto sul mondo, ed Egli regnerà nei secoli dei secoli. E i ventiquattro anziani si prostrarono faccia a terra e adorarono Dio dicendo: “Ti ringraziamo, o Signore Dio onnipotente, che sei venuto, perché hai ricevuto la tua grande potenza e hai regnato”. E le nazioni erano in collera, ma è giunta la tua ira ed è giunto il momento che i morti siano giudicati. Fa riferimento qui all’inizio e alla fine: Tu hai regnato, e le nazioni si sono infuriate: e questo è il primo avvento; … è giunta la tua ira ed il tempo di giudicare i morti: questo ne è il secondo, … e dare la ricompensa ai tuoi servi i profeti, e a quelli che temono il tuo nome, e distruggere quelli che distruggono la terra. Ecco, il terzo « guai! » viene dalla voce del settimo Angelo, nell’ultima lotta e alla venuta manifesta del Signore. Non c’è nessuno che lodi il Signore e ringrazi il Creatore, tranne la Chiesa, perché vive rettamente e crede rettamente, e pertanto i guai sono partiti dagli uomini empi. – Da questo comprendiamo che non c’è remunerazione dei buoni senza i « guai! » degli empi. Così ha detto la stessa Chiesa: è arrivata la tua ira ed è giunto il momento di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi e distruggere coloro che distruggono la terra. Questo è l’ultimo “guai” che l’Aquila aveva annunziato: « Guai, guai, guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre Angeli stanno per suonare! » (Ap. VIII, 13); in questo “guai!” giunge la fine. Così ricapitolato il tutto dalla nascita del Signore, si diranno nuovamente le medesime cose con maggiore chiarezza. « Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l’arca dell’alleanza. » È … nel suo santuario (Ap. XI, 19) – cioè nella Chiesa – che si è manifestato Cristo, e si è aperta così la profezia nella Chiesa. E ci sono stati fulmini, e tuoni, ed un terremoto, ed una grande grandinata. Tutte queste cose si riferiscono alle proprietà dello splendore della predicazione e delle guerre della Chiesa. Come in precedenza, nelle sette trombe degli Angeli sono stati esposti i fatti dalla venuta del Signore fino alla fine, perché si potesse riconoscere quanto accaduto con ciascuna delle trombe, così ora, non appena il Santuario di Dio in cielo è stato aperto, si sono susseguite le lotte e dice: « Ed ho visto la bestia che saliva dall’abisso. » Dopo aver inflitto molte piaghe al mondo, si dice che la bestia è risorta dall’abisso. Questo lo dice propriamente dell’Anticristo, che da quando Cristo è nato, è sempre stato negli uomini malvagi: coloro che hanno crocifisso Cristo erano il suo “abisso”; coloro che perseguitano la Chiesa sono l’abisso dell’Anticristo, perché “abisso” sono gli uomini che camminano nelle tenebre; infatti, al pari di Cristo che ha avuto come mediatori i Patriarchi e i Profeti che parlavano di Lui in figura e, dopo la sua venuta, coloro che avendolo annunciato lo hanno riconosciuto, e per mezzo dei quali fu suscitata la Chiesa, in cui Cristo, Capo di tutta la Chiesa, regna come un unico Corpo con i suoi membri, … così l’Anticristo ha i suoi mediatori nei re e nei sacerdoti empi, che riconosce come suoi membri per mezzo delle loro azioni nefande, e di tutti i malvagi è re e capo.
[5] E un grande segno apparve nel cielo (Ap. XII), cioè nella Chiesa, Dio si fa uomo: una Donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, ed una corona di dodici stelle. È questa l’antica Chiesa dei Patriarchi, dei Profeti e degli Apostoli, che ha fatto proprio il gemito e l’angoscia del suo desiderio, fin quando non ha visto che Cristo, promesso secondo la carne, ha assunto il corpo dal suo stesso popolo. A sua volta, colei che è vestita di sole è la speranza della Resurrezione. La “luna” in vero, sono i pericoli dei Santi che soffrono nelle tenebre di questo secolo, che non possono mai mancare e che ora decrescono ed ora crescono, proprio come la luna che decresce e poi cresce. Allo stesso modo, i Santi brillano in mezzo alle tenebre, proprio come la luna. La corona di dodici stelle rappresenta il coro dei Patriarchi, secondo i quali Cristo doveva assumere la carne. E in Cristo vi sono le dodici tribù di Israele, cioè la Chiesa. E la donna è incinta, e grida nel travaglio e nel dolore del parto. Quando parliamo di questa donna ci riferiamo alla Chiesa, che porta Cristo nel suo grembo. Infatti la Chiesa partorisce con gran gemito volendo imitare Cristo. E un altro segno è apparso in cielo: un grande dragone rosso. Il “cielo” è la Chiesa, il dragone è il diavolo. Egli finge di adorare Cristo attraverso i suoi ministri nella Chiesa, e come Erode, il nemico interno, che cercò di uccidere colui che simulava voler adorare, così il diavolo, fingendosi santo, si sforza di uccidere Cristo, nato dalla donna-Chiesa, nel nostro petto attraverso i cattivi Cristiani. Esso ha sette teste e dieci corna. Però quante sono le teste, tante sono anche le corna. Nelle sette teste si indicano tutti i re, e nelle dieci corna, tutti i regni: queste vengono designate con un numero perfetto. E la sua coda attirava la terza parte delle stelle del cielo e le gettava sulla terra. La coda di questo dragone sono i profeti ed i sacerdoti iniqui, come detto parlando delle cavallette, e le stelle del cielo che vi aderiscono, cioè i santi che sembrano essere nella Chiesa, sono gettate sulla terra: tutti i Santi infatti sono il “cielo” ed i peccatori, chiamati “terra”, sono sotto i piedi della donna. E la donna partorì un figlio maschio, cioè la Chiesa (diede alla luce) il Cristo, di poi il suo corpo, che sono i Santi, partoriti ogni giorno con dolore. Ha parlato solo di un “Figlio”, perché Cristo, che ne è il Capo, costituisce un solo corpo con i membri della Chiesa. Lo dice “maschio”, cioè vincitore del diavolo che aveva vinto la donna. Infatti la donna che vince il diavolo vien chiamata uomo. E quando l’uomo è sopraffatto dal diavolo, si dice: “il diavolo ha sopraffatto la donna”. E la donna fuggì nel deserto: “deserto” sono i malvagi che non accolgono la predicazione, questi sono gli scorpioni e le vipere, ed è per questo che il Signore dice ai suoi servi: « Vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni » (Lc. X, 19). Poi si svolse una battaglia nel cielo: Michele e i suoi angeli combatterono con il dragone; anche il dragone ed i suoi angeli combatterono. Per “Michele” si intende Cristo; per cielo la Chiesa e per Angeli gli uomini santi. Non c’è nessuno che possieda gli Angeli, se non nostro Signore Gesù Cristo. Lungi da noi dunque il pensare che il diavolo con i suoi angeli potesse osare di combattere in cielo, dal momento che dovette chiedere al Signore il permesso di colpire un uomo sulla terra: Giobbe. Egli ha ricevuto però il potere di combattere con la progenie della donna, non con il Figlio di Dio o i suoi Angeli. Ma essi non hanno prevalso, e non c’era più posto per loro in cielo, cioè tra gli uomini santi, che, una volta creduto in Cristo, non hanno più accolto il diavolo che era stato cacciato via. Quando il dragone vide che era stato gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva dato alla luce un uomo maschio: poiché più si respinge il diavolo, tanto più esso perseguita. Poi il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d’acqua dietro alla donna, per portarla via con la sua corrente, cioè con le persone che perseguitano la Chiesa. E ho visto una bestia salire dal mare (Ap. XIII). Prima aveva detto, “dall’abisso”; ed ora dice, “dal mare”. Il mare, l’abisso e la bestia sono in realtà una cosa sola, sono cioè gli uomini malvagi che nascono da uomini malvagi, così come le vipere nascono dalle vipere. In questa “bestia” sono rappresentate molte membra, a volte il diavolo, a volte i sacerdoti empi, a volte le persone malvagie, a volte i falsi religiosi. Essa aveva dieci corna e sette teste, e sulle corna dieci diademi, e sulle loro teste un nome blasfemo. “Sulle corna” si allude al potere o all’orgoglio dei capi, dei principi del mondo; con il nome “diademi”, al nome della Cristianità; col nome di “blasfemia”, al fatto che si lodano i loro principi e si venerano, si ascoltano come dei, senza che si voglia riconoscere Dio che ha fatto tutte le cose: questi, senza dubbio, sono annoverati tra i membri dell’Anticristo. E ho visto un’altra bestia sorgere dalla terra. Ha detto “un’altra” per la sua funzione, ma essa è sempre la stessa, perché la seconda fa la volontà della prima bestia, e si riferisce al falso profeta e sacerdote. E aveva due corna come un agnello, cioè predicava la Legge e il Vangelo, come l’Agnello, e fingeva di avere il volto di un uomo giusto: … ma parlava come un dragone, e faceva scendere fuoco dal cielo davanti al popolo: come i maghi oggi che, servendosi degli angeli decaduti, fanno miracoli agli occhi degli uomini, così gli empi sacerdoti battezzano alla presenza del popolo, ordinano sacerdoti, e danno l’assoluzione. Sono questi atti che fanno scendere il fuoco dal cielo. Il “fuoco” è lo Spirito Santo; il “cielo”, la Chiesa. E seducono non coloro che abitano in cielo, ma coloro che abitano sulla terra, e si fanno essi stessi simulacro della prima bestia, e attraverso di loro l’Anticristo regna nella Chiesa. Ed io guardai, ed ecco un agnello in piedi sul monte Sion, e con lui centoquaranta quattromila, con il suo nome e quello di suo Padre sulla fronte (Ap. XIV). L’Agnello è il Cristo; Sion è la torre di guardia della contemplazione; i centoquarantaquattro mila sono la Chiesa nella sua globalità. Questi seguono l’Agnello, cantando un inno nuovo: annunciano cioè Cristo che è nato ed ha patito e quindi, attraverso il Battesimo e la Penitenza, il perdono di tutti i peccati. Poi ho visto un altro Angelo volare nel cielo e un altro Angelo che lo seguiva, questi sono Elia e colui che verrà con lui, che precederà il regno dell’Anticristo con la sua predicazione. – Abbiamo detto tutte queste cose nel senso letterale. Ma, in senso mistico, con l’Angelo che vola nel cielo e quello che lo segue, si allude alla Legge ed al Vangelo, e che attraverso la loro predicazione percorrono il cielo, cioè la Chiesa. – E un secondo Angelo lo seguì dicendo: “È caduta, è caduta Babilonia la grande”. Babilonia significa la città del diavolo, vale a dire il suo popolo. Come la città di Dio è la Chiesa, così, all’opposto, la città del diavolo è Gerusalemme e Babilonia per tutto il mondo: questa è la Gerusalemme che uccide i profeti, mentre la Gerusalemme celeste è quella di Dio, dove si trova “nostra conversatio”. Questa è libera, come madre di tutti noi, mentre l’altra è schiava insieme ai suoi figli. Infatti la nostra Chiesa in questo mondo non si chiama Gerusalemme, cioè visione della pace, perché essa è nel combattimento; la nostra Chiesa si chiama invece Sion, cioè torre di guardia della contemplazione, perché calpesta ciò che è terreno e brama invece l’essenza delle cose celesti, contemplando in enigma Colui che desidera vedere quanto prima faccia a faccia. Quando dice: Babilonia la grande è caduta, si riferisce ai condannati nel giudizio: lo dice come se ciò che sta per accadere fosse già stato realizzato. Il fatto che ripeta due volte “è caduta, è caduta”, ci fa vedere innanzitutto che è caduta la Chiesa a causa delle eresie, degli scismi e delle opere di discordia, e che costoro saranno doppiamente condannati nel giorno del giudizio. – Un terzo Angelo li seguì, dicendo: Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e accetta il marchio sulla sua fronte, deve anche bere il vino dell’ira di Dio, ed essere tormentato con fuoco e zolfo davanti a Dio nei secoli dei secoli. Abbiamo detto sopra che la bestia è il diavolo ed il suo popolo. Sulla fronte, hanno la dottrina del diavolo; nella mano destra, un nome come di Cristianesimo: ma ne ricevono il marchio nella mano destra o sulla fronte quando fanno ciò che riconoscono essere come suo. – Poi ho guardato, e c’era una nuvola bianca: e sulla nuvola uno come un figlio dell’uomo, cioè Cristo. Si descrive la Chiesa nella sua luminosità, resa biancheggiante dalla fiamma della persecuzione. Portava una corona d’oro in testa. Questi sono gli Anziani con le corone d’oro: … e nella sua mano una falce affilata, simbolo nella loro attività della potestà di maledire. Per questo motivo ogni ladro e spergiuro sarà punito d’ora in poi fino alla morte. Il ladro e lo spergiuro sono gli ipocriti di cui dice il Signore: « Chi non entra dalla porta – che è Cristo – è un ladro ed un brigante » (Gv. X, 7). – E un Angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che sedeva sulla nuvola: “Getta la falce, perché il raccolto della terra è maturo”. Allora ecco un altro Angelo anch’egli tenendo una falce affilata dicendo: “Getta la tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra .. metti la falce nel torchio della terra e gettala nel torchio dell’ira del furore del Signore”. La falce del mietitore e la falce del vendemmiatore sono una cosa sola. La spremitura del torchio e la mietitura del raccolto è la retribuzione del peccatore. Così che coloro che ora, con la penitenza, non si liberano della pula per diventare grano, e non vengono schiacciati dal torchio della tribolazione per diventare grano e vino nella Chiesa, saranno schiacciati all’infinito, fuori della Chiesa, nella gehenna. – Poi ho visto in cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette Angeli che portavano le sette ultime piaghe, poiché con esse è consumata l’indignazione di Dio (Ap. XV). Dice sette” e ripete “sette”: questo deve essere inteso spiritualmente, perché nelle sette piaghe, l’ira è intesa nella sua perfezione, così come attraverso le sette chiese si esprime la grazia settiforme. In queste sette piaghe ci si riferisce all’ira del Signore, perché l’ira di Dio percuote nella perfezione il popolo contumace. – Vidi anche come un mare di cristallo, e quelli che vi stavano sopra, che avevano le arpe e le coppe. Col “mare” allude al Battesimo, perché l’acqua del mare è amara. Con l’acqua si intende il Battesimo e con l’amarezza la penitenza. Il vetro significa “fragilità”, perché il Battesimo presto si infrange, ma con la penitenza si ripristina nella fornace della tribolazione. Le “arpe” a cui si allude, sono i cuori di coloro che lodano Dio, cioè di coloro che hanno crocifisso la loro carne insieme ai vizi ed alle concupiscenze di questo tempo, ed hanno mortificato sulla terra le loro membra. – Dopo ciò vidi aprirsi nel cielo il tempio che contiene la Tenda della Testimonianza; dal tempio uscirono i sette Angeli che avevano le sette piaghe. – Il Santuario, il Tabernacolo e il Cielo sono un’unica cosa, cioè la Chiesa. Quella che dice “aprirsi” è la manifestazione, buona o cattiva, nella Chiesa. I sette Angeli, che portano le sette piaghe, sono le chiese, che nella grazia settiforme costituiscono una sola Chiesa, alle quali è stato dato dal Signore il potere di legare e sciogliere, e ciò che ciascuno fa, sia in bene che in male, non può rimanere nascosto nella Chiesa. – Poi uno dei quattro animali ha dato ai sette Angeli sette coppe d’oro piene dell’ira del Dio vivente. Sono queste le coppe con gli aromi portati dai Seniori e dagli Animali, che sono la Chiesa, … essa è anche i sette Angeli, ed anche gli aromi che significano l’ira di Dio. Infatti le preghiere dei Santi, che sono il fuoco che esce dalla bocca dei testimoni, per il mondo è l’ira. Uno degli animali diede alla Chiesa le coppe, cioè la predicazione del Vangelo, perché chiunque lo ascolti possa essere salvato, e chi non lo ascolta venga colpito dall’ira di Dio, poiché il Vangelo è la volontà di Dio. Chiunque segue Cristo fa la volontà del Padre. – … e nessuno poteva entrare nel Santuario fino a quando non avessero termine le sette piaghe, cioè nessuno degli ipocriti poteva entrare nella Chiesa, perché ci sarebbe stata una grande angoscia, come non è mai esistita. E nessuna carne sarebbe risparmiata, se Dio non accorciasse quei giorni, a causa degli eletti. – E udii una voce forte dal cielo che diceva ai sette angeli: “Versate sulla terra le sette coppe dell’ira di Dio” (Ap. XVI). Alla Chiesa è stato dato il potere di diffondere l’ira sulla terra dalla quale salì. Tutte queste sono piaghe spirituali: infatti in quel tempo tutti gli empi non saranno affetti da piaghe corporee, ed è come se avessero ricevuto tutto il potere di fare il male. E non sono flagellati nel corpo, perché se fossero flagellati, infine si correggerebbero, ma perdureranno fino alla fine nella pienezza dei loro peccati. E il primo Angelo versò la sua coppa sulla terra. E il secondo Angelo versò la sua coppa sul mare. E il terzo angelo ha versato la sua coppa sui fiumi e sulle sorgenti d’acqua. E il quarto angelo versò la sua coppa sul sole. E il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia. E il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate. E il settimo angelo versò la sua coppa nell’aria. – La terra, il mare, i fiumi, le sorgenti d’acqua, il sole, il trono della bestia, il fiume Eufrate, l’aria, sulla quale gli Angeli hanno versato le loro coppe, sono la terra, cioè gli uomini. il che è facile da dimostrare, poiché a tutti gli Angeli è stato ordinato di versare sulla terra. Tutte queste piaghe sono da intendersi in senso spirituale. Infatti costituisce una piaga incurabile ed un segno di grande ira, ricevere il potere di peccare, specialmente nei Santi, senza che siano corretti. È ancora segno di maggiore ira di Dio, e procurarsi un accrescimento dei tormenti, quando ogni Santo ritenga giusto ciò che fa, per potersi dare sempre al piacere, e pensi che in questo modo si sacrifichi davanti a Dio e serva i fratelli. Questa è la piaga dell’ira di Dio, che si diffonde soprattutto tra i servi di Dio che seguono la propria volontà. E vidi tre spiriti impuri come rane uscire dalla bocca del serpente, dalla bocca della bestia, e dalla bocca del falso profeta. Abbiamo già detto sopra che il dragone è il diavolo; la bestia, costituita dagli uomini malvagi, è il corpo del diavolo, come i falsi profeti; i prepositi del corpo del diavolo, sono i sacerdoti ed i predicatori malvagi, che hanno lo spirito come le rane. Le rane sono i demoni; queste di solito si nutrono in pozzanghere ed in acquitrini, la cui acqua è impura: questo animale non ha altra caratteristica, se non quella di emettere come voce un suono simile ad un gracchiare improbo ed importuno. Così, di per sé, un tale animale è impuro, ed anche l’acqua della quale si nutre è impura. Con cos’altro abbiamo allora a che fare se non con falsi profeti, cioè con sacerdoti e predicatori di impurità, che, essendo in se stessi sporchi come le rane, sporcano anche le acque medesime delle Scritture, introducendo nel mondo delle falsità con una modulazione vacua come con il suono ed il gracchiare delle rane. E questi stanno all’interno della Chiesa sotto il nome di religione, così da opprimere la Chiesa; e in Essa i falsi profeti sono composti da quattro categorie: l’eretico, che si caratterizza per il fatto che ognuno sceglie per sé ciò che vuole e fa come meglio gli pare e, se viene corretto da un qualche Cattolico, giustifica ciò che ha fatto e si considera essere come santo: costui è fuori dalla Chiesa. Altro è lo scismatico. Si chiama “scisma” dalla “scissura” delle anime: perché pur stando nella stessa Religione, con lo stesso culto, il medesimo rito, con gli altri Santi della Chiesa, non aderisce alla medesima gerarchia, ritenendosi più santo degli altri della Chiesa. E poiché veglia di più, lavora di più, digiuna più degli altri, crede di essere più santo, al punto da dire che egli santifica tutto ciò che è impuro. Altro è il Superstizioso: si dice superstizione, un’osservanza superflua, che è sovrapposta alle osservanze dell’istituzione religiosa. E questi non vivono come gli altri fratelli, ma per il desiderio del martirio si tolgono la vita in modo che, lasciandola in modo violento, siano considerati martiri. Questi si chiamano « cotopici » in greco e noi li chiamiamo “circumcelliones” in latino perché sono vagabondi. Vagano per le province, perché non tollerano di essere in un unico luogo in comune accordo con i frati e di avere una vita in comune onde vivere con un’anima sola e un cuore solo alla maniera degli Apostoli ma – come detto – vagano per molti paesi e contemplano attentamente i sepolcri dei Santi come se questo servisse alla salvezza delle loro anime: ma questo non giova loro a nulla, perché lo fanno senza il comune accordo con i fratelli. Il quarto è l‘ipocrita. Nella lingua greca, un ipocrita è ciò che in latino si chiama « simulatore ». È colui che ha il male dentro e si mostra buono agli occhi di tutti, perché “hypo” significa falso e “crisis” significa giudizio. Il nome “hypo” deriva dall’aspetto di chi appare negli spettacoli con il volto coperto, volto tinto con vernice nera, rossa od altre pitture, indossando maschere di gesso tinto di diversi colori. A volte si spalmano il collo e le mani con l’argilla, per acquisire l’aspetto di un personaggio e quindi ingannare il pubblico durante la rappresentazione dei giochi, assumendo l’aspetto di uomo o di donna, di uomo calvo o peloso, di anziano o di fanciulla, e con facce diverse per età e sesso; l’idea dell’argomento è stata poi traslata e da questa prende il nome di ipocrita, che cioè sono coloro che camminano con una faccia falsa e simulano ciò che non sono. Così, questo genere di monaci sono cattivi all’interno, ma buoni all’esterno. E dunque non si possono chiamare ipocriti coloro che, una volta manifestatisi, vengono allo scoperto, perché si chiamano già eretici. – Questi quattro tipi sono propriamente considerati come falsi profeti. E sono considerati falsi profeti perché si nominano da sé, sia all’Episcopato, che al Presbiterato o al Diaconato, sia nella manifestazione religiosa o nel culto penitenziale, e vivono a loro discrezione, ritenendo santo ciò che operano e giustificandolo non con l’autorità delle Scritture, ma con parole mendaci. Infatti non sono scelti dalla Chiesa Cattolica, e quindi sono “ladri e briganti” che non entrano nella Chiesa attraverso la porta, che è Cristo. Questi sono membri del dragone, della Bestia e del falso profeta, dalla cui bocca si vedono uscire tre spiriti impuri come rane. Si vede un solo spirito, ma con il numero delle parti si sono indicate le membra di un corpo: il dragone, cioè il diavolo; la bestia, il corpo del diavolo, che è il popolo malvagio; ed i falsi profeti, cioè i preposti del corpo del diavolo, hanno un solo spirito, come di rana, perché tutti affermano una stessa parola. – E il settimo Angelo versò la sua coppa nell’aria; e una voce forte uscì dal santuario che diceva: è fatta, cioè è finita. Il Santuario e il trono diciamo essere la Chiesa. E quando dice: è finita, dice che sono finite le sette piaghe, ma ricapitola la stessa persecuzione. – Ci furono fulmini, tuoni e un terremoto, come non ce n’erano da quando gli uomini esistevano sulla terra. Un terremoto di questo tipo, un terremoto così grande, significa un’angoscia come mai prima d’ora. E la grande città è stata aperta in tre parti. La grande città è tutto il popolo, in generale, che è sotto il cielo; esso sarà aperto in tre parti, quando la Chiesa sarà stata divisa, in modo che la gentilità ne sia una parte, l’abominio della desolazione un’altra, e la Chiesa che è uscita da essa, la terza. – E le città delle nazioni caddero; Dio si ricordò della grande Babilonia, per darle il calice del vino della sua collera. Poi tutte le isole fuggirono e le montagne sparirono. Le “città delle nazioni” sono i popoli non battezzati. Babilonia è l’abominio della desolazione, che in latino è: tutto il male. Che o sia fatto tra i pagani, o tra i Cristiani o tra i servi di Dio, il male operato, si definisce sempre Babilonia. Babilonia si interpreta come confusione, cioè come una mistura. E ciò che è male, si separa da Cristo e dalla sua Chiesa. Così Babilonia cade o beve l’ira di Dio quando riceve potere contro la Chiesa, specialmente alla fine dei tempi. Per questo si dice che è caduta a causa del terrore, della paura e della contumelia che fa alla Chiesa, perché, come detto, i pagani ed i Cristiani sono mescolati con la Chiesa. Essi – i pagani – non hanno città separate dai Cristiani, così che in particolare debbano cadere. E se dobbiamo pensare al giorno del giudizio, perché Dio se lo è ricordato dopo Babilonia? Perché queste città buone e cattive si formano dappertutto. E quando dice che le città delle nazioni caddero, significa che esse hanno perso la speranza che avevano in questo mondo. A sua volta, le isole e le montagne che sono fuggite e non sono apparse, sono ancora la Chiesa che sopporta tutti gli insulti e non restituisce male per male. E quando subisce gli insulti e non risponde alle parole dei bestemmiatori, si dice che fugge e scompare. – E una grande grandine, con pietre di quasi un talento, cadde dal cielo sugli uomini. “Grandine” viene chiamata l’ira di Dio, con la quale Dio minaccia il popolo. E gli uomini bestemmiavano Dio a causa della piaga della grandine, perché era una grandissima piaga. Questa piaga di cui parliamo si trova all’interno della Chiesa: quando qualcuno non adempie ai precetti del Signore, è spiritualmente devastato dalla grandine. Allo stesso modo, l’ira di Dio devasta ciò che trova tenero, cioè morbido e dissoluto o tiepido, quando si vede che non si lavora con tutte le proprie forze. – Poi venne uno dei sette Angeli che avevano le sette coppe e mi disse: “Vieni, ti mostrerò il castigo della famosa prostituta, che siede sulle grandi acque: con essa fornicarono i re della terra, e gli abitanti della terra si ubriacarono con il vino delle sue prostituzioni. (Ap. XVII). “Uno dei sette Angeli” di cui si parla, è la Chiesa. La coppa è il Vangelo. Quella che si designa come prostituta si riferisce alla corruzione ed alle opere malvagie, e si dice che “siede sulle grandi acque”, cioè sui popoli. Infatti le acque sono i popoli, siano essi cattivi Cristiani, pagani o eretici; ed essa è quella bestia riferita in precedenza. Coloro che si designano come “re della terra” sono i principi del mondo, quelli che vengono detti inebriati, sono le opere e le disposizioni malvagie che per loro si attuano sulla terra. – E sono andato in spirito nel deserto: e ho visto una donna seduta su una bestia. Deserto è lo stesso che dire “sterile”, è cioè, laddove la predicazione del Vangelo non viene né fatta né recepita. È chiamato deserto perché abbandonato da Dio. D’altra parte, la bestia e le grandi acque sono una cosa sola, e cioè il popolo malvagio che è il corpo del diavolo ed il nemico dell’Agnello, cioè di Cristo e della Chiesa. E vidi una donna seduta su una bestia di colore scarlatto, cioè una peccatrice, insanguinata dal sangue dei martiri e di tutti i Santi, con sette teste e dieci corna. Le sette teste si riferiscono a tutti i re e le dieci corna a tutti i regni. Infatti il sette ed il dieci costituiscono un numero perfetto. Ed era adorna di oro, pietre preziose e di perle. E aveva in mano una coppa d’oro piena di abomini e delle impurità della sua prostituzione. Quando si dice “adornata” ed avente una “coppa d’oro”, ci si riferisce agli ipocriti pieni di sporcizia, che infatti appaiono davanti agli uomini effettivamente dei giusti, ma dentro sono pieni di sporcizia. Questa donna con la bestia ed i re della terra appaiono in cielo, cioè nella Chiesa. Questi sono coloro che combatteranno contro l’Agnello, sono cioè coloro che si opporranno alla Chiesa fino alla fine dei secoli. Ma l’Agnello, come Signore dei signori e Re dei re, li vincerà, in unione con i chiamati, gli eletti ed i fedeli; indica così la Chiesa: i chiamati, gli eletti e i fedeli, ed infatti non tutti i chiamati sono anche eletti, dacché « molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti » (Mt. XXII, 14). Molti fedeli, non sono eletti. – E mi fu detto: “Vieni, ti sto per mostrare la Sposa dell’Agnello”, e mi mostrò la città che scendeva dal cielo. L’Agnello è Cristo, la Sposa dell’Agnello è la Chiesa. Essa discende sempre dal cielo, perché la Chiesa nasce sempre dalla Chiesa, come i Santi dai Santi che imitano i Santi, così come pure, al contrario, i malvagi dai malvagi che imitano i malvagi. – Dopo questo vidi un altro Angelo scendere dal cielo, che aveva un grande potere, e la terra fu illuminata dal suo splendore. E gridò a gran voce, dicendo: Babilonia la grande è caduta, è caduta, ed è diventata l’abitazione dei demoni. (Ap. XVIII). Questo Angelo è Cristo. Il gridare con forza è la predicazione del Vangelo. Quando dice: “Babilonia la grande è caduta ed è diventata l’abitazione dei demoni”, insegna chiaramente che Babilonia si divide in due parti, cioè tra i pagani ed i cattivi Cristiani, e che entrambi sono separati da Dio: alcuni lo rinnegano per la fede ed altri con le opere. Perciò egli avverte la Chiesa dicendo: Uscite da essa, popolo mio, affinché non diventiate complici dei suoi peccati e le sue piaghe non vi raggiungano: questo lo dice alla Chiesa. Allora un Angelo sollevò una pietra, come se fosse una grande macina da mulino, e la gettò in mare, dicendo: “Con questa pietra da macina Babilonia, la grande città, sarà scacciata e non apparirà più“. Dice così che la gioia degli empi passa e che non si ritroverà mai più. Poi ho sentito dal cielo un grande rumore di una folla immensa, che diceva: Alleluia (Ap. XIX). Questo è quel che dice sempre la Chiesa. Quando avrà luogo la separazione ed essa sarà apertamente vendicata, allora sarà veramente divisa da Babilonia, non ora in questo mondo: quando entrambe saranno uscite dal corpo, i malvagi andranno nelle profondità dell’inferno – che l’angelo ha chiamato “pietra da macina gettata nelle profondità del mare” – ed i giusti, invece, andranno alla vita eterna. – Poi ho visto il cielo aperto, e c’era un cavallo bianco: colui che cavalca su di esso si chiama Fedele e Verace. Questo cavallo è la Chiesa, e il suo cavaliere è Cristo. Questo è il cavallo visto nel primo sigillo tra il rosso, il nero ed il pallido. – Poi vidi un Angelo in piedi sul sole, e questa è la predicazione nella Chiesa: esso gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volavano in mezzo al cielo: venite, radunatevi per il grande banchetto di Dio, perché mangerete la carne dei re, dei tribuni e dei potenti, degli uomini liberi e degli schiavi, dei piccoli e dei grandi. La Chiesa, mangia tutto questo spiritualmente; la Chiesa ha preparato spiritualmente questi cibi e queste prelibatezze. Gli uccelli che volano si dicono Chiesa, e quelli che abbiamo detto essere mangiati sono i nemici della Chiesa, che essa divora sempre spiritualmente. – Poi ho visto la bestia ed i re della terra con i loro eserciti riuniti per combattere contro Colui che è a cavallo e contro il suo esercito. La bestia è il diavolo e tutto il suo popolo che combatte contro la Chiesa e contro Cristo. Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta, colui che aveva realizzato segni al cospetto della bestia perché si adorasse il suo simulacro. I due furono gettati vivi nel lago di fuoco che brucia di zolfo. La bestia catturata, significa che il Signore nella sua venuta finale sottometterà il diavolo, e con lui il falso profeta: quindi il diavolo, il popolo malvagio ed i suoi prepositi: un solo corpo diviso in parti. Infatti questi due vivi, sono il popolo ed i prepositi, che il Signore incontrerà viventi. E dice che li getterà vivi nel lago di fuoco ardente. Gli altri furono sterminati dalla spada che usciva dalla bocca di colui che sedeva sul cavallo, e tutti gli uccelli furono sazi della loro carne, cioè quando dice “gli altri” si riferisce a coloro che Cristo troverà morti al suo arrivo. “Colui che cavalca il cavallo” si riferisce a Cristo che è al di sopra della Chiesa. La “spada che esce dalla sua bocca” è la parola della predicazione. Tutti quelli che dice “gli uccelli”, sono i Santi che formano la Chiesa. Quando dice che si saziarono delle loro carni, significa che la Chiesa mangerà sempre la carne dei suoi nemici. Se ne ciberà perciò alla resurrezione, vendicatrice delle loro opere carnali. Ma, dopo la venuta del Signore e la punizione della bestia, chi deve essere ucciso con la spada per essere mangiato da veri uccelli, quando i corpi saranno risuscitati essendo gli uomini giudicati nella loro integrità? Qui finisce e ricapitola dall’inizio. Poi ho visto un Angelo scendere dal cielo, che teneva in mano la chiave dell’abisso ed una grande catena. Dominò il dragone, cioè il diavolo, e lo incatenò per mille anni. Lo rinchiuse e vi pose i sigilli, affinché non seducesse più gli uomini, fino al compimento dei mille anni (Ap. XX). L’Angelo qui nominato si riferisce al Cristo nella sua prima venuta. La chiave dell’abisso è il potere del suo popolo. Quella che egli chiama “catena” designa il potere che Dio ha dato al suo popolo. E quando dice che lo ha incatenato nell’abisso per mille anni, “l’abisso” è il popolo escluso dai cuori dei credenti. Ciò che egli ha chiamato mille anni, è il tempo dalla prima venuta del Signore fino alla sua seconda venuta, in modo che esso – il dragone – non possa nuocere per quanto vorrebbe a coloro che credono. Di poi deve essere liberato per un breve periodo, e questo alla fine del mondo, quando il diavolo, il principe introdottosi nell’Anticristo, e i suoi ministri negli uomini malvagi, avranno allora potere come non mai, anche di prima che Cristo venisse. Poi vidi dei troni, ed essi si sedettero su di essi, e fu dato loro il potere di giudicare. Per “troni” si intendono le dodici tribù di Israele, che sono la Chiesa stabilita in Cristo; già fin dalla prima venuta del Signore, quando il diavolo era legato, essi sono seduti e giudicano, perché, come sta scritto, « i santi giudicano già il mondo » (1 Cor. VI, 2); ma lo fanno coloro che abbandonano completamente il mondo e seguono Cristo con tutta la loro mente. Questo lo dice dei Santi che sono vivi. Dei Santi che sono già sepolti dice: Ho visto anche le anime di coloro che sono stati uccisi a causa della parola di Dio e per la testimonianza di Gesù. Infatti la Chiesa testimonia ad entrambi, cioè al Verbo ed alla carne, che c’è un solo Cristo Figlio di Dio. Beato e santo colui che partecipa alla prima risurrezione; la seconda morte non ha alcun potere su di costui. Cioè, chiunque in questo mondo attende alla penitenza, in futuro non sarà gettato nell’inferno … ma saranno sacerdoti di Cristo e regneranno con Lui per mille anni, cioè per sempre. Infatti mille è un numero perfetto. E quando i mille anni saranno passati, satana sarà liberato dalla sua prigione, cioè si dissolverà nel nulla, così da svanire ed andare alla perdizione eterna. Perché non sarà liberato per ricevere la libertà, ma sedurrà le nazioni dei quattro angoli della terra, Gog e Magog. “Sedurre” significa rovinare e trascinare con sé alla perdizione. Tutti i malvagi che esso ha sedotto dai quattro angoli della terra, uniti a lui nella stessa perdizione, farà sì che siano sottoposti ai tormenti eterni. E li radunerà per la lotta, numerosi come la sabbia del mare: questa è cioè la moltitudine di peccatori levatisi con la superbia, ma le cui azioni terrene li faranno sprofondare. E circonderanno l’accampamento dei Santi, cioè vivranno insieme ai Santi. Ma di loro è già stato profetizzato: « tornano a sera, hanno fame, vagano per la città » (Psal. LVIII,7). – Ma il fuoco scese dal cielo e li divorò; e il diavolo, il loro seduttore, fu gettato nel lago di fuoco e di zolfo, dove si trova anche la bestia, e il falso profeta; ed essi saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Questa è la dissoluzione a cui ci siamo riferiti in precedenza, in modo che il seduttore muoia insieme con il sedotto. – Poi ho visto un grande trono bianco e Colui che vi sedeva sopra. Il “trono” è figura del giudizio, quando Cristo, in quel giorno del giudizio, giudicherà Egli stesso il mondo intero. Lo chiama bianco, perché tutti saranno giudicati con giustizia. Il cielo e la terra sono fuggiti dalla sua presenza, perché il cielo e la terra non possono resistere ad un giudizio di così grande potenza. Infatti davanti ad esso non c’è alcun posto che occupi spazio, ma c’è come il niente ed il vuoto. Così mostrata la forma del giudizio, indicata la qualità del Giudice, si riferisce già all’esecuzione della sentenza. Ho visto i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, ed i libri sono stati aperti, cioè sono state proclamate le opere di tutti. E poi è stato aperto un altro libro, che è il libro della vita. Il libro della vita è Cristo. È allora che si rende manifesto a tutte le sue creature. E i morti venivano giudicati secondo ciò che era scritto nei libri, secondo le loro opere, cioè venivano giudicati secondo la Legge ed il Vangelo, secondo ciò che avevano operato o non fatto. E il mare restituì i suoi morti, cioè coloro che si trovarono vivi in questo mondo. E la Morte e l’Ade hanno restituito i loro morti, che sono i sepolti. E colui che non è stato trovato scritto nel Libro della Vita – cioè colui che non è giudicato vivo dal Signore – fu gettato nel lago di fuoco; questa è la seconda morte. Poi vidi un nuovo cielo ed una nuova terra, perché il cielo di prima e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c’era più. E vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, salire dal cielo, preparata da Dio, come una sposa adorna per il suo sposo (Ap XXI). Il nuovo cielo e la nuova terra si riferiscono ai Santi incorrotti. Gerusalemme è la schiera celeste dei Santi che si dice vengano con il Signore, si uniscano al loro Signore e rimangano con Lui per sempre. – E udii una voce dal trono che diceva: “Questa è la dimora di Dio con gli uomini, e tu porrai la tua casa in mezzo a loro, ed essi saranno il suo popolo, ed egli, Dio con loro, sarà il loro Dio”. Ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né il dolore, né il pianto, perché il vecchio mondo è passato.