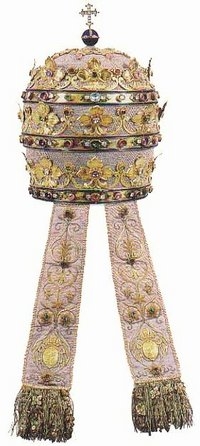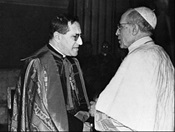TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (39b.)
HENRICUS DENZINGER
ET QUID FUNDITUS RETRACTAVIT AUXIT ORNAVIT
ADOLFUS SCHÖNMATZER S. J.
ENCHIRIDION SYMBOLORUM DEFINITIONUM ET DECLARATIONUM
De rebus fidei et morum
HERDER – ROMÆ – MCMLXXVI
Imprim.: Barcelona, José M. Guix, obispo auxiliar
(SAN PIO X – 1907 – 1914)
Decreto del Sant’Uffizio “Lamentabili”, 3 luglio 1907.
Errori dei modernisti
L’emancipazione dell’esegesi dal magistero della Chiesa
3401 1. La legge ecclesiastica che prescrive di sottoporre a censura preventiva i libri che trattano delle Sacre Scritture non si estende agli studiosi che fanno una critica scientifica o un’esegesi dei libri dell’Antico e del Nuovo Testamento.
3402 (2) L’interpretazione dei libri sacri da parte della Chiesa non è certo da disprezzare, ma è soggetta al giudizio e alla correzione più esatta degli esegeti.
3403 (3) Le sentenze e le censure ecclesiastiche contro l’esegesi libera e scientifica dimostrano che la fede proposta dalla Chiesa è in contraddizione con la storia e che i dogmi cattolici non sono realmente conciliabili con le origini più vere della religione cristiana.
3404 4 Il magistero della Chiesa non può decidere il significato autentico della Sacra Scrittura, nemmeno con definizioni dogmatiche.
3405 5 Poiché nel deposito della fede sono contenute solo verità rivelate, non spetta in alcun modo alla Chiesa giudicare le affermazioni delle discipline umane.
3406 (6) Nel definire le verità, la Chiesa insegnata e la Chiesa docente collaborano in modo tale che alla Chiesa docente non resta che sancire le concezioni comuni della Chiesa insegnata.
3407 (7) Quando la Chiesa proibisce gli errori, non può pretendere dai fedeli un assenso che li induca ad adottare la sentenza da essa emessa.
3408 (8) Coloro che ritengono prive di significato le condanne pronunciate dalla Sacra Congregazione dell’Indice o da altre Sacre Congregazioni Romane sono da considerarsi esenti da ogni colpa.
L’ispirazione o inerranza della Sacra Scrittura
3409 9. Coloro che credono che Dio sia veramente l’autore della Sacra Scrittura danno prova di eccessiva semplicità e ignoranza.
3410 10. L’ispirazione dei libri dell’Antico Testamento consiste nel fatto che gli scrittori di Israele hanno trasmesso le dottrine da un punto di vista che era poco o per nulla conosciuto dai pagani.
3411 11. L’ispirazione divina non si estende a tutta la Sacra Scrittura in modo tale da proteggere dall’errore ogni singola parte.
3412 12. Se l’esegeta vuole dedicarsi utilmente agli studi biblici, deve innanzitutto mettere da parte ogni opinione preconcetta sull’origine soprannaturale della Scrittura, e non interpretarla in modo diverso da altri documenti puramente umani.
3413 13. Le parabole evangeliche sono state organizzate ad arte dagli stessi evangelisti e dai cristiani di seconda e terza generazione, che hanno così potuto spiegare gli scarsi frutti della predicazione di Cristo agli ebrei.
3414 14. In molti casi, gli evangelisti non hanno riferito tanto ciò che è vero, quanto ciò che, pur essendo vero, non lo è.
false, che consideravano più redditizie per i loro lettori.
3415 15. I Vangeli furono arricchiti da continue aggiunte e correzioni fino alla costituzione definitiva del canone; da allora in poi rimase solo una traccia lieve e incerta della dottrina di Cristo.
3416 16. Le narrazioni di Giovanni non sono propriamente storia, ma contemplazione mistica del Vangelo; i discorsi contenuti in questo Vangelo sono meditazioni teologiche sul mistero della salvezza, prive di verità storica.
3417 17. Il Quarto Vangelo esagera i miracoli, non solo perché appaiano più straordinari, ma anche perché siano più capaci di significare l’opera e la gloria del Verbo incarnato.
3418 18. Giovanni afferma di essere stato il testimone di Cristo; in realtà, però, è solo un mirabile testimone della vita cristiana o della vita di Cristo nella Chiesa, alla fine del I secolo.
3419 19. Gli esegeti eterodossi hanno espresso il vero significato delle Scritture più fedelmente degli esegeti cattolici.
La concezione della Rivelazione e del dogma
3420 20. La Rivelazione non può essere altro che la presa di coscienza da parte dell’uomo della sua relazione con Dio.
3421 21. La Rivelazione, oggetto della fede cattolica, non è stata completata dagli apostoli.
3422 22. I dogmi che la Chiesa presenta come rivelati non sono verità cadute dal cielo, ma un’interpretazione di fatti religiosi a cui la mente umana è giunta con un laborioso sforzo.
3423 23. Ci può essere, e di fatto c’è stata, un’opposizione tra i fatti narrati nella Sacra Scrittura e i dogmi della Chiesa che si basano su di essi; così che i critici possono respingere come falsi fatti che la Chiesa ritiene molto certi.
3424 24. Non si può rimproverare all’esegeta di porre delle premesse da cui derivi che i dogmi sono storicamente falsi o dubbi, purché non neghi direttamente i dogmi stessi.
3425 25. L’assenso di fede si basa in ultima analisi su un insieme di probabilità.
3426 26. I dogmi di fede devono essere conservati solo in base al loro significato pratico, cioè come norma precettiva dell’azione, ma non come norma di fede.
3427 27. La divinità di Gesù Cristo non è dimostrata dai Vangeli, ma è un dogma che la coscienza cristiana ha dedotto dalla nozione di Messia.
3428 28. Gesù, quando esercitò il suo ministero, non parlò con l’intenzione di insegnare che era il Messia, e i suoi miracoli non avevano lo scopo di dimostrare che lo era.
3429 29. Il Cristo mostrato nella storia può essere considerato molto inferiore al Cristo oggetto della fede.
3430 30. In tutti i testi evangelici il termine “Figlio di Dio” è equivalente solo al termine “Messia”, ma non significa affatto che Cristo sia veramente e per natura il Figlio di Dio.
3431 31. La dottrina su Cristo data da Paolo, Giovanni e dai Concili di Nicea, Efeso e Calcedonia non è quella insegnata da Gesù, ma quella che la coscienza cristiana ha di Gesù.
3432 32. Il significato naturale dei testi evangelici non è conciliabile con ciò che i nostri teologi insegnano sulla coscienza e sulla conoscenza infallibile di Gesù Cristo.
3433 33. È evidente a chiunque non sia guidato da opinioni preconcette, sia che Gesù professò un errore sulla venuta del Messia, sia che la maggior parte della sua dottrina, contenuta nei Vangeli sinottici, è priva di autenticità.
3434 34. I critici non possono attribuire a Cristo una conoscenza assolutamente illimitata, a meno che non facciano una distinzione tra le due cose.
l’ipotesi, difficile da concepire storicamente e contraria al senso morale, che Cristo come uomo possedesse la conoscenza di Dio e che, tuttavia, non volesse comunicare la conoscenza di tante cose ai suoi discepoli e ai suoi posteri.
3435 35. Cristo non fu sempre consapevole della sua dignità messianica.
3436 36. La risurrezione del Salvatore non è propriamente un fatto di ordine storico, ma un fatto di ordine puramente soprannaturale, non dimostrato né dimostrabile, che la coscienza cristiana ha gradualmente derivato da altri dati.
3437 37. All’inizio, la fede nella risurrezione di Cristo non aveva tanto a che fare con il fatto della risurrezione stessa, quanto con la vita immortale di Cristo presso Dio.
3438 38. La dottrina della morte espiatoria di Cristo non è evangelica ma solo paolina.
I sacramenti.
3439 39. Le concezioni sull’origine dei sacramenti di cui erano impregnati i padri del Concilio di Trento, e che indubbiamente hanno influito sui loro canoni dogmatici, sono molto lontane da quelle che oggi sono giustamente sostenute da coloro che si dedicano alla ricerca storica sul cristianesimo.
3440 40. I sacramenti hanno avuto origine dal fatto che gli apostoli e i loro successori hanno interpretato un’idea e un’intenzione di Cristo sotto lo stimolo e l’impulso delle circostanze e degli eventi.
3441 41. I sacramenti hanno il solo scopo di ricordare alla mente degli uomini la presenza sempre benefica del Creatore.
3442 42. La comunità cristiana ha introdotto la necessità del Battesimo, adottandolo come rito necessario e associandovi gli obblighi della professione cristiana.
3443 43. La pratica di conferire il battesimo ai bambini è uno sviluppo disciplinare ed è una delle ragioni per cui il sacramento è stato diviso in due: battesimo e penitenza.
3444 44. Non c’è alcuna prova che il rito del sacramento della confermazione fosse usato dagli apostoli: la distinzione formale tra i due sacramenti, battesimo e confermazione, non appartiene affatto alla storia del cristianesimo primitivo.
3445 45. Non tutto ciò che Paolo racconta dell’istituzione dell’Eucaristia in 1 Cor 11, 23-25 deve essere inteso storicamente.
3446 46. Il concetto di peccatore riconciliato dall’autorità della Chiesa non esisteva nella Chiesa primitiva, ma la Chiesa si è abituata a questo concetto solo molto lentamente. Inoltre, anche dopo che la penitenza fu riconosciuta come istituzione della Chiesa, non fu chiamata sacramento, perché avrebbe dovuto essere considerata un sacramento infame.
3447 47. Le parole del Signore: “Ricevete lo Spirito Santo e se rimetterete i peccati, vi saranno rimessi; se invece li riterrete, vi saranno rimessi” (Gv 20, 22-23) non si riferiscono in alcun modo al sacramento della penitenza, nonostante quanto si siano compiaciuti di affermare i Padri di Trento.
3448 48. Giacomo, nell’epistola Giacomo 5,14-15 , non intende promulgare un sacramento di Cristo, ma raccomandare una pia consuetudine, e se per caso vede in questa consuetudine un mezzo di grazia, non lo intende con il rigore dei teologi che hanno fissato la nozione e il numero dei sacramenti.
3449 49. Quando la Cena del Signore cristiana assunse gradualmente il carattere di azione liturgica, coloro che erano abituati a presiederla acquisirono un carattere sacerdotale.
3450 50. Gli anziani, che avevano il compito di vegliare sulle assemblee dei cristiani, furono istituiti sacerdoti e vescovi dagli apostoli per garantire l’ordine reso necessario dalla crescita delle comunità, ma non per perpetuare in senso stretto la missione e il potere degli apostoli.
3451 51. Il matrimonio poteva diventare un sacramento della nuova legge solo tardivamente; perché il matrimonio fosse considerato un sacramento, doveva essere preceduto dal pieno sviluppo della dottrina della grazia e dei sacramenti.
La Costituzione della Chiesa
3452 52. Cristo era ben lontano dal pensare di costituire la Chiesa come una società destinata a durare per una lunga serie di secoli; al contrario, nella mente di Cristo il Regno dei cieli doveva arrivare presto, contemporaneamente alla fine del mondo.
3453 53. La costituzione organica della Chiesa non è immutabile, ma la società cristiana è soggetta a una perpetua evoluzione, proprio come la società umana.
3454 54. I dogmi, i sacramenti e la gerarchia, sia nella loro concezione che nella loro realtà, non sono che interpretazioni e sviluppi del pensiero cristiano che hanno sviluppato e perfezionato un piccolo germe nascosto nel Vangelo.
3455 55. Simon Pietro non sospettò mai che il primato nella Chiesa fosse stato affidato a lui.
3456 56. La Chiesa romana è diventata il capo di tutte le Chiese non per disposizione della Divina Provvidenza, ma per circostanze puramente politiche.
3457 57. La Chiesa è ostile al progresso delle scienze naturali e teologiche.
Il carattere immutabile delle verità religiose.
3458 58. La verità non è più immutabile dell’uomo stesso, poiché si sviluppa con lui, in lui e attraverso di lui.
3459 59. Cristo non ha insegnato un corpo definito di dottrina applicabile a tutti i tempi e a tutti gli uomini, ma ha dato inizio a un movimento religioso adatto o da adattare a diversi tempi e luoghi.
3460 60. La dottrina cristiana ai suoi inizi era ebraica, ma per successive evoluzioni divenne prima paolina, poi giovannea e infine ellenica e universale.
3461 61. Si può dire senza paradosso che nessun capitolo della Scrittura, dal primo capitolo della Genesi all’ultimo dell’Apocalisse, contiene una dottrina veramente identica a quella presentata dalla Chiesa sullo stesso argomento, e che per questo nessun capitolo della Scrittura ha lo stesso significato per il critico e per il teologo.
cristiani lo stesso significato che hanno per i cristiani di oggi.
3463 63. La Chiesa si dimostra incapace di difendere efficacemente la morale evangelica, perché è ostinatamente attaccata a dottrine immutabili che non possono essere conciliate con il progresso contemporaneo.
3464 64. Il progresso delle scienze richiede una riforma dei concetti della dottrina cristiana su Dio, la Creazione, la Rivelazione, la persona del Verbo incarnato e la Redenzione.
3465 65. Il cattolicesimo di oggi non può fare i conti con la vera scienza se non si trasforma in un cristianesimo non dogmatico, cioè in un protestantesimo ampio e liberale.
3466 66. Censura del Sommo Pontefice: “Sua Santità ha approvato e confermato il decreto degli eminenti padri, e ha ordinato che ognuna delle proposizioni sopra riportate sia ritenuta da tutti riprovevole e proscritta”.
Decreto della Sacra Congregazione del Concilio “Ne temere“, 2 agosto
1907.
Promessa di matrimonio e matrimonio
3468. Fidanzamento. I. È considerato valido e ha effetti canonici solo il fidanzamento contratto con atto scritto e firmato dalle parti e dal parroco o dall’Ordinario del luogo, oppure da almeno due testimoni. …
3469. Matrimonio. III. Sono validi solo i matrimoni contratti davanti al parroco o all’Ordinario del luogo, o a un sacerdote da essi delegato, e davanti ad almeno due testimoni. …
3470 VII. Quando c’è pericolo di morte e non è possibile che il parroco o l’Ordinario del luogo, o un sacerdote delegato da uno di loro, pacifichi la coscienza o, se necessario, legittimi i figli, il matrimonio può essere validamente e lecitamente contratto davanti a qualsiasi sacerdote del luogo o a un sacerdote da essi delegato
3471 VIII. Se in una regione non è possibile avere il parroco o l’Ordinario del luogo o un sacerdote da loro delegato davanti al quale celebrare il matrimonio, e questo stato di cose dura già da un mese, il matrimonio può essere validamente e lecitamente contratto se il consenso è formalmente dato dagli sposi davanti a due testimoni.
3472. XI – Par. 1. Le leggi precedenti vincolano tutti i battezzati nella Chiesa cattolica e i convertiti ad essa dall’eresia o dallo scisma (anche se successivamente l’hanno abbandonata) ogni volta che contraggono tra loro il fidanzamento o il matrimonio.
3473. Par. 2: Si applicano anche agli stessi cattolici di cui sopra se contraggono un fidanzamento o un matrimonio con non cattolici, battezzati o meno, anche dopo aver ottenuto la dispensa dall’impedimento della mescolanza di religione o della disparità di culto; a meno che per un determinato luogo o regione la Santa Sede non abbia stabilito diversamente.
3474. Par. 3 Se gli acattolici, battezzati o meno, stipulano un contratto tra di loro, non sono tenuti in nessun luogo a osservare la forma cattolica del fidanzamento e del matrimonio.
Lettera Enciclica “Pascendi dominici gregis”, 8 settembre 1907.
Dz 2071 Poiché è un artificio molto abile da parte dei modernisti (poiché essi sono giustamente chiamati così in generale) quello di non esporre le loro dottrine ordinate e raccolte insieme, ma come se fossero sparse e separate l’una dall’altra, in modo da sembrare molto vaghe e, per così dire, sconclusionate, Sebbene al contrario siano forti e costanti, è bene, venerabili fratelli, presentare prima queste stesse dottrine in un’unica visione e mostrare il nesso con cui si fondono l’una con l’altra, in modo da poter poi esaminare le cause degli errori e prescrivere i rimedi per rimuovere la calamità. . . . Ma, affinché si possa procedere con ordine in un argomento piuttosto astruso, occorre notare innanzitutto che ogni modernista svolge diversi ruoli e, per così dire, mescola in sé: (1) il filosofo, (11) il credente, (111) il teologo, (IV) lo storico, (V) il critico, (Vl) l’apologeta, (VII) il riformatore. Tutti questi ruoli deve distinguerli uno per uno, chi vuole capire bene il loro sistema e discernere gli antecedenti e le conseguenze delle loro dottrine.
3475. Dz 2072 [I] Ora, per cominciare dal filosofo, i modernisti pongono il fondamento della loro filosofia religiosa in quella dottrina che viene comunemente chiamata agnosticismo. Per forza di cose, dunque, la ragione umana è interamente limitata ai fenomeni, cioè alle cose che appaiono e all’apparenza con cui appaiono; non ha né il diritto né il potere di oltrepassare i limiti della stessa. Pertanto, non può elevarsi a Dio né riconoscere la sua esistenza, nemmeno attraverso le cose che si vedono. Da ciò si deduce che Dio non può in alcun modo essere direttamente oggetto di scienza e che, per quanto riguarda la storia, non deve essere considerato un soggetto storico. Questi, naturalmente, i modernisti li rifiutano completamente e li relegano all’intellettualismo, un sistema assurdo, a loro dire, e morto da tempo. Né li frena il fatto che la Chiesa abbia condannato molto apertamente questi errori portentosi, perché il Sinodo Vaticano ha così decretato: “Se qualcuno, eccetera” [cfr. n. 1806 s., 1812].
3476. Dz 2073 Ma in che modo i modernisti passano dall’agnosticismo, che consiste solo nella nescienza, all’ateismo scientifico e storico, che invece è interamente postulato nella negazione; così, per quale legge di ragionamento si passa dallo stato di ignoranza se Dio sia intervenuto o meno nella storia del genere umano, alla spiegazione della stessa storia, tralasciando del tutto Dio, come se non fosse realmente intervenuto, chi può ben saperlo. Tuttavia, questo è fisso e stabilito nelle loro menti, che la scienza così come la storia dovrebbero essere atee, nei cui limiti ci può essere posto solo per i fenomeni, Dio e tutto ciò che è divino sono completamente messi da parte.–Come risultato di questo insegnamento più assurdo vedremo presto chiaramente cosa si deve pensare riguardo alla persona più sacra di Cristo, ai misteri della sua vita e morte, e anche riguardo alla sua resurrezione e ascensione al cielo.
3477. Dz 2074 Ma questo agnosticismo va considerato solo come la parte negativa del sistema dei modernisti; la parte positiva consiste, come dicono, nell’immanenza vitale. La religione, sia essa naturale o soprannaturale, deve ammettere, come ogni fatto, una spiegazione. Ma la spiegazione, con la teologia naturale distrutta e l’approccio alla rivelazione sbarrato dal rifiuto degli argomenti di credibilità, con la totale rimozione di qualsiasi rivelazione esterna, è cercata invano al di fuori dell’uomo. Va quindi cercata all’interno dell’uomo stesso e, poiché la religione è una forma di vita, va trovata interamente all’interno della vita dell’uomo. Da qui si afferma il principio dell’Immanenza religiosa. Inoltre, di ogni fenomeno vitale, a cui si è appena detto che la religione appartiene, la prima attuazione, per così dire, va ricercata in una certa necessità o pulsione; ma, se parliamo più specificamente della vita, gli inizi sono da ricercare in una sorta di moto del cuore, che si chiama senso. Pertanto, poiché Dio è l’oggetto della religione, si deve assolutamente concludere che la fede, che è l’inizio e il fondamento di ogni religione, deve essere collocata in un qualche senso interiore, che ha il suo inizio in un bisogno del divino. Inoltre, questo bisogno del divino, poiché viene avvertito solo in certi ambienti particolari, non può di per sé appartenere al regno della coscienza, ma rimane nascosto all’inizio sotto la coscienza, o, come si dice con una parola presa in prestito dalla filosofia moderna, nella subcoscienza, dove, anch’essa, la sua radice rimane nascosta e inosservata.- Qualcuno forse chiederà in che modo questo bisogno del divino, che l’uomo stesso percepisce dentro di sé, si evolve infine in religione? A questo i modernisti rispondono: “La scienza e la storia sono comprese in un duplice confine: uno esterno, che è il mondo visibile; l’altro interno, che è la coscienza. Quando hanno raggiunto l’uno o l’altro, non possono procedere oltre, perché oltre questi confini c’è l’inconoscibile. In presenza di questo inconoscibile, sia che esso sia al di fuori dell’uomo e al di là del mondo percepibile della natura, sia che si celi nella subcoscienza, il bisogno del divino in un’anima incline alla religione, secondo i principi del fideismo, senza che il giudizio della mente lo anticipi, eccita un certo senso peculiare; ma questo senso ha la realtà divina stessa, non solo come oggetto, ma anche come causa intrinseca implicata in sé, e in qualche modo unisce l’uomo a Dio”. Questo senso, inoltre, è ciò che i modernisti chiamano con il nome di fede, ed è per loro l’inizio della religione.
3478. Dz 2075 Ma questa non è la fine del loro filosofare, o più correttamente del loro delirare. Perché in questo senso i modernisti non solo trovano la fede, ma insieme alla fede e nella fede stessa, come la intendono loro, affermano che c’è posto per la rivelazione. Perché qualcuno si chiederà se c’è bisogno di qualcosa di più per la rivelazione? Non dovremmo forse chiamare “rivelazione” quel senso religioso che appare nella coscienza, o almeno l’inizio della rivelazione; perché non Dio stesso, anche se in modo piuttosto confuso, si manifesta alle anime nello stesso senso religioso? Ma aggiungono: Poiché Dio è allo stesso tempo oggetto e causa della fede, quella rivelazione è ugualmente di Dio e da Dio, cioè ha Dio come Rivelatore e come Rivelato. Da qui, inoltre, Venerabili Fratelli, deriva quell’assurda affermazione dei modernisti, secondo cui ogni religione, secondo i suoi vari aspetti, deve essere chiamata naturale e anche soprannaturale. Da ciò deriva che coscienza e rivelazione hanno significati intercambiabili. Da qui la legge secondo cui la coscienza religiosa è tramandata come regola universale, da equiparare completamente alla rivelazione, alla quale tutti devono sottomettersi, anche il potere supremo nella Chiesa, sia che questa insegni o legiferi in materia sacra o disciplinare.
3479. Dz 2076 Tuttavia, in tutto questo processo da cui, secondo i modernisti, scaturiscono la fede e la rivelazione, c’è una cosa da notare in modo particolare, anzi di non poco conto per le sequenze storico-critiche che ne traggono. Infatti, l’inconoscibile di cui parlano non si presenta alla fede come qualcosa di semplice o di isolato, ma al contrario aderisce strettamente a qualche fenomeno che, pur appartenendo ai campi della scienza e della storia, in qualche modo va al di là di ogni logica, sia che si tratti di un fatto della natura che contiene in sé qualche segreto, sia che si tratti di un uomo il cui carattere, le cui azioni e le cui parole non sembrano conciliabili con le leggi ordinarie della storia. Allora la fede, attratta dall’inconoscibile che è unito al fenomeno, abbraccia l’intero fenomeno stesso e in qualche modo lo permea della propria vita. Da ciò derivano due cose: in primo luogo, una sorta di trasfigurazione del fenomeno per elevazione, cioè al di sopra delle sue condizioni reali, per cui la sua materia diventa più adatta a rivestirsi della forma del divino che la fede deve introdurre; in secondo luogo, una sorta di sfigurazione (possiamo chiamarla così) dello stesso fenomeno, derivante dal fatto che la fede gli attribuisce, quando è spogliato di tutte le aggiunte di luogo e di tempo, ciò che in realtà non possiede; e ciò avviene soprattutto quando si tratta di fenomeni del passato, e tanto più pienamente quanto più sono antichi. Da questa duplice fonte i modernisti ricavano nuovamente due canoni che, aggiunti a un altro già mutuato dall’agnosticismo, costituiscono i fondamenti della critica storica.
3480. L’argomento sarà illustrato con un esempio, e prendiamo questo esempio dalla persona di Cristo. Nella persona di Cristo, si dice, la scienza e la storia non incontrano altro che l’umano. Pertanto, in virtù del primo canone dedotto dall’agnosticismo, tutto ciò che ha un sapore divino deve essere cancellato dalla sua storia. Inoltre, in virtù del secondo canone, la persona storica di Cristo è stata trasfigurata dalla fede; pertanto, tutto ciò che la eleva al di sopra delle condizioni storiche deve essere eliminato da essa. Infine, in virtù del terzo canone, la stessa persona di Cristo è sfigurata dalla fede; pertanto, devono essere eliminate da essa le parole e le azioni, tutto ciò che, in una parola, non corrisponde minimamente al suo carattere, al suo stato, alla sua educazione, al luogo e al tempo in cui è vissuto. Un metodo di ragionamento davvero meraviglioso! Ma questa è la critica dei modernisti.
3481. Dz 2077 Pertanto, il senso religioso, che attraverso l’immanenza vitale emerge dai nascondigli della subcoscienza, è il germe di ogni religione e la spiegazione di tutto ciò che è stato o sarà in ogni religione. Tale senso, rozzo all’inizio e quasi informe, gradualmente e sotto l’influenza di quel misterioso principio da cui ha avuto origine, è maturato con il progresso della vita umana, di cui, come abbiamo detto, è una sorta di forma. Così, abbiamo l’origine di ogni religione, anche se soprannaturale; esse sono, ovviamente, semplici sviluppi del senso religioso. E nessuno pensi che la religione cattolica ne sia esclusa; anzi, è del tutto simile alle altre; perché è nata nella coscienza di Cristo, un uomo di natura sceltissima, di cui nessuno è mai stato o sarà simile, attraverso il processo di immanenza vitale. . . . [addotto dal can. 3 del Concilio Vaticano II sulla rivelazione; cfr. n. 1808].
3482. Dz 2078 Tuttavia, fino a questo punto, Venerabili Fratelli, non abbiamo scoperto alcun posto riservato all’intelletto. Ma anch’esso, secondo la dottrina dei modernisti, ha la sua parte nell’atto di fede. È bene notare poi in che modo. In quel senso, dicono, che abbiamo citato più volte, poiché si tratta di senso e non di conoscenza, Dio si presenta all’uomo, ma in modo così confuso e disordinato che viene distinto con difficoltà, o non viene distinto affatto, dal soggetto credente. È necessario, quindi, che questo senso sia illuminato da qualche luce, affinché Dio si distingua completamente e sia separato da esso. Ciò riguarda l’intelletto, la cui funzione è la riflessione e l’analisi, con cui l’uomo porta alla luce i fenomeni vitali che nascono dentro di lui e poi li rende noti con le parole. Da qui l’espressione comune dei modernisti, secondo cui l’uomo religioso deve pensare la sua fede. La mente poi, incontrando questo senso, riflette su di esso e lo lavora, come un pittore che schiarisce i contorni sbiaditi di un quadro per farlo emergere più chiaramente, perché essenzialmente così spiega uno dei maestri dei modernisti. Inoltre, in tale opera la mente opera in modo duplice: dapprima, con un atto naturale e spontaneo, presenta la questione in un giudizio semplice e popolare; ma poi, dopo la riflessione e l’approfondimento, o, come si dice, l’elaborazione del pensiero, esprime i suoi pensieri in giudizi secondari, derivati, certo, dal primo semplice, ma più precisi e distinti. Questi giudizi secondari, se vengono infine sanciti dal supremo magistero della Chiesa, costituiranno il dogma.
3483. Dz 2079 Così, dunque, nella dottrina dei modernisti siamo giunti a un capitolo importante, ossia l’origine del dogma e la natura interna del dogma. Essi, infatti, collocano l’origine del dogma in quelle formule primitive e semplici che, sotto un certo aspetto, sono necessarie per la fede; perché la rivelazione, per essere tale, richiede una chiara conoscenza di Dio nella coscienza. Ma il dogma stesso, sembrano affermare, è propriamente contenuto nelle formule secondarie… Inoltre, per accertare la sua natura dobbiamo indagare soprattutto quale rivelazione interviene tra le formule religiose e il senso religioso dell’anima. Ma questo lo capirà facilmente chi ritiene che tali formule non abbiano altro scopo che quello di fornire i mezzi con cui egli (il credente) può rendere conto della sua fede. Perciò sono a metà strada tra il credente e la sua fede; ma per quanto riguarda la fede, sono segni inadeguati del suo oggetto, di solito chiamati symbolæ; nel loro rapporto con il credente, sono semplici strumenti. –Quindi non si può assolutamente sostenere che contengano la verità in modo assoluto; infatti, in quanto simboli, sono immagini della verità, e quindi vanno adattati al senso religioso, in quanto questo si riferisce all’uomo; e in quanto strumenti sono veicoli della verità, e quindi vanno a loro volta adattati all’uomo, in quanto c’è un riferimento al senso religioso. Ma l’oggetto del senso religioso, in quanto contenuto nell’assoluto, ha infiniti aspetti di cui può apparire ora uno, ora un altro. Allo stesso modo, l’uomo che crede può servirsi di condizioni diverse. Di conseguenza, anche le formule che chiamiamo dogmi dovrebbero essere soggette alle stesse vicissitudini, e quindi modificabili. Così, dunque, si apre la strada all’evoluzione intrinseca del dogma… Sicuramente un accumulo infinito di sofismi, che rovinano e distruggono tutta la religione.
Dz 2080 Tuttavia, che il dogma non solo possa, ma debba essere evoluto e cambiato, lo affermano in modo frammentario anche i modernisti stessi, e ciò deriva chiaramente dai loro principi. Infatti, tra i punti principali della dottrina essi sostengono questo, che deducono dal principio dell’immanenza vitale, che le formule religiose, per essere veramente religiose e non solo speculazioni intellettuali, devono essere vive, e devono vivere la vita del senso religioso. Non si deve intendere così, come se queste formule, soprattutto se puramente immaginative, fossero inventate per il senso religioso; perché la loro origine non interessa, né il loro numero o la loro qualità, ma come segue: che il senso religioso, applicando qualche modifica, se necessario, le unisca a sé vitalmente. Naturalmente, in altre parole, è necessario che la formula primitiva sia accettata dal cuore e da esso sanzionata; allo stesso modo, è necessario che il lavoro con il quale le formule secondarie vengono prodotte sia sotto la guida del cuore. Perciò accade che queste formule, per essere vitali, debbano essere e rimanere adattate sia alla fede che al credente. Inoltre, poiché questo potere e la fortuna delle formule dogmatiche sono così instabili, non c’è da stupirsi che siano oggetto di scherno e disprezzo da parte dei modernisti, che non dicono nulla al contrario e non esaltano altro che il senso religioso e la vita religiosa. E così attaccano con grande coraggio la Chiesa come se si muovesse su un sentiero di errore, perché non distingue minimamente la forza religiosa e morale dal significato superficiale delle formule, e aggrappandosi con vana fatica e con grande tenacia a formule prive di significato, lascia che la religione stessa crolli.– Certo, “ciechi e capi dei ciechi” (Mt 15,14) sono coloro che, gonfiati dal nome orgoglioso di scienza, arrivano a un punto tale del loro delirio da pervertire il concetto eterno di verità e il vero senso della religione introducendo un nuovo sistema, “in cui per un esagerato e sfrenato desiderio di novità”, la verità non viene cercata dove certamente esiste, e trascurando le tradizioni sante e apostoliche, si adottano altre dottrine vuote, futili, incerte e non approvate dalla Chiesa, sulle quali gli uomini, nella loro estrema vanità, pensano che si fondi e si mantenga la verità stessa. ”* Questo è quanto, Venerabili Fratelli, per il modernista come filosofo.
3484. Dz 2081 [11] Ora, se avanzando verso il credente si vuole sapere come si distingue dal filosofo tra i modernisti, si deve osservare che, sebbene il filosofo ammetta la realtà del divino come oggetto di fede, tuttavia questa realtà non la trova da nessuna parte se non nel cuore del credente, poiché è oggetto di senso e di affermazione, e quindi non supera i confini dei fenomeni; Inoltre, se questa realtà esista di per sé al di fuori del senso e dell’affermazione, il filosofo passa oltre e trascura. Per il credente modernista, invece, è assodato e certo che la realtà del divino esiste sicuramente in sé, e non dipende certo dal credente. Ma se chiedete su cosa poggia l’affermazione del credente, vi risponderà: “Sull’esperienza personale di ogni uomo”: In questa affermazione, pur rompendo con i razionalisti, si allineano all’opinione dei protestanti e degli pseudomistici [cfr. n. 1273]. Infatti, essi spiegano l’argomento nel modo seguente: che in senso religioso si deve riconoscere una sorta di intuizione del cuore, con la quale l’uomo raggiunge direttamente la realtà di Dio, e ne trae una tale convinzione dell’esistenza di Dio e dell’azione di Dio sia all’interno che all’esterno dell’uomo, che supera di gran lunga ogni convinzione che si possa ricercare nella scienza. Essi stabiliscono, quindi, una vera esperienza, superiore a qualsiasi esperienza razionale. Se qualcuno, come i razionalisti, lo nega, si dice che ciò deriva dal fatto che non è disposto a stabilirsi nello stato morale richiesto per produrre l’esperienza. Inoltre, questa esperienza, quando qualcuno l’ha raggiunta, rende propriamente e realmente un credente. — Quanto siamo lontani dagli insegnamenti cattolici.
Dz 2082 Abbiamo già visto [cfr. n. 2072] tali falsificazioni condannate dal Concilio Vaticano II. Una volta ammessi questi errori, insieme ad altri già citati, esprimeremo di seguito quanto sia aperta la strada all’ateismo. Sarà bene notare subito che, a partire da questa dottrina dell’esperienza unita a un’altra del simbolismo, qualsiasi religione, nemmeno il paganesimo, deve essere ritenuta vera. Perché mai esperienze di questo tipo non dovrebbero verificarsi in qualsiasi religione? In effetti, più di una afferma che si sono verificate. Con quale diritto i modernisti negheranno la verità di un’esperienza affermata da un islamico e rivendicheranno la verità delle esperienze solo per i cattolici? In realtà, i modernisti non negano questo; anzi, alcuni in modo piuttosto oscuro, altri in modo molto aperto sostengono che tutte le religioni sono vere. Ma è evidente che non possono pensare diversamente. Su quale base, infatti, si sarebbe dovuta attribuire la falsità a qualsiasi religione secondo i loro precetti? Sicuramente o per la falsità del senso religioso o perché l’intelletto ha proposto una formula falsa. Ora, il senso religioso è sempre uno e identico, anche se a volte è più imperfetto; ma affinché la formula intellettuale sia vera, è sufficiente che risponda al senso religioso e al credente umano, qualunque sia il carattere della perspicacia di quest’ultimo. Nel conflitto tra religioni diverse, i modernisti potrebbero sostenere al massimo una cosa: che la religione cattolica, in quanto più viva, ha più verità; e anche che è più degna del nome di cristiana, in quanto corrisponde più pienamente alle origini del cristianesimo.
Dz 2083 C’è anche qualcos’altro in questa parte della loro dottrina, che è assolutamente in contrasto con la verità cattolica. Infatti, il precetto relativo all’esperienza viene applicato anche alla tradizione, che la Chiesa ha finora affermato, e la distrugge completamente. Infatti, i modernisti intendono la tradizione in questo modo: come una sorta di comunicazione ad altri di un’esperienza originale, attraverso la predicazione per mezzo della formula intellettuale. A questa formula, quindi, oltre alla forza rappresentativa, come dicono loro, attribuiscono una sorta di potere suggestivo, non solo per eccitare in chi crede il senso religioso, che forse sta diventando fiacco, e per ripristinare l’esperienza una volta acquisita, ma anche per far nascere in chi non crede ancora un senso religioso per la prima volta, e per produrre l’esperienza. In questo modo, inoltre, l’esperienza religiosa si diffonde ampiamente tra i popoli; e non solo tra quelli attuali, ma anche tra i posteri, sia attraverso i libri che attraverso la trasmissione orale da uno all’altro.-Ma questa comunicazione dell’esperienza a volte mette radici e fiorisce; a volte invecchia improvvisamente e muore. Inoltre, il fiorire è per i modernisti un argomento di verità, perché ritengono che la verità e la vita siano la stessa cosa. Quindi, possiamo dedurre ancora una volta che tutte le religioni, quante ne esistono, sono vere; altrimenti non sarebbero vive.
3485. Dz 2084 Ora che la nostra discussione è stata portata a questo punto, Venerabili Fratelli, abbiamo abbastanza e di più per considerare con precisione il rapporto che i modernisti stabiliscono tra la fede e la scienza; inoltre, anche la storia è da loro classificata sotto questo nome di scienza.–Anche in primo luogo, in effetti, si deve ritenere che l’oggetto-materia dell’una sia del tutto estraneo all’oggetto-materia dell’altra e separato da essa. La fede, infatti, guarda solo a ciò che la scienza ritiene inconoscibile a se stessa. Quindi a ciascuno spetta un compito diverso: la scienza si occupa di fenomeni in cui non c’è posto per la fede; la fede, invece, si occupa del divino, di cui la scienza è totalmente ignorante. Così, infine, si stabilisce che non ci può mai essere dissenso tra fede e scienza; perché se ognuna tiene il proprio posto, non potranno mai incontrarsi e quindi contraddirsi. Se per caso qualcuno obietta a ciò, adducendo che nella natura visibile si verificano alcune cose che riguardano anche la fede, come, ad esempio, la vita umana di Cristo, i modernisti lo negheranno. Infatti, sebbene queste cose siano classificate come fenomeni, tuttavia, nella misura in cui sono impregnate della vita della fede, e nel modo già menzionato sono state trasfigurate e sfigurate dalla fede [cfr. n. 2076], sono state strappate al mondo sensibile e trasferite nella materia del divino. Perciò, a chi chiederà se Cristo abbia compiuto veri miracoli e abbia realmente predetto il futuro; se sia veramente risorto dai morti e asceso al cielo, la scienza agnostica darà una negazione, la fede un’affermazione; eppure, in conseguenza di ciò, non ci sarà conflitto tra le due. Perché l’una, rivolgendosi ai filosofi da filosofo, cioè contemplando Cristo solo secondo la realtà storica, negherà; l’altra, parlando da credente con i credenti, vedendo la vita di Cristo come è rivissuta dalla fede e nella fede, affermerà.
3486. Dz 2085 Un grande errore, tuttavia, lo commette chi pensa di poter credere che fede e scienza non siano affatto soggette l’una all’altra. Infatti, per quanto riguarda la scienza, egli pensa in modo giusto e corretto; ma non è così per la fede, che si deve dire soggetta alla scienza non solo per uno, ma per tre motivi. Infatti, in primo luogo, dobbiamo osservare che in qualsiasi fatto religioso, tolta la realtà divina e qualunque sia l’esperienza che ne fa colui che crede, tutte le altre cose, soprattutto le formule religiose, non superano i confini dei fenomeni e quindi rientrano nella scienza. In ogni caso, si permetta al credente, se vuole, di uscire dal mondo, ma finché vi rimane, che gli piaccia o no, non sfuggirà mai alle leggi, alle osservazioni, ai giudizi della scienza e della storia.-Inoltre, anche se si dice che Dio è l’oggetto della sola fede, ciò va concesso per quanto riguarda la realtà divina, ma non per quanto riguarda l’idea di Dio. Perché questa è oggetto della scienza, che, mentre filosofeggia nell’ordine logico, come si dice, raggiunge anche ciò che è assoluto e ideale. Pertanto, la filosofia o la scienza hanno il diritto di conoscere l’idea di Dio e di indirizzarla nella sua evoluzione e, se qualcosa di estraneo vi entra, di correggerla. Da qui l’assioma dei modernisti: L’evoluzione religiosa deve essere conciliata con quella morale e intellettuale, cioè, come insegna chi segue come maestro, deve essere soggetta a loro… Alla fine accade che Dio non soffre la dualità al suo interno, e così il credente è spinto da una forza interiore ad armonizzare la fede con la scienza in modo tale da non essere mai in disaccordo con l’idea generale che la scienza espone sull’intero universo. In questo modo, dunque, la scienza è completamente svincolata dalla fede, mentre la fede, per quanto si proclami estranea alla scienza, è soggetta ad essa. Tutto ciò, Venerabili Fratelli, è contrario a quanto Pio IX, Nostro predecessore, ha insegnato: “È dovere della filosofia, nelle cose che riguardano la religione, non dominare ma servire, non prescrivere ciò che si deve credere, ma abbracciare ciò che si deve credere con ragionevole obbedienza, e non esaminare le profondità dei misteri di Dio, ma riverirli piamente e umilmente”. * I modernisti capovolgono completamente la questione; a questi si può applicare ciò che il Nostro predecessore, Gregorio IX, scrisse a proposito di alcuni teologi della sua epoca: “Alcuni tra voi, gonfiati come vesciche dallo spirito di vanità, si sforzano con la novità di oltrepassare i confini fissati dai Padri, stravolgendo il significato del testo sacro … all’insegnamento filosofico dei razionalisti, per fare sfoggio di scienza, senza alcun beneficio per i loro uditori. . . . Questi uomini, sviati da varie strane dottrine, riducono il capo alla coda e costringono la regina a servire l’ancella”.
Dz 2086 Questo sarà sicuramente chiaro a chi osserva come i modernisti agiscano in modo del tutto conforme a ciò che insegnano. Infatti, sembra che abbiano scritto e parlato molto in modo contrario, tanto che si potrebbe facilmente pensare che siano dubbiosi e incerti. Ma ciò avviene in modo deliberato e consigliato, cioè in accordo con l’opinione che essi hanno sulla reciproca esclusione di fede e scienza. Così nei loro libri troviamo alcune cose che un cattolico approva completamente, eppure, girando la pagina, alcune cose che si potrebbero pensare dettate da un razionalista. Così, quando scrivono la storia non menzionano la divinità di Cristo, ma quando predicano nelle chiese la professano con forza. Allo stesso modo, quando discutono di storia non fanno posto ai Concili e ai Padri, ma quando insegnano il catechismo si riferiscono ai primi e ai secondi con rispetto. Così pure separano l’esegesi teologica e pastorale da quella scientifica e storica. Allo stesso modo, sulla base del principio che la scienza non dipende in alcun modo dalla fede, quando trattano di filosofia, storia e critica, senza alcun particolare timore di seguire le orme di Lutero [cfr. n. 769], mostrano in ogni modo un disprezzo per i precetti cattolici, i Santi Padri, i Sinodi ecumenici e il magistero ecclesiastico; e se vengono criticati per questo, si lamentano di essere privati della loro libertà. Infine, professando che la fede deve essere sottomessa alla scienza, rimproverano la Chiesa in generale e apertamente, perché rifiuta risolutamente di assoggettare e accomodare i suoi insegnamenti alle opinioni della filosofia; ma essi, ripudiando la vecchia teologia a questo scopo, si sforzano di introdurre la nuova, che segue i deliri dei filosofi.
3487. Dz 2087 [III] Ecco ora, Venerabili Fratelli, che ci avviciniamo allo studio dei modernisti in campo teologico, un compito arduo, ma da svolgere brevemente. Si tratta, infatti, di conciliare la fede con la scienza, e questo solo sottoponendo l’una all’altra. In questo campo il teologo modernista si avvale degli stessi principi che abbiamo visto utilizzati dal filosofo, e li adatta al credente; intendiamo i principi dell’immanenza e del simbolismo. In questo modo, inoltre, realizza il compito più facilmente. Il filosofo ritiene certo che il principio della fede sia immanente; il credente aggiunge che questo principio è Dio; ed egli stesso (il teologo) conclude: Dio, dunque, è immanente nell’uomo. Da ciò deriva l’immanenza teologica. Ancora, per il filosofo è certo che le rappresentazioni dell’oggetto della fede sono solo simboliche; per il credente, allo stesso modo, è certo che l’oggetto della fede è Dio in sé; così il teologo deduce che le rappresentazioni della realtà divina sono simboliche. Da qui nasce il simbolismo teologico, sicuramente l’errore più grande, e quanto pernicioso sia ciascuno di essi sarà chiaro dall’esame delle conseguenze. Per parlare subito di simbolismo, poiché tali simboli sono simboli per quanto riguarda il loro oggetto, ma per quanto riguarda il credente sono strumenti, il credente deve innanzitutto stare in guardia, dicono, per evitare di aggrapparsi troppo alla formula, in quanto formula, ma deve farne uso solo per potersi aggrappare alla verità assoluta, che la formula allo stesso tempo scopre e copre, e si sforza di esprimere senza mai raggiungerla. Inoltre, aggiungono, tali formule devono essere applicate dal credente nella misura in cui lo aiutano; perché sono date come un aiuto, non come un ostacolo, con la piena stima che per rispetto sociale è dovuta alle formule che il magistero pubblico ha giudicato adatte a esprimere la coscienza comune, purché, naturalmente, lo stesso magistero non dichiari il contrario. Ma per quanto riguarda l’immanenza, cosa intendano veramente i modernisti è difficile da dimostrare, perché non tutti hanno la stessa opinione. Ci sono alcuni che sostengono a questo proposito che Dio che opera nell’uomo è più intimamente presente in lui di quanto l’uomo non lo sia in se stesso; il che, se ben inteso, non ha nulla da rimproverarsi. Altri, invece, affermano che l’azione di Dio è un tutt’uno con l’azione della natura, come l’azione della causa prima è un tutt’uno con quella della causa seconda, il che distrugge davvero l’ordine soprannaturale. Altri, infine, lo spiegano in modo tale da far sospettare un significato panteistico; eppure ciò coincide opportunamente con il resto delle loro dottrine.
Dz 2088 Ora a questo assioma dell’immanenza se ne aggiunge un altro che possiamo chiamare permanenza divina; questi due differiscono l’uno dall’altro più o meno come l’esperienza privata dall’esperienza trasmessa dalla tradizione. Un esempio illustrerà il punto, e prendiamolo dalla Chiesa e dai sacramenti. La Chiesa, dicono, e i sacramenti non sono assolutamente da credere come istituiti da Cristo stesso. Lo prevede l’agnosticismo, che non riconosce altro che l’umano in Cristo, la cui coscienza religiosa, come quella del resto degli uomini, si è formata gradualmente; lo prevede la legge dell’immanenza, che rifiuta le applicazioni esterne, per usare i loro termini; lo prevede anche la legge dell’evoluzione, che esige il tempo e una certa serie di circostanze unite ad esso, affinché i germi si evolvano; lo prevede, infine, la storia, che dimostra che tale è stato il corso delle cose. Tuttavia, si deve ritenere che la Chiesa e i sacramenti siano stati istituiti mediatamente da Cristo. Ma come? Tutte le coscienze cristiane, affermano, sono state in un certo senso virtualmente incluse nella coscienza di Cristo, come la pianta nel seme. Inoltre, poiché i germi vivono la vita del seme, si può dire che tutti i cristiani vivono la vita di Cristo. Ma la vita di Cristo secondo la fede è divina; così è anche la vita dei cristiani. Se, dunque, questa vita nel corso dei secoli ha dato origine alla Chiesa e ai sacramenti, giustamente si dirà che tale origine proviene da Cristo ed è divina. In questo modo, essi affermano completamente che anche le Sacre Scritture sono divine e che i dogmi sono divini. Una disposizione sicuramente breve, ma molto abbondante per chi professa che la scienza deve sempre essere obbedita, qualunque cosa essa ordini. Ognuno vedrà facilmente da sé l’applicazione di questi principi alle altre questioni che menzioneremo.
3488. Dz 2089 Fin qui abbiamo parlato dell’origine della fede e della sua natura. Ma dato che la fede ha molte appendici, soprattutto la Chiesa, il dogma, il culto e le devozioni, i Libri che chiamiamo “sacri”, dovremmo chiedere cosa insegnano i modernisti anche su questi. Prendendo come inizio il dogma, è già stato mostrato sopra quale sia la sua origine e la sua natura [n. 2079 s.]. Esso nasce da una sorta di impulso o di necessità, in virtù della quale colui che crede elabora il proprio pensiero affinché la propria coscienza e quella degli altri siano maggiormente chiarite. Questo lavoro consiste interamente nell’indagare e nel perfezionare la formula primitiva della mente, non in sé, secondo la spiegazione logica, ma secondo le circostanze, o vitalmente, come si dice, in un modo meno facilmente comprensibile. Perciò accade che intorno a quella formula nascano gradualmente alcune formule secondarie, come abbiamo già indicato [cfr. n. 2078]; queste poi riunite in un unico corpo, o in un unico edificio di fede, come rispondenti alla coscienza comune, sono chiamate dogmi. Da questo vanno ben distinte le dissertazioni dei teologi che, pur non vivendo la vita del dogma, non sono affatto inutili, non solo per armonizzare la religione con la scienza e per eliminare le divergenze tra di esse, ma anche per illuminare e proteggere la religione dall’esterno, forse anche come mezzo per preparare materiale per qualche nuovo dogma futuro.
3489. –Non sarebbe stato necessario parlare a lungo del culto, se non fossero rientrati in questo termine anche i sacramenti, sui quali gli errori dei modernisti sono più gravi. Essi affermano che il culto nasce da un duplice impulso o necessità; infatti, come abbiamo visto, nel loro sistema si dice che tutte le cose nascono da impulsi o necessità interiori. La prima necessità è quella di attribuire qualcosa di sensibile alla religione; la seconda è quella di esprimerla, cosa che sicuramente non può essere fatta senza una forma sensibile, o senza atti consacranti che chiamiamo sacramenti. Ma per i modernisti i sacramenti sono semplici simboli o segni, anche se non privi di efficacia. Per evidenziare questa efficacia, ricorrono all’esempio di alcune parole che si dice abbiano preso piede, poiché hanno concepito il potere di propagare certe idee che sono vigorose e scuotono soprattutto la mente. Come queste parole sono ordinate in relazione alle idee, così i sacramenti lo sono al senso religioso, niente di più. Certamente parlerebbero più chiaramente se affermassero che i sacramenti sono stati istituiti unicamente per alimentare la fede. Ma questo il Sinodo di Trento lo ha condannato: “Se qualcuno dice che questi sacramenti sono stati istituiti solo per alimentare la fede, sia anatema” [n. 848].
3490. Dz 2090 Abbiamo già accennato un po’ alla natura e all’origine dei Libri Sacri. Secondo i principi dei modernisti, si potrebbe benissimo descriverli come una raccolta di esperienze, non come quelle che si verificano in generale per tutti, ma straordinarie e distinte, che sono state vissute in ogni religione.- Esattamente così insegnano i modernisti sui nostri libri dell’Antico e del Nuovo Testamento. Tuttavia, in accordo con le loro stesse opinioni, notano con grande sagacia che, sebbene l’esperienza appartenga al presente, la si può assumere anche del passato e del futuro, in quanto naturalmente chi crede all’uno o all’altro vive il passato con il ricordo alla maniera del presente, o il futuro con l’anticipazione. Inoltre, questo spiega come i libri storici e apocalittici possano essere classificati tra i Libri Sacri. In questi Libri, dunque, Dio parla certamente attraverso il credente, ma, come dice la teologia dei modernisti, solo per immanenza e permanenza vitale.
3491. – Chiederemo: e l’ispirazione? Questa, rispondono, non si distingue affatto da quell’impulso, se non forse nella veemenza, con cui il credente è stimolato a rivelare la sua fede con la parola o lo scritto. Ciò che abbiamo nell’ispirazione poetica è simile; per questo un certo disse: “Dio è in noi, quando si agita ci infiamma”. * Inoltre, a proposito di questa ispirazione, i modernisti aggiungono che non c’è nulla nei Libri Sacri che sia privo di tale ispirazione. Quando affermano questo si sarebbe portati a ritenerli più ortodossi di alcuni che, in tempi più recenti, limitano in qualche modo l’ispirazione, come ad esempio quando introducono le cosiddette citazioni tacite. Ma queste sono solo parole e pretese da parte loro. Infatti, se giudichiamo la Bibbia secondo i precetti dell’agnosticismo, cioè come un’opera umana scritta da uomini per uomini, sebbene al teologo sia concesso il diritto di chiamarla divina per immanenza, come si può forzare l’ispirazione in essa? Ora, il modernista afferma sicuramente un’ispirazione generale dei Libri Sacri, ma non ammette alcuna ispirazione in senso cattolico.
3492. Dz 2091 Ciò che la scuola dei modernisti immagina sulla Chiesa offre un campo più ricco per la discussione: essi stabiliscono all’inizio che la Chiesa è nata da una duplice necessità: una in ogni credente, specialmente in colui che ha trovato un’esperienza originale e speciale, di comunicare la sua fede agli altri; l’altra, dopo che la fede si è comunicata tra molti, nella collettività di riunirsi in una società e di vegliare, aumentare e propagare il bene comune. Che cos’è dunque la Chiesa? È il frutto della coscienza collettiva, o dell’associazione di coscienze individuali che, in virtù della permanenza vitale, dipende da un primo credente, cioè, per i cattolici, da Cristo. Inoltre, ogni società ha bisogno di un’autorità direttrice, il cui compito è quello di orientare tutti gli associati verso il fine comune, di promuovere con prudenza gli elementi di coesione, che in una società religiosa sono soddisfatti dalla dottrina e dal culto. Da qui, la triplice autorità nella Chiesa cattolica: disciplinare, dogmatica, liturgica… Ora, la natura dell’autorità va desunta dalla sua origine; dalla sua natura, infatti, vanno ricercati i suoi diritti e i suoi doveri. Nelle epoche passate un errore comune era quello di ritenere che l’autorità venisse alla Chiesa dall’esterno, cioè immediatamente da Dio; quindi era giustamente ritenuta autocratica. Ma questa concezione è ormai obsoleta. Come si dice che la Chiesa sia nata dalla collettività delle coscienze, così l’autorità emana vitalmente dalla Chiesa stessa. L’autorità, quindi, proprio come la Chiesa, ha origine dalla coscienza religiosa, e quindi è soggetta alla stessa; e se rifiuta questa subordinazione, vira verso la tirannia. Inoltre, stiamo vivendo in un’epoca in cui il senso della libertà ha raggiunto il suo punto più alto. Nello Stato civile la coscienza pubblica ha introdotto il governo popolare. Ma la coscienza nell’uomo, così come la vita, è una sola. A meno che, quindi, l’autorità ecclesiastica non voglia eccitare e fomentare una guerra intestina nella coscienza degli uomini, ha l’obbligo di usare forme (di procedura) democratiche, tanto più per questo motivo, perché se non lo fa, minaccia la distruzione. Infatti, è sicuramente pazzo chi pensa che con il senso di libertà così come fiorisce ora possa mai verificarsi una recessione. Se fosse limitato e controllato con la forza, scoppierebbe più forte, con la distruzione della Chiesa e della religione. Questo pensano i modernisti, che di conseguenza sono molto occupati a escogitare modi per conciliare l’autorità della Chiesa con la libertà dei credenti.
Dz 2092 Ma la Chiesa non ha solo tra le mura della propria casa coloro con i quali dovrebbe intrattenere rapporti amichevoli, ma li ha anche fuori. La Chiesa, infatti, non occupa il mondo da sola; lo occupa anche altre società, con le quali necessariamente avvengono comunicazioni e contatti. Questi diritti, dunque, che sono i doveri della Chiesa nei confronti delle società civili, devono essere determinati, e non possono essere determinati altrimenti che in base alla natura della Chiesa stessa, come i modernisti ci hanno effettivamente descritto. Lì la discussione era incentrata sugli oggetti, qui sui fini. Così, come a causa dell’oggetto vediamo la fede e la scienza estranee l’una all’altra, così lo Stato e la Chiesa sono estranei l’uno all’altra a causa dei fini che perseguono; il primo persegue un fine temporale, la seconda un fine spirituale. Certo, un tempo era permesso subordinare il temporale allo spirituale; era permesso intavolare discussioni su questioni miste, in cui la Chiesa era tenuta come padrona e regina, poiché la Chiesa, ovviamente, era dichiarata istituita da Dio senza intermediari, in quanto è l’autore dell’ordine soprannaturale. Ma tutto questo è ripudiato dai filosofi e dagli storici. Lo Stato, dunque, deve essere dissociato dalla Chiesa, così come il cattolico dal cittadino. Pertanto, ogni cattolico, essendo anche cittadino, ha il diritto e il dovere, ignorando l’autorità della Chiesa, mettendo da parte i suoi desideri, i suoi consigli e i suoi precetti, sì, disprezzando i suoi rimproveri, di perseguire ciò che pensa sia favorevole al bene dello Stato. Prescrivere un modo di agire per un cittadino, con qualsiasi pretesto, è un abuso del potere ecclesiastico, da respingere con ogni mezzo… Naturalmente, Venerabili Fratelli, la fonte da cui scaturisce tutto questo è proprio quella che Pio Vl, Nostro predecessore, ha solennemente condannato [cfr. n. 1502 s.] nella Costituzione Apostolica Auctorem fidei.
Dz 2093 Ma alla scuola dei modernisti non basta che lo Stato sia separato dalla Chiesa. Infatti, come la fede, per quanto riguarda gli elementi fenomenici, come essi dicono, dovrebbe essere subordinata alla scienza, così negli affari temporali la Chiesa dovrebbe essere soggetta allo Stato. Questo, in verità, non lo dicono apertamente, ma a causa del loro pensiero sono costretti ad ammetterlo. Infatti, posto il principio che solo lo Stato ha potere nelle questioni temporali, se accade che il credente, non contento degli atti interni della religione, proceda ad atti esterni, come ad esempio l’amministrazione o la ricezione dei sacramenti, questi cadranno necessariamente sotto il dominio dello Stato. Che dire, allora, dell’autorità della Chiesa? Poiché questa non si esplica se non attraverso atti esterni, essa sarà interamente responsabile nei confronti dello Stato. Ovviamente costretti da questa conclusione, molti dei protestanti liberali rifiutano completamente ogni culto sacro esterno, anzi, persino ogni associazione religiosa esterna, e si sforzano di introdurre la religione individuale, come dicono loro. Ma se i modernisti non procedono ancora apertamente su questo punto, chiedono intanto che la Chiesa tenda di sua iniziativa nella direzione in cui essi stessi la spingono, e che si adatti alle forme dello Stato. Queste sono le loro idee sull’autorità disciplinare. D’altra parte, molto più cattive e perniciose sono le loro opinioni sul potere dottrinale e dogmatico. Sul magistero della Chiesa essi commentano, ad esempio, come segue: Una società religiosa non potrà mai essere veramente unitaria se la coscienza dei suoi membri non sarà una sola e la formula che essi usano una sola. Ma questa duplice unità richiede una sorta di mente comune il cui compito è quello di trovare e determinare la formula che meglio corrisponde alla coscienza comune; e questa mente deve avere un’autorità sufficiente per imporre alla comunità la formula che ha determinato Inoltre, in questa unione e fusione, per così dire, sia della mente che elabora la formula, sia del potere che la prescrive, i modernisti collocano la nozione di magistero della Chiesa. Poiché, dunque, il magistero nasce in qualche momento dalle coscienze individuali e ha come mandato il dovere pubblico a beneficio delle stesse coscienze, ne consegue necessariamente che il magistero dipende da queste, e quindi deve piegarsi alle forme popolari. Pertanto, vietare alle coscienze dei singoli di esprimere pubblicamente e apertamente gli impulsi che sentono; ostacolare la via della critica che spinge il dogma sulla strada delle necessarie evoluzioni, non è l’uso ma l’abuso del potere consentito per il bene pubblico. Allo stesso modo, nell’uso stesso del potere, si devono applicare misura e moderazione. Censurare e proscrivere qualsiasi libro senza che l’autore ne sia a conoscenza, senza permettere alcuna spiegazione, senza discutere, è sicuramente molto vicino alla tirannia.- Anche in questo caso, quindi, si deve trovare una via di mezzo per preservare i diritti allo stesso tempo dell’autorità e della libertà. Nel frattempo, il cattolico deve comportarsi in modo da proclamare pubblicamente il suo rigoroso rispetto per l’autorità, senza tuttavia mancare di obbedire alla propria mente.–In generale, essi prescrivono quanto segue per la Chiesa: poiché il fine del potere ecclesiastico riguarda solo lo spirituale, devono essere aboliti tutti gli ornamenti esterni, con i quali essa si adorna più magnificamente per gli occhi degli astanti. In questo modo si trascura completamente il fatto che la religione, pur riguardando le anime, non è confinata esclusivamente alle anime e che l’onore reso all’autorità spetta a Cristo come suo fondatore.
3493. Dz 2094 Inoltre, per completare l’intero argomento della fede e dei suoi vari rami, ci rimane, Venerabili Fratelli, di considerare infine i precetti dei modernisti sullo sviluppo di entrambi. – Ecco un principio generale: in una religione che vive nulla è senza cambiamento, e quindi ci deve essere cambiamento. Da qui si passa a quello che è essenzialmente il punto principale delle loro dottrine, cioè l’evoluzione. Il dogma, quindi, la Chiesa, il culto, i Libri che veneriamo come sacri, persino la fede stessa, a meno che non vogliamo che tutti questi siano impotenti, devono essere vincolati dalle leggi dell’evoluzione. Ciò non può apparire sorprendente, se si tiene presente ciò che i modernisti hanno insegnato su ciascuno di questi argomenti. Quindi, concessa la legge dell’evoluzione, abbiamo il modo di evolvere descritto dagli stessi modernisti. In primo luogo, per quanto riguarda la fede. La forma primitiva di fede, dicono, era rozza e comune a tutti gli uomini, poiché aveva origine nella natura umana e nella vita umana. L’evoluzione vitale ha contribuito al progresso; certo, non per la novità di forme aggiunte dall’esterno, ma per la crescente pervasione quotidiana del senso religioso nella coscienza. Inoltre, questo progresso si è realizzato in due modi: in primo luogo, in senso negativo, eliminando tutto ciò che è estraneo, come ad esempio ciò che può provenire dalla famiglia o dalla nazione; in secondo luogo, in senso positivo, grazie al perfezionamento intellettuale e morale dell’uomo, per cui la nozione del divino diventa più piena e più chiara, e il senso religioso più preciso. Le cause del progresso della fede sono le stesse che sono state utilizzate per spiegare le sue origini. Ma a queste vanno aggiunti alcuni uomini straordinari (che chiamiamo profeti, e di cui Cristo è il più importante), non solo perché portarono davanti a sé, nella loro vita e nelle loro opere, qualcosa di misterioso che la fede attribuiva alla divinità, ma anche perché incontrarono nuove esperienze mai avute prima, corrispondenti alle esigenze religiose del tempo di ciascuno.–Ma il progresso del dogma nasce soprattutto da questo, che gli impedimenti alla fede devono essere superati, i nemici devono essere vinti, le obiezioni devono essere confutate. A questo si aggiunge una lotta perpetua per penetrare più profondamente le cose che sono contenute nei misteri della fede. Così, per passare ad altri esempi, è accaduto nel caso di Cristo: in Lui quel qualcosa di divino che la fede ammetteva, si è lentamente e gradualmente ampliato, tanto che alla fine è stato ritenuto Dio. La necessità di adattarsi ai costumi e alle tradizioni del popolo ha contribuito in modo particolare all’evoluzione del culto; così come la necessità di utilizzare il potere di certi atti, acquisito con l’uso. Questo pensano riguardo a ciascuno di essi. Ma prima di procedere vorremmo che questa dottrina delle necessità o dei bisogni fosse ben annotata; perché, al di là di tutto quello che abbiamo visto, essa è, per così dire, la base e il fondamento di quel famoso metodo che essi chiamano storico.
Dz 2095 Per soffermarci ancora sulla dottrina dell’evoluzione, va notato soprattutto che, sebbene i bisogni o le necessità spingano all’evoluzione, tuttavia se guidata solo da questa, oltrepassando facilmente i confini della tradizione e separandosi così dal principio vitale primitivo, porterebbe alla rovina piuttosto che al progresso. Quindi, seguendo più completamente il pensiero dei modernisti, diremo che l’evoluzione nasce dal conflitto di due forze, una delle quali porta al progresso, l’altra trattiene alla conservazione. La forza conservatrice fiorisce nella Chiesa ed è contenuta nella tradizione. Anzi, l’autorità religiosa se ne serve; e lo fa sia di diritto, perché è nella natura dell’autorità custodire la tradizione, sia di fatto, perché l’autorità lontana dai cambiamenti della vita non è affatto o molto poco sollecitata dagli stimoli che spingono al progresso. Al contrario, la forza che attrae al progresso e risponde alle esigenze interiori, si nasconde e opera nelle coscienze degli individui, soprattutto di coloro che si avvicinano alla vita, come si suol dire, più da vicino e intimamente. Ecco qui, Venerabili Fratelli, che si fa strada la dottrina più perniciosa, che introduce nella Chiesa i membri del laicato come elementi di progresso… – Da una sorta di alleanza e di patto tra queste due forze, la conservatrice e la promotrice del progresso, cioè tra l’autorità e le coscienze degli individui, avvengono progressi e cambiamenti. Infatti, la coscienza degli individui, o di alcuni di essi, agisce sulla coscienza collettiva; ma quest’ultima agisce su coloro che hanno l’autorità, costringendoli a stipulare accordi e a rispettare il patto.–A seguito di ciò, inoltre, è facile capire perché i modernisti si meravigliano così tanto, quando si rendono conto di essere catturati o puniti. Ciò che per loro è una colpa, loro stessi lo considerano un dovere religioso da compiere. Nessuno meglio di loro conosce i bisogni delle coscienze, perché sono più a contatto con loro di quanto non lo sia l’autorità ecclesiastica. Pertanto, essi raccolgono tutti questi bisogni, per così dire, dentro di sé; e così sono tenuti al dovere di parlare e scrivere pubblicamente. Che l’autorità li rimproveri, se vuole; essi stessi sono sostenuti dalla coscienza del dovere e sanno per intima esperienza che non meritano critiche ma elogi. Di certo non sfugge loro che il progresso non si fa senza lotte, né le lotte senza vittime; perciò siano essi stessi vittime, come i profeti e Cristo. Poiché godono di cattiva fama, non guardano con sospetto l’autorità per questo motivo; ammettono persino che essa compie il suo dovere. Si lamentano solo di non essere ascoltati, perché così si ostacola il cammino delle anime; ma il momento di porre fine ai ritardi arriverà sicuramente, perché le leggi dell’evoluzione possono essere fermate, ma non possono assolutamente essere infrante. Perciò continuano sulla loro strada; continuano, anche se confutati e condannati, nascondendo la loro incredibile audacia con un velo di finta umiltà. In effetti, chinano la testa per finta, ma con le mani e con la mente portano avanti con coraggio ciò che hanno intrapreso. Inoltre, agiscono in modo del tutto volontario e consapevole, sia perché ritengono che l’autorità debba essere stimolata e non rovesciata, sia perché è una necessità per loro rimanere all’interno dell’ovile della Chiesa, per poter cambiare gradualmente la coscienza collettiva. Tuttavia, quando dicono questo, non fanno notare che confessano che la coscienza collettiva è a prescindere da loro, e quindi senza diritto si propongono come suoi interpreti. . . . [Ma dopo aver osservato il filosofo, il credente e il teologo tra i seguaci del modernismo, non ci resta che osservare allo stesso modo lo storico, il critico, l’apologeta e il riformatore.
3494. Dz 2096 [IV] Alcuni dei modernisti che si sono dedicati alla composizione della storia sembrano particolarmente preoccupati di non essere creduti filosofi; anzi, si professano del tutto privi di esperienza filosofica. Questo lo fanno con consumata astuzia, per evitare, ad esempio, che qualcuno pensi che siano imbevuti delle opinioni pregiudiziali della filosofia e che, per questo motivo, come dicono, non siano affatto obiettivi. la verità è che la loro storia o la loro critica è pura filosofia; e qualsiasi conclusione a cui sono arrivati, è derivata da un ragionamento corretto dai loro principi filosofici. I primi tre canoni di questi storici e critici, come abbiamo detto, sono gli stessi principi che abbiamo citato sopra a proposito dei filosofi: l’agnosticismo, il teorema della trasfigurazione delle cose per fede e un altro che, a quanto pare, potrebbe essere chiamato “sfigurazione”. Vediamo ora le conseguenze che ne derivano singolarmente.
3495. –Secondo l’agnosticismo, la storia, così come la scienza, si occupa solo di fenomeni. Pertanto, come Dio, così ogni intervento divino nelle vicende umane deve essere relegato alla fede, in quanto appartenente solo ad essa. Così, se si verifica qualcosa che consiste in un doppio elemento, divino e umano, come sono Cristo, la Chiesa, i sacramenti e molti altri di questo tipo, ci dovrà essere una divisione e una separazione, in modo che ciò che era umano possa essere assegnato alla storia e ciò che era divino alla fede. Così, la distinzione comune tra i modernisti tra il Cristo della storia e il Cristo della fede, la Chiesa della storia e la Chiesa della fede, i sacramenti della storia e i sacramenti della fede, e altre distinzioni simili in generale.
3496. –Allora si deve parlare di questo stesso elemento umano, che vediamo lo storico assumere per sé, come appare nei documenti, innalzato al di sopra delle condizioni storiche dalla fede attraverso la trasfigurazione. così, le aggiunte fatte dalla fede devono a loro volta essere dissociate, e relegate alla fede stessa, e alla storia della fede; così, quando si parla di Cristo, si deve dissociare tutto ciò che supera la condizione naturale dell’uomo, come mostra la psicologia, o che è stato innalzato fuori dal luogo e dal tempo in cui è vissuto.
3497. -Inoltre, in accordo con il terzo principio della filosofia, anche le cose che non escono dal campo della storia, le vedono per così dire al setaccio, eliminando tutto e relegando alla fede anche quelle che, a loro giudizio, non sono nella logica dei fatti o non sono adatte ai personaggi. Così non vogliono che Cristo abbia detto quelle cose che sembrano superare le capacità della moltitudine in ascolto. Perciò dalla sua storia reale cancellano e trasferiscono alla fede tutte le allegorie che si trovano nei suoi discorsi. Forse dovremmo chiederci in base a quale legge questi argomenti vengono dissociati? Dal carattere dell’uomo, dalla condizione di cui godeva nello Stato, dalla sua educazione, dal complesso degli incidenti di ogni fatto, in una parola, se capiamo bene, da una norma che infine a un certo punto si ritira nel meramente soggettivo. Essi mirano, naturalmente, ad assumere essi stessi il carattere di Cristo e, per così dire, a farlo proprio; tutto ciò che, in circostanze simili, avrebbero fatto loro, lo trasferiscono a Cristo.-Per concludere, a priori e secondo certi principi di filosofia che essi in verità detengono ma che professano di ignorare, affermano che Cristo, in quella che chiamano storia reale, non è Dio e non ha mai fatto nulla di divino; anzi, che ha fatto e detto come uomo ciò che essi stessi gli attribuiscono il diritto di fare e di dire, riportandosi ai suoi tempi.
3498. Dz 2097 [Inoltre, come la storia riceve le sue conclusioni dalla filosofia, così la critica prende le sue conclusioni dalla storia. Infatti il critico, seguendo le indicazioni fornite dallo storico, divide i documenti in due modi. Ciò che rimane dopo la triplice eliminazione appena menzionata lo assegna alla storia reale; il resto lo delega alla storia della fede o storia interna. Infatti, essi distinguono nettamente tra queste due storie; la storia della fede (e questo vogliamo che sia ben notato) la oppongono alla storia reale, in quanto reale. Così, come abbiamo già detto, i due Cristi: uno reale, l’altro, che non è mai stato di fatto, ma appartiene alla fede; uno che è vissuto in un certo luogo e in una certa epoca; un altro, che si trova solo nei pii commenti della fede; tale, per esempio, è il Cristo che il Vangelo di Giovanni presenta, che, secondo loro, non è altro che una meditazione.
Dz 2098 Ma il dominio della filosofia sulla storia non è finito con questo. Dopo che i documenti sono stati distribuiti in modo duplice, il filosofo si ripresenta con il suo dogma dell’immanenza vitale e dichiara che tutte le cose nella storia della Chiesa devono essere spiegate con l’emanazione vitale. Ma la causa o la condizione dell’emanazione vitale deve essere collocata in qualche necessità o bisogno; quindi, anche il fatto deve essere concepito dopo la necessità, e l’uno è storicamente posteriore all’altro. –Perché allora lo storico? Dopo aver esaminato nuovamente i documenti, sia quelli contenuti nei Libri Sacri che quelli introdotti altrove, ne ricava un indice delle esigenze particolari che riguardano non solo il dogma, ma anche la liturgia e altre questioni che hanno avuto un posto uno dopo l’altro nella Chiesa. Consegna l’indice così realizzato al critico. Ora egli (il critico) prende in mano i documenti che sono dedicati alla storia della fede, e li dispone età per età in modo che corrispondano uno per uno all’indice presentato, sempre tenendo presente il precetto che il fatto è preceduto dal bisogno, e il bisogno dal fatto. Certo, a volte può accadere che alcune parti della Bibbia, come ad esempio le epistole, siano il fatto stesso creato dal bisogno. Tuttavia, qualunque cosa sia, la legge è che l’età di un documento non può essere determinata altrimenti che dall’età di un bisogno che è sorto nella Chiesa.- Inoltre, bisogna distinguere tra l’origine di un fatto e lo sviluppo dello stesso, perché ciò che può nascere in un giorno, cresce solo con il passare del tempo. Per questo motivo il critico deve, come abbiamo detto, dividere nuovamente i documenti già distribuiti nei secoli, separando quelli che hanno a che fare con l’origine della cosa e quelli che riguardano il suo sviluppo, e deve a sua volta disporli per periodi.
Dz 2099 Poi c’è di nuovo posto per il filosofo, il quale impone allo storico di esercitare il suo zelo come prescrivono i precetti e le leggi dell’evoluzione. Quindi lo storico esamina di nuovo i documenti; esamina attentamente le circostanze e le condizioni che la Chiesa ha vissuto periodo dopo periodo: la sua forza conservatrice, le necessità interne ed esterne che l’hanno stimolata a progredire, gli ostacoli che le sono stati frapposti, in una parola, tutto ciò che aiuta a determinare come le leggi dell’evoluzione sono state mantenute. Infine, descrive la storia dello sviluppo, per così dire, a grandi linee. Il critico entra in scena e adatta il resto dei documenti. Si mette a scrivere. La storia è finita… Ora ci chiediamo: a chi si deve attribuire questa storia? Allo storico o al critico? Sicuramente a nessuno dei due, ma al filosofo. L’intera faccenda è portata avanti per apriorismo, anzi per un apriorismo che puzza di eresia. Sicuramente sono da compatire questi uomini, dei quali l’Apostolo avrebbe detto: “Diventano vani nei loro pensieri. … professandosi sapienti sono diventati stolti” (Rm 1,21-22); eppure ci fanno arrabbiare, quando accusano la Chiesa di confondere e cambiare i documenti in modo tale che possano testimoniare a suo vantaggio. Sicuramente accusano la Chiesa di ciò per cui si sentono apertamente condannati dalla loro stessa coscienza.
Dz 2100 Inoltre, come risultato di questa divisione e disposizione dei documenti per epoche, ne consegue naturalmente che i Libri Sacri non possono essere attribuiti a quegli autori a cui in realtà sono attribuiti. Per questo motivo i modernisti in genere non esitano ad affermare che quegli stessi libri, specialmente il Pentateuco e i primi tre Vangeli, dal breve resoconto originale sono cresciuti gradualmente con aggiunte, con interpolazioni, anzi, alla maniera di interpretazioni teologiche o allegoriche; o anche con l’interposizione di parti solo per unire brani diversi. Per dirla brevemente e più chiaramente, si deve certamente ammettere l’evoluzione vitale dei Libri Sacri, nata dall’evoluzione della fede e corrispondente alla stessa.–Infatti, aggiungono che le tracce di questa evoluzione sono così evidenti che la sua storia può quasi essere descritta. Anzi, la descrivono senza esitazione, tanto che si potrebbe credere di aver visto con i propri occhi gli stessi scrittori che, in ogni epoca, si sono dedicati all’ampliamento dei Libri Sacri. Inoltre, per sostenere queste azioni chiamano in aiuto una critica che chiamano testuale; e si sforzano di convincerci che questo o quel fatto o espressione non è al suo posto, e adducono altri argomenti del genere… Si direbbe infatti che abbiano prescritto per se stessi certi tipi, per così dire, di narrazioni e di discorsi, in seguito ai quali decidono con certezza ciò che sta al suo posto o in un posto sconosciuto… Chi vuole giudichi quanto possano essere abili a prendere decisioni in questo modo. Inoltre, chi li ascolta mentre parlano dei loro studi sui Libri Sacri, in seguito ai quali è stato loro concesso di scoprire tante cose impropriamente enunciate, quasi crederebbe che nessun uomo prima di loro abbia sfogliato le pagine di questi stessi libri; e che un numero quasi infinito di dottori non li abbia esaminati da ogni punto di vista, un gruppo chiaramente molto superiore a loro per mente, erudizione e santità di vita. Questi sapientissimi dottori, infatti, lungi dal trovare difetti nelle Sacre Scritture in ogni loro parte, anzi, più le esaminavano a fondo, più ringraziavano l’autorità divina per essersi degnata di parlare così con gli uomini. Ma, ahimè, i nostri dottori, per quanto riguarda i Libri Sacri, non si affidavano a quegli ausili su cui si basano i modernisti; quindi non avevano la filosofia come maestro e guida, né sceglievano se stessi come propria autorità nel prendere decisioni. Ora, dunque, ci sembra chiaro quale sia il metodo dei modernisti nel campo della storia. Il filosofo va avanti; lo storico gli succede; subito dopo, nell’ordine, opera la critica, sia interna che testuale. E poiché è caratteristica della causa prima comunicare il suo potere alle sue conseguenze, diventa evidente che tale critica non è affatto critica; che è giustamente chiamata agnostica, immanentista ed evoluzionista; e che quindi, chi la professa e la usa, professa gli errori impliciti nella stessa e si oppone alla dottrina cattolica.–Per questo motivo può sembrare molto strano che una critica di questo tipo abbia oggi un tale peso tra i cattolici. Ciò ha ovviamente una duplice causa: innanzitutto il patto con cui gli storici e i critici di questo tipo sono così strettamente uniti, mettendo in secondo piano le differenze di nazionalità e il dissenso delle religioni; poi l’infinita sfrontatezza con cui tutti, a una sola voce, esaltano ciò che ciascuno di loro blatera, attribuendolo al progresso della scienza; con cui, a stretto giro, attaccano colui che vuole esaminare la nuova meraviglia o la propria; con cui accusano di ignoranza colui che la nega, adornando di lodi colui che la abbraccia e la difende. Da questo potente dominio da parte di chi è nell’errore e da questa incurante adesione da parte delle anime volubili, deriva una corruzione dell’atmosfera circostante che penetra ovunque e diffonde la sua pestilenza.
3499. Dz 2101 [VI] Ma passiamo all’apologeta. Anche lui, tra i modernisti, dipende in modo duplice dal filosofo. Prima indirettamente, prendendo come materia la storia, scritta su dettatura del filosofo, come abbiamo visto; poi direttamente, avendo ottenuto da lui le sue dottrine e i suoi giudizi. Da qui quel precetto diffuso nella scuola dei modernisti secondo cui la nuova apologetica dovrebbe risolvere le controversie sulla religione con indagini storiche e psicologiche. Pertanto, l’apologeta modernista affronta il suo compito consigliando ai razionalisti di difendere la religione non con i Libri Sacri, né con la storia ampiamente utilizzata nella Chiesa, che è scritta alla vecchia maniera, ma con la vera storia composta da principi moderni e dal metodo moderno. E questo lo affermano non come se usassero un argumentum ad hominem, ma perché di fatto pensano che solo tale storia tramandi la verità. In effetti, non si preoccupano di affermare la loro sincerità in ciò che scrivono; sono già conosciuti tra i nazionalisti; sono già lodati per aver prestato servizio sotto la stessa bandiera; e su questa lode, che un vero cattolico rifiuterebbe, si congratulano con se stessi, e la sostengono contro i rimproveri della Chiesa.-Ma ora vediamo come procede uno di loro nelle sue scuse.
3500. Il fine che si prefigge di raggiungere è questo: conquistare alla fede una persona finora inesperta, affinché raggiunga questa esperienza della religione cattolica, che secondo i modernisti è l’unica base della fede. A questo scopo si aprono due vie: una oggettiva, l’altra soggettiva. La prima procede dall’agnosticismo e si sforza di mostrare che nella religione, soprattutto nella religione cattolica, c’è quella virtù vitale che persuade ogni psicologo e anche ogni storico di buona volontà che nella sua storia deve nascondersi qualcosa di ignoto. A tal fine è necessario dimostrare che la religione cattolica, così come esiste oggi, è esattamente quella che Cristo ha fondato, o che non è altro che lo sviluppo progressivo di quel germe che Cristo ha introdotto. Per prima cosa, quindi, bisogna stabilire di che natura sia questo germe. Questo, inoltre, vogliono dimostrare con la seguente formula: Il Cristo ha annunciato l’avvento del regno di Dio, che sarebbe stato instaurato a breve, e che Egli stesso ne sarebbe stato il Messia, cioè il fondatore e ordinatore divinamente dato. Poi bisogna mostrare in che modo questo germe, sempre immanente e permanente nella religione cattolica, si è evoluto gradualmente e secondo la storia, e si è adattato alle circostanze successive, prendendo da queste vitalmente qualsiasi forma dottrinale, culturale ed ecclesiastica fosse utile per lui, ma nel frattempo superando gli ostacoli che incontrava, disperdendo i suoi nemici e sopravvivendo a tutti gli attacchi e i combattimenti. Tuttavia, dopo che è stato dimostrato che tutti questi ostacoli, nemici, attacchi, combattimenti, e anche la vitalità e la fecondità della Chiesa sono stati di natura tale che, sebbene le leggi dell’evoluzione appaiano inalterate nella storia della Chiesa, tuttavia non saranno sviluppate appieno dalla stessa storia; l’ignoto si troverà di fronte ad essa e si presenterà da sé. In tutto questo ragionamento, però, non notano che la determinazione del germe primitivo è dovuta unicamente all’apriorismo del filosofo agnostico ed evoluzionista, e che il germe stesso è definito da loro in modo così gratuito da adattarsi al loro caso.
Dz 2102 Tuttavia, mentre con la recita di argomenti i nuovi apologeti lottano per proclamare e portare convinzione alla religione cattolica, di loro iniziativa ammettono e concedono che in essa ci sono molte cose che offendono. Con una sorta di malcelato piacere dichiarano persino ripetutamente e apertamente di trovare errori e contraddizioni anche nel campo del dogma; eppure aggiungono che questi non solo ammettono una scusa, ma, cosa che dovrebbe essere oggetto di meraviglia, che sono stati prodotti in modo giusto e legittimo. Così, anche secondo loro, molto dei Libri Sacri nel campo della scienza e della storia è affetto da errore. Ma essi affermano che qui non si tratta di scienza o storia, ma solo di religione e morale. Lì la scienza e la storia sono una sorta di copertura con cui si legano le esperienze religiose e morali, in modo che possano diffondersi più facilmente tra le masse; poiché, in effetti, le masse non lo capirebbero altrimenti, un tipo di scienza e di storia più perfetto non sarebbe stato un aiuto ma un danno per loro. Ma, aggiungono, i Libri Sacri, in quanto religiosi per natura, possiedono necessariamente la vita; ora, la vita ha anche una sua verità e una sua logica, ben diversa dalla verità razionale e dalla logica razionale, anzi di tutt’altro ordine, cioè la verità del confronto e della proporzione non solo in riferimento al mezzo (così essi stessi lo chiamano) in cui si vive, ma anche in riferimento al fine per cui si vive. Infine, procedono a tal punto che, abbandonando ogni freno, affermano che qualsiasi cosa si evolva attraverso la vita, è del tutto vera e legittima.-Ora noi, Venerabili Fratelli, per i quali esiste una sola, unica verità, e che consideriamo i Libri Sacri così, “che scritti sotto l’ispirazione dello Spirito Santo hanno Dio come autore” [cfr. n. 1787], dichiariamo che questo è lo stesso che dare la menzogna dell’utilità, o la menzogna offensiva a Dio stesso, e affermiamo con le parole di Sant’Agostino: “Una volta ammessa una qualche menzogna illecita contro un’autorità così elevata, non resterà in quei libri una clausola che, per quanto possa apparire a chiunque difficile da praticare o incredibile da credere, non sia riferita, secondo questa stessa regola perniciosa, al piano e allo scopo di un autore bugiardo”. * Perciò accadrà, come aggiunge lo stesso Santo Dottore: “In queste, cioè nelle Scritture, ognuno crederà ciò che vorrà; ciò che non vorrà, non crederà. “* Ma gli apologeti modernisti vanno avanti rapidamente. Ammettono anche che nei Libri Sacri si scoprono spesso ragionamenti che tentano di dimostrare una certa dottrina senza fondamento razionale, come quelli che si basano sulle profezie. E li difendono come una sorta di artificio per la predicazione, reso legittimo dalla vita. Che cosa c’è di più? Ammettono, anzi, affermano che Cristo stesso ha palesemente sbagliato nell’indicare il tempo della venuta del regno di Dio; e questo non dovrebbe sembrare strano, dicono, perché anche Lui era legato alle leggi della vita! E che dire dei dogmi della Chiesa? Anche questi abbondano di aperte contraddizioni; ma oltre al fatto che sono ammessi dalla logica vitale, non si oppongono alla verità simbolica; perché in questi si tratta di una questione di infinito, a cui appartengono infinite considerazioni. Infine, dimostrano e difendono tutto questo a tal punto da non esitare a professare che non c’è onore più nobile per l’Infinito che l’affermazione di contraddizioni su di Lui.-Ma quando una contraddizione è approvata, cosa non sarà approvato?
Dz 2103 Chi non crede ancora può essere disposto alla fede non solo con argomenti oggettivi ma anche soggettivi. A questo scopo gli apologeti modernisti tornano alla dottrina dell’immanenza. Si sforzano infatti di persuadere l’uomo che in lui, e nei recessi più reconditi della sua natura e della sua vita, si celano il desiderio e il bisogno di una qualche religione; non di una religione qualsiasi, ma di una religione come quella cattolica; perché questa, dicono, è assolutamente postulata dal perfetto sviluppo della vita. Qui, inoltre, dobbiamo ancora una volta lamentare con forza che tra i cattolici non mancano coloro che, pur rifiutando la dottrina dell’immanenza come dottrina, la utilizzano come metodo di apologia; e lo fanno in modo così incurante che sembrano ammettere nella natura umana non solo una capacità e un’idoneità all’ordine soprannaturale, come alcuni apologeti cattolici hanno sempre dimostrato entro i giusti limiti, ma un vero e proprio bisogno nel vero senso della parola.– Per essere più precisi, questa necessità della religione cattolica è introdotta dai modernisti che vogliono essere conosciuti come i più moderati. Infatti, coloro che possono essere chiamati integralisti desiderano che il germe sia dimostrato all’uomo che non crede ancora, come se fosse nascosto in lui, lo stesso germe che era nella coscienza di Cristo e che è stato trasmesso agli uomini da Lui. Così dunque, Venerabili Fratelli, riconosciamo il metodo apologetico dei modernisti, sommariamente descritto, come del tutto conforme alla loro dottrina; un metodo invero, come anche le dottrine, pieno di errori, non adatto a edificare, ma a distruggere, non a rendere cattolici, ma a trascinare i cattolici nell’eresia, sì, persino a sovvertire completamente ogni religione.
Dz 2104 [VII] Infine, occorre spendere qualche parola sul modernista come riformatore. Quanto abbiamo detto finora mostra abbondantemente quanto grande e acuto sia lo zelo per l’innovazione di questi uomini. Inoltre, questo zelo si estende a tutto ciò che esiste tra i cattolici. Vogliono riformare la filosofia, soprattutto nei seminari ecclesiastici, affinché, dopo aver relegato la filosofia scolastica nella storia della filosofia insieme agli altri sistemi obsoleti, si insegni ai giovani la filosofia moderna, che è l’unica vera e conforme alla nostra epoca.-Per riformare la teologia, desiderano che ciò che chiamiamo razionale abbia come base la filosofia moderna, ma pretendono che la teologia positiva sia basata soprattutto sulla storia del dogma.-Chiedono anche che la storia sia scritta e insegnata secondo il loro metodo e le loro prescrizioni moderne. I dogmi e la loro evoluzione, dichiarano, devono essere messi in armonia con la scienza e la storia. Per quanto riguarda la catechesi, chiedono che nel catechismo siano annotati solo i dogmi che sono stati riformati e che sono alla portata delle masse. Per quanto riguarda il culto, dicono che le devozioni esterne devono essere ridotte di numero e che si devono prendere provvedimenti per impedirne l’aumento, anche se alcuni che sono più favorevoli al simbolismo si mostrano più indulgenti su questo punto.-Gridano che il governo della Chiesa deve essere riformato sotto ogni aspetto, ma soprattutto dal punto di vista disciplinare e dogmatico. Così, sia all’interno che all’esterno, deve essere armonizzato con la coscienza moderna, come dicono, che tende interamente alla democrazia; così al clero inferiore e ai laici stessi devono essere assegnate parti appropriate nel governo, e quando l’autorità è stata unificata troppo e troppo centralizzata, deve essere dispersa.-Le congregazioni romane desiderano anche essere modificate nell’adempimento dei loro doveri sacri, ma soprattutto quello che è conosciuto come il Sant’Uffizio ed è anche chiamato l’Indice. Allo stesso modo, sostengono che l’azione dell’autorità ecclesiastica deve essere cambiata in campo politico e sociale, in modo che possa allo stesso tempo vivere in disparte dagli affari civili, ma adattarsi ad essi per impregnarli del suo spirito.–In campo morale adottano il principio degli americanisti, secondo cui le virtù attive devono essere anteposte a quelle passive, e devono essere messe in pratica. Desiderano che il clero sia preparato a praticare l’antica umiltà e povertà; inoltre, che nel pensiero e nell’azione si conformi ai precetti del modernismo.– Infine, ci sono alcuni che, dando retta alle parole dei loro maestri protestanti, desiderano l’eliminazione del santo celibato stesso dal sacerdozio… Che cosa, dunque, lasciano intatto nella Chiesa, che non debba essere riformato da loro o secondo i loro pronunciamenti?
Dz 2105 Nello spiegare tutta questa dottrina dei modernisti, Venerabili Fratelli, sembreremo ad alcuni, per caso, di aver indugiato troppo. Eppure era necessario farlo, sia perché, come di consueto, non fossimo accusati da loro di ignoranza dei loro principi, sia perché fosse chiaro che, quando si parla di modernismo, non si tratta di insegnamenti sparsi e non collegati tra loro, ma di un corpo unico e compatto, per così dire, in cui, se si ammette una cosa, il resto segue necessariamente. Così abbiamo fatto uso di ciò che equivale a un ragionamento didattico, e talvolta non abbiamo rifiutato le parole atroci che i modernisti hanno usato. – Ora, se guardiamo all’intero sistema con un solo sguardo, per così dire, nessuno si stupirà se lo definiamo come la sintesi di tutte le eresie. Di certo, se qualcuno si fosse proposto di riunire in un’unica soluzione la linfa e il sangue di tutti gli errori che sono esistiti sulla fede, nessuno avrebbe svolto il compito in modo più completo di quanto abbiano fatto i modernisti. Anzi, sono andati talmente oltre da distruggere non solo la religione cattolica, ma tutta la religione, come abbiamo già detto. Da qui il plauso dei razionalisti; per questo motivo quelli tra i razionalisti che parlano più liberamente e apertamente si congratulano per non aver trovato alleati più efficaci dei modernisti.
Dz 2106 Torniamo ora per un momento, Venerabili Fratelli, alla dottrina perniciosissima dell’agnosticismo. Con essa evidentemente, per quanto riguarda l’intelletto, si sbarra all’uomo ogni strada verso Dio, mentre si suppone che un approccio più adeguato sia aperto attraverso un certo senso dell’anima e dell’azione. Chi non vede quanto questo sia sbagliato? Perché il senso dell’anima è la risposta all’azione della cosa che l’intelletto e i sensi esterni hanno proposto. Se si toglie l’intelletto, l’uomo sarà portato a seguire i sensi esterni, nella cui direzione sta già procedendo. Anche questo è un male; perché eventuali fantasie del senso religioso non distruggeranno il senso comune; inoltre, il senso comune ci insegna che ogni turbamento o occupazione dell’anima non è un aiuto, ma piuttosto un ostacolo alla ricerca della verità, della verità, diciamo, così com’è in sé; perché quell’altra verità soggettiva, frutto del senso interno e dell’azione, se davvero è adatta al gioco, non contribuisce affatto all’uomo, la cui principale preoccupazione è sapere se al di fuori di sé c’è un Dio nelle cui mani un giorno cadrà.– Ma i modernisti introducono l’esperienza come aiuto per questo grande compito. Ma cosa aggiungerà questo al senso dell’anima? Niente di niente, se non renderlo più veemente e, come risultato di questa veemenza, rendere la sua convinzione della verità dell’oggetto proporzionalmente più forte. Ora, queste due cose non fanno sì che il senso dell’anima cessi di essere senso, né cambiano la sua natura, che è sempre suscettibile di inganno, a meno che non sia diretto dall’intelletto; ma piuttosto lo confermano e lo aiutano, perché quanto più intenso è il senso, a maggior ragione è senso.
Dz 2107 Ora, poiché stiamo trattando del senso religioso e dell’esperienza in esso contenuta, sapete bene, Venerabili Fratelli, quanto ci sia bisogno di prudenza in questa materia; così come quanta dottrina debba guidare la prudenza stessa. Lo sapete per la vostra esperienza con le anime, soprattutto con quelle in cui il senso è preminente; lo sapete per l’abitudine di leggere i libri che trattano di ascesi, le quali opere, pur essendo di scarso valore per i modernisti, presentano una dottrina molto più solida e più profonda per l’osservazione della saggezza di quella che essi si arrogano. In effetti, ci sembra una follia, o almeno una consumata imprudenza, ritenere vere senza indagini le esperienze intime che i modernisti raccomandano. Ma perché, per parlare sommariamente, se c’è tanta forza e valore in queste esperienze, non si dovrebbe attribuire lo stesso valore a quell’esperienza che molte migliaia di cattolici affermano di avere riguardo al sentiero errato su cui camminano i modernisti? Non è forse tutto falso e fallace? Ma la grande maggioranza degli uomini è fermamente convinta di questo, e lo sarà: che attraverso il solo senso e l’esperienza, senza la guida e la luce della mente, l’uomo non potrà mai raggiungere Dio. E così abbiamo di nuovo l’ateismo e nessuna religione.
Dz 2108 I modernisti non si ripromettono nulla di meglio proclamando la dottrina del simbolismo. Infatti, se tutti gli elementi intellettuali, come dicono, sono solo simboli di Dio, il nome stesso di Dio o della personalità divina non sarà forse un simbolo? E se così fosse, allora ci sarebbe la possibilità di dubitare della personalità divina e si aprirebbe la strada al panteismo. Inoltre, allo stesso modo, l’altra dottrina dell’immanenza divina porta al panteismo puro e semplice. Infatti, chiediamo questo: Questa immanenza distingue o no Dio dall’uomo? Se distingue, in che cosa differisce dalla dottrina cattolica o perché rifiuta la dottrina della rivelazione esterna? Se non distingue, abbiamo il panteismo. Ma questa immanenza dei modernisti sostiene e concede che ogni fenomeno di coscienza procede dall’uomo in quanto uomo. Quindi il buon ragionamento ne deduce che Dio e l’uomo sono una cosa sola; e così abbiamo il panteismo.
Dz 2109 In effetti, la distinzione che essi proclamano tra scienza e fede non ammette altra conclusione. Infatti, essi pongono l’oggetto della scienza nella realtà del conoscibile; l’oggetto della fede, al contrario, nella realtà dell’inconoscibile. Ora, l’inconoscibile è pienamente stabilito da questo, che tra l’oggetto materiale e l’intelletto non c’è proporzione, e questo difetto di proporzione non potrà mai essere rimosso, nemmeno nella dottrina dei modernisti. Pertanto, l’inconoscibile rimarrà sempre inconoscibile, sia per il credente che per il filosofo. Perciò, se avremo una religione, sarà quella di una realtà inconoscibile. Perché questa non possa essere anche l’anima dell’universo, come ammettono alcuni razionalisti, non lo vediamo di certo. Ma lasciamo che queste parole siano sufficienti per mostrare pienamente come la dottrina dei modernisti conduca per molteplici vie all’ateismo e alla distruzione di ogni religione. In effetti, l’errore dei Protestanti è stato il primo a percorrere questa strada; l’errore dei modernisti lo segue; l’ateismo sarà il passo successivo. [Dopo aver fissato le cause di questi errori – curiosità, orgoglio, ignoranza della vera filosofia – si stabiliscono alcune regole per il sostegno e l’organizzazione degli studi filosofici, teologici e profani, e per la scelta prudente degli insegnanti, ecc.].
Motu Proprio “Præstantia Scripturæ“, 18 novembre 1907.
L’autorità delle decisioni della Commissione biblica.
3503. (Ci sono alcuni che) non hanno ricevuto o non ricevono queste decisioni con l’obbedienza dovuta, anche se sono approvate dal Sommo Pontefice. Per questo motivo riteniamo necessario dichiarare e ordinare, come espressamente dichiariamo e ordiniamo, che tutti, senza eccezione, sono tenuti in coscienza a obbedire alle decisioni della Pontificia Commissione Biblica, sia a quelle emanate che a quelle che saranno emanate, allo stesso modo dei decreti delle Sacre Congregazioni che hanno a che fare con la dottrina e che sono stati approvati dal Sommo Pontefice; che tutti coloro che, con parole o scritti, attaccheranno queste decisioni non potranno evitare la nota della disobbedienza o della temerarietà, e graveranno la loro coscienza di una grave colpa, senza contare lo scandalo che potranno causare e le altre responsabilità in cui potranno incorrere davanti a Dio per le loro affermazioni diverse, avventate ed erronee, come spesso accade in queste materie.
Risposta della Commissione Biblica. 29 giugno 1908
Personaggio e autore del libro di Isaia.
3505. Domanda 1: Si può insegnare che le profezie che si leggono nel libro di Isaia – e in vari passi delle Sacre Scritture – non sono profezie propriamente dette, ma narrazioni composte dopo l’evento, o che, se si deve ammettere che certi fatti erano stati predetti prima dell’evento, il profeta non ha predetto questi eventi per una rivelazione soprannaturale di Dio, che conosce il futuro, ma per una congettura dedotta dagli eventi passati, in virtù di una felice sagacia e della naturale perspicacia della sua mente? Risposta: No.
3506. Domanda n. 2: L’opinione che Isaia e gli altri profeti abbiano predetto solo eventi imminenti o prossimi può essere conciliata con le profezie – specialmente quelle messianiche ed escatologiche – che questi stessi profeti hanno certamente formulato con molto anticipo, e con il comune sentire dei Santi Padri, i quali affermano che i profeti hanno predetto anche eventi che si sarebbero realizzati solo molti secoli dopo? Risposta: No
3507. Domanda 3: Possiamo ammettere che i profeti, non solo quando censuravano la depravazione umana e annunciavano la Parola divina in vista di coloro che li ascoltavano, ma anche quando annunciavano eventi futuri, dovevano sempre rivolgersi non ad ascoltatori futuri, ma ad ascoltatori attuali e in una situazione simile alla loro, per poter essere pienamente compresi da loro, e che, di conseguenza, la seconda parte del libro di Isaia (Is 40-66), in cui il profeta rivolge parole di consolazione, come se vivesse in mezzo a loro, non a ebrei nella stessa situazione di Isaia, ma a ebrei che gemono nell’esilio babilonese, non può avere come autore Isaia stesso, morto da tempo, ma deve essere attribuita a un profeta sconosciuto che condivideva l’esistenza degli esuli? Risposta: No.
3508 Domanda 4: L’argomento filologico, basato sulla lingua e sullo stile, in virtù del quale si contesta l’identità dell’autore del libro di Isaia, deve essere giudicato così forte da obbligare un uomo serio, ben preparato nella conoscenza del metodo critico e della lingua ebraica, ad ammettere una pluralità di autori per questo stesso libro? Risposta No.
3509 Domanda 5: Esistono argomenti solidi, anche presi collettivamente, per dimostrare che il libro di Isaia non deve essere attribuito al solo Isaia, ma a due o addirittura più autori? Risposta: No.
Risposta della Commissione Biblica, 30 giugno 1909.
Il carattere storico dei primi capitoli della Genesi
3512 Domanda 1: I vari sistemi esegetici che sono stati escogitati per escludere il significato storico letterale dei primi tre capitoli del libro della Genesi, e che sono stati difesi con il pretesto della scienza, si basano su solide fondamenta? Risposta: No.
3513 Domanda 2 : È possibile, nonostante il carattere e la forma storica del libro della Genesi, il particolare legame che esiste tra i primi tre capitoli e tra questi e i capitoli successivi, le molteplici testimonianze delle Scritture sia dell’Antico che del Nuovo Testamento, l’opinione quasi unanime dei Santi Padri e l’opinione tradizionale, trasmessa anche dal popolo israelita, che la Chiesa ha sempre sostenuto, ad insegnare che i tre capitoli suddetti della Genesi non contengono racconti di cose realmente accadute, cioè corrispondenti alla realtà oggettiva e alla verità storica, ma sono o favole prese in prestito dai miti e dalle cosmogonie dei popoli antichi e adattate dall’autore sacro alla dottrina monoteista dopo aver espurgato ogni errore politeista, o allegorie o simboli privi del fondamento della realtà oggettiva e che sono stati proposti sotto la veste della storia per inculcare verità religiose e filosofiche, o infine leggende, in parte storiche e in parte inventate, che sono state liberamente composte per l’istruzione e l’edificazione delle anime? Risposta: No per entrambe le parti.
3514 Domanda n. 3 : È possibile, in particolare, dubitare del senso storico letterale quando si tratta di fatti narrati in questi stessi capitoli che toccano il fondamento della religione cristiana, come, tra gli altri, la creazione di tutte le cose fatte da Dio all’inizio dei tempi; la creazione particolare dell’uomo; la formazione della prima donna dal primo uomo; l’unità del genere umano; la felicità originaria dei primi genitori nello stato di rettitudine, integrità e immortalità; il comandamento dato da Dio all’uomo per testare la sua obbedienza; la trasgressione del precetto divino, su istigazione del diavolo sotto forma di serpente; la caduta dei primi genitori da questo primitivo stato di innocenza; e la promessa del Redentore a venire? Risposta: No.
3515 Domanda 4: Nell’interpretare i passi di questi capitoli, che i Padri e i Dottori hanno inteso in modi diversi, senza trasmettere qualcosa.
hanno inteso in modi diversi senza trasmettere nulla di certo e definito, è lecito, essendo sicuro il giudizio della Chiesa e salvaguardata l’analogia della fede, seguire e difendere l’opinione che ciascuno, con prudenza, ha ritenuto giusta? Risposta: Sì.
3516 Domanda 5: Tutte le cose e ciascuna di esse, cioè le parole e le frasi, che compaiono nei capitoli sopra citati sono sempre e necessariamente da intendersi nel senso proprio, così che non è mai permesso discostarsene, anche quando risulta che i modi di dire sono stati usati in modo improprio, metaforico o analogico, e che la ragione vieta di attenersi al senso proprio o la necessità impone di abbandonarlo? Risposta: No.
3517. Domanda 6: Dato che il senso letterale e storico è presupposto, è possibile applicare, in modo saggio e utile, un’interpretazione allegorica e profetica di alcuni passi di questi stessi capitoli, secondo l’esempio luminoso dei santi Padri e della Chiesa stessa? Risposta: Sì.
3518. Domanda 7: Sebbene, nel comporre il primo capitolo della Genesi, l’intenzione dell’autore sacro non fosse quella di insegnare in modo scientifico la costituzione interna delle realtà visibili e l’ordine completo della creazione, ma piuttosto di trasmettere al suo popolo una conoscenza popolare quale il linguaggio comune dell’epoca consentiva, e che era adatta ai sensi e alle capacità degli uomini, dobbiamo, nell’interpretare queste cose, cercare esattamente e costantemente il carattere proprio del discorso scientifico? Risposta: No.
3519. Domanda 8: In questa designazione e distinzione dei sei giorni di cui si parla nel primo capitolo della Genesi, la parola yôm (giorno) può essere intesa sia in senso proprio, come giorno naturale, sia in senso improprio, come un certo lasso di tempo, ed è lecito discutere questa questione tra esegeti? Risposta: Sì.
Risposta della Commissione Biblica, 1 maggio 1910.
Autore e data di redazione dei Salmi.
3521. Domanda n. 1: Le denominazioni “Salmi di Davide”, “Inni di Davide”, “Libro dei Salmi di David”, “Salterio davidico”, che sono stati usati nelle antiche raccolte e nei primi concili per designare il libro dei centocinquanta Salmi dell’Antico Testamento, così come l’opinione di diversi Padri e Dottori che hanno sostenuto che tutti i Salmi del Salterio devono essere attribuiti al solo David, sono di tale importanza che David deve essere considerato come l’unico autore dell’intero Salterio? Risposta: No.
3522 Domanda 2: La concordanza tra il testo ebraico e il testo greco di Alessandria e di altre versioni antiche ci permette di affermare a ragion veduta che i titoli dei Salmi che precedono il testo ebraico sono più antichi della traduzione nota come LXX, e che di conseguenza provengono, se non direttamente dagli autori dei Salmi stessi, almeno da un’antica tradizione ebraica? Risposta: Sì.
3523 Domanda n. 3: Si può ragionevolmente dubitare dei titoli dei suddetti Salmi, testimoni della tradizione ebraica, quando non vi sono ragioni importanti contro la loro autenticità? Risposta: No.
3524 Domanda 4 : Se consideriamo le testimonianze della Sacra Scrittura, che non sono rare, sul talento naturale, illuminato dal dono benevolo dello Spirito Santo, che Davide aveva per la composizione di canti religiosi, sulle disposizioni da lui stabilite per il canto liturgico dei Salmi, sul fatto che i Salmi sono attribuiti a lui sia nell’Antico Testamento che nel Nuovo, e sui titoli che per lungo tempo sono stati posti davanti ai Salmi, Oltre all’accordo degli ebrei, dei Padri e dei Dottori della Chiesa, è ragionevolmente possibile negare che Davide sia l’autore principale dei canti del Salterio o, al contrario, affermare che solo un piccolo numero di canti debba essere attribuito a questo stesso cantore reale? Risposta: No per entrambe le parti.
3525. Domanda 5: È possibile, in particolare, negare l’origine davidica di quei Salmi che nell’Antico e nel Nuovo Testamento sono espressamente citati con il nome di Davide, e tra i quali dobbiamo menzionare in particolare il Salmo 2: “Perché questo turbamento delle nazioni?”. Salmo 2; Salmo 15: “Custodiscimi Signore” Salmo 15; Salmo 16: “Voglio amare te, Signore, mia forza” Salmo 17; Salmo 29: “Beati quelli a cui sono perdonate le iniquità” Salmo 30; Salmo 68: “Dio, salvami” Salmo 68; Salmo 109: “Il Signore dice al mio Signore”? Risposta: No.
3526. Domanda 6: È possibile ammettere l’opinione di coloro che affermano che tra i Salmi del Salterio ve ne sono alcuni il cui autore è Davide o altri e che, per motivi liturgici o musicali, per la fatica degli scribi o per altre ragioni, sono stati divisi in più o uniti in uno solo; e allo stesso modo che vi sono altri Salmi, come “Pietà di me Signore” Sal 50, che per adattarsi meglio alle circostanze storiche o alle festività del popolo ebraico, sono stati leggermente rimaneggiati o modificati, con la cancellazione o l’aggiunta di uno o più versetti, salvaguardando tuttavia l’ispirazione del testo sacro nel suo insieme? Risposta: Sì per entrambe le parti.
3527. È possibile sostenere come probabile l’opinione di quegli autori recenti che, basandosi solo su indizi interni o su un’interpretazione meno corretta del testo sacro, hanno cercato di dimostrare che un numero abbastanza elevato di Salmi è stato composto dopo i tempi di Esdra e Neemia, o addirittura al tempo dei Maccabei? Risposta: No.
3528. Domanda 8: Date le molteplici testimonianze dei libri sacri del Nuovo Testamento e l’accordo unanime dei Padri, o anche ciò che viene detto da autori del popolo ebraico, è necessario riconoscere diversi Salmi profetici e messianici che predicevano la venuta, il Regno, il sacerdozio, la Passione, la morte e la Risurrezione del Liberatore a venire; e per questo motivo dobbiamo respingere assolutamente l’opinione di coloro che mettono in dubbio il carattere profetico e messianico dei Salmi, e che limitano questi oracoli relativi a Cristo alla mera predizione del futuro destino del popolo eletto? Risposta: Sì per entrambe le parti.
Decreto della Sacra Congregazione per i Sacramenti “Quam singulari”, 8 agosto 1910.
Comunione e unzione degli infermi nei bambini
3530 I. L’età della discrezione per la confessione e per la Comunione è quella in cui il bambino comincia a ragionare, cioè verso i sette anni, o anche meno. Da questo momento inizia l’obbligo di osservare il duplice precetto della confessione e della comunione 812.
3531 II. La conoscenza piena e perfetta della dottrina cristiana non è necessaria per la prima confessione e la prima comunione. Il bambino, tuttavia, deve continuare ad apprendere l’intero catechismo gradualmente, secondo le capacità della sua intelligenza.
3532 III. La conoscenza della religione richiesta al bambino per prepararlo adeguatamente alla prima comunione è che egli comprenda, secondo le sue capacità, i misteri necessari della fede, che sono tanti mezzi, e che sappia distinguere il pane eucaristico dal pane ordinario e corporale, per accostarsi alla Santissima Eucaristia con la devozione che la sua età richiede.
3533 IV. L’obbligo del precetto della confessione e della comunione, che riguarda il bambino, ricade soprattutto su coloro che ne sono responsabili, cioè i genitori, il confessore, gli insegnanti e il parroco. Ma secondo il Catechismo Romano, spetta al padre o a chi lo sostituisce e al confessore ammettere il bambino alla Prima Comunione.
3534 VI. Coloro che hanno la responsabilità dei bambini abbiano cura di portarli frequentemente alla santa mensa dopo la Prima Comunione e, se possibile, anche ogni giorno, come desiderano Cristo Gesù e la nostra Madre Chiesa 3375-3383 e che lo facciano con la devozione adeguata alla loro età.
3535 VII. L’usanza di non ammettere alla confessione o di non assolvere mai i bambini che hanno raggiunto l’età della ragione è da riprovare assolutamente.
3536 VIII. È un abuso detestabile non dare il viatico e l’estrema unzione ai bambini che hanno raggiunto l’età della ragione e seppellirli secondo il rito dei neonati.
Motu proprio “Sacrorum antistitum”, 1° settembre 19l0
Giuramento antimodernista
3537. Io, N…, abbraccio e accolgo fermamente tutte le verità che sono state definite, affermate e dichiarate dal Magistero infallibile della Chiesa, specialmente quei capitoli di dottrina che si oppongono direttamente agli errori di questo tempo.
3538 In primo luogo, professo che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere certamente conosciuto, e quindi anche dimostrato alla luce naturale della ragione, “da ciò che è stato fatto” (Rm 1,20), cioè dalle opere visibili della creazione, come la causa dagli effetti.
3539. In secondo luogo, ammetto e riconosco le prove esterne della Rivelazione, cioè i fatti divini, in particolare i miracoli e le profezie, come segni molto certi dell’origine divina della religione cristiana, e ritengo che siano pienamente adatti alla comprensione di tutti gli uomini, anche di quelli di oggi.
3540. In terzo luogo, credo anche fermamente che la Chiesa, custode e maestra della Parola rivelata, sia stata istituita immediatamente e direttamente da Cristo in persona, vera e storica, quando viveva tra noi, e che sia stata edificata su Pietro, capo della gerarchia apostolica, e sui suoi successori per sempre.
3541. In quarto luogo, accetto sinceramente la dottrina della fede trasmessa dagli apostoli a noi sempre nello stesso senso e con la stessa interpretazione da parte dei padri ortodossi; per questo motivo, respingo assolutamente l’invenzione eretica dell’evoluzione dei dogmi, che passerebbe da un senso a un altro, diverso da quello professato per primo dalla Chiesa. Condanno anche qualsiasi errore che sostituisca al deposito divino rivelato, affidato alla Sposa di Cristo per custodirlo fedelmente, un’invenzione filosofica o una creazione della coscienza umana, formata a poco a poco dallo sforzo umano e che un progresso indefinito perfezionerebbe in futuro.
3542. In quinto luogo, ritengo e professo sinceramente che la fede non è un cieco sentimento religioso che emerge dalle tenebre del subconscio sotto la pressione del cuore e l’inclinazione della volontà moralmente informata, ma che è un vero assenso dell’intelligenza alla verità ricevuta dall’esterno, dall’udito, con la quale crediamo vero, per l’autorità di Dio che è sovranamente veritiero, ciò che è stato detto, attestato e rivelato dal Dio personale, nostro Creatore e nostro Signore.
3543. Mi sottometto anche, con la dovuta riverenza, e aderisco con tutto il cuore a tutte le condanne, le dichiarazioni e le prescrizioni che si trovano nell’enciclica Pascendi (3475-3500) e nel decreto Lamentabili 3401-3466, specialmente su quella che viene chiamata la storia dei dogmi.
3544. Allo stesso modo, respingo l’errore di coloro che affermano che la fede proposta dalla Chiesa può essere in contraddizione con la storia e che i dogmi cattolici, nel senso in cui sono intesi oggi, non possono essere conciliati con una conoscenza più esatta delle origini della religione cristiana.
3545. Condanno e respingo anche l’opinione di coloro che affermano che il cristiano erudito assume una doppia personalità, quella del credente e quella dello storico, come se fosse lecito per lo storico sostenere ciò che contraddice la fede del credente, o porre premesse da cui deriverebbe che i dogmi sono falsi o dubbi, purché questi dogmi non siano direttamente negati.
3546. Disapprovo anche il modo di giudicare e interpretare la Sacra Scrittura che, disdegnando la tradizionedella Chiesa, l’analogia della fede e le regole della Sede Apostolica, si aggrappa alle invenzioni dei razionalisti e adotta la critica testuale come unica e suprema regola, con tanto di squilibrio quanto di temerarietà.
3547. Respingo anche l’opinione di chi sostiene che l’insegnante di discipline storico-teologiche o l’autore che scrive su queste questioni debba innanzitutto mettere da parte qualsiasi opinione preconcetta, sia sull’origine soprannaturale della tradizione cattolica, sia sull’aiuto promesso da Dio per la conservazione eterna di ciascuna delle verità rivelate; in secondo luogo, che gli scritti di ciascuno dei Padri devono essere interpretati unicamente in base a principi scientifici, indipendentemente da qualsiasi autorità sacra, con la libertà critica consueta nello studio di qualsiasi documento secolare.
3548. Infine, in generale, dichiaro di non avere assolutamente nulla in comune con l’errore dei modernisti che ritengono che non ci sia nulla di divino nella tradizione sacra o, peggio ancora, che ammettono il divino in senso panteistico, per cui tutto ciò che rimane è un fatto puro e semplice, da porre sullo stesso piano dei fatti della storia: gli uomini con i loro sforzi, la loro abilità, il loro genio continuano, attraverso i secoli, l’insegnamento inaugurato da Cristo e dai suoi apostoli.
3549. Infine, tengo molto fermamente e terrò fino all’ultimo respiro la fede dei Padri nel carisma certo della verità che è, è stato e sarà sempre “nella successione dell’episcopato a partire dagli apostoli”, non perché si possa tenere ciò che sembra più adatto alla cultura di ogni epoca, ma perché “nessuno creda mai ad altro, né comprenda in altro modo la verità assoluta e immutabile predicata fin dall’inizio dagli apostoli”.
3550. Tutte queste cose prometto di osservarle fedelmente, completamente e sinceramente, e di mantenerle inviolabilmente, non allontanandomi mai da esse né nell’insegnamento né in alcun modo nella mia parola o nei miei scritti. Lo giuro, lo giuro. Che Dio mi aiuti e questi santi Vangeli.
Lettera “Ex quo, nono” ai delegati apostolici di Bisanzio, Grecia, Egitto, Mesopotamia, ecc., 26 dicembre 1910
Errori degli orientali
3553. In modo non meno avventato che falso, si apre la porta all’opinione che il dogma della processione dello Spirito Santo dal Figlio non provenga dalle parole stesse del Vangelo e che non sia confermato dagli antichi Padri.
3554. Allo stesso modo, si mette imprudentemente in dubbio che i sacri dogmi del Purgatorio e dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria siano stati riconosciuti dai santi uomini dei secoli precedenti;
3555. … a proposito della costituzione della Chiesa … innanzitutto si rinnova l’errore condannato da tempo dal nostro predecessore Innocenzo X 1999, che insinua che san Paolo sia da considerarsi un fratello uguale in tutto a san Pietro; – poi con non minore falsità si manifesta la convinzione che la Chiesa cattolica non fosse, nei primi secoli, il governo di una sola, cioè una monarchia; o che il primato della Chiesa romana non sia basato su validi argomenti.
3556. Ma anche la dottrina cattolica sul tema del santissimo sacramento dell’Eucaristia non viene lasciata intatta, quando si insegna senza mezzi termini che si potrebbe ammettere la concezione secondo cui presso i Greci le parole di consacrazione non hanno effetto se non viene pronunciata questa preghiera, che essi chiamano epiclesi, Eppure sappiamo che la Chiesa non ha il diritto di innovare in alcun modo sulla sostanza stessa dei sacramenti, e non è meno spiacevole che ritenga valida la cresima conferita da qualsiasi sacerdote 2522. (Censura: respinta come) errore grave.
Risposta della Commissione Biblica, 19 giugno 1911
Autore, data di composizione e verità storica del
Vangelo secondo Matteo.
3561. Domanda 1: In considerazione dell’accordo universale e costante di tutta la Chiesa fin dai primi secoli, che è chiaramente dimostrato dalle testimonianze esplicite dei Padri, dai titoli dei manoscritti dei Vangeli, dalle versioni più antiche delle Sacre Scritture, dai cataloghi trasmessi dai santi Padri, scrittori ecclesiastici, pontefici e concili, e infine dagli usi liturgici della Chiesa d’Oriente e d’Occidente, possiamo e dobbiamo affermare con certezza che Matteo, l’apostolo di Cristo, è davvero l’autore del Vangelo pubblicato con il suo nome? Risposta: Sì.
3562. Domanda 2: L’opinione che Matteo abbia preceduto gli altri evangelisti nella scrittura e che abbia composto il primo Vangelo pubblicato con il suo nome deve essere considerata sufficientemente fondata dalla Tradizione?
primo vangelo nella lingua madre allora usata dagli ebrei di Palestina ai quali quest’opera era destinata? Risposta: Sì, per entrambe le parti.
3563. Domanda 3: È possibile spostare la stesura di questo testo originale oltre il tempo della distruzione di Gerusalemme, in modo che le predizioni che vi si leggono riguardo a questa distruzione siano state scritte dopo l’evento; oppure la testimonianza di Ireneo, che di solito viene addotta, e la cui interpretazione è incerta e controversa, deve essere considerata di peso tale da obbligarci a respingere l’opinione di coloro che ritengono più conforme alla Tradizione che questa stesura sia avvenuta ancora prima dell’arrivo di Paolo in città? Risposta: No per entrambe le parti.
3564. Domanda 4: Possiamo almeno sostenere come probabile l’opinione di alcuni moderni secondo i quali il Vangelo di Matteo non sarebbe stato composto, nel senso proprio e ristretto del termine, il Vangelo così come ci è stato trasmesso, ma solo una raccolta di detti e parole di Cristo che un altro autore, anonimo, che essi fanno diventare il redattore stesso del Vangelo, avrebbe usato come fonti? Risposta: No.
3565. Domanda 5: Dato che tutti i Padri e gli scrittori ecclesiastici, e la Chiesa stessa fin dalle sue origini, hanno usato come canonico solo il testo greco del Vangelo conosciuto come Matteo – senza escludere coloro che hanno espressamente trasmesso che Matteo scriveva nella sua lingua naturale – si può dimostrare con certezza che nella sostanza il Vangelo greco è identico a quello scritto dallo stesso apostolo nella sua lingua madre? Risposta: Sì.
3566. Domanda 6: Dato che l’autore del primo Vangelo persegue uno scopo prevalentemente teologico e apologetico, cioè dimostrare agli ebrei che Gesù è il Messia annunciato dai profeti e nato dalla stirpe di Davide, e che, inoltre, nel modo in cui dispone i fatti e i detti che racconta e riporta, non segue sempre l’ordine cronologico, è lecito dedurre da ciò che essi non debbano essere riconosciuti come veri? Oppure possiamo anche affermare che i racconti delle azioni e delle parole di Gesù che leggiamo nel Vangelo hanno subito un cambiamento o un adattamento sotto l’influenza delle profezie dell’Antico Testamento e dello stato più evoluto della Chiesa, e che quindi non sono conformi alla verità storica? Risposta: No da entrambe le parti.
3567 Domanda 7: Le opinioni di coloro che mettono in dubbio l’autenticità storica dei primi due capitoli, in cui sono narrate la genealogia e l’infanzia di Cristo, e di alcune affermazioni di grande importanza dogmatica, come quelle sul primato di Pietro (Mt 16,17-19), sulla forma di battesimo trasmessa agli Apostoli con la missione universale di predicazione (Mt 28,19 ss.), devono essere considerate prive di un solido fondamento?
la forma di battesimo trasmessa agli, la professione di fede degli apostoli nella divinità di Cristo Mt 14,33, e altre affermazioni simili che sembrano essere affermate in modo particolare in Matteo? Risposta: Sì.
Risposta della Commissione Biblica, 26 giugno 1912.
I. Autore, data di composizione e verità storica dei Vangeli secondo Marco e Luca.
3568. Domanda 1: La chiara voce della Tradizione, che fin dalle origini della Chiesa è stata mirabilmente unanime e che è stata confermata da molteplici prove, cioè le testimonianze esplicite dei santi Padri e degli scrittori ecclesiastici, le citazioni e le allusioni che si trovano nei loro scritti, l’uso degli antichi eretici, le traduzioni dei libri del Nuovo Testamento, È possibile affermare con certezza che Marco, il discepolo e interprete di Pietro, e Luca, il medico, assistente e compagno di Paolo, sono realmente gli autori dei Vangeli loro rispettivamente attribuiti? Risposta: Sì.
3569. Domanda 2: Gli argomenti utilizzati da alcuni critici per dimostrare che gli ultimi dodici versetti del Vangelo di Marco Mc 16,9-20
non sono stati scritti da Marco, ma aggiunti da un’altra mano, sono tali da dare il diritto di affermare che non devono essere riconosciuti come ispirati e canonici; o almeno che dimostrano che Marco non è l’autore di questi versetti? Risposta: No, da entrambe le parti.
3570. Domanda 3: È ugualmente lecito dubitare dell’ispirazione e della canonicità dei racconti di Luca sull’infanzia di Cristo Lc 16,9-20 o sull’apparizione dell’angelo che consola Gesù e sul sudore di sangue Lc 22,43s; o si può almeno dimostrare con solidi argomenti – che piacevano agli antichi eretici e che piacciono anche ai critici più recenti – che questi racconti non fanno parte del Vangelo originale di Luca? Risposta: No per entrambe le parti.
3571. Domanda 4: I rarissimi e del tutto isolati documenti in cui il cantico del Magnificat (Lc 1,46-55) è attribuito non alla Beata Vergine Maria ma a Elisabetta, possono e devono prevalere in qualche modo contro la testimonianza concorde di quasi tutti i manoscritti, sia del testo originale greco che delle traduzioni, e contro l’interpretazione che il contesto richiede non meno del sentimento della Vergine stessa e della costante Tradizione della Chiesa? Risposta: No.
3572 Domanda 5: Per quanto riguarda l’ordine cronologico dei Vangeli, è lecito discostarsi dall’opinione corroborata dall’antichissima e costante testimonianza della Tradizione, che attesta che dopo Matteo, che fu il primo di tutti a comporre il suo Vangelo nella sua lingua madre, Marco scrisse il secondo e Luca il terzo; oppure l’opinione che il secondo e il terzo Vangelo siano stati composti prima della traduzione greca del primo Vangelo deve essere considerata contraria a questa opinione? Risposta: No per entrambe le parti.
3573. Domanda n. 6: La data di composizione dei Vangeli di Marco e Luca può essere posticipata fino alla distruzione di Gerusalemme; oppure, poiché in Luca la profezia del Signore sulla distruzione di questa città appare più precisa, si può sostenere che almeno il suo Vangelo sia stato composto dopo che l’assedio era già iniziato? Risposta: No per entrambe le parti.
3574. Domanda n. 7: Si deve affermare che il Vangelo di Luca precede il libro degli Atti degli Apostoli e che, poiché questo libro, composto dallo stesso Luca (At 1,1), fu terminato alla fine della cattività romana dell’Apostolo (At 28,30), il suo Vangelo non fu composto dopo questa data? Risposta: Sì.
3575. Domanda 8: Considerando sia le testimonianze della Tradizione sia le argomentazioni interne relative alle fonti utilizzate da ciascun evangelista nella composizione del Vangelo, è ragionevole mettere in dubbio l’opinione che Marco abbia scritto secondo la predicazione di Pietro e Luca secondo la predicazione di Paolo, affermando allo stesso tempo che questi evangelisti avevano anche altre fonti attendibili, orali o già scritte? Risposta: No.
3576. Domanda 9: Le parole e le azioni che sono raccontate esattamente e, per così dire, alla lettera da Marco secondo la predicazione di Pietro, e che sono presentate nel modo più sincero da Luca, che fin dall’inizio si è informato accuratamente su tutto da testimoni molto degni di fede, poiché essi stessi videro fin dall’inizio e furono servi del Verbo (Lc 1,2 s.), rivendicano giustamente per sé questa fede storica che la Chiesa ha sempre accordato loro; o, al contrario, queste stesse azioni e queste stesse parole devono essere considerate “così prive, almeno in parte, di verità storica, sia perché gli autori non furono testimoni oculari, sia perché non è raro trovare nei due evangelisti una mancanza di ordine e una differenza nel modo in cui sono stati scritti?
o perché, essendo venuti a scrivere più tardi, dovevano necessariamente riportare concezioni estranee al pensiero di Cristo e degli apostoli, o fatti già più o meno distorti dall’immaginazione del popolo, o infine perché, ciascuno secondo il proprio disegno, si sono lasciati guidare da idee dogmatiche preconcette? Risposta: Sì per la prima parte; no per la seconda.
II. La questione sinottica, ovvero le relazioni reciproche tra le prime tre parti.
3577. Domanda 1: Mantenendo eccetto ciò che, in conformità con quanto stabilito in precedenza, deve essere mantenuto eccetto – in particolare per quanto riguarda l’autenticità e l’integrità dei tre Vangeli di Matteo, Marco e Luca, l’identità sostanziale del Vangelo greco di Matteo con il suo originale primitivo, nonché l’ordine cronologico in cui sono stati scritti -, Date le numerose concezioni diverse e opposte degli autori, è lecito per gli esegeti discutere liberamente le somiglianze e le differenze tra i Vangeli, e ricorrere alle ipotesi della Tradizione scritta o orale, o della dipendenza di uno da quello o quelli precedenti? Risposta: Sì.
3578. Domanda n. 2: Coloro che, non basandosi su alcuna testimonianza della Tradizione o su alcuna prova storica, approvano senza esitazione l’ipotesi delle cosiddette “due fonti”, che tenta di spiegare la composizione del Vangelo greco di Matteo e del Vangelo di Luca basandosi soprattutto sulla loro dipendenza dal Vangelo di Marco e da una raccolta nota come Detti del Signore, devono essere considerati come sostenitori di ciò che è stato stabilito sopra, e possono quindi difenderla liberamente? Risposta: No per entrambe le parti.
Risposta della Commissione Biblica, 12 giugno 1913.
I. Autore, data di composizione e verità storica degli Atti degli Apostoli.
3581. Domanda n. 1: Considerando soprattutto la Tradizione della Chiesa universale che risale ai primi scrittori ecclesiastici, e tenendo conto delle caratteristiche interne del libro degli Atti
considerato sia in sé che in relazione al terzo Vangelo, soprattutto per quanto riguarda l’affinità e la reciproca connessione dei due prologhi Lc 1,1-4 Ac 1,1-5
È certo che il libro intitolato Atti degli Apostoli, o “Praxeis Apostolon”, sia stato scritto dall’evangelista Luca? Risposta: Sì.
3582. Domanda n. 2: Possono gli argomenti critici, suggeriti dal linguaggio e dallo stile e dalla forma della narrazione, nonché dall’unità di scopo e di dottrina, dimostrare che il libro degli Atti deve essere attribuito a un unico autore e che, di conseguenza, l’opinione dei critici recenti secondo cui Luca non è l’unico autore di questo libro, ma che devono essere riconosciuti diversi autori distinti in questo scritto, è priva di fondamento? Risposta: Sì su entrambi i punti.
3583. Domanda 3: In particolare, le principali pericopi degli Atti, in cui il discorso in terza persona viene abbandonato a favore della prima persona plurale (Wir-Stücke), invalidano l’unità di composizione e l’autenticità degli Atti? O dovremmo piuttosto dire che, considerati storicamente e filologicamente, la confermano? Risposta: No sul primo punto; sì sul secondo.
3584. Domanda 4: Dal fatto che il libro stesso, dopo un rapido accenno ai due anni della prima prigionia di Paolo a Roma, si chiuda bruscamente, abbiamo il diritto di concludere che l’autore scrisse un altro volume, ora perduto, o che intendesse scriverlo, e possiamo quindi posticipare la data di composizione del libro degli Atti a molto tempo dopo questa prigionia; o piuttosto dobbiamo legittimamente e giustamente dedurre che l’Apostolo Luca terminasse il suo lavoro negli ultimi giorni della prima prigionia di Paolo a Roma? Risposta: No sul primo punto; sì sul secondo.
3585. Questione 5: Se consideriamo allo stesso tempo i frequenti e facili rapporti che Luca ebbe certamente con i primi e principali fondatori della Chiesa di Palestina, e anche con Paolo, l’apostolo delle genti, con il quale fu collaboratore nella predicazione del Vangelo e compagno di viaggio; la sua abituale sagacia e la cura con cui cerca testimoni e vede le cose con i propri occhi; e infine la frequentissima, evidente e mirabile concordanza del libro degli Atti con le epistole di Paolo e con i più veritieri monumenti della storia, dobbiamo dare per scontato che Luca abbia avuto tra le mani fonti assolutamente attendibili, che le abbia utilizzate con cura, probità e fedeltà, e che quindi possa a buon diritto rivendicare la piena autorità storica? Risposta: Sì.
3586. Domanda 6: Per quanto riguarda le difficoltà che di solito vengono sollevate qua e là, a causa dei miracoli raccontati da Luca, o di certi discorsi che, riportati sotto forma di riassunti, passano per appropriati alle circostanze, o di certi passaggi che sono almeno apparentemente in contrasto con la storia secolare o biblica; o infine di certi racconti che sembrano contraddire l’autore stesso degli Atti o altri scrittori biblici, sono di natura tale da mettere in dubbio l’autorità storica degli Atti o almeno da sminuirla in qualche modo? Risposta: No.
II L’autore, l’integrità e la data di composizione delle Epistole pastorali dell’Apostolo Paolo
3587. Domanda 1: Se consideriamo la Tradizione ecclesiastica, che fin dall’inizio si afferma ovunque e con fermezza, come testimoniano in molti modi gli antichi monumenti ecclesiastici, dobbiamo ritenere certo che le cosiddette epistole pastorali, cioè le due a Timoteo e l’epistola a Tito, nonostante l’audacia di alcuni eretici che, ritenendole contrarie al loro insegnamento, le hanno cancellate, senza darne alcuna motivazione, dal numero delle epistole paoline, siano state scritte dallo stesso apostolo Paolo e siano sempre state annoverate tra le epistole autentiche e canoniche? Risposta: Sì.
3588. Domanda 2: La cosiddetta ipotesi dei frammenti, introdotta e proposta in varie forme da alcuni critici contemporanei che, peraltro, senza alcuna ragione plausibile, e anche contraddicendosi tra loro, sostengono che le Epistole pastorali siano state formate in un secondo momento, da autori ignoti, da frammenti di epistole o da epistole paoline perdute e notevolmente ampliate, può in qualche modo invalidare la precisa e saldissima testimonianza della Tradizione? Risposta: No.
3589. Domanda n. 3: Le difficoltà che di solito vengono sollevate, sia per lo stile e il linguaggio dell’autore, sia per gli errori, soprattutto degli gnostici, descritti all’epoca come serpenti che si insinuano, sia per lo stato della gerarchia ecclesiastica che si supponeva già sviluppata, e altre obiezioni dello stesso tipo, invalidano in qualche modo la tesi che ritiene accertata e certa l’autenticità delle Lettere pastorali? Risposta: No.
3590. Domanda 4: Dato che gli argomenti storici e la Tradizione ecclesiastica, in conformità con le testimonianze dei Padri d’Oriente e d’Occidente, nonché le prove facilmente ricavabili sia dalla brusca conclusione del libro degli Atti, sia dalle epistole paoline composte a Roma, principalmente la seconda a Timoteo, ci obbligano a ritenere certa la doppia prigionia dell’apostolo Paolo a Roma, possiamo affermare con certezza che le Epistole pastorali sono state scritte tra la fine dell’Impero romano e la fine dell’Impero romano?
prigionia e la morte dell’apostolo? Risposta: Sì.
Risposta della Commissione Biblica, 24 giugno 1914.
Autore e data di composizione dell’epistola agli Ebrei.
3591. Domanda 1: È necessario attribuire una tale forza ai dubbi che fin dai primi secoli, dovuti soprattutto all’abuso degli eretici, abitavano le menti di alcuni in Occidente circa l’ispirazione divina e l’origine paolina dell’epistola agli Ebrei che, tenendo conto della continua, unanime e costante affermazione dei Padri orientali a cui si unì, dopo il IV secolo, il pieno assenso di tutta la Chiesa d’Occidente; e considerando anche gli atti dei sovrani pontefici e dei santi concili, in particolare quello di Trento, nonché l’uso perpetuo delle Chiese, è lecito esitare non solo ad annoverarla tra le epistole canoniche – che è stata definita per fede – ma anche ad annoverarla con certezza tra le epistole autentiche dell’apostolo Paolo? Risposta: No.
3592. Domanda 2: Gli argomenti che di solito si traggono dall’insolita assenza del nome di Paolo e dall’omissione del consueto esordium e saluto nell’epistola agli Ebrei, o dalla purezza della lingua greca, dall’eleganza e perfezione dell’espressione e dello stile, o dal modo in cui viene citato e argomentato l’Antico Testamento, o da certe differenze che si dice esistano tra la dottrina di questa epistola e quella delle altre epistole di Paolo, sono in qualche modo in grado di confutare la sua origine paolina? o al contrario, la perfetta concordanza di dottrina e di pensiero, la somiglianza delle monizioni e delle esortazioni, così come l’armonia del modo di parlare e delle parole stesse, spesso lodata anche da alcuni non cattolici, che si osserva tra questa epistola e gli altri scritti dell’Apostolo delle Genti, manifesta e conferma proprio questa origine paolina? Risposta: No per la prima parte; sì per la seconda.
3593. Domanda 3: L’apostolo Paolo deve essere considerato l’autore di questa epistola nel senso che dobbiamo necessariamente affermare che egli non solo l’ha concepita ed elaborata interamente sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, ma che le ha anche dato la forma in cui è presentata? Risposta: No, con riserva di un successivo giudizio da parte della Chiesa.
Decreto della Sacra Congregazione degli Studi, 27 luglio 1914.
Tesi approvate in filosofia tomistica
3601. 1. La potenza e l’atto dividono l’essere in modo tale che tutto ciò che è o è puro atto, o è necessariamente composto da potenza e atto come principi primi e intrinseci.
3602. 2. L’atto, in quanto perfezione, è limitato solo dalla potenza, che è l’attitudine alla perfezione. Di conseguenza, quando l’atto è puro, esiste solo come illimitato e unico; ma quando è finito e multiplo, entra in vera composizione con la potenza.
3603.3 Perciò, per la ragione assoluta del suo stesso essere, Dio è uno, il più semplice; tutti gli altri esseri che partecipano all’essere stesso hanno una natura per cui l’essere è limitato, e sono composti di essenza ed esistenza come di due principi realmente distinti.
3604.4 L’essere, che è denominato dall’esistenza, non è attribuito a Dio e alle creature in modo univoco, né in modo totalmente equivoco, ma in modo analogo, secondo l’analogia a volte di attribuzione, a volte di proporzionalità.
3605.5 Inoltre, in ogni creatura c’è una composizione reale del soggetto sussistente e di forme aggiunte in un secondo modo, cioè di accidenti: questi non sarebbero intelligibili se l’essere non fosse realmente ricevuto in un’essenza distinta.
3606 (6). Oltre agli accidenti assoluti, esiste anche un accidente relativo, cioè relativo a qualcosa. Sebbene relativo a qualcosa non significhi che una cosa sia inerente a un’altra secondo la propria ragione, spesso tuttavia ha la sua causa nelle cose, e per questo ha un’entità reale distinta dal soggetto.
3607 (7) La creatura spirituale è nella sua essenza del tutto semplice. Ma rimane in essa una doppia composizione di essenza ed esistenza, di sostanza e di accidenti.
3608 (8). La creatura corporea è, rispetto all’essenza stessa, composta di atto e potenza; questa potenza e questo atto, nell’ordine dell’essenza, sono designati dai termini materia e forma.
3609 9. Nessuna di queste due parti possiede l’esistenza da sola, né può prodursi o distruggersi da sola, né essere presa come predicato se non come principio sostanziale.
3610 10. Anche se l’estensione risulta dalla natura corporea nelle sue parti integranti, non è la stessa cosa per un corpo essere una sostanza ed essere esteso. La sostanza in quanto tale è indivisibile non nel modo di un punto, ma nel suo proprio modo, che non è dell’ordine della dimensione. La quantità, che dà estensione alla sostanza, è realmente distinta dalla sostanza ed è un accidente a sé stante.
3611 11. La materia considerata sotto l’aspetto della quantità è il principio dell’individuazione, cioè della distinzione numerica di un individuo da un altro appartenente alla stessa specie, cosa che non può avvenire per le creature puramente spirituali.
3612 12. Dallo stesso attributo di quantità consegue che un corpo sia circoscritto in un luogo e che si trovi in un luogo solo in questo modo, per qualsiasi potenza.
3613 13. Esistono due tipi di corpi, i corpi viventi ed i corpi inerti. Nei corpi viventi, poiché sia la parte motrice che quella mobile si trovano nello stesso soggetto, la forma sostanziale chiamata anima richiede una disposizione organica, cioè parti distinte.
3614 14. In nessun modo le anime dell’ordine vegetativo e dell’ordine sensibile sussistono da sole o si producono da sole, ma esistono solo in base al principio per cui il vivente esiste e vive, e poiché dipendono interamente dalla materia, quando il composto muore, esse periscono per caso.
3615 15. Al contrario, l’anima umana sussiste da sola; è stata creata da Dio per essere unita a un soggetto sufficientemente preparato, e per natura è imperitura e immortale.
3616 16. Quest’anima razionale è unita al corpo in modo da costituire la sua unica forma sostanziale, e attraverso di essa l’uomo esiste come uomo, come animale, come essere vivente, come sostanza e come essere. L’anima dà all’uomo tutta la sua perfezione essenziale; inoltre, comunica al corpo l’atto di esistere con il quale esso stesso esiste.
3617 17. Due ordini di facoltà derivano dall’anima umana in virtù della sua natura; i primi, che riguardano i sensi, hanno come soggetto il composto, i secondi la sola anima. L’intelletto è una facoltà intrinsecamente indipendente da un organo.
3618 18. L’intelligenza segue necessariamente l’immaterialità, così che il grado di intellettualità
corrisponde al grado di distanza dalla materia. L’oggetto proprio dell’intelligenza è comunemente l’essere stesso; il proprio dell’intelletto umano nell’attuale stato di unione si limita ad astrarre le quiddità dalle loro condizioni materiali.
3619 19. Noi traiamo la conoscenza dalle cose sensibili. Ma poiché il sensibile non è intelligibile in atto, dobbiamo ammettere, oltre all’intelletto che raggiunge le cose formali (gli intelligibili), l’esistenza nell’anima di una facoltà attiva che astrae le forme intelligibili dalle immagini.
3620 20. Con queste forme intelligibili conosciamo direttamente le forme universali; gli esseri individuali li raggiungiamo con i sensi e con l’intelletto che ritorna alle immagini; per analogia, conosciamo le realtà spirituali.
3621 21. La volontà segue l’intelletto, non lo precede; la volontà desidera necessariamente ciò che le viene presentato come il bene che soddisfa in ogni caso il suo appetito, ma tra diversi beni che le vengono presentati come desiderabili, sceglie liberamente con un atto di giudizio revocabile. Così la scelta segue l’ultimo giudizio pratico; infine la volontà esegue.
3622 22. Non si arriva a intuire direttamente l’esistenza di Dio, né la si può dimostrare a priori, ma piuttosto a posteriori, “dalle cose create Rm 1,20 , ragionando dagli effetti alla causa; cioè dalle cose che si muovono e non possono avere in sé il principio adeguato del loro movimento al primo movente immobile; dallo svolgersi delle cose nel mondo subordinate tra loro alla prima causa senza causa ; dalle cose corruttibili, che potrebbero benissimo non essere o essere, all’essere assolutamente necessario; dalle cose che, tra le perfezioni limitate dell’essere, della vita, dell’intelligenza, hanno più o meno essere, vita e intelligenza, a quella che è in sommo grado intelligenza, vita ed essere; infine dall’ordine dell’universo a un’intelligenza separata che ordina, dispone e dirige tutte le cose verso il loro fine.
3623 23. L’essenza divina, poiché il suo stesso essere si identifica con l’atto in atto, cioè poiché è l’Essere stesso sussistente, si presenta a noi anche come la ragione metafisica del bene e, per questo, ci rivela la ragione della sua infinita perfezione.
3624 24. Per la purezza del suo essere Dio è separato dalle cose limitate. Da ciò consegue, in primo luogo, che il mondo non può procedere da Dio se non attraverso la creazione; in secondo luogo, che l’energia creatrice con la quale l’essere in quanto tale si è formato per la prima volta in se stesso non può essere comunicata neppure per miracolo a qualche natura finita; in terzo luogo, che nessun agente creato può agire su alcun essere se non attraverso un moto ricevuto dalla Causa prima.
TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (40): “Da BENEDETTO XV a PIO XII, 1914-1944”