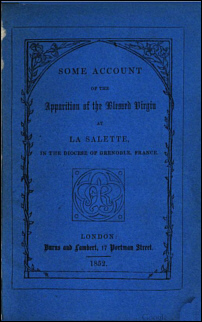LA SALETTE (III)
[Some account of the APPARITION OF THE BLESSED VIRGIN Of LA SALETTE London 1853]
Non sarà necessario il produrre estratti di altre numerose lettere e pubblicazioni apparse in Francia e altrove su questo evento; non resta che accertare se la verità del racconto dei bambini sia stata in qualche modo sostenuta da un’interposizione soprannaturale, cioè se siano stati fatti o meno dei miracoli. Di miracoli nell’ordine della grazia sarebbe facile citarne molti; come l’improvvisa conversione di peccatori incalliti e infedeli dopo aver visitato la montagna o dopo aver preso, contro la loro volontà, alcune gocce d’acqua dalla misteriosa sorgente. Una grande conversione c’è, e si manifesta a tutti: la completa riforma portata avanti in tutto il cantone e nel quartiere di Corps dalle parole di due bambini, che sono state più efficaci degli appelli infuocati di pastori zelanti e di missionari evangelici. Sì, tutto il Paese si è convertito; e le loro preghiere e le penitenze, insieme a quelle delle centinaia di migliaia di forestieri che hanno visitato il luogo, indubbiamente hanno evitato la punizione di cui la Santa Vergine ha minacciato il “suo popolo” nel caso non si fosse pentito. Di miracoli nell’ordine della natura, compiuti con l’uso dell’acqua di La Salette, accompagnati da una novena, i commissari ecclesiastici di Grenoble ne hanno ricevuto così tanti resoconti debitamente autenticati dalla testimonianza di medici, che è utile un esame molto rapido per fugare ogni dubbio su questo punto. Tra i tanti riportati nell’opuscolo di M. Rousselot, che non sono altro che una selezione tra i tanti di cui egli sia venuto a conoscenza, se ne noteranno qui solo due o tre, che si caratterizzano per la particolarità di portare con sé tutti i segni di autenticità richiesti.
I – Guarigione della Suora Saint Charles, del Convento di San Giuseppe, nella città di Avignone. Di seguito si riporta la dichiarazione della Superiora del convento : – « La suora Saint Charles è entrata nella nostra casa a diciassette anni e mezzo; la sua costituzione era molto delicata: poco dopo la professione la sua salute ha ceduto del tutto; e prima della fine del noviziato si era ridotta in uno stato gravissimo con dolori allo stomaco, frequenti vomiti sanguinolenti, dissenteria, febbre bassa e continua, che la tennero per più di otto anni sul letto di dolore. Durante questo periodo le è stato più volte somministrato ed ha ricevuto il Viatico. Tutti i medici che l’avevano visitata avevano dichiarato il suo stato senza speranza alcuna. Poteva ella alzarsi dal letto solo molto raramente, e solo per un tempo molto breve; non assisteva al santo Sacrificio della Messa più di cinque o sei volte all’anno al massimo; e poi lo sforzo che faceva era accompagnato da una tale stanchezza tanto da ridursi ad un grado estremo. Più di una volta è stato necessario portarla via in uno stato di completa incoscienza; per cui questo favore le è stato accordato solo in considerazione del suo ardente desiderio, e non per affliggerla troppo. Nel mese di dicembre 1846, i suoi sintomi si aggravarono molto; e noi ripetutamente ci aspettavamo di perderla ad ogni momento. Lo stato infiammatorio si diffuse alla gola e alla bocca; ingoiava con grande difficoltà. Quest’affezione presentava tutti i sintomi di un’ulcera: ne derivava un odore così corrotto da essere quasi insopportabile; un’abbondante espettorazione mista a sangue contribuiva ancora di più ad indebolirla e a rendere il suo stato deplorevole. Da questo periodo fino al 16 aprile non ha potuto assaggiare né pane né alcunché di solido; viveva alimentandosi solo di brodo, o di latte ed acqua, che poteva assumere solo in piccolissima quantità, anche se era costretta a bere spesso; perché, se non lo faceva, la sua gola collassava. Il 14 febbraio 1847 ricevette l’Estrema Unzione, ed il Viatico le fu somministrato due o tre volte nelle settimane successive. Tale era la condizione della sorella quando si cominciò a parlare dei miracoli provocati dall’uso dell’acqua di La Salette. Riconosco, a mia confusione, di non aver dato credito a tutte queste voci; ma avendo sentito parlare della guarigione di una suora del “Sacro Cuore”, ho sentito nascere in me una convinzione, e ho proposto una Novena alla nostra povera inferma. Per quanto grande fosse il desiderio che avevo della sua guarigione, avevo ancora di più in vista la gloria della Santa Vergine, la confermazione della sua apparizione ai due pastorelli e la conversione dei peccatori. Fu per questi motivi che tra le nostre sorelle malate, che allora erano molto numerose, scelsi la suora Saint Charles come colei che, essendo la più conosciuta in conseguenza della lunga durata della sua malattia, poteva meglio servire al fine che mi proponevo. Le comunicai la mia idea: lei mi sembrò, la prima volta, molto indifferente, e mi dichiarò che non aveva alcun desiderio di recuperare la sua salute, che le avrebbe solo impedito di tornare nell’eternità, e che preferiva morire, o rimanere nello stato in cui si trovava fino a quando sarebbe piaciuto a Dio. Le feci la stessa proposta più volte; ma trovandola sempre nelle stesse disposizioni, pensai che avrei dovuto usare la mia autorità. Ottenuta una piccola quantità d’acqua da La Salette, le dissi che non avrebbe dovuto considerare tanto se stessa quanto la gloria di Dio, e la maggior devozione verso la Santa Vergine, che ne sarebbe risultata da una guarigione, o da una straordinaria opera in suo favore. Le ordinai allora di unirsi alla Novena che la comunità avrebbe fatto per lei, e di prendere l’acqua che le avevo portato. Fu convinta fin dall’inizio che se avesse fatto questa Novena sarebbe stata guarita, e si sottomise nel farlo in obbedienza. Le feci anche indicare le preghiere e gli esercizi da seguire durante la Novena. Ogni giorno una delle suore si recava alla santa Comunione in spirito di riparazione per i peccati principali che la Vergine aveva indicato ai pastorelli, e con l’intenzione di ottenere la conversione dei bestemmiatori e dei profanatori della domenica. Abbiamo anche digiunato tre volte con la stessa intenzione; e ogni giorno abbiamo recitato la “Salve Regina”, tre Ave, con le invocazioni “O Maria concepita senza peccato etc. “, e “Mater admirabilis“. La Santa Vergine sembrava mettere la nostra fiducia a dura prova, perché la nostra povera sorella era sempre molto malata e sofferente. Il giovedì, al settimo giorno della Novena, ebbe uno svenimento, seguito da un’abbondante espettorazione di materia purulenta mescolata al sangue. Questo incidente ci ha molto allarmato. Vedendola in questo stato, le ho detto: « Penso che la Santa Vergine ti curerà portandoti in cielo ». Ella rispose: « Le mie malattie non indeboliscono la mia coscienza, e siccome ho solo altri tre giorni per soffrire, prego la mia buona Madre di non risparmiarmi; e ho grandi speranze di poter andare sabato alla santa Messa e di potermi comunicare ». In una parola, ha fatto tutti i preparativi necessari per farlo, e ha implorato che le venissero portati i suoi vestiti ed il suo velo, di cui non aveva fatto uso per molto tempo. Il venerdì 16 aprile, dopo aver trascorso una notte molto brutta, sputava ancora sangue al mattino. Monsignor de Prilly, Vescovo di Chalons, doveva celebrare la Messa nella nostra cappella alle sette. Per ottenere le indulgenze legate alla Messa del prelato, ho proposto per un giorno la Comunione generale, che doveva essere il sabato, per la fine della Novena. Questo cambiamento affliggeva molto la sorella Saint Charles, che era molto addolorata per non essere riuscita a unirsi quel giorno alla comunità, ed aveva paura di rimanere sola alla sua Comunione del mattino, che sarebbe stato, secondo lei, il giorno della sua guarigione. Mentre noi assistevamo alla Messa, lei faceva i suoi progetti e proponeva di chiedere al nostro confessore un’altra Comunione generale, per potersi presentare alla santa Mensa con tutte le sue sorelle ed essere più certamente accetta a Dio. La sua mente era abbastanza piena di quest’idea, quando all’improvviso si rese conto che era avvenuto in lei un totale cambiamento. Tutti i suoi mali cessarono improvvisamente, « … come se una mano invisibile li avesse portati via »: questa era la sua stessa espressione; non riconosceva più se stessa e non poteva credere a ciò che aveva vissuto. Si mise alla prova in vari modi, per essere sicura di non soffrire di un’illusione; e percependo di aver recuperato completamente le forze, non esitò a credere di aver ricevuto la grazia che le era stata chiesta e gridò: « Sono guarita! ». La sorella Saint Joseph, che era a letto nella stessa stanza, non capiva quello che diceva, e pensava, al contrario, che stesse peggiorando; era tanto più allarmata, perché in quel momento era sola e troppo malata per andare ad aiutarla. La sorella Saint Charles, sentendola piangere, si alzò dal letto e andò a consolarla. Lo stesso fece con la portinaia, che si prendeva cura del convento durante la Messa, e fu terribilmente spaventata nel sentire qualcuno correre nella stanza in cui aveva lasciato a letto, solo persone malate. Arrivò di corsa, senza fiato, e si sentì male. La suora Saint Charles la calmò, le diede qualcosa da bere, così come alla suora Saint Joseph, e assicurò loro che fosse guarita. Erano appena arrivati al Vangelo della Messa. La suora si è vestita di fretta e si è recata all’anticapella, dove ha ascoltato il resto della Messa in ginocchio e senza alcun sostegno. Quando lasciammo il coro, venne ad incontrarmi per abbracciarmi. Le ho detto che doveva tornare, per ringraziare la sua Benefattrice celeste. Mi rispose che lo aveva già fatto, avendo ascoltato gran parte della Messa e avendo recitato il “Te Deum“, ma che desiderava molto qualcosa da mangiare, perché aveva un grande appetito. Ho affrettato il passo e le ho detto di seguirmi, per provare le sue forze; lei ha camminato in fretta, ed è scesa le scale con la stessa velocità con cui l’ho fatto io. Le diedi un pezzo di biscotto, che mangiò quasi con avidità. In seguito entrò nella sala della comunità per abbracciare le suore, che rimasero stupefatte da questo avvenimento meraviglioso, e per ricevere la benedizione di Monsignor de Prilly. Questo santo prelato la esortò a ringraziare Dio e la sua beata Madre e ad essere molto fedele ai doveri del nostro santo stato. La mattina, ora, si pone in ginocchio in preghiera per un’ora, dopo di che si reca al lavoro, stira la biancheria per un tempo considerevole, segue subito tutte le osservanze della casa e si reca al refettorio, dove mangia la cena ordinaria della comunità. Lo stesso giorno, ricordando che le avevano preparato del brodo di carne, che non le era ormai più necessario, mi chiese il permesso di portarlo ad una povera ammalata che era tra le nostre mura e che noi assistevamo. Per andare da lei, era necessario salire una lunga e scomoda scala; la sorella lo fece con grande facilità. La fama di questo evento, che si diffuse presto all’esterno in città, attirò nel nostro convento una moltitudine di persone, che vollero accertarsi di persona della verità di un fatto così straordinario. Le nostre sale sono state affollate per molti giorni; e la fatica che tante visite devono aver causato alla suora, non è stata che una piccola ulteriore prova della sua forza. Lei ha sostenuto tutto questo in un modo che ci ha stupito, e non ne è stata affatto affranta, anche se è stata costretta a parlare quasi tutto il giorno. Soprattutto i medici non potevano credere ai loro occhi. Uno di loro, che veniva molto spesso, e che aveva seguito tutto l’andamento della malattia della sorella, mi aveva spesso detto: « Nel momento in cui meno te lo aspetti, la vedrai morire, perché non so cosa possa essere che la tenga ancora in vita ». Le ho parlato della novena che stavamo facendo, e gli avevo chiesto se avesse potuto fare un’attestazione nel caso in cui le nostre preghiere fossero state accettate. « Se sarà guarita – rispose – ti darò mille attestati, perché per lei tutto è inutile ». Mi affrettai ad informarlo di tutto ciò che era accaduto; e gli permisi di raccontare da se stesso, nella sua attestazione, di quale sia stata la sua sorpresa, la sua meraviglia, e le prove alle quali ha sottoposto la sorella per essere certamente sicuro della guarigione. Poiché la suora Saint Charles aveva potuto unirsi alla Novena solo in parte, aveva promesso di digiunare per tre giorni, nel caso fosse guarita; ha adempiuto al suo voto pochi giorni dopo, senza provare la benché minima stanchezza. Aveva anche fatto i digiuni dei giorni della quatempora e del giubileo, che avvenivano nello stesso periodo. Sono passati ormai quindici mesi da quando questa guarigione si è verificata; e da allora la suora Saint Charles continua a seguire gli esercizi della comunità, si alza alle cinque del mattino, e gode di uno stato di salute perfetto, considerando la delicatezza abituale della sua costituzione. Desidero che questo rapporto possa contribuire alla gloria di Dio, all’incremento della fede, e possa essere un eterno monumento della nostra gratitudine verso la nostra gloriosa Benefattrice, che ha concesso alla nostra comunità una prova così toccante della sua potente protezione. È con questa convinzione che firmo questo testimonianza, certificando che in essa non c’è nulla che non sia conforme alla più esatta verità.
J. PINEAU, Superiora delle Sorelle di San Giuseppe ».
A questa lettera si aggiungono gli attestati di due medici che erano stati costantemente presenti nella malattia della sorella Saint Charles, e che di conseguenza conoscevano bene da tempo il suo caso. L’uno fornisce un dettagliato resoconto scientifico del suo disturbo, e dichiara che la sua guarigione è contraria alle leggi della natura. L’attestazione dell’altro è così formulata: « Il sottoscritto dottore in medicina, primario onorario dell’ospedale di Avignone, dopo trentasei anni di servizio attivo, dichiara che la guarigione imprevista ed inattesa da una condizione considerata, secondo le leggi della medicina, mortale, nella persona della suora Saint Charles, sopra citata, ad uno stato di perfetta salute di tutti i suoi organi e di tutte le loro funzioni, è stata operata istantaneamente, senza l’intervento di alcuna applicazione dell’arte, e che quindi è di natura prodigiosa. Rooms, D.M. ». – Durante la vacanza nella sede di Avignone, causata dalla morte dell’Arcivescovo, i tre Vicari generali che poi hanno diretto gli affari della diocesi, su richiesta del Vescovo di Grenoble circa il loro parere sul tema della guarigione della suora Saint Charles, hanno risposto come segue: « -1). La guarigione di questa suora, tanto completa quanto improvvisa, fu operata il 16 aprile 1847, ottavo giorno di una novena che la comunità stava facendo in onore di Nostra Signora di La Salette, per ottenere questa grazia. -2) I due medici che avevano curato la suora durante la sua malattia, e che da allora hanno reso rapporto della sua guarigione, sono degni di ogni credito. – 3) Il defunto Arcivescovo di Avignone era pienamente convinto che la sorella fosse stata guarita per miracolo. – 4). La suora Saint Charles continua a godere di buona salute e segue le regole ordinarie della comunità. Avignone, 23 giugno 1848 ».
II. Ad Avallon, nella diocesi di Sens, si è verificato un caso clamoroso di guarigione, dopo una novena fatta a Nostra Signora di La Salette, che da allora è stata autorevolmente dichiarata miracolosa dal Vescovo.
Il medico che l’ha assistita ha redatto una lunga e dettagliata dichiarazione rispetto alla sua malattia e alla successiva guarigione. Le sue dichiarazioni conclusive sono le seguenti:
« – 1). Per diciassette anni A. Bollenat rimetteva tutto i cibi solidi che ingoiava, e poteva solo con difficoltà digerire qualche cucchiaio di latte o di zuppa di carne. Negli ultimi tre mesi precedenti il 21 novembre, non ha praticamente ingerito nulla.
– 2). Per tre anni A. Bollenat non aveva mai potuto camminare; era rimasta seduta, riuscendo a malapena a fare qualche leggero movimento delle estremità inferiori.
– 3). Per dieci anni A. Bollenat non era stata mai n grado di sdraiarsi sul fianco sinistro; era stata anche quasi completamente privata del sonno.
– 4). Per diciannove anni i dolori allo stomaco, che erano alla fine diventati insopportabili, non erano mai cessati.
– 5). Da diciassette anni si apprezzava un enorme tumore sul fianco, e per molto tempo non avevo usato nessun tipo di rimedio né per guarire questo tumore né per fermarne lo sviluppo.
– 6). Il 19 novembre 1847, Antoinette Bollenat presentava tutti i segni di morte imminente.
1. Il 21 novembre, alle sei di sera, senza alcuna transizione, senza che si manifestasse alcuna crisi, mangiò e digerì una zuppa solida, verdura e frutta.
2. Il 21 novembre A. Bollenat si è alzata dal letto, si è vestita ed ha camminato nella sua stanza.
3. Il 21 novembre A. Bollenat si è sdraiata sul fianco sinistro dormendo tutta la notte.
4. Dal 21 novembre non è residuato alcun dolore interno in nessuna parte del corpo.
5. Il 21 novembre il tumore è completamente scomparso; non c’è stata alcuna crisi, né alcuna fuoriuscita di materia liquida di alcun tipo dal tumore, né internamente né esternamente.
6. Il 21 novembre e i giorni successivi l’ho vista piena di salute.
Gagniard, D.M. »
Le autorità ecclesiastiche della diocesi hanno preso conoscenza di questo caso; e dopo un minuzioso esame, l’Arcivescovo ha rilasciato una dichiarazione sul caso in oggetto, in cui dice: « Dopo aver esaminato le prove dei vari testimoni e del medico curante; dopo aver esaminato la relazione presentata dalla Commissione incaricata di esaminare il caso; dopo aver ascoltato il parere del Consiglio Episcopale, e dopo aver invocato il santo Nome di Dio, dichiariamo, a gloria di Dio, e ad onore della Santissima Vergine, per l’edificazione dei Fedeli, che la guarigione di Antonietta Bollenat, avvenuta il 21 novembre 1847. dopo un Novena alla Santissima Vergine Madre di Dio, invocata sotto il nome di “Nostra Signora di La Salette”, presenta tutte le condizioni e tutti i caratteri di una guarigione miracolosa, e costituisce un miracolo del terzo ordine.
Dato a Sens, sotto la nostra mano, con il sigillo delle nostre braccia, e il contro sigillo del nostro Vicario generale e segretario privato, il 4 marzo dell’anno di grazia 1849. (Firmato) MELLON, Arcivescovo di Sens. »
III. Nel grande seminario della diocesi di Verdun è avvenuta un’altra sorprendente guarigione nella persona di uno degli studenti.
« Il Vescovo gli ordinò di redigere un resoconto del suo caso, della sua malattia e della sua guarigione. In esso egli racconta come – secondo il parere dei suoi medici – tutta la sua costituzione era stata completamente debilitata, in parte a causa dei terribili attacchi nervosi e dei dolori a tutte le articolazioni di cui aveva sofferto, in parte a causa delle medicine che aveva assunto per alleviarli. Era stato costretto due volte a lasciare il seminario e, dopo aver ottenuto a casa qualche piccolo miglioramento delle sue sofferenze, vi era tornato per la terza volta. Egli continua: « Sono tornato il giorno stabilito; ma nuove e più terribili prove mi aspettavano in seminario. Dal 7 marzo le mie pene, invece di diminuire, aumentavano rapidamente, e mi costringevano continuamente a trattenere grida disperate, e solo il pensiero di Maria le ha fermate. Infatti questo mi faceva ricordare vivamente le sofferenze di suo Figlio, ed io mi nascondevo nelle sue ferite. Poi mi ha visto il medico al quale mostrai come fosse ridotta la mia gamba, in uno stato di atrofia e rigida come una sbarra di ferro; gli provai che non potevo fare un passo senza la più crudele delle sofferenze, e che il dolore saliva fino alle mie reni, e attraverso la spina dorsale fino alla testa. Mi disse, per tutta consolazione: « Ebbene, amico mio, dobbiamo aspettare il caldo; allora userò bagni alcalini aromatici; poi, se questo non dovesse servire a nulla, faremo qualcos’altro; e se anche questo dovesse fallire, allora … addio, mio caro. Quindi sono andato dal mio direttore per consolarmi nelle mie pene; perché la consolazione mi era necessaria. Sono stato felice di sentirgli esprimere un’idea che avevo a lungo meditato, ma che ero deciso a non menzionare per primo: egli ha proposto una Novena alla Madonna di La Salette. Il giorno dopo scrissi alla confraternita di Nostra Signora delle Vittorie a Parigi, di cui ero membro, per implorare le loro preghiere. Il primo aprile, domenica delle Palme, la nostra Novena è iniziata con l’offerta del santo Sacrificio, che molti Sacerdoti della città mi hanno applicato. Molte Comunioni sono state offerte secondo la mia intenzione da molte persone caritatevoli delle diverse comunità di Verdun, che hanno invocato specialmente Nostra Signora di La Salette. Nel frattempo le mie sofferenze continuavano esattamente come prima. Quel giorno, come in quelli precedenti, per rispettare la regola, andai a passare il tempo libero nel luogo dove si recava il resto della comunità. Scesi le scale con estremo dolore, sostenuto sulle braccia da un compagno di studi, al quale devo un debito di eterna gratitudine per la sua gentilezza nei miei confronti. Dopo un quarto d’ora di dolorosissimo esercizio fisico, provai una stanchezza in tutto il corpo. Ho dovuto fare grandi sforzi per rimontare la scala. Sono andato in cappella e vi sono rimasto solo cinque o sei minuti. Non era lì che Dio mi aspettava, ma in quella povera cella in cui avevo tanto sofferto. Finalmente ci arrivai, e mi gettai davanti all’immagine di Maria, alla quale tanto spesso avevo rivolto gli occhi. Pieno di fiducia in Maria, afferrai la sua immagine e caddi in ginocchio senza accorgermene. Per molto tempo mi era stato impossibile piegare la mia gamba irrigidita. Poi, afferrando il mio piccolo flacone di acqua di La Salette, l’ho premuto sulle labbra e, contemplando l’immagine di Maria, ho gridato: « O Maria! O Madre mia! sì, tu mi guarirai, e io mi consacro a te ». Poi sono caduto in uno stato di totale insensibilità, non pensavo più a nulla, non ricordo cosa abbia detto; ero come schiacciato sotto l’azione divina, che però non ho sentito. – Questo stato durò per circa sei o otto minuti; e dopo, riprendendomi da questo tipo di insensibilità, e senza sentire il cambiamento che era avvenuto in me, mi precipitai giù per una lunga scalinata per dire ancora una volta al mio compagno di studi: « Siate di buona coscienza, sarò guarito ». Più tardi, questo eccellente amico, che mi aveva curato così bene durante la mia malattia, mi assicurò che il mio passo e la mia espressione di condiscendenza lo avevano stranamente sorpreso; che non capiva le mie parole, e che diceva in tono basso a se stesso: « Sarai guarito? Ma lo sei già! ». Continuai senza preoccuparmi di lui, ma poco dopo incontrai un altro studente, che mi afferrò e gridò: « Sei guarito! ». Solo allora ho percepito il cambiamento che si era avvenuto in me. Mi resi conto della mia felicità, e andai in giro a proclamare la mia guarigione, non come se fosse in procinto, ma come se fosse realmente già accaduta. Io non ero lontano dalla cappella dove poco prima non avevo potuto pregare: ora mi sentivo irresistibilmente spinto lì. Durante il quarto d’ora che passai ai piedi dell’altare in ginocchio, senza sentire il minimo dolore, non so cosa dissi, né quale preghiera abbia rivolto al mio Salvatore. Andai prima dal mio direttore, che mi strinse tra le sue braccia, poi dal superiore, che si rifiutò di credermi, finché non udì la parola « La Salette ». Andai poi in refettorio così in fretta, che due compagni non riuscirono a stare al passo con me. Il mio stomaco, debilitato da tante malattie e sofferenze, ricevette senza disgusto e digerì facilmente il mio cibo, cosa che poi continuò a fare. All’uscita dal refettorio, ero circondato dalla comunità, che mi ha fatto dare tutte le prove della completa guarigione. Corsi, piegai la gamba, colpii violentemente il piede contro il terreno e feci tutto quello che mi chiesero durante tutta la ricreazione, che passai tra i miei compagni di scuola come se non fossi mai stato malato. Il giorno dopo, un’ora di cammino non mi ha affaticato minimamente. Quello stesso giorno, tre persone hanno esaminato la mia gamba e si sono convinte che aveva recuperato la vitalità che essa aveva perso. Posso affermare che prima della mia guarigione era almeno di due terzi più piccola dell’altra.
Manrm, chierico negli Ordini minori. Gran Seminario di Verdun, 26 luglio 1849 ».
Questa relazione, quando fu presentata al medico, fu da lui dichiarata esatta in tutti i suoi dettagli. – Il superiore e i professori del seminario hanno fatto una dichiarazione sul caso, nella quale concludono dicendo: « Questa guarigione ha prodotto l’impressione più vivida in tutto il seminario, frequentato da più di cento studenti. I seminaristi la considerano un prodigio, la cui natura miracolosa si ammette senza dubbio. Noi stessi, dopo aver esaminato e ponderato attentamente le circostanze di questo evento, non vediamo come possa essere spiegato da cause puramente naturali ». Il Vescovo di Verdun, nella costatazione ufficiale della guarigione, dice: « Abbiamo visto senza sorpresa che gli studenti del nostro seminario attribuiscono all’unanimità la guarigione ad un intervento soprannaturale della Santa Vergine. >X< LOUIS, vescovo di Verdun.
Dato a Verdun, presso il Palazzo episcopale, agosto 1849 ».
IV. L’ultimo miracolo di cui si darà notizia è la guarigione di un ufficiale di stanza a Calais, avvenuta dopo una novena fatta a Nostra Signora di La Salette. M. Delattaignant, agente di dogana di Calais, quarantadue anni, ha deposto come segue: « Nel mese di maggio del 1848 ho scoperto che non riuscivo più a dormire regolarmente; nel mese di giugno non riuscivo a dormire affatto, uno stato che durò fino al lunedì della settimana di Pasqua del 1849. Ero in un continuo stato di sofferenza, senza conoscerne la causa. Mi consultai con i medici, che mi dissanguarono, e mi ordinarono delle correnti d’aria rinfrescanti, ma senza risultati soddisfacenti. L’idea del suicidio era continuamente presente nella mia mente, e mi pesava. Ero in un tale stato di agitazione nervosa, che a volte non avevo alcun potere sulle mie membra. Non volevo vedere nessuno. Quando si parlava di pazienza e di rassegnazione alla volontà di Dio, mi sentivo esasperato, convinto che non potevo guarire, che ero disgustato dalla vita, e più volte ho aperto il coltello per pugnalarmi, cosa che non facevo se non pensando a mia moglie e ai miei figli. Forse devo la mia conservazione alle mie preghiere, che non ho mai smesso di fare. Uno dei miei amici cominciò a farmi visita per incoraggiarmi ad avere fiducia in Dio, « Dio – dissi io – nella mia esasperazione, c’è un Dio buono? Se ci fosse, non mi farebbe soffrire così » Poi ho cominciato a piangere. Avevo perso del tutto la memoria e riuscivo a malapena a svolgere i compiti del mio ufficio. Non scrissi più alla mia famiglia. Le mie facoltà morali erano scomparse. Non avevo più alcun affetto nemmeno per mia moglie e per i miei figli. Se qualcuno mi avesse offerto una fortuna considerevole o un rango elevato, ai miei occhi non sarebbe stato assolutamente nulla. Tutto il mio essere era annientato. Di dolore fisico non ne sentivo nessuno in una parte più che in un’altra; ma il mio corpo svolgeva le sue funzioni con difficoltà. Il mio stomaco era molto dilatato. Avevo un appetito straordinario e insaziabile; niente mi faceva male, e mangiavo come quattro persone. Un giorno, mentre mangiavo, mi è venuta una tale crisi che ho lasciato l’impronta dei miei denti sul cucchiaio. Sono rimasto trentasei ore senza mangiare, senza riuscire a spiegarmi il perché, sperando così di morire di fame. Su suggerimento di un pio ecclesiastico ho fatto una novena alla Madonna di La Salette, ma senza alcun risultato. Poi ne iniziai un’altra; mia moglie e i miei figli fecero la Comunione per la mia intenzione. Alla fine di questa novena, il lunedì della settimana di Pasqua, ho assistito in modo meccanico alla Messa, e quel giorno sono caduto in un tale stato di irritazione che avrei voluto distruggermi; mia moglie si è gettata tra le mie braccia, abbiamo pianto insieme, e da quel momento sono guarito. Da allora non ho più avuto un solo momento di tristezza o di insonnia. Sto bene secondo i miei desideri. La mia memoria e le mie facoltà morali sono ritornate. La mia guarigione è stata istantanea, e senza alcuna transizione. Non attribuisco la mia guarigione a nessun rimedio umano; poiché, a parte alcune correnti d’aria rinfrescanti, per diversi mesi ho rifiutato ogni presidio medico. Ringrazio Dio e la sua benedetta Madre per la mia guarigione.
DELATTAIGNANTE.
Calais, 2 giugno 1849. »
La verità di questa deposizione è certificata da trentasei firme, tutte apposte in forma legale davanti al sindaco di Calais, con il sigillo della città. Tra queste firme ci sono quelle di sette sacerdoti. – Sarebbe facile moltiplicare la citazione di un gran numero di esempi di guarigioni miracolose tanto notevoli quanto quelle sopra menzionate. Questo, tuttavia, non sarà oramai più considerato necessario; la questione dell’apparizione non è più un argomento aperto di discussione da dimostrare con delle prove. La Chiesa si è pronunciata su di essa; e tutto ciò di cui il lettore avrà ora bisogno sarà un resoconto del modo in cui questo autorevole riconoscimento della sua verità sia stato fatto. Il primo maggio 1852, il Vescovo di Grenoble pubblicò una lettera pastorale in cui, dopo averne dichiarato l’accettazione universale in Francia, Belgio, Inghilterra, Germania e Italia, accordata ad una precedente lettera da lui inviata il 19 settembre dell’anno precedente, in cui dichiarava la verità dell’apparizione, annunciava che era allora suo dovere comunicare allo stesso modo l’erezione di una chiesa e di un presbiterio a Salette, e fissare per il 25 maggio la posa della prima pietra. Questo evento si svolse infatti il giorno stabilito. Nel seguente estratto del numero dell’Università del 1° giugno 1852, c’è il rapporto che ne fa il giornale locale del dipartimento: « Ieri si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra del Santuario di La Salette. È stata una magnifica solennità, anche se il tempo è stato piuttosto poco clemente. Alla vigilia un gran numero di pellegrini è arrivato sulla scena dell’Apparizione e vi ha trascorso la notte. All’una del mattino c’erano già 2000 comunicanti; non c’erano abbastanza Sacerdoti per soddisfare il desiderio dei fedeli. Ma quando arrivò il giorno, lo spettacolo era ancora più imponente. Da tutte le parti arrivarono pellegrini che apparivano come se fossero usciti dalla montagna stessa. Nulla poteva essere, allo stesso tempo, più grandioso e più pittoresco di queste processioni, che arrivavano con striscioni esposti e canti di inni pii. Il numero di stranieri che erano concorsi a questa cerimonia è stato stimato essere più di 15.000 persone. L’entusiasmo più vivo si manifestava tra la moltitudine quando si vide arrivare il Vescovo di Grenoble, che, nonostante la sua veneranda età, non aveva esitato ad intraprendere le fatiche dolorose di un tale viaggio onde presiedere a questa cerimonia. Tutta la compagnia riunita si recò ad incontrare il venerabile prelato, e lo accolse con espressioni di profondo rispetto e di gioia; mille voci si levarono ad accoglierlo. È stato un momento molto toccante. Il volto di Mons. de Bruillard ha tradito le profonde emozioni della sua anima. In seguito la cerimonia è iniziata in mezzo alla profonda attenzione di tutti. Il ricordo di questa santa e imponente cerimonia non sarà mai cancellato dalla memoria di chi ne è stato testimone. Non è l’unica chiesa che sta per essere eretta sotto il patrocinio di Nostra Signora di La Salette: una in Bretagna e un’altra in Belgio sono già state annunciate essere in corso di costruzione.
Pensiamo di aver detto abbastanza per fornire al lettore una chiara documentazione delle circostanze dell’apparizione stessa, e anche delle prove scientifiche a sostegno della sua credibilità. Dal suo riconoscimento pubblico da parte del Vescovo di Grenoble, non è più necessario accumulare ulteriori prove a suo favore. Per più di cinque anni l’apparizione è stata oggetto di ogni tipo di obiezione, non solo da parte degli scrittori francesi, ma anche da parte di coloro che erano più ansiosi di crederlo vero, ma che pensavano fosse loro dovere cedere a nient’altro che ad una certezza. – Tutte le opposizioni, però, ora tacciono; è ormai un fatto approvato dalla Chiesa, che la Santa Vergine abbia scelto questi due pastorelli come portatori di un messaggio al « suo popolo », minacciandoli di vendicarsi di suo Figlio se non si pentiranno; ed è anche la convinzione di tutti, che il Vescovo nella sua lettera pastorale riconosca che le preghiere, le penitenze, e la vita riformata, che sono così largamente derivate da questo evento, siano state il mezzo per arrestare al braccio di nostro Signore e scongiurare il castigo minacciato ». In effetti, non è quasi possibile considerare le prove attraverso le quali la Francia sia passata dall’anno dell’Apparizione, il 1846, senza notare gli elementi di disordine e di confusione che sono stati ovunque percepibili, e senza al tempo stesso riconoscere chiaramente la .presenza di qualche misteriosa influenza, che fino ad ora ha calmato la formidabile eccitazione e ha trasformato tutto in bene. La Madre di Dio è la “Mater misericordiæ”, la Madre della misericordia; le sue interposizioni visibili, di cui si registrano diversi casi nella storia ecclesiastica, non sono mai state considerate come presagio di sventure, ma piuttosto come significative di un tempo prossimo di accettazione; ed è in tale luce che la sua gloriosa apparizione a La Salette è stata finora considerata dai fedeli.
FINE.
[Ribadiamo qui, che la Congregazione dell’Indice non si è mai sognata di negare la veridicità dell’apparizione mariana de La Salette, come farfugliano ancora i satanisti modernisti o scismatici attuali, ma che la condanna riguardava solo un libricino in lingua francese che riportava in modo improprio i fatti dell’apparizione. Eccone ancora il testo:
DAMNATUR OPUSCULUM: « L’APPARITION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE DE LA SALETTE ».
DECRETUM
Feria IV, die 9 maii 1923
In generali consessu Supremæ Sacræ Congregationis S. Officii Emi. ac R.mi Domini Cardinales fidei et moribus tutandis præpositi proscripserunt atque damnaverunt opusculum: L’apparition de la très Sainte Vierge sur la sainte montagne de la Salette le samedi 19 septembre 1845. – Simple réimpression du texte intégral publié par Melanie, etc. Société Saint-Augustin, Paris-Rome-Bruges, 1922; mandantes ad quo spectat ut exemplaria damnati opusculi e manibus fidelium retrahere curent.
Et eadem feria ac die Sanctissimus D. ST. D. Pius divina providentia
Papa XI, in solita audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, relatam sibi Emorum Patrum resolutionem approbavit.
Datum Romæ, ex ædibus S. Officii, die 10 maii 1923.
Aloisius Castellano,
Supremæ S. C. S. Officii Notarius.]