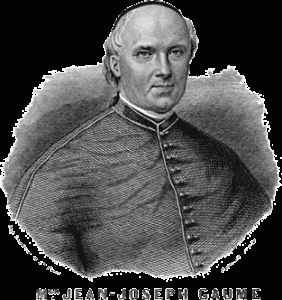CONOSCERE SAN PAOLO (20)
[F. Prat, S. J. : La Teologia di San Paolo, vol. I – S.E.I. Ed. Torino, 1945]
LIBRO QUINTO
Le pastorali.
CAPO II
Dottrina delle Pastorali.
I . GLI ERRORI COMBATTUTI.
- ERRORI SEGNALATI A TITO. — 2. ERRORI SEGNALATI A TIMOTEO. — 3. CARATTERI COMUNI.
1 . La sollecitudine di conservare intatto il deposito della fede è, insieme con le disposizioni relative alla scelta dei sacri ministri, l’argomento principale di questo gruppo di lettere. L’Apostolo sente il bisogno di assicurare la parola di Dio contro gli assalti malsani di una fantasia senza freno e di una scienza senza regola. La verità sana e forte servirà di antidoto contro le dottrine perniciose che, come la cancrena, minacciano d’invadere il corpo della Chiesa (II Tim. II, 17). – Il pericolo del contagio ha prodotto in lui un’impressione così viva, che quasi ad ogni pagina ripete queste metafore di medicina, come gli avviene ordinariamente per tutte le idee che sono profondamente penetrate nella sua mente. – Prima di venire a conclusioni, lasciamo parlare il testo. Con Tito, l’Apostolo si esprime in questi termini: “Vi sono, specialmente tra i circoncisi, molti spiriti turbolenti, vani, ciarloni e seduttori, ai quali bisogna chiudere la bocca. Essi sconvolgono intere famiglie, insegnando per un vile interesse quello che non si deve insegnare… Riprendili severamente, affinché abbiano una fede sana e non si attacchino a favole giudaiche e a prescrizioni di uomini che respingono la verità. Tutto è puro per coloro che sono puri, ma niente è puro per gl’impuri e gl’increduli, la cui intelligenza e la cui coscienza sono macchiate. Essi fanno professione di conoscere Dio ma lo rinnegano con le loro azioni: essi sono abbominevoli, ribelli e incapaci di ogni opera buona (It. I, 10-11, 13-16). Evita le questioni stolte, le genealogie, le querele, le dispute intorno alla Legge, perché sono inutili e vane. Dopo uno o due avvisi, allontanati dal fautore delle discordie, sapendo che un uomo di questa specie è pervertito e che peccando si condanna da se stesso” (Tit. III, 9-11). – Gli errori messi in vista hanno questi caratteri: Si tratta di dottrine sparse tra i fedeli, poiché Paolo ingiunge a Tito di chiudere la bocca a quelli che le propagano, di riprenderli severamente e, in caso di ostinazione, di separarsi da loro; ma non intendiamo di escludere le influenze esterne, e coloro che « facendo professione di conoscere Dio lo rinnegano con le loro azioni », sono certamente Ebrei infedeli, e non giudaizzanti. Queste dottrine sono rivolte di preferenza ai convertiti dal giudaismo; sono dispute intorno la Legge, le quali non possono avere per autori o per fautori altri che Ebrei oppure giudaizzanti; esse dispongono a dare ascolto agli spacciatori di favole giudaiche e di prescrizioni arbitrarie che riguardano le purificazioni rituali e la distinzione degli alimenti puri e impuri. – Quello che più colpisce l’Apostolo, non è tanto la falsità di quelle dottrine, quanto la loro vanità e la loro inutilità. I loro propagandisti hanno per motivo un vile interesse; sono vani ciarloni che ingannano i semplici col ciarlatanesimo delle loro stolte questioni e delle loro strane genealogie. Invece di discutere con loro, bisogna imporre loro di tacere e se resistono, scacciarli dalla Chiesa.
2. Vediamo ora gli errori ricordati nelle due lettere a Timoteo: “Partendo dalla Macedonia, ti ho pregato di restare a Efeso per imporre a certuni di non insegnare altre dottrine e di non andar dietro a favole ed a genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni, anziché far progredire l’opera di Dio nella fede. Il fine di questa prescrizione è la carità che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Alcuni essendosene allontanati, si sono traviati in vani discorsi: pretendono di essere dottori della Legge e non capiscono quello che dicono nè quello che affermano con sicurezza” (I Tim. I, 3-7). – “Lo Spirito dice chiaramente che negli ultimi tempi alcuni abbandoneranno la fede, attaccandosi a spiriti di errore e a dottrine diaboliche, sedotti dall’ipocrisia d’impostori dalla coscienza macchiata che proscriveranno il matrimonio e l’uso di alimenti che Dio h a creato affinché siano presi con rendimento di grazie dai fedeli e dai seguaci della verità. Ora ogni creatura di Dio è buona e nulla si deve respingere, purché si prenda con rendimento di grazie; poiché la parola di Dio e la preghiera lo santificano” (I Tim. IV. 1-4). – Se qualcuno dà un altro insegnamento e non aderisce alle salutari parole del Nostro Signor Gesù Cristo e alla dottrina conforme alla pietà, è un superbo, un ignorante, un uomo preso dalla malattia delle questioni oziose e delle dispute di parole: di qui nascono l’invidia, le querele, le calunnie, i cattivi sospetti, le discussioni ^terminabili di uomini che hanno l a mente pervertita e che, privi della verità, s’immaginano che la pietà sia un mezzo di guadagno” (I Tim. VI, 3-5). – “Scongiurali in nome di Dio, di evitare le dispute di parole che servono alla rovina degli uditori. Sforzati di diportarti dinanzi a Dio da uomo provato, da operaio che non ha da arrossire, dispensando con rettitudine la parola di verità. Fuggi i discorsi vani e profani; perché i loro autori affondano sempre di più nell’empietà e la loro parola si propagherà come una cancrena. Di questo numero sono Imeneo e Fileto che hanno abbandonato la fede, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, ed hanno sovvertita la fede di alcuni” (II. Tim. 14-18). – “Sappi che alla fine dei tempi sorgeranno giorni difficili. Gli uomini saranno egoisti, cupidi, gonfi… con l’esteriore della pietà, senza averne la realtà. Fuggi anche costoro. Tra loro ve ne sono che s’insinuano nelle case e seducono femminucce cariche di peccati, agitate da passioni di ogni sorta. Imparando sempre, essi non possono arrivare mai alla conoscenza della verità. Come Gianne e Giambre si opposero a Mosè, costoro si oppongono alla verità, corrotti di mente, pervertiti nella fede. Ma essi non faranno più progresso, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quei due” (II Tim. III, 1-9). – “Verrà un tempo in cui gli uomini non sopporteranno più la sana dottrina. Abbandonati al desiderio di udire quello che accarezza le loro orecchie, si prenderanno una turba di maestri e, distogliendo il loro udito dalla verità, si volgeranno verso le favole” (II Tim. IV, 3-3). – Tre di questi testi riguardano il presente, e gli altri tre — il secondo e gli ultimi due — l’avvenire (I Tim. IV, 1; II Tim. III, 1; II Tim. IV, 3). Gli errori attualmente in corso hanno precisamente i caratteri che abbiamo veduto nell’Epistola a Tito. Sono dottrine sparse tra i fedeli, poiché Timoteo riceve la missione d’imporre silenzio a coloro che le vanno spacciando. Costoro sono evidentemente Ebrei di nazionalità, perché si spacciano per dottori della Legge. Le dottrine stesse non sono tanto eresie, quanto questioni oziose atte a suscitare querele: dispute di parole che non concludono nulla, vane ciarle e pettegolezzi. Le espressioni incontrate nell’Epistola a Tito, si ritrovano costantemente anche qui: la situazione è dunque la stessa. – Ma l’errore non può vivere se non a condizione di crescere; esso si propaga come la cancrena. L’Apostolo prevede per l’avvenire un traboccare di false dottrine,, che andrà di pari passo con la corruzione dei costumi: saranno le aberrazioni presenti portate alla loro più alta potenza; già si vanno agitando nell’ombra. A forza di dominare, lo spirito di contesa arriverà fino allo scisma; non si sopporterà più la verità; si abbandonerà la fede; si farà ressa intorno a falsi dottori e a falsi profeti che apertamente predicheranno dottrine diaboliche. Non si tratterà più soltanto di fiabe e di genealogie, di dispute di parole e di querele riguardo la Legge, di pratiche arbitrarie e senza frutto; si proscriverà il matrimonio, si condanneranno come cattive certe creature, o per l’influenza del dualismo o per un malinteso ascetismo. Finalmente l’amore del lucro cagionerà mille abusi detestabili, e si copriranno con la maschera dell’ipocrisia i peggiori eccessi.
3. Riunendo in un quadro generale tutti i caratteri, senza distinguere troppo il futuro dal presente, ci possiamo fare un’idea precisa dei predicatori, dei loro motivi e delle loro dottrine. I predicatori sono Ebrei o giudaizzanti. Soprattutto appartengono alla circoncisione (Tit. I, 10): si chiamano dottori della Legge (I Tim. I, 17); vanno dietro a favole giudaiche (Tit. I, 14); si abbandonano a dispute intorno alla Legge (Tit. III, 9); resistono alla verità come i due celebri impostori resistevano a Mosè (Tit. III, 8). Essi sono seduttori (Tit. I, 10), ipocriti (II Tim. III, 5), spiriti turbolenti (Tit. I 10), vani ciarloni (I Tim. I, 6), uomini di mente pervertita (II Tim. III, 8), ai quali prudono le orecchie (II Tim. IV, 3), incapaci di intendere la verità (II Tim. III, 7), gente avida di guadagno (I Tim. VI, 5; Tit. I, 11) e di popolarità, che getta la divisione nella Chiesa e nelle famiglie (I Tim. III, 6), che fa combriccole e prepara scismi. Le dottrine che essi propagano, non sono tanto eresie, quanto novità, pericolose per la loro stessa inutilità, perché coltivano una curiosità malsana, pascolano la mente di fiabe e l’avvezzano al falso e all’irreale. Una parola difficile a tradursi (I Tim. I, 3) riassume bene l’insegnamento di questi dottori senza missione. Essi generalmente non insegnano cose contrarie alla dottrina dell’Apostolo, ma insegnano cose che egli ha giudicato mutile e pericoloso insegnare, e insegnano diversamente da lui gli articoli del suo vangelo. Paolo spiega la natura di quelle novità con proibire di « andar dietro a favole ed a genealogie interminabili ». Si sarebbe tentati di pensare ai mitografì greci, a quegli storici delle origini i quali raccoglievano le favole riguardanti gli dei e le liste genealogiche a cui si riduceva quasi tutta la storia primitiva (Polibio). Ma le parole di San Paolo non permettono di pensare né alle leggende della mitologia pagana né alle genealogie degli dei e degli eroi. Difatti quelle favole di cui parla l’Apostolo sono dette giudaiche e il passo parallelo dimostra che sono spacciate da persone che si chiamano dottori della Legge. Del resto possiamo credere che fossero insulsaggini o pettegolezzi simili a quelli di cui sono zeppi i libri talmudici. In quanto alle genealogie interminabili e soprattutto senza profitto, gli apocrifi dell’Antico Testamento, composti in tempi poco lontani dall’era cristiana, ce ne danno più di un esempio. Lo spirito amante di novità si lascia abbagliare dal falso splendore dei sofismi: « O Timoteo, custodisci il deposito, evitando le parole profane e vuote di senso come pure le contradizioni di una falsa scienza di cui fanno pompa certuni che hanno deviato dalla fede (I Tim. VI, 20) ». Prima questioni oziose, poi obiezioni sciocche e arguzie sterili, finalmente la perdita della fede: tale è la via dell’errore.
II. I DIGNITARI ECCLESIASTICI.
1 . SACERDOTI E DIACONI. — 2. QUALITÀ RICHIESTE NEI CANDIDATI. — 3. VEDOVE E DIACONESSE.
1 . Nelle lettere autentiche di Sant’Ignazio, all’alba del secondo secolo, la terminologia e le attribuzioni della gerarchia ecclesiastica sono già completamente fissate. Vi sono tre ordini distinti: il Vescovo sempre unico (Ephes. I, 3), i sacerdoti strettamente associati al vescovo e così intimamente uniti tra loro, che si chiamano ordinariamente col nome collettivo di πρεσβυτέριον (=presbuterion) o collegio sacerdotale (Ephes. II, 2; IV, 1, etc.), finalmente, nell’ultimo grado, i diaconi che devono obbedienza ai sacerdoti e al Vescovo, come a loro stessi devono obbedienza i fedeli. Il Vescovo, il presbiterato e i diaconi costituiscono il clero; il clero e i laici costituiscono la Chiesa. L’episcopato è monarchico e residenziale: Ignazio è Vescovo di Antiochia, Policarpo di Smirne, Onesimo di Efeso, Polibio di Traile, Damaso di Magnesia. Il vescovo compie o dirige la cerimonia del Battesimo e dell’agape, la celebrazione dei matrimoni e soprattutto la consacrazione dell’eucaristia; ma gli è sempre lecito delegare ad altri la sua autorità. I sacerdoti e i diaconi non devono esercitare nessuna funzione, se non lo sa o se non vi assiste il Vescovo. I laici poi non hanno nessuna parte nel governo della Chiesa: il loro compito è di obbedire al Vescovo, oppure al Vescovo e al presbiterato, oppure al Vescovo, al presbiterato e ai diaconi (Ephes. IV, 1), poiché i due ordini inferiori sono uniti al Vescovo come le corde alla lira (Ephes. IV, 1): non vi è che un’eucaristia, una carne del Cristo, un calice del suo sangue, un altare un Vescovo col presbiterato e con i diaconi. – Le Pastorali presentano un ordinamento assai più primitivo, il che distrugge il paradosso dei critici i quali vogliono che siano state scritte in pieno secolo secondo, da un falsario desideroso di promuovere la gerarchia in via di formazione. Però l’evoluzione ulteriore che avvenne molto in fretta e dappertutto nella stessa maniera, con tutti i caratteri di uno sviluppo legittimo, dimostra che le linee generali erano state tracciate in precedenza dagli Apostoli, dietro, le indicazioni del Maestro e sotto l’impulso sempre vigile dello Spirito Santo. Essa dunque ci può servire per interpretare i dati oscuri dell’età apostolica; ma vi sarebbe paralogismo se si trasportassero a quei tempi remoti le funzioni e le denominazioni di un tempo più recente. Ciascun autore va studiato da parte, e non si ha il diritto di supporre a priori che tutti parlino delle medesime cose con gli stessi termini. – In San Paolo, la terminologia ecclesiastica è incerta. Se ἐπίσκοπος (=episcopos) indica sempre un sacro ministro, πρεσβυτέριον (=presbuterion), prende spesso il significato di « vegliardo », e διάκονος (= diakonos) quasi sempre non significa altro che « servo od aiutante ». Invece i capi della Chiesa ricevono talora altri titoli: quelli di Tessalonica, per esempio, sono chiamati presidenti. Il linguaggio è ancora incerto, ma vi è piuttosto da meravigliarsi che le incertezze siano finite così presto. Di comune accordo, per i ministri inferiori del culto si tenne il nome diacono, a preferenza di tutti i sinonimi. Forse “doulos” fu lasciato da parte per il significato troppo servile, “uperetes”, perché ricordava il sacrestano delle sinagoghe ebree, “terapon” perché ricordava il custode di certi santuari idolatrici. Comunque sia, “diaconos” fu tosto scelto ad esclusione di ogni altro titolo, e fa stupire il vedere che San Luca, il quale ci racconta l’elezione dei primi sette diaconi ellenisti, non adoperi questo termine. Per San Paolo, la parola diacono ha già ricevuto la sua impronta gerarchica; l’Apostolo saluta in particolare i diaconoi di Filippi ed enumera le qualità che si devono esigere dal “diaconos” per imporgli le mani. Non è possibile alcun dubbio: si tratta proprio del diaconato e dei diaconi. – Per le funzioni superiori, i termini più generici, spogliati per la loro stessa indeterminatezza da ogni associazione di idee compromettenti, erano anche i più convenienti. Di questo numero è la parola πρεσβυτέρος (=presbuteros). Quasi tutte le società antiche, almeno dove non regnava l’autocrazia pura, erano governate da un consiglio o senato di anziani. In origine era il privilegio dell’età; più tardi divenne un titolo ereditario. In tutte le epoche della storia sacra, sotto Mosè, sotto i Giudici, sotto la monarchia, al ritorno dalla schiavitù, dappertutto constatiamo la presenza di questi anziani. Durante il periodo del giudaismo propriamente detto, essi erano a capo delle sinagoghe, esercitavano nelle città e nei villaggi un’autorità simile a quella dei nostri municipi ed entravano in parte notevole nel gran sinedrio di Gerusalemme; perciò sono continuamente nominati nel Nuovo Testamento insieme con gli scribi e con i principi dei sacerdoti. Per indicare i direttori spirituali delle chiese cristiane, si lasciò da parte la parola ἱερεύς (=iereus); che faceva pensare al sacerdote levitico e al sacerdos o sacrificulus pagano, ma si accettò la parola πρεσβύτερος (=presbuteros), che aveva il vantaggio di essere compresa dagli Ebrei governati dappertutto, civilmente e religiosamente, da un consiglio di anziani, ed era familiare ai Greci ai quali ricordava, fuori delle attribuzioni politiche e municipali, i membri di certi comitati istituiti per la celebrazione delle feste, per il servizio dei tempi e per la sepoltura dei soci. Ma mentre la comunità di Gerusalemme la adoperava ad esclusione di ogni altro nome, le chiese della gentilità la adottarono soltanto gradualmente e insieme con ἐπίσκοπος (=episcopos). – Questo terzo titolo è ancora più indeterminato che gli altri due. Esso significa, nella Scrittura, «custode, sorvegliante, ispettore. commissario ». Ad Atene significava certi delegati speciali, simili agli armosti di Sparta, che la metropoli mandava ad ordinare le nuove colonie o i paesi di conquista. Nella Batanea e nella Decapoli, era il titolo di ufficiali incaricati di amministrare le proprietà di un tempio. Altrove le funzioni erano diverse; ma la brevità dei testi ci permette raramente di precisarle. Perciò non sapremmo dire con certezza perché, nella gerarchia ecclesiastica, l’ἐπίσκοπος (=episcopos) ebbe il più alto grado, sopra il πρεσβύτερος (=presbuteros). Sarebbe forse perché la parola πρεσβύτερος (=presbuteros) richiamava naturalmente l’idea di una pluralità di persone riunite in collegio, per l’esercizio di una medesima carica, mentre la funzione di ἐπίσκοπος (=episcopos) era spesso conferita unicamente ad una persona? Ci affrettiamo però ad aggiungere che, per San Paolo, le due parole sono sinonimi. Nel saluto che egli rivolge al clero di Filippi, distingue soltanto due classi: gli l’ἐπίσκοποι (=episcopoi) e i diaconi (Fil. I, 1). I primi, per la stessa ragione della loro pluralità, non possono essere che gli anziani della chiesa, poiché è cosa inaudita che una sola città avesse più vescovi. Supposto che gli ἐπίσκοποι (=episcopoi) fossero vescovi, non si potrebbe spiegare l’omissione del secondo grado. – La cosa è ancora più chiara nel passo in cui San Paolo ordina a Tito di stabilire dei πρεσβύτεροι (=presbuteroi) in ciascuna città; egli esige che siano di una virtù e di una riputazione senza macchia, perché, soggiunge, bisogna che l’ἐπίσκοπος (=episcopos), sia irreprensibile (Tit. I, 5-7). Il suo ragionamento sarebbe un sofisma, se i due termini non fossero sinonimi. E poi, se si trattava del più alto grado della gerarchia, egli non metteva il plurale, perché ogni città aveva soltanto un Vescovo. – Un’altra prova è questa: avendo egli mandato a Mileto i πρεσβύτεροι (=presbuteroi) di Efeso, cioè i capi di questa chiesa particolare, i quali non erano certamente vescovi, poiché dovrà più tardi lasciare Timoteo a Efeso per esercitarvi le funzioni episcopali, parla a loro in questi termini: « Vigilate su voi stessi e su tutto il gregge in cui lo Spirito Santo vi ha stabiliti ἐπίσκοποι (=episcopoi) (40) ». Non si può dunque dubitare che questi due termini indicassero indifferentemente le stesse persone e si applicassero ai membri del secondo grado della gerarchia, ossia ai sacerdoti. – Converrà ricordarlo nel solo testo che dà luogo a discussione: « Chiunque desidera la carica di ἐπίσκοπος (=episcopos), desidera una cosa buona; bisogna dunque che l’ἐπίσκοπος (=episcopos), sia irreprensibile (I Tim. III, 1-2) ». Il parallelismo e la lista delle qualità richieste in questo dignitario, dimostrano a sufficienza che l’ἐπίσκοπος (=episcopos) dell’Epistola a Timoteo è il medesimo dell’Epistola a Tito; ora quest’ultimo, come abbiamo veduto, non è un vescovo, ma un sacerdote.
- 2. Non sappiamo quali virtù Paolo avrebbe richiesto dal futuro Vescovo, se l’episcopato monarchico fosse già esistito nelle sue chiese. Possiamo farcene un’idea da quelle doti che egli loda in Tito e in Timoteo, Vescovi missionari, che gli servivano da coadiutori. Sono soprattutto lo zelo, la pietà, la fedeltà, il coraggio nella prova, la fermezza nell’adempimento del dovere, lo spirito di fede e una vita di abnegazione e di sacrificio. Ma la lista delle doti richieste negli anziani, si trova due volte nelle Pastorali, con certe varianti che non sono prive di interesse: “Bisogna che l’ἐπίσκοπος (=episcopos) sia irreprensibile, ammogliato una volta sola, sobrio, prudente, degno (nel suo esteriore), ospitale, capace d’insegnare, non bevitore, né violento, ma dolce, pacifico, disinteressato, che governi bene la casa, che abbia figli sottomessi con ogni onestà — perché se uno non sa guidare la sua casa, come governerà la Chiesa di Dio? — non neofito, per timore che gonfiato di superbia non incorra nel giudizio del diavolo. Bisogna pure che abbia buona testimonianza delle persone estranee, affinché non cada nell’obbrobrio e nei tranelli del diavolo. Ti ho lasciato in Creta… per stabilire in ciascuna città degli anziani, come ti ho ordinato: Se alcuno è irreprensibile, ammogliato una volta sola, con figli fedeli che non siano accusati di cattiva condotta e d’insubordinazione — poiché bisogna che l’ἐπίσκοπος (=episcopos), sia irreprensibile come intendente di Dio — non arrogante, né collerico, né bevitore, né violento, né avaro, ma ospitale, amico del bene, prudente, giusto, pio, continente, attaccato alla vera dottrina quale è stata insegnata, affine di essere capace di esortare secondo la sana dottrina e di confutare i contradittori” (I Tim. III, 3-7). – San Paolo vuole che un candidato giudicato degno del sacerdozio risponda a tre condizioni principali: che sia atto all’insegnamento, che abbia una casa bene regolata e che si sia ammogliato una sola volta. I protestanti facevano una volta sforzi sovrumani per togliere alle parole μιᾶς γυναικὸς ἄνηρ (= mias gunaikos aner) il loro significato naturale. Parecchi, trovandosi in caso disperato, adottarono la spiegazione proposta da Vigilanzio e così vigorosamente combattuta da San Gerolamo: « bisogna che egli sia ammogliato, che abbia una moglie ». Ma è evidente che non è inetto alle funzioni ecclesiastiche chi segue l’esempio e il consiglio dello stesso Apostolo. I più sostengono dunque che San Paolo intende soltanto di escludere il bigamo e il poligamo, colui che avesse ancora o che avesse avuto più di una moglie contemporaneamente. La loro ragione più forte è che San Paolo non chiede ai chierici nulla di più che ai laici e che egli permette formalmente ai laici di passare a seconde nozze. Ora la prima asserzione è una pura petizione di principio; la seconda è giusta, ma allora l’uomo che passa a seconde nozze, rinunzia al chiericato. Non è che gli si rimproveri una colpa, ma egli manca di una delle condizioni richieste, come il neofìto, l’ignorante o l’incapace. L’esegesi razionalista ha questo di buono, che non teme di romperla apertamente con l’ortodossia protestante; essa ritorna dunque risolutamente al senso sostenuto dai Cattolici, e molti protestanti oggi le tengono dietro. Difatti è impossibile spiegare diversamente l’espressione ἑνὸς ἀνδρὸς γυνῆ (= enos andros gune) « maritata una volta sola », che qualifica la vedova ammessa al servizio della Chiesa,. Il desiderio di legittimare una situazione personale e poi lo spirito di setta soltanto, poterono far prevalere una deformazione così manifesta del pensiero di San Paolo. – Nel fare della fedeltà al primo vincolo coniugale una condizione assoluta per l’elevazione al sacerdozio, l’Apostolo era certamente guidato da ragioni simboliche, ma è certo che essa era, soprattutto in quel tempo, un pegno di onorabilità. Per lo stesso motivo, San Paolo domanda con insistenza che il candidato al sacerdozio, se è ammogliato, abbia una famiglia esemplare e una casa bene regolata (I Tom. III, 4). La condotta equivoca della moglie o dei figli diminuirebbe la sua influenza e intralcerebbe la sua azione, come l’impotenza di mantenere il buon ordine nella famiglia e negli affari, dimostrerebbe che egli è incapace al governo della Chiesa. Le raccomandazioni riguardo alla buona fama del candidato, così nella comunità cristiana come tra i pagani, sono del medesimo ordine. Come potrebbe il nuovo sacerdote conciliarsi il rispetto e la simpatia degli infedeli, se la sua condotta, dopo il battesimo, fosse stata scandalosa o poco conforme alla severa morale del Vangelo? Il suo apostolato tra loro sarebbe già in precedenza destinato a non riuscire, perché difficilmente si dà ascolto ad un predicatore del quale non si ha Nelle cristianità di recente fondazione, qualche volta si erano dovuti prendere i sacri ministri tra i nuovi convertiti; ma l’esperienza aveva mostrato gl’inconvenienti di tale provvedimento. – Perciò Paolo proibisce a Timoteo d’imporre le mani troppo presto al primo venuto e specialmente di ordinare un neofìto (I Tim. V, 22), per timore che, gonfiato di superbia per un’elevazione così rapida, non faccia la fine di lucifero. L’ingiunzione era opportuna per la chiesa di Efeso che già contava dieci o dodici anni di vita; ma non poteva applicarsi altrettanto in quella di Creta che, a quanto pare, era allora appena nata: ecco perché la lettera a Tito non contiene questo divieto. – Le disposizioni interne di colui che dev’essere onorato del sacerdozio, sono riassunte in una parola energica: bisogna che sia irreprensibile, per la sua eminente dignità e perché è rappresentante di Dio su la terra. Questa parola dice tutto: richiede l’esenzione di vizi grossolani che rovinerebbero la sua autorità — come l’avarizia, la collera, l’arroganza, la brutalità, l’ubriachezza — e il possesso delle virtù che la mantengono: sobrietà, prudenza, modestia, animo ospitale, giustizia, purezza di costumi. Le qualità richieste nei diaconi sono le stesse, fatta la debita proporzione:
“Anche i diaconi siano onorevoli, esenti da doppiezza, non dediti al vino, non avidi di guadagno, che portino il mistero della fede in una coscienza pura.
E siano messi prima alla prova, affinché esercitino poi senza rimproveri l’ufficio del diaconato.
Le loro mogli siano anch’esse onorevoli, non maldicenti, sobrie, fedeli in tutte le cose.
Essi poi abbiano contratto un solo matrimonio e governino bene i figli e la casa. Poiché quelli che esercitano bene il diaconato si acquistano un buon posto e una grande sicurezza nella fede in Gesù Cristo” (I Tim. VIII, 3). – I diaconi devono essere esenti da tre vizi che li screditerebbero completamente agli occhi del pubblico: la doppiezza, l’intemperanza e l’avarizia. Per le loro molteplici e delicate relazioni con i laici, essi dovevano premunirsi specialmente contro il pericolo della doppiezza. Essi dunque eviteranno di « dire bianco e nero, di parlare ora in un modo ora in un altro », per piacere ai loro uditori o per non dispiacere loro. – Le visite frequenti che entravano nelle loro attribuzioni, imponevano a loro più che agli altri il dovere della sobrietà. Gli eccessi di questo genere, o anche una mancanza generale di contegno, sarebbero state dannose al loro ministero e contrarie all’edificazione. Finalmente la cupidigia li avrebbe screditati del tutto. L’Apostolo non allude certamente alle possibili malversazioni nell’amministrazione dei beni temporali di cui erano incaricati i diaconi, ma piuttosto alla tentazione di valersi del loro ministero per il proprio vantaggio personale, accettando, per esempio, dei doni spontaneamente offerti. Questo sfruttamento indiretto del Vangelo sarebbe evidentemente la ricerca di un guadagno sordido. – Paolo vuole che il diacono goda anche dell’autorità che deriva dalla gravità delle maniere e dalla dignità dei costumi; finalmente richiede che egli porti « il mistero della fede in una coscienza pura ». Che cosa vuol dire questa ingiunzione disparata? Che cosa significa il mistero della fede e che relazione ha con la coscienza pura? Noi pensiamo che non si tratti della fede soggettiva dei diaconi, ma dei misteri del Vangelo di cui essi sono, in una certa misura, i dispensatori. Qualunque sia il senso preciso di questa locuzione enigmatica, si domanda al diacono una vita esemplare e non soltanto l’assenza dei gravi difetti che lo renderebbero inetto al suo ufficio. Perciò egli dev’essere prima messo alla prova per un certo tempo e non può essere definitivamente promosso se non quando la prova riesce a suo onore ed a soddisfazione comune.
3. Accanto e sotto la gerarchia ecclesiastica, vi erano allora delle vergini e delle diaconesse regolarmente costituite? Nel passo dell’Epistola ai Colossesi, in cui l’Apostolo consiglia ai due sessi la continenza e la verginità, egli appoggia il suo consiglio sulla maggiore libertà che avranno nel servizio di Dio, senza allusimi ad una speciale attitudine per servire la Chiesa. Il voto di verginità è presentato come un atto di perfezione individuale (I Cor. VII, 8-9). Vi sono già delle vergini, ma l’ordine delle vergini non esiste ancora e soprattutto non ha ancora preso posto accanto alla gerarchia. – La pia Febe era « serva » (diaconos) della chiesa di Cenere e patronessa » (prostatis) dei Cristiani che avevano affari a Corinto, e dello stesso Paolo (Rom. XVI, 1-2). Questo vuol dire che essa si era volontariamente consacrata al servizio della chiesa e che si valeva della sua influenza a vantaggio dei suoi correligionari. Nella terminologia di San Paolo, essa aveva ricevuto dallo Spirito Santo i carismi della diaconia (διακονία = diaconia) e dei soccorsi (ἀντίληψις = antilepèsis). Febe è chiamata διάκονος (= diakonos), come Epafra, come Tichico, come i predicatori del Vangelo, come tutti quelli che servono la causa della fede; essa non è diaconessa nel senso ecclesiastico della parola. Le mogli dei diaconi, delle quali si fa menzione nella prima a Timoteo e che sono tenute a maggiore modestia, regolarità e pietà, per non compromettere il ministero dei loro mariti, non sono neppur esse diaconesse (I Tim. III, 8-10). Le diaconesse che i costumi dell’Oriente obbligarono a stabilire in certe province asiatiche, vennero soltanto più tardi, e di esse non vi è nessuna traccia in San Paolo. L’istituzione delle vedove invece risale al secolo apostolico. Esse avevano il loro prototipo nelle pie donne che accompagnavano Gesù Cristo da una città all’altra, e forse in quelle dalle quali certi apostoli, come Pietro e i fratelli del Signore, si facevano seguire (I Cor. IX, 5; Luc. XXIII, 40). – Paolo riconosce alla vedova la piena libertà di passare a seconde nozze, benché le consigli generalmente di rimanere nello stato di vedovanza (I Cor, VII, 39-40). Questo consiglio alquanto vago può dare luogo a inconvenienti, e l’Apostolo, istruito dall’esperienza, si vede obbligato a precisarlo. Egli fa un dovere alle persone agiate di accogliere le vedove della loro famiglia, le quali vogliano rimanere vedove, affinché non siano di peso alla Chiesa. Paolo ci lascia capire che certe donne generose accettavano spontaneamente di mantenere a loro spese delle vedove, affinché non gravassero sul bilancio comune. Alle vedove giovani poi che restassero prive di mezzi, consiglia di passare a seconde nozze (I Tim. V 3-16). Vi erano certamente stati abusi; certe vedove attratte dalla prospettiva dell’ozio e dell’indipendenza, si erano fatte inscrivere nei ruoli della Chiesa facendo professione di vedovanza; ma ben presto, disgustate del Cristo e sotto l’impulso di desideri sensuali, esse davano triste spettacolo della loro leggerezza e del loro ozio, occupate in nulla, girando da una casa all’altra e scandalizzando tutti con i loro sfacciati pettegolezzi. Esse sono colpevoli di aver violata la fede giurata e di aver dato ai malevoli un pretesto per calunniare il Vangelo. Paolo vuole che d’allora in poi non si inscrivano nei ruoli della Chiesa se non le vedove di almeno sessant’anni, di condotta provata e di vita esemplare, le quali non facciano temere né lo scandalo né l’incostanza. Alle vere vedove che fanno professione di vedovanza sotto la sanzione della Chiesa, si renderanno gli onori che meritano il loro stato, le loro virtù e i servizi che prestano. Erano esse certamente che con le loro lezioni e col loro esempio formavano alla pietà le giovani cristiane; erano forse anch’esse che catechizzavano i catecumeni del loro sesso. Lavorando indirettamente per l’altare, esse avevano diritto di vivere dell’altare. L’Apostolo non dà a loro altre prerogative; egli che proibiva alle donne di prendere la parola in chiesa, non era disposto ad assegnare loro una parte nell’esercizio delle sacre funzioni. riesce a suo onore ed a soddisfazione comune.