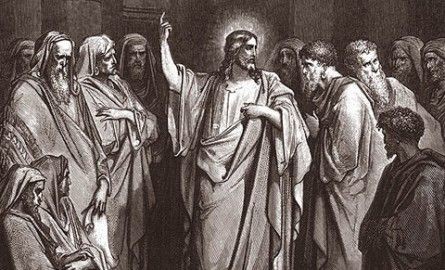SALMO 9: “Confitebor tibi Domine”
CHAINE D’OR SUR LES PSAUMES
ou LES PSAUMES TRADUITS, ANALYSÉS, INTERPRÉTÉS ET MÉDITÉS A L’AIDE D’EXPLICATIONS ET DE CONSIDÉRATIONS SUIVIES, TIRÉES TEXTUELLEMENT DES SAINTS PÈRES, DES ORATEURS ET DES ÉCRIVAINS CATHOLIQUES LES PLUS RENOMMÉS.
[I Salmi tradotti, analizzati, interpretati e
meditati con l’aiuto delle spiegazioni e delle considerazioni seguite, tratte
testualmente dai santi Padri, dagli oratori e dagli scrittori cattolici più
rinomati da …]
Par M. l’Abbé
J.-M. PÉRONNE,
CHANOINE TITULAIRE DE L’ÉGLISE DE SOISSONS, Ancien Professeur d’Écriture sainte et d’Éloquence sacrée.
PARIS
LOUIS VIVES, LIBRAIRE-ÉDITEUR
13, RUE DELAMMIE, 1878
IMPRIM.
Soissons, le 18 août 1878.
f ODON, Evêque de Soissons et Laon.
TOME PREMIER.
SALMO IX.
In finem, pro occultis filii. Psalmus David.
[1] Confitebor tibi, Domine,
in toto corde meo; narrabo omnia mirabilia tua.
[2] Laetabor et exsultabo in te; psallam nomini tuo, Altissime.
[3] In convertendo inimicum meum retrorsum; infirmabuntur, et peribunt a facie tua.
[4] Quoniam fecisti judicium meum et causam meam; sedisti super thronum, qui judicas justitiam.
[5] Increpasti gentes, et periit impius: nomen eorum delesti in aeternum, et in saeculum saeculi.
[6] Inimici defecerunt frameæ in finem, et civitates eorum destruxisti. Periit memoria eorum cum sonitu;
[7] et Dominus in æternum permanet. Paravit in judicio thronum suum;
[8] et ipse judicabit orbem terræ in aequitate, judicabit populos in justitia.
[9] Et factus est Dominus refugium pauperi; adjutor in opportunitatibus, in tribulatione.
[10] Et sperent in te qui noverunt nomen tuum, quoniam non dereliquisti quærentes te, Domine.
[11] Psallite Domino qui habitat in Sion; annuntiate inter gentes studia ejus,
[12] quoniam requirens sanguinem eorum recordatus est; non est oblitus clamorem pauperum.
[13] Miserere mei, Domine: vide humilitatem meam de inimicis meis,
[14] qui exaltas me de portis mortis, ut annuntiem omnes laudationes tuas in portis filiae Sion.
[15] Exultabo in salutari tuo. Infixæ sunt gentes in interitu quem fecerunt; in laqueo isto quem absconderunt comprehensus est pes eorum.
[16] Cognoscetur Dominus judicia faciens; in operibus manuum suarum comprehensus est peccator.
[17] Convertantur peccatores in infernum, omnes gentes quæ obliviscuntur Deum.
[18] Quoniam non in finem oblivio erit pauperis; patientia pauperum non peribit in finem.
[19] Exsurge, Domine; non confortetur homo: judicentur gentes in conspectu tuo.
[20] Constitue, Domine, legislatorem super eos, ut sciant gentes quoniam homines sunt.
[21] Ut quid, Domine, recessisti longe, despicis in opportunitatibus, in tribulatione?
[22] Dum superbit impius, incenditur pauper: comprehenduntur in consiliis quibus cogitant.
[23] Quoniam laudatur peccator in desideriis animæ suæ, et iniquus benedicitur.
[24] Exacerbavit Dominum peccator, secundum multitudinem iræ suæ, non quæret.
[25] Non est Deus in conspectu ejus, inquinatae sunt viae illius in omni tempore. Auferuntur judicia tua a facie ejus; omnium inimicorum suorum dominabitur.
[26] Dixit enim in corde suo: Non movebor a generatione in generationem, sine malo.
[27] Cujus maledictione os plenum est, et amaritudine, et dolo; sub lingua ejus labor et dolor.
[28] Sedet in insidiis cum divitibus in occultis, ut interficiat innocentem.
[29] Oculi ejus in pauperem respiciunt; insidiatur in abscondito, quasi leo in spelunca sua. Insidiatur ut rapiat pauperem; rapere pauperem dum attrahit eum.
[30] In laqueo suo humiliabit eum; inclinabit se, et cadet cum dominatus fuerit pauperum.
[31] Dixit enim in corde suo: Oblitus est Deus; avertit faciem suam, ne videat in finem.
[32] Exsurge, Domine Deus, exaltetur manus tua; ne obliviscaris pauperum.
[33] Propter quid irritavit impius Deum? dixit enim in corde suo: Non requiret.
[34] Vides, quoniam tu laborem et dolorem consideras, ut tradas eos in manus tuas. Tibi derelictus est pauper; orphano tu eris adjutor.
[35] Contere brachium peccatoris et maligni; quæretur peccatum illius, et non invenietur.
[36] Dominus regnabit in æternum, et in sæculum saeculi; peribitis, gentes, de terra illius.
[37] Desiderium pauperum exaudivit Dominus; præparationem cordis eorum audivit auris tua,
[38] judicare pupillo et humili, ut non apponat ultra magnificare se homo super terram.
[Vecchio Testamento secondo la Volgata
Tradotto in lingua italiana da mons. ANTONIO MARTINI Arciv. Di Firenze etc.
Vol. XI
Venezia, Girol. Tasso ed. MDCCCXXXI]
SALMO IX
Càntico trionfale a Dio per la liberazione dai nemici, e nel senso più inteso dallo Spirito Santo, per la liberazione dal demonio e dalla idolatria, operata da Cristo con la sua morte. Per ciò il titolo del
Salmo: Per gli arcani del Figlio; e nell’ Ebreo:
Per la morte del
Figlio.Per la fine:
pegli occulti (misteri) del Figlio.
1. Te, io loderò, o Signore, con tutto
il mio cuore: racconterò tutte le tue meravigli!
2. in te mi rallegrerò e tripudierò,
canterò inni al tuo nome, o Altissimo.
3. Perché tu hai messo in fuga il mio
nemico: e diverranno impotenti, e dal tuo cospetto saran dissipati.
4. Perocché tu hai presa in mano la mia
causa e la mia difesa: ti se’ assiso sul trono, tu che giudichi con giustizia.
5. Tu hai sgridate le nazioni, e l’empio
è ito in rovina: hai cancellato il nome loro in eterno e per tutti i secoli.
6. Sono senza forza per sempre le spade dell’inimico;
tu hai distrutte le loro cittadi.
7. Svanì col suono la loro memoria; ma
il Signore sussiste in eterno.
8. Egli ha preparato il suo trono per
far giudizio; ed egli stesso giudicherà il mondo con equità, giudicherà i
popoli con giustizia.
9. E il Signore è stato rifugio al
povero, aiutatore al tempo opportuno, nella tribolazione.
10. E sperino in te quei checonoscono il nome tuo, perchè tu, o Signore, non
hai abbandonato coloro che ti cercano.
11. Cantate inni al Signore, che abita
in Sion; annunziate i consigli di lui tra le nazioni;
12. Imperocché colui che fa vendetta del
sangue, si è ricordato di essi: non ha posto in dimenticanza le grida del
povero.
13. Abbi misericordia di me, o Signore: mira l’umiliazione mia per opera de’ miei
nemici.
14. Tu che mi rialzi dalle porte di morte, affinché annunzi io tutte le lodi
tue alle porte della figliuola di Sion.
15. Esulterò per la salute che viene da
te; si son sommerse le genti nella fossa, che aveano fatta. In quel laccio
stesso, che tenevan nascoso è stato preso il loro piede.
16. Sarà conosciuto il Signore, che fa
giustizia: nelle opere delle mani sue è stato preso il peccatore.
17. Sian gettati nell’inferno i
peccatori, le genti tutte che di Dio si dimenticano.
18. Imperocché non per sempre sarà dimenticato
il povero; la pazienza del povero non sarà vana per sempre.
19. Levati su, o Signore, non cresca l’uomo in possanza, sien giudicate le
genti dinanzi a te.
20. Poni sopra di loro, o Signore, un
legislatore, affinché conoscan le genti ch’elle sonouomini.
21. E perché, o Signore, ti se’ ritirato
in lontananza, ci hai negletti nel maggior uopo, nella tribolazione?
22. Mentre l’empio insolentisce, il
povero è nella fornace: sono presi nei consigli che hanno ideati.
23. Imperocché lode riscuote il peccatore nei desideri dell’anima sua, el’iniquo benedizione.
24. Il peccatore ha esacerbato il
Signore; secondo la molta sua arroganza
egli noi cercherà.
25. Dinanzi a lui Dio non è: le di lui
vie sono sempre contaminate. I tuoi giudizi son lungi dalla vista; ei trionferà
di tutti i suoi avversari.
26. Imperocché egli ha detto in cuor suo:
Io non sarò scosso, d’una in altra età (sarò) senza infortunio.
27. La bocca di lui è piena di maledizione e di amarezza e di fraude; sotto la lingua di lui, affanno e dolore.
28. Sta in agguato co’ facoltosi, all’oscuro
per uccidere l’innocente.
29. Ei tiene gli occhi rivolti contro
del povero: sta in agguato, come un leone nella sua tana. Sta in agguato per
porre le unghie sopra del povero; per porre le unghie sopra del povero,
attraendolo a sé.
30. Nei suoi lacci lo abbatterà; si
inchinerà egli, e si getterà a terra, quando si farà padrone de’ poveri.
31. Imperocché egli ha detto in cuor
suo: Dio non tiene ricordanza, ha rivolto altrove la faccia per non vedere
giammai.
32. Levati su, Signore Dio, si alzi la
mano tua; non ti scordare de’ poveri.
33. Per qual motivo ha l’empio irritato
Dio? Perché ha detto in cuor suo: Ei non faranno ricerca:
34. Tu vedi; tu l’affanno e il dolore
consideri, per abbandonar coloro nelle tue mani. Alla tua cura è rimesso il
povero; aiuto dell’orfano sarai tu.
35. Spezza il braccio del peccatore e
del maligno: si farà ricerca del peccato di lui, e non troverassi.
36. Il Signore regnerà in eterno e per tutti i secoli; nazioni, voi sarete sterminate dalla terra di lui!
37. Il Signore ha esaudito il desiderio
dei poveri: il tuo orecchio ha ascoltato la preparazione del loro cuore.
38. Per far giustizia al pupillo eall’oppresso, affinché non
seguiti più a farla da grande l’uomo sopra la terra.
Sommario
analitico
Questo salmo è un cantico di azioni
di grazie cantato da Davide dopo una qualche grande vittoria. Nel titolo, per i
misteriosi segreti del Figlio, la maggior parte degli interpreti ha intravisto la
visione di un canto di trionfo per la gloriosa vittoria riportata dal Figlio di
Dio sul principe delle tenebre nell’Incarnazione, la Passione e gli altri
misteri compiuti per la salvezza degli uomini, e soprattutto per i segreti
giudizi di Dio in favore dei buoni e contro i malvagi. Questo salmo può essere
diviso in due parti principali. Nella prima (1-12) Davide rende grazie a Dio
dei suoi benefici; nel secondo (13-39), egli implora il soccorso di Dio contro
le afflizioni presenti e future. Per maggiore chiarezza noi lo divideremo in
sei sezioni.
Sezione PRIMA
-I frutti
della Redenzione-
Davide annuncia che loda il Signore
come Salvatore, ed erompe
in azioni di grazie, di cuore, di bocca, e con le sue opere (2, 3).
Egli indica: 1) la ragione di questa
azione di grazie: il demonio messo in fuga; – l’abbattimento del demonio e del
suo seguito; – la sua completa distruzione (4) 2) La causa di queste
meraviglie, la Passione di Gesù-Cristo, per la quale il Salvatore ha interrotto
la controversia che esisteva tra Dio e l’uomo, tra l’uomo ed il demonio,
soddisfacendo alla giustizia di Dio e strappando al demonio la sua preda.
(4-5).
Sezione II
I frutti della vittoria: la predicazione degli Apostoli.
Gli Apostoli sono stati inviati: 1)
per impedire i crimini e distruggere l’impero del demonio (6); 2) per
distruggere il culto tanto rinomato degli idoli; 3) per togliere le armi ai
ribelli, distruggere le loro fortezze, annientare ogni ricordo degli idoli e
affermare la fede di Gesù-Cristo (7).
Sezione III
Gesù-Cristo,
protettore dei suoi Apostoli e dei poveri perseguitati.
I. Egli ci presenta Gesù-Cristo come
il sovrano giudice che ha stabilito un trono nei cieli, ed ha due assistenti, la misericordia
e la giustizia (8).
II. Egli lo considera giudice della
terra di sovrana equità (9).
III. Egli mette a confronto i due
avversari: da un lato
gli Apostoli, gli uomini apostolici e tutti i fedeli perseguitati; dall’altro i
tiranni, i potenti del secolo che li perseguitano: 1) Egli dichiara che i primi
troveranno rifugio ed appoggio nel tempo favorevole (10); 2) di rimando egli
esige da essi che servano il Signore sperando in Lui e celebrando i suoi
benefici (11, 12); 3) predice la punizione dei ricchi e dei potenti che hanno
perseguitato i poveri (13).
Sezione IV
Quale sarà
al termine della vita, la sorte dei giusti e degli empi.
I. Il profeta ci fa scorgere un Dio
interamente dedicato agli interessi dei giusti.
-1) Essi sono l’oggetto particolare
della sua misericordia; 2) considera attentamente le loro afflizioni (13,14);
3) Egli li toglie dalle porte della morte e li conduce fino alle porte della
Città celeste, dove li ricolma di una gioia eterna (15).
II. Descrive la rovina degli empi. –
1) … che cadranno nella fossa che
essi stessi hanno scavato, ed il loro piede sarà nella rete che essi stessi
hanno teso (16); 2) tutti applaudiranno ai giudizi di Dio su di loro (17); 3)
la giusta punizione che essi hanno ricevuto dell’oblio nei confronti di Dio, sarà
l’essere precipitati nell’inferno (18).
II. – Egli fa conoscere le cause e gli
effetti della punizione degli empi.- 1) Il povero non sarà mai dimenticato, la
speranza dell’afflitto non sarà senza ricompensa (19); .2) Dio si leverà nel
prendere la sua difesa, per giudicare e condannare i suoi persecutori (20); 3)
Egli farà sentire loro che è il loro Legislatore ed il loro Giudice (21).
Sezione V
Il profeta
si rincresce che le punizioni degli empi e dei persecutori siano differite.
.I. – Egli espone il suo pianto
con un’umile e filiale richiesta a Dio (22), ed apporta due motivi in appoggio
della sua preghiera:
1) nel suo orgoglio l’empio
perseguita il povero (23); 2) e si glorifica altamente dei desideri della sua
anima (24); 3) mentre egli si affida a Dio solo, e disdegna il proprio pensiero
(25).
II – Fa vedere l’enormità e la moltitudine
dei crimini dell’empio: che è:
1) cieco nella sua intelligenza,
dalla quale ha bandito il ricordo di Dio; 2) corrotto nei suoi desideri e nella
sua volontà; 3) i giudizi di Dio non sono nulla per lui, ed esercita la sua
tirannia su tutti quelli che considera come suoi nemici con arrogante insolenza
(26, 27); 4) la sua bocca è piena di maledizioni e bestemmie (28).
III. – Lo compara ad un leone nel suo antro, che spia la sua preda per aggredirla e ridurla in pezzi (29-31).
IV. – Indica la causa di
tutti questi crimini: l’errore insensato nel quale vivono gli empi, che Dio
cioè non si occupa delle cose umane (32).
Sezione VI
Cura paterna che Dio prende per i poveri e gli oppressi.
I- Il profeta domanda a Dio di venire in soccorso del povero oppresso ed offre tre ragioni pressanti della sua preghiera (33):
1) la blasfemia dell’empio che dice
con alterigia che Dio non recriminerà per i suoi misfatti (34); 2) il giogo
schiacciante che egli fa pesare sul povero, e che non può sfuggire riguardo a
Dio; 3) è a Dio solo che è rimessa la cura del povero, Lui solo può essere suo
appoggio e suo Salvatore (35).
.II. – Egli annuncia che le sue
richieste saranno esaudite:
1) Dio si ergerà per esercitare il
suo sovrano impero; 2) gli empi saranno distrutti (37); 3) Dio si ricorderà dei
poveri e porgerà l’orecchio ai desideri del loro cuore, giudicherà la loro
causa e porrà un termine all’oppressione dei malvagi (38,42).
Spiegazioni e Considerazioni
I. – 1-5.
ff. 1. – Dio vuole il cuore tutto intero e non vuole dividere
con nessuno ciò che Gli è dovuto « la coperta è troppo stretta, ci dice il
profeta Isaia, di modo che se due vi si riparano, uno cadrà e la coperta
stretta non può coprire l’uno e l’altro » (XXVIII, 20). – Lodare Dio con tutto
il proprio cuore, è applicarsi interamente alla lode, all’azione di grazie che
sono la parte principale della preghiera, è ricordarla interamente davanti a
Dio, in modo da poter dire come Davide: « il vostro servo ha trovato puro il
suo cuore per offrirvi questa preghiera » (II Re, VII, 27).-
Lodare Dio con tutto il cuore, significa lodarlo in ogni tempo, nella
tribolazione e nella prosperità; significa riconoscere che Dio è l’autore di
ogni dono perfetto; è comprendere e proclamare che tutte le cose sono
sottomesse al governo della divina Provvidenza (S. Agos.). La
redenzione, sintesi di tutte le meraviglie di Dio, è l’opera di misericordia
che riassume tutti i benefici di Dio.
ff. 2. – È indizio di un’anima avanzata in saggezza, il
porre in Dio tutta la propria gioia. In tal modo colui che sa rallegrarsi
perfettamente in Dio, allontana il cuore da ogni altro piacere, da ogni altra
gioia dei piaceri presenti (S. Chrys.). – Non sarà più nelle
gioie di questo mondo che mi rallegrerò, né nelle voluttà sensuali, né nelle
soddisfazioni del palato o della lingua, né nella soavità degli odori, né nel
piacere dei suoni sfuggenti, né nelle forme e nei colori del corpo, né nella
vanità della lode umana, né nel superfluo delle ricchezze temporali, né nelle
ricerche della scienza mondana, ma « io mi rallegrerò e farò accendere la mia
gioia in voi » (S. Agost.). – Coloro che amano prendere come
materia dei loro canti le persone oggetto del loro amore, hanno sempre il loro nome
sulle labbra e si consolano così della loro assenza. È ciò che fa il profeta:
egli non può vedere Dio, Lo prende a soggetto dei suoi canti, si unisce a Lui
con una unione così stretta, da un nuovo ardore ai suoi desideri e sembra
gioire della sua presenza (idem).
ff. 3. – Questo nemico per eccellenza è il
demonio, che prima della venuta di Gesù-Cristo era il maestro, il principe del
mondo, e che il Salvatore ha messo in fuga. Tutti gli altri nemici sono abbattuti
ed annientati col solo sguardo di Dio (S. Chrys.).
ff. 4. – Uno degli attributi particolare di
Dio, e che si avvicina maggiormente alla sua natura divina, è la giustizia. Gli
uomini mille volte giusti, non giudicano secondo giustizia, perché essi non
possono distinguere ciò che sia veramente giusto, tanto per ignoranza, tanto
per effetto delle loro passioni e della loro negligenza; ma Dio, che è esente
da queste imperfezioni, giudica sempre secondo giustizia, perché Egli sa
con-formarvi il suo giudizio (S.Chrys.) – Nei mali che arrivano, occorre
guardare a Dio che è nel nostro cuore, come su di un trono dal quale giudica la
nostra giustizia, cioè ciò che c’è di più giusto in noi, alfine di renderci più
conformi all’immagine di suo Figlio (Duguet).
ff. 5. – Dio non ha bisogno né di armi, né di spade, né d’arco,
né di frecce, queste espressioni sono adattate al nostro linguaggio. Egli ha
semplicemente da riprendere e fa perire coloro che meritano questo castigo (S.
Chrys.). Sull’esempio di Dio, occorre tuonare contro l’empio e la sua
empietà, distruggere l’empio, facendolo morire al peccato e passare alla vita
della grazie, cancellare il suo nome primitivo, e farne prendere uno nuovo (Dug.).
Cosa significa « il secolo dei secoli »
se non l’eternità della quale il secolo presente non ci offre, per così dire,
che l’immagine e l’ombra. (S. Agost.).
II. 6 – 7
ff. 6. – Learmi del demonio, nostro
nemico, hanno perso la loro forza per sempre. Il “forte armato” è stato vinto
da Colui che era più forte di lui. Le sue armi gli sono state tolte, come dice
Gesù-Cristo (Matt. XII, 19). – Tale è la collera di Dio, essa
distrugge, annienta tutto ciò che colpisce (S. Chrys.). – Questa
spada smussa sono i diversi errori con i quali satana fa perire le anime (S.
Agost.). – Queste città distrutte sono le assemblee di satana, città
sulle quali regna il demonio, o i consigli di inganno e di frode che hanno
luogo nei governi, nei quali il demonio ha come satelliti e ministri, ognuno
dei membri del corpo: gli occhi per la curiosità, le orecchie per i propositi
lascivi e per tutte le parole cattive, le mani per la rapina e per ogni altro
crimine odioso, e le altre membra che assecondano in questo modo il potere
tirannico di una volontà perversa. C’è dunque una città ovunque si trovino un re,
un consiglio, un ministro e un popolo. In effetti, tutte questi mali non
esisterebbero nelle città corrotte, se non esistessero prima già negli uomini,
che sono gli elementi ed i principi delle città (S. Agost.).
ff. 7. – È ancora uno dei caratteri della Provvidenza
di Dio, quella di non punire i propri nemici in segreto, affinché il castigo
degli uni possa rendere gli altri migliori. La loro rovina sarà dunque
eclatante! (S. Chrys.). – Cosa vogliono i grandi, i potenti della
terra? Fare grande strepitio. Dio permette talvolta che essi ne facciano più di
quanto essi non avrebbero osato sperare, ma quando non sono più, essi periscono
con lo strepitio che hanno fatto, la loro caduta è proporzionale alla loro elevazione,
e la memoria dell’empio – dice Sant’Agostino – si estingue con il medesimo
strepitio nel quale la loro empietà si agitava tumultuosamente (S. Agost.).
– Quanti personaggi sono passati davanti a noi con tutto il fulgore di una brillante
nomea! Si vantava in essi il loro sapere, la prudenza, la saggezza, il bel
talento dell’eloquio e dello scrivere; essi erano gli arbitri del gusto, il
centro degli affari, e ciò nonostante la loro memoria è sparita nella tomba con
un po’ di schiamazzo. Il brusio della lode si è forse prolungato ancora per
qualche giorno dopo il loro funerale, oggi il loro ricordo è perso nell’oblio,
come in un abisso. – Ecco l’opposizione che c’è tra la distruzione dei malvagi
e la durata eterna di Dio!
ff. 8. – Due motivi propri inspirano agli uomini il
timore di Dio: la grandezza della sua gloria, opposta alla bassezza della loro
natura, e la sua eterna giustizia che infligge ai peccatori terribili punizioni
(S. Chrys.). Il Signore ha preparato questo trono nel momento in
cui Egli stesso andava ad essere giudicato. Da allora Egli rende dei giudizi
segreti su ognuno di noi (S. Agost.). Ma questa predizione
abbraccia nello stesso tempo la vita presente e quella futura. Il giudizio
generale e definitivo è riservato all’altra vita, ma in questa vita Dio
esercita un giudizio parziale, e fa spesso mostrare dei tratti della sua
giustizia, affinché gli insensati non immaginino che tutto vada sulla terra
secondo il caso (S. Chrys.). – Si rappresenta spesso questo trono di potenza, di
giustizia e di verità da cui esce in ogni attimo il nostro giudizio, e da cui
uscirà un giorno la nostra sentenza definitiva, irrevocabile per l’eternità.
Tutto è preparato da ora: i supplizi, le corone, ed i giudizi (S. Chrys.).
Quanto diverso è il giudizio di Dio da quello degli uomini! (S. Agost.).
III — 9 – 13.
ff. 9. – Davide, benché re, si riconosce e si definisce povero,
considerandosi un mendicante seduto alla porta di un ricco sovrano. Noi tutti
siamo dei mendicanti davanti a Dio (S.
Agost.). – Tutti i beni
di questa vita sono più fuggitivi di un’ombra, il solo bene che ci è veramente
proprio, è la virtù che portiamo con noi ovunque andiamo, tutto il resto è
simile alle foglie degli alberi che non si vedono che all’esterno (S.
Chrys.). – Il povero per il quale la terra è niente, ed il cielo è
tutto, merita di avere Dio come rifugio e come difensore, sia in questa vita in
mezzo alle sue afflizioni, sia nel giorno della grande desolazione di tutti gli
uomini. (Dug.). – doppia convenienza, evidenzia Davide, è il
soccorso che Dio accorda, e l’opportunità del tempo in cui lo dà, cioè il tempo
dell’afflizione (S. Chrys.). – È proprio del soccorso celeste l’arrivare
sempre nel momento in cui si presenti all’uomo nel tempo più conveniente. Ausilio
intelligente: se il Signore presta man forte alla sua creatura, fa giungere il
rinforzo sempre nel momento critico e decisivo, e si può dire che la principale
efficacia dell’intervento divino consista ordinariamente nella sua perfetta
opportunità (Mgr. Pie. Inst. Sur le Jub.).
ff. 10. – Conoscere un nome, significa conoscere colui che lo
porta; un nome non è un nome per se stesso, ma per ciò che esso significa (S.
Agost.). – Non è conoscere Dio il non volere o il non osare sperare in
Lui. – Non bisogna mettere la propria speranza nelle cose che il tempo
trasporta nel suo rapido incedere, e che non conoscono che un futuro e un
passato. L’avvenire che sembra appartenere loro non è ancora arrivato, che è
già passato: lo si aspetta con avidità, lo si perde con dolore. In Dio, al
contrario, non c’è futuro che non sia già, non c’è passato che non sia più; non
c’è se non quel che c’è, e cioè l’eternità (S. Agost.). – La
principale ragione per la quale noi dobbiamo sperare in Dio, è che Egli non
abbandona mai quelli che Lo cercano. – Come possiamo cercare Dio, visto che
Egli è dappertutto? Con l’attività santa della nostra anima, con il distacco
dalle cose della terra e da tutte le preoccupazioni del secolo. Talvolta accade
di avere sotto gli occhi o tra le mani degli oggetti senza accorgercene e che
ci circondano da ogni lato, e cerchiamo ciò che abbiamo davanti a noi, perché
il nostro spirito è occupato da altri pensieri (S. Chrys.).
ff. 11, 12. – Dio abita in Sion, cioè nella Chiesa; Egli
abita in mezzo a noi, non che Egli possa essere limitato dalla nostra debole
natura, ma a causa del particolare attaccamento che Egli ha per noi (S.
Chrys.). Egli è con la sua Chiesa fino alla fine dei secoli, come un
padre, per fare del bene; come un giudice ed un protettore, per difenderla;
come uno sposo per renderla feconda, e come un pastore, per nutrirla. – È un
obbligo per i Cristiani annunziare ovunque si trovino la saggezza dei consigli
di Dio, l’altezza dei suoi pensieri, la magnificenza dei suoi disegni sulla sua
Chiesa (Duguet). Gli uomini immaginano quasi che Dio dimentichi,
perché non agisce così in fretta come essi vorrebbero (S. Agost.).
– Egli si ricorderà però a suo tempo dei cuoi fedeli servitori, che sembrava
aver dimenticato abbandonati alla malizia dei loro persecutori. Se Egli non
giudica opportuno il farlo in questa vita, si ricorderà della pazienza dei suoi
poveri oppressi (Duguet). Non si intenda qui ogni genere di
povero, ma coloro che sono poveri di spirito, secondo le raccomandazioni di
Gesù-Cristo (S. Chrys.). – Il grido dei poveri è l’affezione del
loro cuore piuttosto che il suono prolungato della loro voce (idem).
IV. — 14 – 21
ff. 13, 14. – Mai è da separare queste due cose,
la preghiera e l’umiltà; l’umiltà è come il veicolo della preghiera (S.
Crys.). – Rappresentare con umiltà a Dio la propria abiezione, è un
mezzo efficace per attirare i suoi sguardi ed il suo soccorso. – Davide non
dice soltanto « … Voi che mi liberate », ma « … Voi che mi togliete dalle porte
della morte ». La protezione di Dio non si limita a liberare i suoi servi dalle
loro prove, essa li eleva e li circonda di considerazione, di onore e di gloria
(S. Chrys.). – Dio attende talvolta fino all’estremo per venire
in nostro soccorso, ci tira fuori dalle porte della morte per dimostrarci che
Egli dà la morte e ci resuscita, che ci sprofonda fino agli inferi e che ce ne
ritrae, che guarisce in un attimo tutte le nostre ferite. – Saggio consiglio di
Dio per attirare a Lui i peccatori, è far loro annunziare la sua misericordia
dagli uomini che l’hanno già provata. Non si desideri però essere liberati dai
propri mali per manifestare le lodi di Dio.
ff. 15, 16. – È una gioia giusta e ragionevole essere salvato dalle mani
dei nemici, ma una gioia incomparabilmente più grande è quella di essere
salvati dal soccorso di Dio solo (Dug.). – Cerchiamo non di
essere salvati e liberati dai nostri mali ad ogni costo, ma secondo la volontà
di Dio (S. Chrys.). – Ben prima del castigo che Dio prepara al
peccatore, il suo crimine diviene il suo primo supplizio (Id.). –
Per consiglio della saggezza divina, ognuno viene tormentato dal suo peccato (Sap.
XI, 17). – Il castigo riservato al peccatore deriva dalle sue opere;
quelli che voglio perseguitare la Chiesa cadono nell’abisso dove essi vogliono
precipitarla (S. Agost.).
ff. 17. – Funesto accecamento dello spirito dell’uomo, è la durezza
inflessibile del suo cuore! Egli non conosce quasi Dio, quando non fa del bene;
bisogna che eserciti i suoi giudizi in modo eclatante per farsi conoscere e
sentire. Dio non ha creato né il peccato né la morte; i peccati sono dunque, in
senso stretto, le opere dei peccatori, nei quali saranno soppressi (Duguet).
ff. 18. – Per essere riprovato, il profeta non assegna
che l’oblio di Dio, come se questo solo peccato sia sufficiente per meritare la
riprovazione. – L’oblio di Dio, è principe in effetti di tutti i peccati e come
il gran cammino per l’inferno. L’oblio di Dio, che in tutti i secoli ha costituito
la grande piaga del mondo, in questi ultimi tempi in modo speciale, ci induce a
dimenticare la nostra qualità di creature. – Questo oblio, che domina in questa
cattiva porzione degli uomini che la Scrittura chiama il “mondo”, si incontra
in una moltitudine di persone che fanno professione di religione (Faber,
Il Creatore e la creatura). –
Vi sono
diverse maniere per cui gli uomini dimenticano Dio. Essi non Lo giudicano degno
che si pensi seriamente a Lui. Appena appena sono attenti alla sua verità quando
si prega, alla sua maestà quando si sacrifica, alla sua giustizia quando
colpisce, alla sua bontà quando dona; infine Lo ritengono talmente un nulla,
che essi pensano in effetti di non aver nulla da temere tanto da averLo per
testimone (Bossuet).
ff. 19. – « La pazienza dei poveri non perirà per sempre
». Questo è ben lungi dal verificarsi sempre per le cose della vita presente,
dove i nostri lavori restano sovente sterili ed infruttuosi. Con Dio non c’è nulla
di simile al timore; ciò che noi facciamo per Lui ottiene necessariamente la
sua ricompensa (S. Chrys.). – È di fede che il povero non sarà
mai eternamente nell’oblio. È di fede che la pazienza dei poveri non perirà
mai. Ed è altrettanto evidente che questi due oracoli dello Spirito-Santo non
si verificano sempre, neanche comunemente in questa vita, ed è anche per questo
che bisogna che vi sia un giudizio superiore a quello degli uomini, nel quale
si riconosca che la pazienza dei poveri non perisca affatto, cioè che Dio ha
per essa tutti gli sguardi che ha il diritto di aspettarsi un maestro
sovranamente equanime (Bourdaloue, Jug. Dern.).
ff. 20. – Èuna contraddizione tanto terrificante quanto inconcepibile, che l’uomo, vile creatura,
che trae origine dalla terra, che non è che polvere e cenere, e che è in fondo
un nulla, acquisendo il peccato, osi sollevarsi contro Dio. Desiderio
ragionevole è che egli non si raffermi in una potenza che Dio gli ha dato per
il bene, e di cui egli si serve invece per il male. Desiderio degno di un Cristiano,
è che l’uomo vecchio, con le viziose inclinazioni, non si fortifichi in noi (Dug.).
ff. 21. – Dove sono qui questi uomini brutali che trovano tutte
le leggi inopportune, e che vorrebbero vederle abolite per non accettarle se
non da se medesimi e secondo i propri desideri sregolati? Che essi si ricordino
almeno di essere uomini, e che non ricerchino una libertà che li renda simili
alle bestie. Che ascoltino queste belle parole di Tertulliano: « È ben accaduto
che Dio abbia dato all’uomo una legge … », e questo per quale motivo? Per privarlo
della propria libertà? « Niente affatto
– egli risponde – ma per testimoniargli la sua stima … ». Se Egli dunque ha
stabilito per noi delle leggi, non è per limitarci nella nostra libertà, ma per
sottolineare la sua stima per noi: ci ha voluto trattare come delle creature
intelligenti e, in una parola, trattarci da uomini. « O Dio, date loro un
legislatore, moderateli con delle leggi, affinché si sappia che sono degli
uomini capaci di ragione e di intelligenza, e degni di essere governati da una
condotta regolata … » Date loro prima un Mosè, che faccia apprendere i primi
elementi, e conduca la loro infanzia; date loro in seguito Gesù-Cristo, che
insegni loro in età più matura, e li conduca alla perfezione; e così farete
conoscere che Voi li trattate da uomini, cioè come creature che avete formato a
vostra immagine, e dei quali volete anche formare i costumi secondo le leggi
della vostra eterna verità (Bossuet, I S. pour une velure, Serm. Pour la
Purification). – Cosa strabiliante è che sia tanto difficile convincere
gli uomini circa questa verità così elementare, che essi cioè non sono che
degli uomini. – Nulla dimostra meglio la loro debolezza, la loro ignoranza, la
loro miseria, triste frutto del peccato originale che ha alterato le nostre
facoltà e degradato i nostri sentimenti, fino a veder perdere finanche la
coscienza della propria natura, dandosi ad eccessi inauditi ed a disconoscere
se stessi (S. Chrys.). – Quando l’uomo rivendica l’indipendenza
nei confronti di Dio, quando vuole porsi al di sopra o solamente al di fuori di
Lui, l’Essere necessariamente deve Egli stesso riportare la sua creatura alla
ragione, ricondurla ad un sentimento più vero e più modesto di quello che è e
di quello che può. « Levatevi o Dio, e che l’uomo non si affermi in questa
attitudine orgogliosa ». Che le nazioni siano entro i vostri limiti, e sappiano
che le loro dimensioni non oltrepassano la dimensione dell’uomo (Mgr.
Pie, Sur les malheurs actuels de la France).
V. — 22-32
ff. 22. – È permesso, senza cadere nel mormorio,
lamentarsi con Dio e domandargli con rispetto e sottomissione, perché si sia
allontanato da noi. Gesù-Cristo stesso ce ne ha dato l’esempio sulla croce.
Talvolta è utile conoscere la cause di questo allontanamento per porvi rimedio:
interrogare la coscienza, sondare il proprio cuore, vedere quale amore vi
predomini, chiedere lumi a Dio per conoscere queste cause (Duguet).
ff. 23. – L’empio a cui l’orgoglio eleva il cuore alla
vista del felice successo della propria empietà, il povero scandalizzato e come
consumato dalla apparente felicità di quest’empio, sono entrambi ingannati nei
pensieri che vanno meditando: l’empio perché il successo dovrebbe farlo tremare
piuttosto che alimentare il suo orgoglio; il povero perché questo successo non
dovrebbe scardinare la sua fede (Duguet). – Orbene, come dice il
Santo Agostino, i disegni colpevoli dei peccatori diventano delle catene per
essi, perché essi si compiacciono di atti che non solo non hanno timore di
veder censurati, ma che intendono anche lodare (S. Agost.).
ff. 24. – Che c’è di più comune, ma di più funesto degli
applausi che un peccatore riceve a causa della sua iniquità! Si ricevono tante
lodi ed ammirazioni per delle azioni che dovrebbero coprirlo di vergogna e di
confusione … Ecco ciò che deplora il Profeta, che il vizio sia divenuto molto
potente nel compiacersi in se stesso, nell’ostentarsi con sicurezza e, ciò che
è più triste ancora, di non vederlo arrossire, anzi che dico, di sentire che si
faccia l’elogio da se stessi e dagli
altri.
ff. 24, 25. – I difetti del ricco e del potente, sono delle
perfezioni; i suoi errori delle luci; Si lodano – dice il Re-Profeta – finanche
i desideri del suo cuore, cioè finanche le sue passioni, perfino le sue
escandescenze. Quello che si biasima negli altri, è per lui materia di elogi e
soggetto di benedizione (Bourdal, Sur les rich.). –Nessuno c’è che
non feliciti il colpevole che prospera nella sua via, che non trovi nulla per cui
vendicare, onde punire i suoi difetti, ma solo degli adulatori per lodarlo. C’è
allora la collera più terribile del Signore. È una prova che il peccatore abbia
irritato il Signore, il sopportare Egli tutto con indifferenza, il non essere
più giudicato degno di punizioni mediante le quali correggere i colpevoli … l’ultimo
effetto della collera del Signore è quando Egli si mette più in afflizione per
il peccatore, quando sembra cioè dimenticare le sue colpe e non farne più
alcuna attenzione, quando infine lo abbandona ai desideri del suo cuore (S.
Agost.). Misericordia apparente, è questa, mille volte più temibile
della giustizia più terribile. È una maniera nuova di vendicarsi che appartiene
a Dio solo: lasciare a riposo il suo nemico, nascondere in sé tutta la sua
collera, di modo tale che il peccatore sia stupefatto delle ampie prosperità e
del corso fortunato dei propri affari, immaginando così di non aver nulla da
temere, e non sentendo alcun rimorso nella propria coscienza (Bossuet).
ff. 26, 27. – Ecco i tristi frutti del vizio, ed in primo
luogo l’accecamento del peccatore. La luce dello spirito si spegne, la forza
della ragione si indebolisce, l’anima diventa schiava dell’iniquità e resta
costantemente annegata nel vizio. Per colui che ha cessato di aver Dio davanti
agli occhi, non c’è altra alternativa di vizio e di virtù, perché è sempre
sotto la schiavitù odiosa del vizio; egli non pensa né all’inferno, né al
giudizio prossimo, né al conto che dovrà rendere, si scrolla come un freno
odioso i pensieri che gli sarebbero di prezioso aiuto. Egli è come un navigante
che ha perso la sua zavorra e diventa il giocattolo del furore dei venti e
della violenza dei flutti, senza guida per dirigere e condurre l’imbarcazione (S.
Chrys.). – « I vostri giudizi sono cancellati davanti ai suoi occhi ».
L’anima che ha coscienza dei suoi peccati, e che non si sente colpita da
nessuna punizione, crede che Dio non lo giudichi; ed è così che i giudizi di
Dio sono tolti dalla sua vista: accecamento che è già la più grave delle
condanne (S. Agost.). – Il peccatore in questa cecità, non
comprende che il suo giudizio più terribile è quello di non essere giudicato al
presente, di dominare tutti i suoi nemici, mentre egli stesso è dominato, o
piuttosto tiranneggiato, dalle sue passioni (Duguet).
ff. 28. – Cosa c’è di più irragionevole di un
uomo la cui esistenza è tanto fragile, che è come avvolto dagli interessi di un
giorno, sottomesso a mille cambiamenti, esposto a tutti gli accidenti di questa
vita, e che possa immaginare di restare sempre nel medesimo stato? Si crede facilmente
a ciò che si desidera! – Egli si forma, con l’abitudine al peccato, una sorta
di baldanza che sfida la Provvidenza, che non prevede né le sue vendette
segrete, né i suoi giudizi pubblici e manifesti (Berthier).
ff. 29. – Dopo gli effetti del peccato nei
riguardi di Dio, vengono gli effetti rispetto al prossimo. Il Profeta ci ha descritto
il cuore dell’empio dimentico di Dio e dei suoi giudizi, che confida orgogliosamente
nell’avvenire, e ci fa ora conoscere i suoi discorsi. – Le maledizioni sono
bestemmie contro Dio ed ingiurie contro gli uomini; l’amarezza nelle parole
sono le maldicenze, le mormorazioni, le liti; l’inganno comprende le calunnie,
la menzogna, lo spergiuro. Accrescere la pena, il dolore degli afflitti, ecco
lo scopo di tutte le parole dell’empio, ciò che nasconde la sua lingua, e ciò a
cui si esercita sempre (Bellarm.). – « Sotto la sua lingua sono
il lavoro e il dolore ». Molto più penosamente laboriosi sono dell’iniquità e
dell’empietà. Il dolore segue questo lavoro, perché esso non è solo
infruttuoso, ma funesto (S. Agost.).
ff. 30-33. – Alle parole fanno seguito le
azioni. La scaltrezza, la sorpresa, la violenza pubblica, gli omicidi, l’unione
con le persone potenti, tutto è messo in opera per opprimere i deboli e gli
innocenti. Il leone nella sua tana è la figura di colui che agisce con violenza
ed astuzia. La prima persecuzione portata contro la Chiesa è stata violenta,
sforzandosi con le proscrizioni, le torture e i massacri, di costringere i Cristiani
a sacrificare agli idoli. La seconda persecuzione ha impiegato la frode, ed è
stata quella degli eretici. Resta la terza, che sarà suscitata dall’anti-Cristo
e che sarà la più pericolosa di tutte, perché metterà in opera nello stesso
tempo la frode e la violenza (S. Agost.). – Questo è un quadro
troppo reale della perfidia crudele degli uomini del mondo nei riguardo di
quegli stessi che hanno dato loro confidenza. Essi si mascherano per sorprenderli,
profanano per ingannarli sotto un nome amichevole; mentre la loro bocca
sorride, essi tendono insidie nell’ombra, e quando a forza di dispute, menzogne
e basse malvagità, li hanno ravvolti nelle loro reti, tutto ad un tratto si riversano
su di essi e li divorano, come la iena divora la sua preda. Condizione
lamentevole questa, ma Dio non abbandona i suoi poveri servi in questo estremo.
– « Come il leone rannicchiato nel suo antro … » ammirabile immagine del
pericolo che ci minaccia e del quale periremo. Non sono tanto i ruggiti della
bestia che sono formidabili, ma è il suo silenzio ed il segreto del suo antro.
– D’altra parte l’impunità non sarà sempre assicurata all’empio: quando sarà
giunto a questa dominazione assoluta, quando si riterrà superiore a tutto e al
riparo da ogni sventura … è allora che Dio lo colpirà per mostrare la sua
potenza (S. Chrys.).
VI. — 33 – 42
ff. 34-36. – Perché, si domanda Davide, l’empio ha irritato
Dio? Perché egli nel suo cuore ha detto queste tre cose oltraggiose nei
riguardi di Dio. L’empio ha irritato Dio, perché ha detto nel suo cuore: non
c’è oltraggio a Dio (Sal. XIII) che non abbia voluto riconoscere.
Egli ha irritato Dio, perché nel suo cuore ha detto: se Dio c’è, o non ha
visto, o questo Dio ha dimenticato il male che io ho commesso; è un oltraggio
alla Provvidenza che egli ha combattuto e alla quale ha preteso sottrarsi. Egli
ha irritato Dio, perché nel suo cuore ha detto: quand’anche questo Dio di cui
mi si minaccia, avesse visto il mio peccato, e se ne fosse ricordato, Egli non
mi cercherà né mi dannerà per così poca cosa; questo è un oltraggio alla
giustizia vendicatrice di Dio, che l’empio ha disprezzato, e di cui ha cercato di
scuotere il giogo … Dio, nel suo giudizio, verrà per tentare di convincere
l’empio che c’è un Dio che non ha ignorato nulla, nulla dimenticato dei più
segreti disordini della sua vita. Egli verrà per confondere l’empio facendogli
vedere che questo Dio, nemico inconciliabile del peccato, non è più capace di
patire eternamente lasciando il peccatore nell’impunità, più di quanto cessi
Egli stesso di essere Dio (Bourdal, Sur le Jug. dern.). – La
pazienza di Dio, stupefacente al punto da dare luogo all’empio il credere che
Egli si sia addormentato. Ma Egli si leva quando è tempo e fa sentire, con gli
effetti della sua Onnipotenza, che Egli veglia sempre e che non ha dimenticato
i poveri (Duguet). – « Voi li vedete ed osservate i loro crimini per
metterli nelle vostre mani », cioè voi aspettate, lo sopportate fino a che essi
siano vittime dell’eccesso stesso della loro ingiustizia. Dio avrebbe potuto
punirli e perderli molto prima, ma la sua pazienza è come un oceano senza
limiti, poiché Egli li vede e non li punisce perché attende che facciano
penitenza. (S. Chrys.). – La giustizia infinitamente saggia di
Dio sa ben prendere il suo tempo per proporzionare la pena al crimine che vuole
punire, e per punirlo con le stesse cause che lo hanno fatto commettere e nelle
stesse circostanze (Duguet).
ff. 37. – « È a voi che è stata lasciata la
cura del povero », è qui la vostra opera di scelta e predilezione. Dio non ha
mancato al dovere che si è imposto. È all’architetto che spetta dirigere la
costruzione dell’edificio, al pilota governare il battello, al sole rischiarare
l’universo, ed anche a voi, mio Dio, il prendere la difesa degli orfani, il
tendere ai poveri una mano sicura; nessuno può prendersene cura più di Voi (S.
Chrys.). – Il Profeta-Re, era entrato ben profondamente nella
meditazione della durata e dell’insensibilità degli uomini, quando dice a Dio:
« O Signore, a Voi si abbandona il povero ». In effetti è vero che si cerca di
evitare lo stato di infelicità, ed ognuno che si affanna intorno alle fortune
della terra; i poveri soltanto sono reietti, solo la loro presenza dà
afflizione, non c’è che Dio solo che al loro pianto li prenda in carico. Quando
i poveri si indirizzano a noi perché li risolleviamo dalle loro necessità, non
è vero che il favore più ordinario che noi facciamo loro, è quello di augurar
loro che Dio li assista? Dio vi aiuti, noi diciamo loro; ma il contribuire da
parte nostra a soccorrerli, è il minore dei nostri pensieri … poiché tutto il
mondo li abbandona, era degno della bontà di Dio riceverli sotto le sue ali, e
prendere nelle mani la loro difesa. Così si è dichiarato loro protettore,
perché non si disprezzi la loro condizione, e si risollevi la loro dignità;
perché non si creda di non dover nulla a loro, … Egli impone la necessità di
soccorrerli (Bossuet).
ff. 39. – Ci sono due maniere per Dio per
spezzare le braccia del peccatore, di modo che non si trovi più il suo peccato:
1) sterminarlo in maniera che non resti alcuna traccia delle sue violenze e dei
suoi crimini; 2) distruggere le sue forze, la sua potenza, questo focolaio di
iniquità che lo divora, di modo che non resti più traccia del suo peccato. La
prima maniera è in effetti di una giustizia terribile; la seconda di una
misericordia infinita (Duguet).
ff. 40. – Non occorre inquietarsi quando il
castigo dei malvagi viene differito. Di che avete paura, dice il Re-Profeta, e
cosa temete? Forse Dio è un giudice passeggero e mortale? Forse che il suo
regno un giorno finirà? Dunque, benché il castigo degli empi sia differito, non
di meno è certo! Colui che gli domanderà conto dei suoi crimini, dimora e regna
eternamente (S. Chrys.). – Nazioni ribelli distrutte ed
annientate ai piedi del suo trono. Questo regno non è possibile qui in terra.
Vi sono soggetti ribelli. Esso non lo sarà perfettamente se non quando « Gesù-Cristo
avrà rimesso il suo reame a Dio e a suo Padre, ed avrà distrutto ogni impero,
ogni dominazione ed ogni potenza ». (I Cor: XV, 24).
ff. 41, 42 – Dio si compiace nell’esaudire semplici
desideri, ed il suo orecchio è così delicato che ascolta finanche la
preparazione dei cuori. È questa preparazione, questo primo desiderio, questo
proposito della vita, dei pensieri e delle opere, che deve essere santo, puro,
sottomesso a Dio e consacrato al suo culto. Quando Dio, il cui sguardo penetra
fino al fondo del nostro essere, scopre questa preparazione ben formata dalla
sua grazia nel cuore dell’anima fedele, non può rifiutargli nulla. Quale grande
consolazione è questa verità, « Dio ascolta la preparazione del loro cuore! »
Ci sono delle circostanze nella quali non si può pregare nell’assemblea dei
fedeli, non sia possibile frequentare il tempio del Signore, ma non c’è luogo
in cui il proprio cuore non possa essere rivolto verso Dio, o non possa formare
il desiderio di piacergli! Dio ascolta e ricompensa questo desiderio, questa
preparazione del cuore. È sufficiente, per piacergli, il volergli piacere, è
sufficiente essere a Lui piegato, per essere ricolmi dei suoi beni (Bourdal,
Rec. des Saints). – Il povero trionferà infine accanto a Voi, Signore:
ciò che gli avrà rifiutato ogni tribunale della terra; Voi prendete la difesa
del povero e dell’orfano, affinché il potente, il grande, che aveva tanto
abusato della sua grandezza, cessi di glorificarsi. Fino ad allora egli avrà
sempre avuto il sopravvento; fin qui, fiero dei suoi successi, perché nulla gli
resisteva, egli sarà passato non solo per il più forte, ma per il più abile,
per il più stabile nei suoi diritti, come il più degno di essere distinto ed
onorato; fino ad allora egli si sarà costituito una falsa gloria ed un presunto
merito delle sue stesse violenze; ma Voi lo disingannerete allora., Signore, e
gli farete abbattere le sue vane idee. E come? Perché sottrarrete il debole dall’oppressione,
ed egli troverà in voi, o mio Dio, un vendicatore ed un protettore (Bourdal).