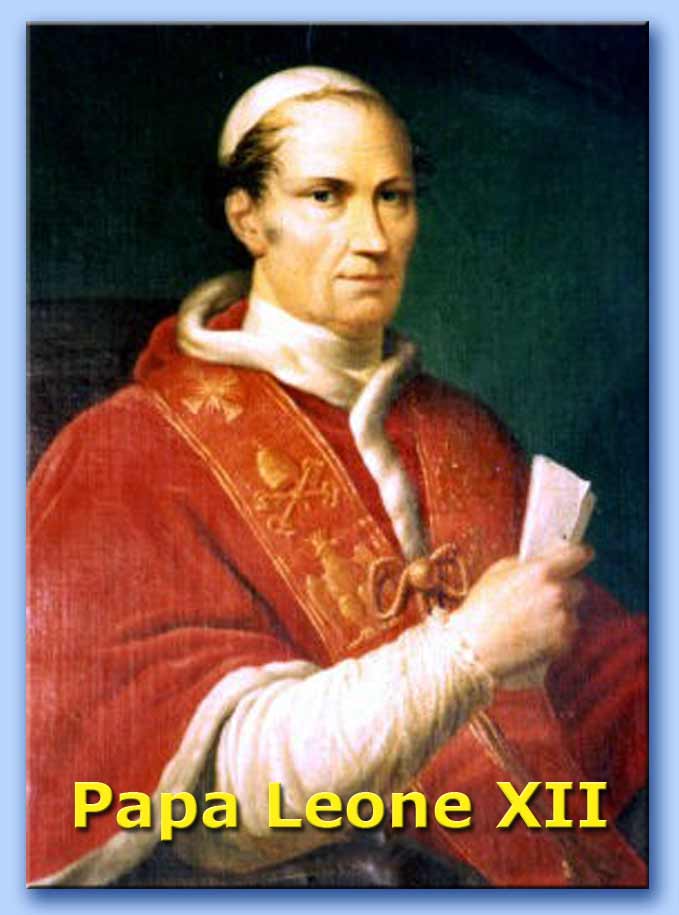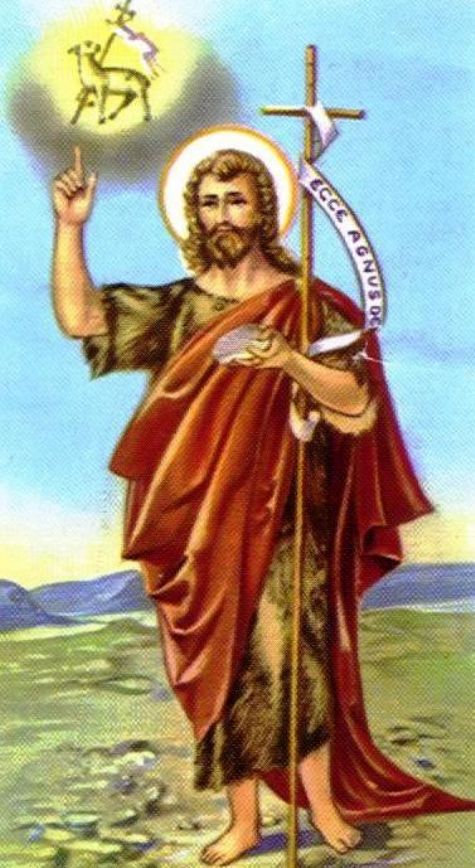CATECHISMO CATTOLICO A CURA DEL CARDINAL PIETRO GASPARRI (21)
PRIMA VERSIONE ITALIANA APPROVATA DALL’AUTORE 1932 COI TIPI DELLA SOC. ED. (LA SCUOLA) BRESCIA
Brixiæ, die 15 octobris 1931.
IMPRIMATUR
+ AEM. BONGIORNI, Vic. Gen
TESTIMONIANZE DEI CONCILI ECUMENICI DEI ROMANI PONTEFICI, DEI SANTI PADRI
DOMANDA 39a
Concilio Lateranense IV (1215), cap. 2:
« Ebbene, noi, coll’approvazione del sacro universale Concilio, crediamo e affermiamo con Pietro (Lombardo) che esiste un essere unico e supremo, incomprensibile a dir vero e ineffabile ed è in verità il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo: tre Persone unite e insieme distinte ognuna delle medesime: e perciò c’è in Dio soltanto una Trinità, non una Quaternità, in quanto che ciascuna delle tre Persone è quell’essere, ossia sostanza, essenza o natura divina, che sola è il principio di tutte le cose e al di fuori di esso niente si può trovare; e quell’essere non è generante, né generato, né procedente, ma è il Padre che genera e il Figlio che è generato e lo Spirito Santo che procede, dimodoché c’è distinzione nelle Persone e unità nella natura. Altro è dunque il Padre, altro il Figlio, altro lo Spirito Santo, non però altra cosa; ma l’essere, che è Padre, è il Figlio è lo Spirito Santo perfettamente identico, com’è da credere, secondo la ortodossa dottrina cattolica, che sono consostanziali. Difatti il Padre, generando dall’eternità il Figlio, a Lui diede la sua sostanza, secondo quanto Egli stesso attesta: Più grande di tutto è ciò che diede a me il Padre (Jo., X , 29). Né si può dire che gli abbia dato una parte della sua sostanza, ritenendone una parte per sé, in quanto la sostanza del Padre è indivisibile, perché semplicissima: né che l’abbia trasferita, per generazione, al Figlio, rimanendone privo, che avrebbe cessato Esso stesso d’essere una sostanza. È chiaro dunque che il Figlio, nascendo, ricevette la sostanza del Padre senza diminuzione di sorta, cosicché Padre e Figlio hanno la medesima sostanza e identico essere sono il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, che ne procede. Orbene, quando la Verità prega il Padre pe’ suoi fedeli, dicendo: Voglio che siano un’unica cosa in noi, come un’unica cosa siamo anche noi (Jo., XVII, 22): questa parola « unica cosa » s’ha da intendere, riguardo a’ fedeli, per unità d’amore nella grazia, mentre per le Persone divine s’ha da intendere per identità di natura, come afferma pure la Verità in altro luogo: Siate perfetti com’è perfetto anche il Padre celeste (Matth., V, 48); quasi dicesse più chiaramente: Siate perfetti nella perfezione di grazia, com’è perfetto il Padre vostro del Cielo nella perfezione di natura, l’una e l’altra cioè a modo proprio ». (Mansi, XXII, 983 s.).
II. Concilio di Lione (1274) De processione Spiritus Sancti:
«Affermiamo con fedele e riverente professione che lo Spirito Santo procede eternamente dal Padre e dal Figlio non come da due principii, ma come da un solo, non per due, ma per unica spirazione. Così ha finora affermato, predicato e insegnato, così fermamente pensa, predica, afferma e insegna la sacrosanta Chiesa Romana, madre e maestra di tutti i fedeli; tal’è il pensiero immutabile e verace de’ Padri e Dottori ortodossi tanto Latini quanto Greci. Ma siccome parecchi caddero in errori vari per ignoranza della predetta irrefragabile verità, noi, per desiderio di precludere la via a siffatti errori, condanniamo, col consenso del sacro Concilio, e riproviamo quelli che oseranno negare l’eterna processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio, oppure temerariamente asserire che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio come da due principii e non come da unico ». (Mansi, XXIV, 81).
Concilio Fiorentino, Decretum prò Graecis:
« Nel nome della S. Trinità, Padre Figlio e Spirito Santo, col consenso di questo sacro universale Concilio Fiorentino definiamo che sia creduta e accolta questa verità di fede da tutti i Cristiani e tutti professino allo stesso modo che lo Spirito Santo è eternamente dal Padre e dal Figlio e ha la sua essenza e il suo essere sussistente unitamente dal Padre e dal Figlio e che procede eternamente dall’uno e dall’altro come da unico principio e per unica spirazione; dichiarando il pensiero de’ santi Dottori e Padri, che dicono lo Spirito Santo procedere dal Padre per mezzo del Figlio, nel senso che anche il Figlio è, secondo i Greci causa, secondo i Latini principio alla sussistenza dello Spirito Santo alla pari del Padre. E poiché il Padre, generando, diede al Figlio suo unigenito tutte quelle cose che son del Padre, tranne l’esser Padre, il Figlio dall’eternità riceve la stessa processione dello Spirito Santo da parte del Padre, che pure lo ha generato dall’eternità. Inoltre definiamo che, per chiarezza della verità e per una necessità allora urgente, fu lecitamente e ragionevolmente aggiunta al Simbolo l a spiegazione di quelle parole « Filioque ». (Mansi, XXXI, 1030).
S. Agostino, De Trinitate, I, 7:
« Gl’interpreti cattolici de libri divini vecchi e nuovi, che prima di me scrissero a proposito della Trinità che è Dio, tutti, quanti ne ho potuti leggere, intesero insegnare a norma delle Sacre Scritture che il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo coll’eguaglianza dell’unica e identica sostanza, che non ammette separazione, affermano la divina unità; sicché non sono tre dei, ma un Dio solo, benché il Padre abbia generato il Figlio e perciò non sia il Figlio chi è il Padre; e il Figlio sia stato generato dal Padre; perciò il Padre non sia chi è il Figlio; e lo Spirito Santo non sia né il Padre, né il Figlio, ma soltanto lo Spirito del Padre e del Figlio, anch’Egli uguale al Padre e al Figlio e appartenente all’unità della Trinità ». (P. L., 42, 824).
S. Epifanio, Ancoratus, 8:
« Ciascuna di queste denominazioni è singolare, né ha nulla che dall’altra sia significato. Difatti il Padre è padre e non ha nulla che gli sia stato posto a confronto, o congiunto con altro padre, per non essere eventualmente due gli dei. Il Figlio unigenito, Dio vero da Dio vero, senz’appropriarsi il nome di Padre, né tuttavia estraneo al Padre, ma nell’unica sussistenza del Padre, è l’Unigenito per esser Figlio di singolare e propria denominazione; ed è Dio da Dio affinché l’unico Dio si chiami Padre e Figlio. E lo Spirito Santo unico, senza usurpare né il nome del Figlio né quello del Padre, ha nome Spirito Santo, senza essere estraneo al Padre. Difatti lo stesso Figlio unigenito così parla: Lo Spirito del Padre (Jo., XV, 26); e ancora: Che procede dal Padre (ib.), e ancora: dal mio riceverà (ib., XVI, 14 s.); dimodoché non lo si ritenesse estraneo né al Padre né al Figlio, ma della stessa sostanza e divinità, Spirito divino, Spirito di verità, Spirito di Dio…. Dunque c’è Dio nel Padre, c’è Dio nel Figlio, c’è Dio nello Spirito Santo, che è egualmente da Dio ed è Dio. Difatti lo Spirito di Dio è lo Spirito del Padre e lo Spirito del Figlio, non in forza d’una qualsiasi composizione, com’è in noi dell’anima e del corpo, ma perché medio tra Padre e Figlio, procedente dal Padre e dal Figlio, terzo nella denominazione ». (P. G., 43, 29).
S. Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa, I , 12:
« Il Padre è sorgente e autore tanto del Figlio quanto dello Spirito Santo, però del solo Figlio è padre e produttore dello Spirito Santo. Il Figlio a sua volta è figlio, Verbo, sapienza, potenza, immagine, splendore, figura del Padre, e dal Padre. Ma lo Spirito Santo non è figlio del Padre, ma Spirito del Padre in quanto ne procede; difatti non vi è impulso senza lo Spirito. Anzi è detto pure Spirito del Figlio, in quanto procede non da esso direttamente, ma per suo mezzo dal Padre. Difatti soltanto il Padre è autore ». (P. G., 94, 850).
DOMANDA 41a.
Concilio di Laterano (649) sotto S. Martino I , can. I , Contra Monothelitas:
« Chi non ammette, secondo il pensiero de’ santi Padri, propriamente e veracemente il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, Trinità nell’unità, e unità nella Trinità, cioè un unico Dio in tre sussistenze consostanziali e di pari gloria, l’unica e medesima divinità dei tre, natura, sostanza, virtù, potenza, regno, impero, volontà, operazione increata, senza principio, incomprensibile, immutabile, creatrice d’ogni cosa e protettrice, sia condannato ». (Mansi, X, 1151).
S. Fulgenzio, De Fide, 4:
« Poiché in quell’unico vero Dio trino è per natura vero non soltanto ciò ch’è Dio uno, ma pure ciò ch’è Trinità, perciò lo stesso vero Dio è Trinità nelle Persone e unico nell’unica natura. Per quest’unità di natura tutto il Padre è nel Figlio e nello Spirito Santo, e tutto il Figlio è nel Padre e nello Spirito Santo, e tutto lo Spirito Santo è nel Padre e nel Figlio. Nessuno di essi è estraneo a qualsivoglia di essi, perché nessuno precede l’altro nell’eternità o l’eccede in grandezza o lo supera di potenza ». (P. L., 65, 673-74).
S. Efrem, Hymnus de dejunctis e Trinitate, 11-12 :
« Il Padre genitore, il Figlio generato dal suo seno, lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio; il Padre creatore che fece il mondo dal nulla; il Figlio creatore che creò tutte le cose insieme al suo genitore. « Lo Spirito Santo paraclito e consolatore, per opera del quale viene compiuto tutto ciò che fu e sarà ed è; mente il Padre, verbo il Figlio, voce lo Spirito Santo: tre nomi un’unica volontà, un’unica potenza ». (Lamy, S. Ephr. hymni et serm., III, 2421).
S. Gregorio Nazianzeno, Oratio, XXXIII, 16:
« Essi (i fedeli) adorano come unica divinità il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio… lo Spirito Santo, unica natura in tre proprietà intelligenti, perfette, sussistenti per sé stesse, distinte sì di numero, ma non di divinità ». (P. G., 36, 235).
DOMANDA 46a.
IV Concilio di Laterano e Concilio Vaticano: Vedi D. 36.
DOMANDA 47a.
Concilio Vaticano: Vedi D. 36.
DOMANDA 48a.
S. Giovanni Crisostomo, Contra Anomeos, XII, 4:
« Non soltanto (Dio) creò la creatura, ma dopo averla creata la protegge e sostenta, angeli o arcangeli che tu voglia, o potestà superiori, o tutte quante le cose che cadono e non cadono sotto la vista: tutte usufruiscono della sua provvidenza e, supposto che siano private dell’influsso efficace di Lui, dileguano, rovinano, periscono ». (P. G., 48, 810).
DOMANDA 49a.
S. Agostino, De spiritu et littera, 58:
« Orbene, Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla cognizione della verità (I Tim., II, 4); in modo però da non toglier loro il libero arbitrio, dal cui buono o cattivo uso saranno con somma giustizia giudicati. Ciò posto, gl’infedeli operano bensì contro la volontà di Dio, se non credono al suo vangelo; ma con ciò non la spuntano, piuttosto privano sé stessi d’un grande e sommo bene e s’irretiscono in castighi punitivi e sperimenteranno tra i tormenti il potere di Colui, di cui mentre godevano i doni, disprezzarono la misericordia ». (P. L., 44, 238).
DOMANDA 50a.
S. Efrem Siro, Carmina Nisibena, III, 8 e 10:
« È noto che il buon Dio non volle i mali che in ogni tempo affliggono gli uomini, pur avendoli mandati lui; e che la causa delle nostre afflizioni sono i nostri peccati. Nessuno può lagnarsi del nostro Creatore, bensì Lui di noi, perché, peccando, l’abbiam costretto contro sua volontà a sdegnarsi con noi e a percuoterci a malincuore…. E l’uomo pure infligge castighi allo scopo di cavarne un utile. Perché ognuno castiga i suoi servi, per tenerseli soggetti; ma il buon Dio castiga i suoi servi perché essi stessi di sé siano padroni. I tuoi mali sieno altrettante ammonizioni per te ». (Ed. G. Bickell, p. 80).
DOMANDA 52a.
S. Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa, II, 3:
« Dunque l’Angelo è una sostanza intelligente, fornita di perpetuo movimento e di libero arbitrio, incorporea, a Dio ministra, immortale in sua natura per munificenza di Dio. Soltanto il Creatore ne conosce la precisa sostanza e definizione. È detta incorporea e immateriale per rapporto a noi; perché, in confronto di Dio il solo a niuno paragonabile, tutto si scopre grossolano e materiale. Soltanto la natura divina è davvero immateriale e incorporea ». (P. G., 94, 866 s.).
DOMANDA 53a.
S. Atanasio, De virginitate, 5 :
« Gran rimedio per la salvezza dell’anima è l’umiltà; satana infatti non fu precipitato dal cielo per colpa d’impudicizia o di adulterio o di furto, ma per la sua superbia finì in fondo agli abissi. Difatti queste furono sue parole: Salirò e pianterò il mio trono fuor dal paese di Dio e sarò simile all’Altissimo (Isa., XIV, 14). Per esse fu abbattuto e il fuoco eterno diventò sua porzione ed eredità ». (P. G., 28, 258).
S. Gregorio Magno, In Evangelia, I I , 34, 7, 8, 9:
« Ho detto nove le schiere degli Angeli, perché sulla testimonianza del sacro testo sappiamo che ci sono gli Angeli, gli Arcangeli, le Virtù, le Potestà, i Principati, le Dominazioni, i Troni, i Cherubini e i Serafini. « Bisogna pur sapere che il vocabolo « Angeli » è denominazione dell’ufficio, non della natura. Difatti que’ santi spiriti della patria celeste sempre sono spiriti, ma non sempre si possono chiamar Angeli, inquantochè sono Angeli soltanto allor che annunziano qualche cosa… E quelli che annunziano le cose meno importanti, Angeli, mentre Arcangeli sono quelli che annunziano le più importanti… Perciò a Maria Vergine fu mandato non un Angelo qualsiasi, ma l’Arcangelo Gabriele. Era giusto che questo incarico fosse affidato all’Angelo più nobile, perché recava il più nobile de’ messaggi. Essi poi sono enumerati anche con nomi propri allo scopo d’indicare anche col nome la loro importanza nell’opera. Difatti Michele è detto: Chi come Dio?; e Gabriele: Fortezza di Dio; e Raffaele: Medicina di Dio ». (P. L., 76, 1249 ss.).
DOMANDA 54a.
S. Girolamo, In Matthæum, lib. III, ad cap. XVIII:
« Grande è la dignità delle anime, tale che fin dall’origine per loro custodia hanno delegato un Angelo ». (P. L., 26, 130).
DOMANDA 58a
S. Ireneo, Adv. haereses, V, 24, 3 e 4:
« Il diavolo dunque, in quanto è un Angelo ribelle, può unicamente… sedurre e traviare l’anima dell’uomo a trasgredire i precetti di Dio e a poco a poco accecare il cuore di coloro, che avrebbero disposizione a servirlo, affinché dimentichino proprio il vero Dio e adorino invece lui come dio…. Si è schierato sempre più contro l’uomo, per invidia di esso e per volerlo vincolare alla sua tirannia di ribelle ». (P. G., 7, 1188).
DOMANDA 60a.
V Concilio di Laterano (1512-1517) sess. VIII De anima humana:
« A di’ nostri (e ci duole constatarlo) il seminator di zizzania, vecchio nemico del genere umano, ha osato sovrasseminare ed aumentare nel campo del Signore taluni disastrosi errori, sempre ributtati da’ fedeli, specialmente circa la natura dell’anima razionale, che cioè sia mortale oppure unica in tutti e singoli gli uomini; e taluni avventati filosofastri affermano che, almeno in linea filosofica, ciò è vero. Desiderando prendere adatti rimedii contro siffatta epidemia, col consenso di questo sacro Concilio, condanniamo e riproviamo quanti asseriscono che l’anima intellettiva sia mortale oppure unica in tutti e singoli gli uomini, o almeno ne dubitano. Quella infatti non soltanto è davvero e per sé stessa ed essenzialmente la forma del corpo umano, com’è detto in un canone del Papa Clemente V di f. m. nostro predecessore, canone pubblicato nel (generale) Concilio di Vienna; ma è immortale e in proporzione al numero de’ corpi, cui s’infonde, volta per volta moltiplicabile e moltiplicata e da moltiplicarsi… Ora, siccome verità non può contraddire a verità, definiamo che sia affatto falsa qualunque asserzione contraria alla verità della fede illuminata; energicamente vietiamo come non lecito d’inventar dogmi differenti; e decretiamo che coloro che si ostinano ad affermare siffatto errore, sono da evitare e punire come detestabili e abbominevoli eretici ed infedeli che seminan dappertutto pessime eresie, a grave danno della cattolica fede ». (Mansi, XXXII, 842).
Pio IX, Lett. Dolore haud mediocri, 30 apr. 1860, al Vescovo di Breslavia:
« Inoltre s’è avvertito che il Baltzerin quel suo opuscolo, riducendo qui tutta la controversia, cioè se per il corpo esista un principio proprio di vita separato nella realtà dall’anima razionale, osò spingersi a tal punto di temerità da proclamar persino eretica la sentenza contraria e sostenere con un mar di parole che per tale deve ritenersi. Ciò noi non possiamo non riprovare considerando che nella Chiesa di Dio è affatto comune la sentenza di ammetter nell’uomo un unico principio della vita, cioè l’anima razionale, dalla quale il corpo riceve anche il movimento e tutta la vitalità e sensibilità; inoltre essa pare a molti dottori tra i più autorevoli indissolubilmente congiunta col dogma della Chiesa, sicché ne costituisce la legittima e sola vera interpretazione né si può rifiutare senza errore nella fede ».
(Acta Pii IX, donde fu estratto il Sillabo, Roma, 1865, p. 178).
S. Giovanni Damasceno, De fide ortodoxa, II, 12:
« Orbene l’anima è vivente, semplice e incorporea sostanza, che sfugge per sua propria natura alla percezione della vista corporea, immortale, fornita di ragione e d’intelletto, che fa uso del corpo fornito di organi al quale corpo conferisce la vita, lo sviluppo, la sensibilità e la potenza di generare; e non ha una mente diversa da sé e separata, dal momento che la mente altro non è che una parte sottilissima di essa: ciò che rappresentano gli occhi nel corpo, ciò è la mente nell’anima; possiede il libero arbitrio e potenza di volontà e d’azione ». (P. G., 94, 923, s.).
DOMANDA 62a.
Benedetto XII, Costit. Benedictus Deus, 29 giugno 1336:
« Per mezzo di questa costituzione, valevole per sempre, definiamo con autorità apostolica: secondo l’universale disposizione di Dio, le anime de’ Santi tutti, morti prima della passione del Signor nostro Gesù Cristo, e similmente le anime de’ santi Apostoli, martiri, confessori, vergini e altri fedeli defunti dopo ricevuto il sacro battesimo di Cristo, se in punto di morte non ebbero nulla da purgare, o non ci sarà quando, anche in avvenire, morissero, oppure — se allora ci fu o ci sarà — quando si siano, dopo morte, purgate; inoltre le anime de’ fanciulli rinati pel medesimo battesimo di Cristo e da battezzarsi, che muoiono, una volta battezzati, prima dell’uso del libero arbitrio, tutte quante furono sono e saranno in cielo subito dopo la loro morte e subito dopo la purificazione accennata per quelle, che di siffatta purificazione avevan bisogno, anche prima di ricongiungersi al loro corpo, cioè prima del giudizio generale, dall’Ascensione in qua del Salvatore e Signor nostro Gesù Cristo; e furono sono e saranno associate in compagnia de’ santi Angeli al regno de’ cieli e al celeste paradiso con Cristo; e dopo la passione e morte del Signore Gesù Cristo, videro e vedono la essenza divina per via d’intuizione e anche faccia a faccia, esclusa ogni intermedia creatura in linea e in ufficio di oggetto della visione, ma per immediata e nuda e chiara e scoperta manifestazione ad esse della divina essenza; e le anime così veggenti godono della divina essenza; e per effetto di tal visione e godimento le anime de’ defunti son davvero felici e hanno vita e riposo in eterno; e anche le anime di quelli che moriranno in futuro, contempleranno la medesima divina essenza e ne godranno prima del giudizio generale; e la visione e il godimento dell’essenza divina renderà superflui per esse gli atti di fede e di speranza, in quanto fede e speranza son propriamente virtù teologiche; e dacché sarà stata o sarà incominciata la detta intuitiva visione e il detto godimento in quell’anime medesime, la medesima visione e godimento perdura di continuo, senz’alcuna interruzione, o attenuazione di detta visione e godimento, e continuerà sino alfin al giudizio e da quel momento in perpetuo. – « Inoltre definiamo che, secondo l’universale disposizione di Dio, l’anima di chi muore in peccato mortale attuale subito dopo la sua morte discende all’inferno, dov’è tormentata dalle pene infernali, e che nondimeno nel giorno del giudizio tutti gli uomini compariranno coi loro corpi dinanzi al tribunale di Cristo per render ragione del fatto loro, affinché ciascuno manifesti di sé stesso come operò, sia bene sia male (II ai Cor., V , 10) » .
(Bullarium Romanum, ed. Torino, IV, 346 a.).
S. Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa, IV, 27 :
« Quelli che avranno ben operato, rifulgeranno come il sole cogli angeli nella vita eterna, col nostro Signore Gesù Cristo per veder sempre e sempre esser veduti e per godere gioia indefettibile, lodandolo per secoli interminabili col Padre e con lo Spirito Santo » .
DOMANDA 63a.
S. Pio V, Costit. Ex omnibus afflictionibus, 1 ott. 1567, nella quale si condannano i seguenti errori di Baio:
« 1. Non si chiamano rettamente grazia i meriti né degli angeli né del primo uomo ancora innocente.
« 2. Come l’opera cattiva per natura sua è meritoria di morte eterna, così per natura sua l’opera buona è meritoria di vita eterna.
« 3. La felicità sia per gli angeli buoni, sia per il primo uomo, se avesse perseverato in quella condizione, era una ricompensa, non una grazia.
« 4. La vita eterna fu promessa all’uomo, in istato d’integrità, e all’angelo in vista delle opere buone; e le opere buone, secondo legge di natura, bastano per sé stesse a conseguirla.
« 5. Nella promessa fatta sia all’angelo sia al primo uomo è osservata e implicita la disposizione di giustizia naturale, in forza della quale la vita eterna è promessa ai giusti in ricompensa delle buone opere senz’altro riguardo.
« 6. Per legge di natura fu stabilito all’uomo che, se perseverava nell’obbedienza, sarebbe giunto alla vita immortale.
« 7. I meriti del primo uomo non decaduto furono doni della prima creazione; ma, secondo il linguaggio della S. Scrittura, non giustamente si chiaman grazia; perciò devon chiamarsi soltanto meriti, non anche grazia.
« 8. Nei redenti per la grazia di Cristo non può riscontrarsi alcun merito buono che non sia conferito gratuitamente a un immeritevole.
« 9. I doni concessi all’uomo non decaduto e all’angelo forse con qualche ragione posson dirsi grazia; ma poiché, secondo il linguaggio usuale della S. Scrittura, col nome di grazia s’intendono soltanto que’ doni, che son conferiti per merito di Gesù Cristo agl’immeritevoli e agl’indegni, perciò né i meriti, né la ricompensa, che loro è conferita, si deve dir grazia.
« 11. Il fatto che, per aver vissuto piamente e da giusti in questa vita mortale sino alla fine della vita, conseguiamo la vita eterna, non si deve propriamente ascrivere alla grazia di Dio, bensì a naturale disposizione, da Dio con giusto giudizio stabilita fin dal primo momento della creazione; e in questa ricompensa de’ buoni non si guarda al merito di Cristo, ma solamente alla prima costituzione del genere umano, nella quale fu stabilito per legge naturale che la vita eterna giusto giudizio di Dio sia conferita all’osservanza de’ precetti ». (Du Plessis, Collectio Judiciorum, III, II, 110 ss.).
Clemente XI, Costit. Unigenitus, contro gli errori di Quesnel, 8 settembre 1713, prop. 35 tra le condannate:
« La grazia in Adamo è conseguenza della creazione ed era dovuta alla natura sana e integra ».
(Id., ibid. III, I I, 462).
Pio VI, Costit. Auctorem fidei contro gli errori del Sinodo di Pistoia, 20 Ag. 1794, 16a . tra le proposizioni condannate:
« La dottrina del sinodo circa lo stato di fortunata innocenza, qual è presentato in Adamo prima del peccato, cioè in guisa da comprendere non soltanto l’integrità, ma pure la santità interiore con islancio a Dio per amor di carità, e inoltre una specie di ricostituzione, dopo la caduta, della primitiva santità; tal dottrina presa nel suo complesso insinua che quello stato fosse un corollario della creazione, dovuto per natural esigenza e condizione della natura umana, non un beneficio gratuito di Dio: è falsa, già condannata in Bajo e Quesnell, erronea, favorevole all’eresia pelagiana ».
(Bullarii Romani Continuatio, ed. Prati, t. VI, p. III, 2710).
DOMANDA 65a.
S. Giovanni Crisostomo, In Genesim, XIII, 1 :
« Hai visto come in grazia della parola ogni cosa è stata formata? Ma vediamo che cosa dica poi a proposito della creazione dell’uomo. E Dio formò l’uomo. Bada come, col temperar le parole, di cui si serve per adattarsi alla nostra insufficienza insegna tanto il modo quanto la diversità della creazione, in virtù della quale, per esprimermi umanamente, lo addita formato, a così dire, dalle mani di Dio, come s’esprime il profeta: Le tue mani m’hanno fatto e plasmato (Giobbe, X, 8) ». (P. G., 53, 106).
DOMANDA 66a.
S. Efrem, In Genesim, cap. 2:
« Veniamo a intendere che Adamo per tre capi fu creato a immagine e somiglianza di Dio. Ma non credere che sia chiamata immagine di Dio la esterna apparenza di Adamo, bensì l’anima formata del libero arbitrio, di potenza e d’impero sopra le altre creature; ossia, come ogni cosa è in mano e in potere di Dio, così ad Adamo fu soggettato il mondo. Anche ricevette pura e integra l’anima, quindi capace d’ogni virtù e divino carisma; finalmente l’intelletto e la ragione, colla quale capisce, distribuisce e ordina tutte le cose e talmente riesce a svolgersi in ogni senso e a formarsi d’ogni cosa l’immagine da sembrare che tutto sia come contenuto in lui solo ».
( S . Ephrem, Opera omnia, ed. Romana, I, syriace et latine, 128).
S. Basilio, Sermo asceticus, I:
« L’uomo fu fatto a immagine e somiglianza di Dio, (Gen., I, 26), ma il peccato, derivato da un trasporto dell’anima verso viziosi desiderii, deturpò la bellezza di quell’immagine. Orbene, Dio, che creò l’uomo, è vera vita. Pertanto colui che ha perduto la somiglianza di Dio, ha perduto anche la partecipazione della vita; chi poi è lontano da Dio non può vivere una vita felice. E allora ritorniamo allo stato primitivo di grazia, donde per il peccato siam decaduti; e di nuovo abbelliamoci a immagine di Dio ». (P. G., 31, 870, ss.).
S. Agostino, Enarratio in Ps. 49, 2:
« È chiaro, dunque, se li ha chiamati dei, che sono stati deificati dalla sua grazia e non generati dalla sua sostanza. Come difatti è atto a giustificare soltanto chi è giusto per se stesso e non per dono altrui, così a deificare è in grado solo colui che per sé stesso è Dio, non per partecipazione altrui. Ora chi giustifica anche deifica perché colla giustificazione rende figli di Dio. Diede infatti a loro la possibilità di diventar figli di Dio (Giov., I , 12). Se siam divenuti figli di Dio, siamo anche divenuti dei, ma per grazia dell’adottante, non della natura generatrice ». (P. L., 36, 565).
DOMANDA 74a.
Il Concilio Cartaginese ( 418) approvato da Zosimo, can. 2 contro i Pelagiani:
« Così pure fu decretato che sia scomunicato chiunque sostiene che i neonati non devono esser battezzati, oppure che sono bensì battezzati per la remissione dei peccati, ma che da Adamo non derivano pur l’ombra di colpa originale da espiarsi col lavacro di rigenerazione, sicché logicamente per essi la forma del battesimo « per la remissione de’ peccati » , s’intende non vera, ma falsa. Dacché il detto dell’Apostolo: Per via d’un solo uomo entrò nel mondo il peccato e per via del peccato la morte e così passò di uomo in uomo a tutti, perché in esso tutti peccarono (Ai Rom., V, 12) non ha da intendersi se non come l’intese sempre la Chiesa universale diffusa dappertutto. Di fatto per questa regola di fede anche i bambini, che in sé stessi nemmeno hanno ancor potuto commettere peccato di sorta, perciò son battezzati per la remissione, de’ peccati in quanto che in essi vien purificato per mezzo della rigenerazione ciò che contrassero per generazione ». (Mansi, III, 811).
II° Concilio di Orange (529) confermato da Bonifacio II, contro i Semipelagiani:
« Can. I. Chi afferma che per il peccato di prevaricazione d’Adamo non fu cangiato in peggio tutto l’uomo, cioè anima e corpo, ma, rimanendo invulnerata la libertà dell’anima, ammette soggetto a corruzione soltanto il corpo, contraddice, ingannato dall’errore di Pelagio, alla S. Scrittura, che dice: Perirà proprio l’anima che ha peccato (Ez., XVIII, 20); e: Non sapete che, se ad uno vi rendete schiavi in obbedienza, schiavi rimanete di lui, al quale obbedite? (ai Rom., VI, 16); e ancora: Uno è dichiarato schiavo di colui, dal quale è vinto (I P di Piet., II, 19).
« Can. 2. Se alcuno afferma che soltanto ad Adamo, non alla sua discendenza, recò danno la sua prevaricazione, o almeno confessa che soltanto la morte del corpo, pena del peccato, non però anche il peccato, morte dell’anima, si sia propagato dal primo uomo al genere umano tutto, fa ingiustizia a Dio, perché contraddice all’Apostolo, il quale afferma: Per via d’un sol uomo entrò il peccato nel mondo e, per il peccato, la morte, e così la morte si propagò a tutti gli uomini, perché in quello tutti peccarono. (Ai Rom., V, 12) ». (Mansi, VIII, 712).
Concilio Fiorentino, Decretum prò Jacobitis:
« Crede fermamente, professa e insegna che nessuno mai, concepito di uomo e di donna, fu liberato dal dominio del demonio, se non per merito del mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo Signor nostro, il quale, concepito senza peccato, nato e morto, da solo colla sua morte abbatté il nemico del genere umano, distruggendo i nostri peccati e dischiuse l’ingresso al regno de’ cieli, che il primo uomo con tutta la discendenza per cagione del proprio peccato aveva perduto. E tutte le sacre espressioni del Vecchio Testamento, i sacrifici, i sacramenti, le cerimonie additarono in antecedenza che un giorno sarebbe venuto ». (Mansi, XXXI, 1738).
Concilio di Trento, sess. V, Decretum de peccato originali:
« 1. Chi non professa che il primo uomo Adamo, dopo aver trasgredito nel Paradiso il comando di Dio, perdette all’istante la santità e giustizia, nella quale era stato stabilito, e che per tale colpa di prevaricazione incorse nell’ira e nello sdegno di Dio e perciò anche nella morte, che già prima Dio gli aveva minacciata, e insieme colla morte nella schiavitù del tiranno, che poi ebbe dominio di morte, cioè il Diavolo; e che tutto Adamo, anima e corpo, per quella colpa di prevaricazione fu cangiato in peggio, sia scomunicato.
« 2. Chi asserisce che la prevaricazione d’Adamo abbia soltanto a lui nociuto, non alla sua discendenza; che per sé soltanto e non anche per noi abbia perduto la santità e la giustizia da Dio ricevuta e poi perduta; o che, infettatosi egli per il peccato di disobbedienza, abbia trasfuso per tutto il genere umano soltanto la morte e le pene corporali, non invece il peccato, che è morte dell’anima, sia scomunicato, perché contraddice al detto dell’Apostolo: Per via d’un sol uomo entrò il peccato nel mondo e, per il peccato, la morte, e così la morte si propagò a tutti gli uomini, perché in quello peccarono tutti (Ai Rom., V, 12).
« 3. Chi asserisce che il suddetto peccato di Adamo, che è unico quanto all’origine e trasmesso a tutti per propagazione, non per imitazione, vale a dire proprio a ciascuno, si tolga o con le forze dell’umana natura, o con altro rimedio, che non siano i meriti del mediatore unico, Signor nostro Gesù Cristo, che nel suo sangue ci riconciliò con Dio, divenuto per noi giustizia, santificazione, redenzione (Ia ai Cor., I , 30); oppure nega che proprio il merito di Gesù Cristo si applica tanto ai bambini quanto agli adulti, per mezzo del Sacramento del Battesimo ritualmente conferito nella forma della Chiesa, sia scomunicato; difatti non c’è altro nome dato agli uomini sotto il cielo, nel quale possiamo noi salvarci (Atti, IV, 12). Quindi quel grido: Ecco l’agnello di Dio, ecco chi toglie i peccati del mondo (Giov., I, 29). E quell’altro: Tutti voi, che siete stati battezzati, vi siete rivestiti di Cristo (Ai Gal., III, 27).
« 4. Chi afferma che i neonati, fossero pure quelli di genitori già battezzati, non si devono battezzare; oppure che si battezzano sì per la remissione dei peccati, ma non contraggono da Adamo ombra di peccato originale, da doversi espiare nel lavacro di rigenerazione per ottenere la vita eterna; sicché logicamente la formola del Battesimo « in remissione de’ peccati » per essi ha da intendersi non vera, ma falsa, sia scomunicato; di fatti non altrimenti deve intendersi quel detto dell’Apostolo: Per via di un sol uomo entrò nel mondo il peccato e per il peccato la morte, e così la morte si propagò a tutti gli uomini, perché in quello tutti peccarono (Rom., V, 12), se non come sempre lo ha inteso la Chiesa universale diffusa dappertutto. Difatti in forza di questa norma di fede, secondo la tradizione degli Apostoli, anche i bambini, che nemmeno furono in grado mai di commettere da sé stessi peccato, perciò sono battezzati per la remissione de’ peccati in quanto che si purifica per rigenerazione in essi ciò che contrassero per generazione. Infatti se uno non rinasce nell’acqua e nello Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio (Gio., III, 5).
« 5. Chi sostiene che la colpa del peccato originale non viene rimessa, per la grazia di Gesù Cristo nostro Signore, la quale vien conferita nel Battesimo; oppure asserisce anche che non vien tolto tutto ciò, che ha vera e propria ragion di peccato, dicendo invece che semplicemente vien cancellato, o non imputato: sia scomunicato. Difatti in chi è rinato pel Battesimo Dio non ha nulla da odiare, perché in essi non vi è più causa di dannazione, dal momento che davvero sono stati sepolti insieme con Cristo a morte per virtù del Battesimo (Rom., VI, 4); che non vivono più secondo la carne (Rom., VIII, 1), ma smesso l’uomo vecchio e rivestito il nuovo, che fu creato secondo il disegno di Dio (Ef., IV, 22) son divenuti innocenti, immacolati, puri, senza colpa e cari a Dio, eredi di Dio e coeredi di Cristo (Rom., VIII, 17); sicché niente più impedisce loro l’ingresso al cielo. Questo santo Sinodo invece professa e pensa che ne’ battezzati rimane la concupiscenza, ossia fomite, la quale, siccome rimane per il combattimento, non può nuocere a chi non consente, ma virilmente s’oppone per la grazia di Gesù Cristo; che anzi chi combatterà lealmente, sarà coronato (II Tim., II, 5). Questa concupiscenza l’Apostolo qualche volta la chiama peccato; orbene il sacro Sinodo dichiara che mai la Chiesa Cattolica intese chiamarla peccato perché davvero e propriamente sia un peccato, ma perché deriva dal peccato e al peccato induce. Che se alcuno pensa il contrario, sia scomunicato.
« 6. Tuttavia questo sacro Sinodo dichiara che non intende di comprendere in questo decreto, dove si parla del peccato originale, la beata e immacolata Vergine Maria, madre di Dio; ma che siano osservate le Costituzioni di Papa Sisto IV di f. m., sotto le pene che vi si contengono e che ora rinnova ».
Pio IX, Allocuz. Singulari quadam, 9 die. 1854:
« E questi seguaci, o meglio idolatri, della ragione umana, che se la propongono come una vera maestra e sotto la sua guida si ripromettono ogni prosperità, hanno certamente dimenticato quanto grave e dolorosa ferita sia stata inflitta all’umana natura dalla colpa del progenitore, in quanto la mente fu ottenebrata e la volontà divenne proclive al male. Perciò anche i più famosi filosofi fin da’ tempi più antichi, pure scrivendo di cose eccellenti, tuttavia contaminarono i loro insegnamenti con errori gravissimi; e di qui quell’incessante lotta, che sperimentiamo dentro di noi, così rappresentata dall’Apostolo: Sento nelle mie membra una legge che ripugna alla legge della mia coscienza (Rom,, VII, 23) ».
(Acta Pii IX, p. I, I, 624).
S. Cirillo Alessandrino, In Epist. ad Rom., al V, 18 :
« Ma noi siam divenuti peccatori per la disobbedienza di Adamo in questo modo preciso: egli era stato creato sì per la vita incorruttibile, e innocenti erano i suoi costumi nel paradiso delle delizie, intenta sempre alla contemplazione di Dio la mente, intatto e calmo il corpo, scevro d’ogni turpe piacere, perché non vi ribollivano passioni. Ma, poiché cadde in peccato e fu soggetto a corruzione, subito irruppero nella corporal natura le impure compiacenze e scaturì dentro noi la fiera legge delle membra. Dunque la natura per la disobbedienza d’un solo, cioè d’Adamo, contrasse il morbo del peccato, e così molti furono i costituiti nella condizione di peccatori, non perché abbian peccato in compagnia di Adamo, dal momento che ancor non esistevano, ma perché son della stessa natura di Adamo, caduta sotto la legge del peccato ». (P. G., 74, 790).
DOMANDA 75a.
Concilio di Trento: V. Dom. 74a.
Sisto IV, Costit. Cam præexcelsa, 28 febbr. 1476:
« Riteniamo giusto, anzi un dovere d’invitare con le indulgenze e col perdono de’ peccati tutti quanti i fedeli di Cristo, affinché ringrazino e lodino il Signore Dio onnipotente…. per la mirabile concezione dell’Immacolata Vergine e offrano le Messe e gli altri divini uffici a questo fine stabiliti e vi prendano parte ».
(Extra comm., III, 12, 1 e 2).
Pio IX, Costit. Ineffabilis Deus, 8 dic. 1854:
« A onore della santa e individua Trinità, a decoro e splendore della Vergine Madre di Dio, per l’esaltazione della fede cattolica e l’accrescimento della cristiana religione, coll’autorità del Signor nostro Gesù Cristo, de’ beati Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dichiariamo, proclamiamo e definiamo che la dottrina secondo la quale la beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezione fu, per singolar grazia e privilegio di Dio onnipotente, in vista de’ meriti di Cristo Gesù Salvatore del genere umano, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, è dottrina rivelata da Dio e perciò i fedeli tutti la devono credere fermamente e costantemente. Quindi coloro che presumeranno (Dio non voglia) pensare diversamente da quanto Noi abbiam definito, conoscano e sappiano bene che, condannati dal loro stesso giudizio, essi hanno fatto naufragio circa la fede e si sono separati dall’unità della Chiesa e inoltre, con ciò, da sé stessi vanno soggetti alle pene stabilite dal diritto, se a parole o per iscritto o con qualsiasi mezzo esteriore oseranno significare quel che pensano in cuor loro ». (Acta Pii IX, p. I, I, 616).
S. Efrem, Carmina Nisibena, XXVII, 8:
« Davvero tu (Signore) e la madre tua siete i soli belli in tutto; difatti non c’è ombra in te, Signore, e nessuna macchia nella madre tua ».
(Ed. G. Biekell, p. 122-123).
S. Agostino, De natura et gratia, 42:
« Eccettuata dunque la santa Vergine Maria, della quale per onor di Dio non voglio nemmeno discutere, quando si parla di peccati (e difatti donde possiam sapere che maggior grazia le sia stata concessa per vincere in ogni parte il peccato, dal momento che meritò di concepire e generare Chi sappiam bene che non ebbe peccato?) dunque, eccettuata la Vergine, se potessimo radunare e interrogare tutti que’ santi e sante se fossero o no senza peccato, quando vivevano in terra, che cosa crediamo che risponderebbero? Forse quel che afferma costui (Pelagio) oppure l’apostolo Giovanni? Di grazia, non esclamerebbero a una voce, per quanto grande sia stata in questa vita l’eccellenza di santità: Se dicessimo che non abbiam peccato, c’inganniamo da noi stessi e non è in noi la verità ( I Giov., I , 8) ». (P. L., 44, 267).
IL CATECHISMO CATTOLICO DEL CARDINAL GASPARRI (22)