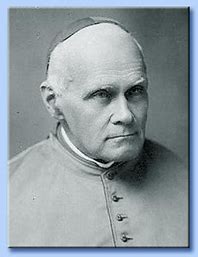CARDINAL LOUIS BILLOT S.J.
LA PARUSIA (9)
PARIS – GABRIEL BEAUCHESNE – Rue de Rennes, 117 – 1920
ARTICOLO NONO
LA PARUSIA NELL’APOCALYPSE. IL VERO SOGGETTO DELLA GRANDE PROFEZIA DEL NUOVO TESTAMENTO
“Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere, e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. Questi attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte. Perché il tempo è vicino”. È così che inizia l’Apocalisse. (I; 1-3). Ed ecco come termina (XXII, 5-20): « Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo Angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra breve. Ecco, io verrò presto e la mia retribuzione è con me per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io, Gesù, ho mandato il mio Angelo, per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese … Si, Io verrò presto, Amen: Venite Signore Gesù. » Come possiamo vedere, la dichiarazione della fine è solo una ripetizione di quella fatta all’inizio. E questa dichiarazione, che apre e chiude l’Apocalisse, che la inquadra nella sua totalità e abbraccia tutto il suo contenuto, che è la prima e l’ultima parola, l’alfa e l’omega, si presenta così come qualcosa di primaria importanza nell’economia del libro. Questa non è una caratteristica accidentale che può essere trascurata e messa da parte, un dettaglio aggiunto incidentalmente, un accessorio infine, senza connessione con l’argomento principale. Al contrario, essa è un punto essenziale tra tutti gli altri, che si riferisce a tutta la rivelazione che San Giovanni, attraverso il ministero dell’Angelo, ha ricevuto da Gesù Cristo: in cui, di conseguenza, siamo costretti a vedere un’indicazione data sul significato generale della profezia, una luce gettata sulle sue oscurità, e una chiave che dovrebbe servire ad aprirne gli arcani. D’altra parte, sono da rilevare due affermazioni molto chiare e categoriche: la prima è che gli eventi oggetto delle predizioni apocalittiche dovevano accadere presto, quæ oportet fieri cito; la seconda è che anche Gesù sarebbe venuto presto, portando con sé la sua ricompensa, per rendere a ciascuno secondo le sue azioni, (ecce venio cito, et merces mecum est reddere uninique secundum opéra sua). E queste due affermazioni, considerate soprattutto come completantesi ed illuminantesi l’un l’altra, sembreranno senza dubbio a molti giustificare le idee moderniste sull’annuncio, negli scritti del Nuovo Testamento, di una parusia molto prossima. Infatti, non dobbiamo pensare di discutere qui il significato della parola “presto” (ταχύ, ἐν τάχει – taku, en takei), che deve ovviamente essere presa nel suo senso ovvio e naturale, senza che ci sia motivo di appellarsi, per uscire dalla difficoltà, alle parole di San Pietro, che dice che “per il Signore, un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno”. Perché una cosa è stimare il tempo in relazione all’eternità di Dio, un’altra è valutarlo in relazione a noi altri che siamo soggetti ad esso. È abbastanza comprensibile che quando si parla di Dio, si dica che davanti a Lui, e in relazione all’eternità che gli è sempre presente, tutto è breve. Ma quello che certamente non capiremmo più è che Dio, parlando con noi, usasse la stessa misura, una misura che, riassumendo tutti i tempi allo stesso modo, eliminerebbe anche tutte le differenze; e se, per indicarci gli eventi che devono avvenire, per esempio, tra mille, diecimila, centomila anni da ora, ci assicurasse di arrivare presto, e che il tempo sia vicino. Molto meno capiremmo se insistesse sulla prossima data degli eventi annunciati, con quel lusso di espressioni che si notano negli ultimi versi dell’ultimo capitolo, dove la vicinanza è confermata, assicurata, inculcata una dopo l’altra, in tutti i modi possibili, fino a cinque volte consecutive: quæ oportet fieri cito (versetto, 6) ed ecce venio velociter (versetto 7); tempus prope est (versetto 10); ecce venio cito (versetto 12); etiam, venio cito (versetto 20). Abbiamo bisogno di altro? Bene, qui c’è ancora di più. Infatti, mentre a Daniele fu detto, quando ricevette l’annuncio profetico della persecuzione di Antioco, che era essa stessa il tipo e come l’abbozzo della suprema persecuzione dell’anticristo: Sigillate la profezia, perché il tempo è lontano (Dan., VIII, 26, confrontare con XII, 4, 9); ora, al contrario, è detto a San Giovanni (Apoc, XII, 10): Non sigillate le parole della profezia di questo libro, come se questo libro dovesse rimanere chiuso per molto tempo. E la ragione di ciò gli viene subito data: perché il tempo in cui deve venire l’adempimento delle predizioni in esso contenute, è vicino … tempus enim prope est. Questo implicava, nel modo più formale e ovvio, che se le cose rivelate a Daniele gli erano state annunciate in un futuro lontano, non era così per quelle rivelate a San Giovanni, che avrebbero cominciato a svolgersi immediatamente dopo di lui. Ecco, dunque i due punti su cui si basa tutta la difficoltà dell’Apocalisse, e che dobbiamo ancora chiarire in questi ultimi articoli: primo, l’annuncio del prossimo compimento delle predizioni apocalittiche; secondo, l’annuncio della venuta di Gesù per rendere a ciascuno secondo le sue opere. E poiché entrambi questi punti richiedono una spiegazione separata, li esamineremo separatamente, uno dopo l’altro, cominciando dal primo, che è anche il principale, mentre il secondo ha bisogno solo dei principi precedentemente enunciati per essere illuminato, i quali, come vedremo, troveranno, nell’Apocalisse stessa. una nuova, formale e definitiva consacrazione.
****
Tra i pregiudizi sui libri della Sacra Scrittura, non ce n’è uno più diffuso di quello che ritiene che l’Apocalisse sia, o esclusivamente, o almeno nella sua parte principale, la profezia della fine dei tempi, dei suoi precursori, degli eventi che la precederanno, delle catastrofi che la annunceranno. Infatti, chiedete alla maggior parte di coloro che si interessano di questioni religiose, e che ne hanno qualche conoscenza, e con pochissime eccezioni, vi diranno che, prima di tutto, l’Apocalisse è un libro sibillino che non si dovrebbe nemmeno tentare di decifrare, poiché tutti coloro che hanno tentato di farlo hanno fallito miseramente; che, inoltre, se la comprensione di esso è forse riservata al futuro, per il momento almeno, solo una cosa si sa vagamente di esso: Che sono predizioni riguardanti l’Anticristo, le ultime lotte della Chiesa, la persecuzione suprema, la venuta di Enoch ed Elia, l’apparizione del Giudice dei vivi e dei morti, le assise generali dell’umanità, con le pene e le ricompense eterne che seguiranno. Ma quanto strana, quanto incredibile, quanto soprattutto paradossale, apparirebbe loro l’opinione di chi, sostenuto anche dalla grande autorità di Bossuet, tenterebbe timidamente di sostenere che la parte dell’Apocalisse direttamente e immediatamente rivolta agli ultimi giorni, occupa nel libro il posto di soli dieci versetti, esattamente gli ultimi nove del capitolo XX! Sicuramente, come a San Paolo che pronunciava nell’Areopago la parola della resurrezione dei morti, gli sarebbe stato detto di tornare per farsi sentire un’altra volta, tanto grande e considerevole è il potere del pregiudizio comunemente ricevuto. Ora, la scuola modernista non poteva non sottolineare questo pregiudizio nella questione della parusia, e cercare in esso una base di argomentazione molto sicura. E infatti, è così se fosse vero che la fine del mondo è l’oggetto, o l’unico o almeno il principale, delle predizioni dell’Apocalisse; se invece, come abbiamo chiaramente dimostrato sopra, queste stesse predizioni vi sono state indiscutibilmente date come prossime a realizzarsi, ne consegue strettamente che, secondo le nostre Scritture, il mondo, al tempo di mondo, al tempo delle visioni di Patmos, era alla vigilia della sua fine e la grande rivelazione di Cristo stava per avere luogo. Così tutta la questione attuale si riduce ad un punto un punto: qual è il vero oggetto delle previsioni apocalittiche? È la fine del mondo? Allora non ci resta che chinare il capo e pronunciare la sentenza. È, al contrario, qualcos’altro? Allora la difficoltà crolla, come crolla un edificio quando crolla la sua base. La questione merita quindi di essere esaminata da vicino, e per circoscrivere meglio il campo su cui la discussione deve concentrarsi, cominciamo con un rapido sguardo sul piano e alla divisione della grande profezia del Nuovo Testamento. – Come osserva Bossuet all’inizio del suo ammirevole commento, le funzioni del ministero profetico si riducono a tre principali, la prima delle quali era di rimproverare, ammonire ed esortare; la seconda, di predire e annunciare il futuro; la terza, di confortare e incoraggiare con la promessa delle ricompense. Quindi non cerchiamo altrove il piano e l’ordine dell’Apocalisse, questa incomparabile profezia, il culmine e il coronamento di tutta l’opera degli antichi profeti. E infatti, dopo il capitolo I, che occupa il posto di un prologo o di una prefazione, troviamo gli avvertimenti e le esortazioni. Questi riempiono i capitoli II e III, dove San Giovanni è incaricato di inviare ai sette Vescovi dell’Asia i rimproveri o gli elogi che le loro chiese meritavano, con le raccomandazioni appropriate alle condizioni di ciascuna di esse. Poi vengono in secondo luogo le predizioni, che sono di gran lunga la parte più considerevole dell’opera, e vanno dal capitolo IV al capitolo XX compreso. Tutti questi sono tratti da quel libro del futuro, chiuso e sigillato, che nessuno poteva aprire o guardare, ma che, quando fu dato nelle mani dell’Agnello per rompere i suoi sigilli (V, vv. 1-1.0), lasciò fuoriuscire i suoi misteriosi segreti. Infine, ecco, in terzo luogo, le promesse della felicità futura, di cui ci viene data un’immagine deliziosa negli ultimi due capitoli XXI e XXII, dove la Gerusalemme celeste appare « tutta bella e perfetta nella riunione di tutti i Santi, e la perfetta assemblea di tutto il Corpo mistico di Gesù Cristo ». Tale, dico, è la divisione molto naturale dell’Apocalisse, e si vedrà subito, da questa rapida esposizione, che non è né la prima né la terza parte, ma solo la seconda, quella delle predizioni, che è ora in questione. Bisognerà eliminare i capitoli iv e v, che non sono che un preludio dedicato a rappresentare la scena della visione, e a descrivere l’apparato della scena in cui l’Agnello, il protagonista divino, riceve dalle mani di colui che era seduto sul trono il libro misterioso, i cui sigilli stava per sciogliere. Così, alla fine, la serie di oracoli riguardanti gli eventi a venire inizia esattamente con il sesto capitolo, e termina definitivamente con il ventesimo. È dunque sui quindici capitoli inclusi e compresi in questi due termini estremi, che riguarda la questione posta sopra; voglio dire la questione di sapere se è vero, sì o no, che, secondo il pregiudizio volgare, le predizioni apocalittiche sono direttamente rivolte, o nella loro totalità, o nella loro parte maggiore e principale, alla catastrofe suprema e agli eventi precedenti. A questo rispondiamo senza esitazione con una negazione assoluta, che sarà giustificata, se non ci sbagliamo, dalle molte ragioni che saranno proposte alla considerazione e alla riflessione del lettore.
***
E prima di tutto un’osservazione preliminare. Se mai c’è stata una profezia che, secondo i principi spiegati all’inizio di questo studio, possa essere ben compresa solo a posteriori, cioè alla luce dei fatti compiuti (almeno nella sua totalità e nella connessione delle sue varie parti), questa deve essere, prima di tutte le altre, quella dell’Apocalisse. Questo è evidente dal modo in cui è scritta, dallo stile enigmatico con cui essa è scritta, dai simboli, dalle immagini e dalle metafore che sono interamente sui generis, e con cui è avvolta e velata dal principio alla fine: in breve, da tutto ciò che fece dire a San Girolamo … che essa conteneva tanti misteri quante erano parole, tot sacramenta quot verba. E non ci sarebbe già qualcosa per escludere a priori l’ipotesi di un’Apocalisse che abbia per unico, o almeno principale oggetto, ciò che doveva accadere solo quando il mondo fosse giunto al punto stesso di finire? Perché, ci si chiede subito, quale utilità avrebbe potuto avere allora … ugualmente nessuna, come sembrerebbe, sia che ci collochiamo prima o dopo l’evento: se ci si colloca dopo, infatti, in tale ipotesi, il tempo successivo sarebbe solo quello della vita futura, per la quale non sono fatte, ovviamente, le profezie; ed ugualmente se ci mettiamo innanzi, poiché non sembra che, senza il filo conduttore dei fatti compiuti, arriveremo mai ad un’interpretazione, non dico congetturale e fantasiosa, di cui non sappiamo cosa farcene, ma certa e autentica, di tante figure misteriose che formano un labirinto ancora più complicato, e più oscuro di quello da cui Arianna tempo addietro, diede a Teseo il mezzo per uscire. – Inoltre, non è questa l’unica ragione dell’idea così generalmente diffusa, alla quale abbiamo accennato sopra? Dico di questa idea che ritiene l’Apocalisse una logografia incomprensibile e indecifrabile, per non dire altro, una specie di rebus che può servire tutt’al più ad esercitare l’immaginazione degli oziosi, i quali, non avendo nulla da fare nel mondo finché dura, pretendono almeno di insegnargli quando e come finirà: creatori chimerici di interpretazioni ancora più chimeriche. Ma ora chiedo a tutti coloro che credono nell’ispirazione delle nostre sacre Scritture: è possibile che questa fosse la vera e reale condizione di un libro di cui Dio stesso era l’autore, e che ha dato, come tutti gli altri, alla sua Chiesa come mezzo per insegnare, convincere, correggere e istruire, secondo le parole di San Paolo a Timoteo: Omnis scriptura utilis ad docendum, ad arguendum, ad erudiendum in justitia? Certamente, porre la questione in questi termini è già risolverla, e immagino che coloro che parlano dell’incomprensibilità senza speranza dell’Apocalisse, difficilmente potranno fare a meno di vedere qui tutto ciò che l’ipotesi conterrebbe di non plausibile, o meglio, inammissibile. Che questa sia la prima indicazione che essi possono sbagliarsi sul vero oggetto della profezia di San Giovanni, e che la collocano molto male in un futuro dove i fatti della storia non dovrebbero mai servire a trovare il filo di tanti oracoli, la maggior parte dei quali sono così disparati e oscuri, e dove non ci sarebbe spazio per nient’altro che interpretazioni oziose, appoggiate su nessun fondamento oggettivo fermo e sicuro. Ma, ripeto, questa è solo un’osservazione preliminare, e sarà valida solo, se si vuole, contro gli avversari, come pura e semplice presunzione. Veniamo ora ad argomenti più attuali, e cominciamo a stabilirne la base, quella base solida che, come è stato appena detto, mancherà sempre a chiunque si lanci nell’esegesi apocalittica sulla base del solo testo, indipendentemente da qualsiasi direzione o informazione tratta dalle fonti della storia.
***
Se ripercorriamo i grandi eventi della storia dai tempi di San Giovanni a Patmos fino ai nostri tempi moderni, non ne troveremo certamente nessuno che eguagli in importanza e portata il crollo dell’Impero Romano, sotto i colpi duplici dei Barbari all’inizio del quinto secolo, e della decomposizione che, seguitane, portò infine, contro ogni aspettativa, alla formazione dei vari regni della cristianità, emersi uno dopo l’altro da questo immenso caos. Sia che si prenda il punto di vista dello storico, sia che si risalga con il teologo alle ragioni ultime delle cose, da entrambe le parti si arriva alla stessa conclusione, quella di un evento assolutamente ineguagliabile. Per lo storico, sarà la scomparsa definitiva della civiltà antica, che lascia il posto ad una civiltà completamente nuova, cioè ad uno stato sociale regolato d’ora in poi secondo i principi e le leggi del Vangelo. Per il teologo, sarà la sorprendente realizzazione delle linee principali del del piano divino, così a lungo segnato nelle antiche profezie, e specialmente in quella di Daniele, sulla successione degli imperi, quando il colosso che era apparso in sogno a Nabucodonosor, “fu ridotto alla polvere sottile che il vento estivo porta via“, e « la pietra che aveva colpito la statua divenne una grande montagna, e riempì tutta la terra. » Ebbene, è questo fatto, immenso, il più vasto, il più fecondo della storia, che, alla luce della storia stessa, la troveremo predetta nell’Apocalisse, e con tale chiarezza, tale abbondanza di prove, tale precisione di dettagli, che sarà impossibile per il più cieco non riconoscerla. È l’evento “maestro” che occupa il posto principale nella profezia di San Giovanni, che ne dà anche la chiave, ne indica il significato, e dal punto centrale in cui è collocato, getta luce su tutto il seguito, in modo sufficiente, almeno, che nessun dubbio possa rimanere sul vero e proprio oggetto delle predizioni apocalittiche. – Apriamo dunque questa misteriosa Apocalisse nei capitoli XVII e XVIII, che sono precisamente il punto centrale da cui abbiamo detto che la luce deve venire, e vediamo lì, in primissimo luogo, presentata sotto il nome mistico di Babilonia, Roma imperiale, la Roma dea della terra e delle nazioni, la madre dell’idolatria e la persecutrice dei santi. Siamo nel punto della visione in cui sette angeli hanno appena ricevuto sette coppe piene dell’ira di Dio, con l’ordine di versarle sulla terra (XVI, 1). Dio si è ricordato della grande Babilonia, che ha fatto bere a tutti i popoli il vino del furore della sua prostituzione (XVI, 8), e ora le darà da bere il vino dello sdegno della sua ira (XVI, 19). È allora che uno dei sette Angeli si avvicina a San Giovanni e gli dice (XVII, 1 sqq.): Vieni, ti mostrerò la condanna della grande prostituta che siede sulle grandi acque, con la quale si sono corrotti i re della terra… E vidi – continua San Giovanni – una donna seduta su una bestia di colore scarlatto, piena di nomi blasfemi, che aveva sette teste e dieci corna. E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, di pietre preziose e di perle, e aveva in mano un vaso d’oro pieno dell’abominio e dell’impurità della sua fornicazione. E questo nome era scritto sulla sua fronte: Mistero: la grande Babilonia, la madre della fornicazione e delle abominazioni della terra. E vidi la donna inebriata del sangue dei Santi e del sangue dei martiri di Gesù… Allora l’Angelo mi disse: Ti svelerò il mistero della donna e della bestia che la porta, che ha sette teste e dieci corna… Le sette teste sono sette montagne (o colline) su cui la donna siede… E la donna che hai visto è la grande città che regna sui re della terra. Certamente, ecco ciò che sembrerebbe non dare adito ad equivoci, poiché in caratteristiche così marcate, chi non riconoscerebbe nella mistica Babilonia, la cui immagine ci viene qui presentata, la Roma del paganesimo? San Giovanni, osserva Bossuet nella sua prefazione, le dà due caratteri che non permettono di disconoscerla. Perché in primo luogo (XVII, versetto 9), è la città dei sette colli (una caratteristica topografica universalmente accettata come caratteristica di Roma); e in secondo luogo (versetto 18), è la grande città che comanda tutti i re della terra (un altro carattere, di natura politica, che al tempo di San Giovanni era ancora più evidente, e più certo). Se essa è rappresentata anche sotto la figura di una prostituta (verso 1), riconosciamo lo stile ordinario della Scrittura, che contrassegna l’idolatria con la prostituzione. Se si dice di questa superba città fosse la madre delle impurità e delle abominazioni della terra (verso 5), è il culto dei suoi falsi dei, che ha cercato di stabilire con tutta la potenza del suo impero, ad esserne la causa. La porpora di cui appare vestita (versetto) era il distintivo dei suoi imperatori e magistrati; l’oro e i gioielli di cui è ricoperta (ibid.) mostrano la sua immensa ricchezza. La parola Mistero che porta scritta sulla sua fronte (versetto 5), non ci indica nulla di più che gli empi misteri del paganesimo, di cui si era fatta la protettrice. Gli altri segni della bestia e della prostituta che essa porta sono visibilmente della stessa natura, e San Giovanni ci mostra molto chiaramente le persecuzioni che ha fatto subire alla Chiesa, quando dice che era ubriaca del sangue dei martiri di Gesù (versetto 6). » È quindi un enigma molto facile da decifrare, Roma sotto la figura di Babilonia (versetto 5). E sarà molto più facile ancora, quando si considererà che già da tempo si era stabilito nella Chiesa l’uso di riferirsi all’una con il nome dell’altra, come è perentoriamente provato dal noto passaggio di San Pietro nella sua prima Epistola: La Chiesa che è in Babilonia, cioè a Roma, ti saluta (l Petr., V, 13). Così vediamo i medesimi interpreti razionalisti, ed i più inflessibili, arrendersi a tanti segni così convergenti e così precisi; li vediamo, dico, presi in questo ambito, come per la gola, e costretti a pronunciare questo nome di Roma, che, se posso dirlo, dovrebbe strangolarli, perché equivale al riconoscimento di una delle profezie più splendide e sorprendenti dei nostri libri sacri. Infatti, qui, prima di tutto, la descrizione della grande Babilonia è seguita in San Giovanni dalla predizione del suo castigo e della sua caduta, che si è poi verificata di fronte all’universo. Questo è il soggetto del capitolo XVIII, dove troviamo i primi grandi tratti della profezia in questione e questo quando l’impero era nella sua piena fioritura, e non mostrava ancora alcun segno di decadenza, ma al contrario, la credenza nella sua perennità era così saldamente radicata nella mente degli uomini, che sia i Cristiani che i pagani, come vedremo in seguito, non le assegnavano meno che la durata del mondo: proprio allora, più di tre secoli prima dell’evento, fu rivelato a San Giovanni, e tramite lui alla Chiesa, che il colosso sarebbe caduto. – Poi, a Patmos, fu dipinto il quadro di ciò che realmente accadde sotto Alarico, quando, assediata, presa, saccheggiata, devastata dal ferro e dal fuoco, l’antica Roma ricevette il colpo fatale dal quale non si sarebbe più rialzata, e, come leggiamo in tutti gli autori contemporanei, San Girolamo, Sant’Agostino, Paolo Orose e tanti altri, il mondo intero fu terrorizzato alla vista della sua desolazione. Dopo questo – continua San Giovanni – vidi un altro Angelo che scendeva dal cielo con grande potenza. E gridò con tutta la sua forza, dicendo: La grande Babilonia è caduta, è caduta ed è diventata una dimora di demoni, una dimora di ogni spirito immondo, una dimora di ogni uccello immondo e ripugnante… E udii un’altra voce dal cielo, che diceva: “Uscite da Babilonia, popolo mio, cosicché non siate partecipi dei suoi peccati e non siate avvolti dalla sua calamità… E i re della terra, che si sono corrotti con essa, piangeranno su di lei e si batteranno il petto quando vedranno il fumo del suo incendio. Ed essi le staranno lontani, dicendo: Guai! Guai! Babilonia, grande città, potente città, la tua condanna è giunta in questo momento. E i mercanti della terra piangeranno e si lamenteranno per lei, perché nessuno comprerà più la loro merce, queste mercanzie d’oro e d’argento, di gioielli e di perle, di lino fine, di porpora, di seta, di scarlatto ed ogni sorta di legno profumato, e mobili d’avorio, di ottone, di ferro, di marmo, di cannella, di profumi, d’incenso, di vino, d’olio, di fior di farina, di frumento, di bestie da soma, di cavalli e di carri, schiavi, e di anime di uomini… Allora un Angelo forte alzò una pietra come una grande macina e la gettò nel mare, dicendo: “Babilonia, la grande città, sarà precipitata … E in quella città fu trovato il sangue dei profeti e dei Santi e di tutti quelli che furono uccisi sulla terra. Questo è l’annuncio profetico che fu ripreso trecento anni dopo dalle parole di San Girolamo, il quale, ricevendo a Betlemme la fulminante notizia dell’immenso disastro, scrisse che « la lucedell’universo si era spenta, la testa dell’impero romano tagliata, o, per parlare più precisamente, l’intero universo rovesciato in una sola città (Lib. 1 in Ezech., Proœm. 1) ».
***
Ma questo non è ancora il punto forte della profezia; né, si noti, è il punto forte della nostra dimostrazione. Inoltre, non ignoriamo che, per quanto precisi siano i caratteri che ci sono appena serviti ad identificare la Babilonia apocalittica, e di conseguenza a riconoscere, nell’annuncio della sua rovina, l’annuncio del grande evento che ha segnato nella storia gli inizi del Medioevo, non mancano menti più esigenti, alle quali non possono ancora bastare i nostri precedenti argomenti, e che vogliono vedere nella detta Babilonia, piuttosto che la Roma dei Cesari, un’entità collettiva e morale senza alcuna particolare determinazione, come sarebbe la società anticristiana in generale, altrimenti detta « la città degli uomini contrapposta alla città di Dio », il cui definitivo rovesciamento non è che da attendersi se non solo alla fine dei tempi. Ecco perché ora dobbiamo andare oltre, e portare alla luce il luogo della profezia fatto per forzare la convinzione dei più ostinati, e allontanare i rimasugli delle loro esitazioni: il luogo, dico, dove le cose sono così determinate, talmente particolarizzate, talmente circostanziate, più che il nome stesso dell’antica Roma, e ove in tutte le sue lettere vi si vedrebbe scritto che non vi potrebbe essere un’indicazione più chiara, né un’informazione più sicura. Questo luogo è quello che si interpone tra i due passaggi riportati sopra, e che, seguendo la descrizione della grande prostituta, o Babilonia mistica, precede e prepara il quadro già presentato del suo rovesciamento e della sua caduta. – Un Angelo spiega a San Giovanni (XVII, 7) il mistero della prostituta e della bestia con sette teste e dieci corna su cui essa siede: simboli entrambi – come il contesto chiarisce – di una stessa cosa, che diciamo essere la Roma idolatra ed il suo impero (« … la bestia e la donna – osserva Bossuet nel commento al capitolo XVII – sono fondamentalmente una stessa cosa… Ecco perché la bestia è rappresentata come colei che ha sette colli (versetto 9), e la donna è la grande città che domina sui re della terra (versetto 18). L’una e l’altra è dunque Roma, ma la donna è più adatta a marcare la prostituzione, che è nelle Scritture il carattere dell’idolatria. » A questo possiamo aggiungere che ogni volta che appare nell’Apocalisse una figura cavalcante, il cavalcato e la figura insieme rappresentano la stessa cosa; come per esempio nel capitolo VI, il cavallo rosso, il cavallo nero ed il cavallo pallido, ciascuno con colui che lo cavalca, rappresentano rispettivamente la guerra, la carestia e la pestilenza. E nello stesso capitolo VI, come più avanti nel capitolo XIX, il cavallo bianco con il suo cavaliere rappresenta un oggetto unico, che è Gesù Cristo vittorioso. Unico quindi sarà anche l’oggetto del mistero della donna e della bestia su cui è seduta). Nella spiegazione che dà, l’Angelo istruttore passa in rassegna successivamente le varie parti della misteriosa figura, e finalmente fermandosi sulle dieci corna della bestia, continua: « Le dieci corna che hai visto sono dieci re che non hanno ancora ricevuto il loro regno, ma che riceveranno come re, il potere nella stessa ora appresso alla bestia. Questi hanno uno stesso disegno, e daranno la loro forza e il loro potere alla bestia. Essi combatteranno contro l’Agnello, ma l’Agnello li vincerà, perché Egli è il Signore dei signori, e quelli che sono con Lui sono i chiamati, gli eletti e i fedeli. Ed egli (l’Angelo) mi disse ancora: “Le dieci corna che hai visto nella bestia, queste sono quelle che odieranno la prostituta; e la ridurranno all’estrema desolazione, la spoglieranno, ne divoreranno la carne, e la faranno bruciare al fuoco. Perché Dio ha messo nei loro cuori di fare ciò che a Lui piace, di dare la loro regalità alla bestia finché le parole di Dio non siano compiute. E la donna che hai visto è la grande città che domina sui re della terra” (XVII, 12-18) ». Ecco, ancora una volta, il passaggio essenziale in cui crediamo sia contenuto il chiaro epilogo della profezia, e sul quale dobbiamo quindi richiamare l’attenzione del lettore. E prima di tutto, ciò che appare a prima vista, è che i re in questione sono gli esecutori della vendetta divina contro la grande Babilonia rappresentata dalla prostituta e dalla bestia che la porta: esecutori che sono stati incaricati di distruggerla, e che la distruggeranno davvero, secondo quanto è scritto nella seconda metà del brano citato, ai versetti 16 e 17: odieranno la prostituta, la ridurranno all’ultima desolazione, divoreranno la sua carne, perché Dio ha messo nei loro cuori di eseguire ciò che gli piace. Certamente, non si può immaginare nulla di più esplicito, e qui certamente ogni commento sarebbe superfluo. – Ma notiamo ora le peculiarità di questi re distruttivi e i caratteri con cui ci vengono presentati. Quattro cose sono da notare. In primo luogo, la profezia li conta come dieci, decem reges sunt (versetto 12), e se questo deve essere inteso come un numero preciso, o piuttosto come un numero tondo e approssimativo, sarà sempre un numero considerevole per i re, specialmente per dei re che, sebbene indipendenti l’uno dall’altro, agiscono come se fossero in concerto, contro lo stesso nemico e nell’unità dello stesso scopo. In secondo luogo, una circostanza ancor più singolare e notevole: tutti e dieci sono dei re senza regno, qui regnum nondum acceperunt, e dovono entrare contemporaneamente, e solo dopo che la bestia sia abbattura, nel pieno possesso del potere reale, sed potestatem tamquam reges una hora accipient post bestiam (versetto 12). – In terzo luogo, e questo diventa un vero enigma di cui non si sa come accordare i dati, tanto sembrerebbero essere contraddittori; questi stessi re che ridurranno la bestia all’ultima desolazione, che divoreranno la sua carne, e sono quindi i suoi nemici implacabili, sono tuttavia presentati come essere le corna, e di conseguenza, le difese della bestia stessa; inoltre, secondo quanto è espressamente segnato, come dando ad essa, la bestia, la loro forza e la loro potenza, et virtutem et potestatem suam bestiæ tradent (versetto. 13). – In quarto ed ultimo luogo, come se tutto ciò non bastasse, questi re, ministri delle alte opere di Dio « che ha messo nei loro cuori di fare ciò che a Lui piace », si dice tuttavia che dovranno combattere contro Dio stesso, o, che è la stessa cosa, contro l’Agnello, che tuttavia li vincerà, perché Egli è il Re dei re ed il Signore dei signori, e quelli che sono con Lui sono i chiamati, gli eletti e i fedeli; cum Agno pugnabunt, et Agnus vincet illos, quoniam dominas dominorum est, el qui cum Me sunt, vocati, fidèles et electi (versetto. 14). Chi non vede che si cercherebbe invano di penetrare, con le sole risorse del testo, il mistero di una complicazione così straordinaria? Ma chi può non vedere che se la storia del passato ci presentasse da qualche parte un gruppo di eventi e di cose a cui il quadro che abbiamo appena visto è applicabile punto per punto, e in tutta l’ampiezza del quadro, non meno che nel dettaglio dei particolari più caratteristici, ci sarebbe in questo solo fatto, insieme alla prova dell’origine divina della profezia, l’indizio certo e indubitabile di quale sia il suo vero oggetto? Ebbene allora! Ecco ora, con la storia alla mano, la prova della piena realizzazione dell’ipotesi: ecco, io dico, il quadro che abbiamo appena visto, che si applica efficacemente, punto per punto, in tutta la sua estensione, fino al dettaglio delle particolarità più singolari, e con la precisione più sorprendente, a tutto quell’insieme di eventi e di cose che riempirono l’epoca notevole tra tutte le altre, della distruzione di Roma antica, dello smembramento del suo impero, e della posa delle prime fondamenta di quello che fu poi chiamato l’edificio politico della cristianità. Per giustificare questa affermazione, basterà presentare un riassunto della glossa di Bossuet sul passo che ci occupa, che unita a tutto ciò che ha già preceduto, costituirà, se non ci sbagliamo, la più convincente delle dimostrazioni (Bossuet, l’Apocalypse con una spiegazione, cap. XVII, spiegazione della seconda parte, 1).
***
Si tratta dunque di dieci re, esecutori, ripetiamolo, delle alte opere di Dio contro la grande città, madre degli abomini della terra. Decem reges sunt. Dieci re! Questo è già molto suggestivo, perché a questo numero considerevole di capi di popoli venuti da vari punti per abbattere un grande impero e stabilirsi nelle sue terre, il pensiero si riferisce al tempo dell’invasione dei barbari, e che ci piaccia o no, pensiamo subito a coloro che hanno rovinato Roma e rovesciato il suo potere, soprattutto in Occidente. Allora, infatti, si sono visti apparire, quasi contemporaneamente, i Vandali, gli Unni, i Franchi, i Burgundi, i Suebi, gli Alani, gli Eruli, i Longobardi, i Germani, i Sassoni, e più di tutti questi, i Goti, che furono i principali distruttori dell’impero. Inoltre, non c’è nulla che forzi a tormentarci nel ridurli precisamente al numero di dieci, anche se potrebbero essere ridotti a quel numero in relazione ai regni fissi che essi vi stabilirono. Ma uno dei segreti dell’interpretazione dei profeti è di non cercare finezze dove non ce ne sono, e di non perdersi in minuzie quando si trovano grandi personaggi che colpiscono l’occhio fin dall’inizio. Qui, senza bisogno di ulteriori dettagli, c’è un carattere piuttosto notevole, che da un solo impero si formino tanti grandi regni, in varie province della Spagna, in Africa, nella Gallia celtica, nell’Aquitania, nella Sequania, nella Gran Britannia, nell’Italia e altrove, e che l’impero romano sia abbattuto alla sua fonte, cioè nell’Occidente dove è nato, non da un solo principe che comanda in capo, come accade di solito, ma dall’inondazione di tanti nemici che agiscono tutti indipendentemente gli uni dagli altri. Ma andiamo sempre avanti. Questi re, che smembrarono l’Impero romano, hanno nella storia caratteri ben marcati e ben determinati. Passiamo dunque in rassegna quelli che, da parte sua, la profezia di San Giovanni attribuisce ai dieci re distruttori della grande Babilonia, confrontiamoli e vediamo se corrispondono. In primo luogo, c’è un carattere per i dieci re di San Giovanni, che consiste, come abbiamo detto, nel fatto che al momento della loro prima apparizione non avevano ancora ricevuto il loro regno, qui regnum nondum acceperunt. Ora, apro la storia, e mi chiedo se sarebbe stato possibile caratterizzare meglio la condizione di questi avventurieri, di questi capi barbari, che vediamo arrivare nei secoli IV e V sulle terre dell’Impero. Certamente, quando sono arrivati lì, non avevano ancora alcun possesso. Così, il regno che dovevano stabilire lì, non era ancora dato loro, e doveva essere effettivamente dato solo dopo la sconfitta della bestia, secondo ciò che è segnato dalle parole che seguono in San Giovanni: sed potestatem tanquam reges accipient post besitam. Ma c’è di più, perché non solo non avevano ancora alcun possesso nell’Impero, ma né nell’Impero né altrove avevano un dominio fisso. Le regioni dove intendevano stabilirsi con il loro popolo dovevano essere conquistate, ed è con grande precisione che Bossuet osserva: « I re in questione non sono re come gli altri, che cercano di fare conquiste per allargare il loro regno. Sono tutti re senza regno, o almeno senza una sede determinata del loro dominio, che cercano di stabilirsi in un paese più conveniente di quello che hanno lasciato. Non ci sono mai stati tanti re di questo carattere come durante la decadenza dell’Impero Romano, e questo è già un carattere molto particolare di quell’epoca, ma gli altri sono molto più sorprendenti. » Molto più sorprendente, infatti, è quello che San Giovanni assegna al secondo posto, e che abbiamo detto prima essere completamente intellegibile: … ed essi metteranno la loro forza e la loro potenza al servizio della bestia: et virtutem et potentiam suam bestiæ tradent. Ma come? Al servizio della bestia, proprio coloro che la profezia ci dà come suscitati da Dio per farla a pezzi e divorarla? Cos’è dunque questo mistero, e chi potrebbe conciliare cose così contrastanti? Ebbene, anche qui non dobbiamo preoccuparci di cercare, perché la storia ci libera da questa preoccupazione e ci dà la chiave dell’enigma mostrandoci gli eserciti di questi re, ricevuti all’inizio al soldo di Roma e nell’alleanza dei suoi imperatori. … « È il secondo carattere di questi re distruttivi di Roma – continua Bossuet – ed il segno dell’avvicinarsi della decadenza di quella città, una volta così trionfante, per trovarsi infine ridotta a un tale punto di debolezza, che non essa non poteva più comporre eserciti se non da queste truppe di barbari, né sostenere il suo Impero se non arruolando coloro che venivano ad invaderlo. » Questo periodo di debolezza è molto ben descritto in queste parole di Procopio: Allora la maestà dei principi romani era così indebolita, che dopo aver sofferto molto dai barbari, non trovò modo migliore per coprire la sua vergogna, che allearsi con i suoi nemici, ed abbandonare a loro anche l’Italia, sotto il titolo specioso di confederazione e alleanza … Oltre agli Alani e ai Goti, Procopio elenca anche gli Eruli e i Longobardi, i futuri padroni di Roma e dell’Italia, tra gli alleati dei Romani. Sotto Teodosio il Grande e i suoi figli, vediamo i Franchi nostri antenati avere un rango considerevole nell’armata romana sotto Arbogasto il loro capo, che poteva fare tutto nell’Impero. Gli alani e gli unni servirono contro Radagasio nell’esercito di Onorio, sotto la guida di Stilicone… I Franchi, i Burgundi, i Sassoni, i Goti sono nell’esercito di Ezio, generale romano, al rango di truppe ausiliarie contro Attila. E per attaccarci ai Goti ai quali appartiene principalmente o la gloria o il disonore di aver sconfitto Roma, li vediamo negli eserciti di Costantino, di Giuliano l’Apostata, di Teodosio il Grande, di suo figlio Arcadio… – Era dunque verissimo che Roma, in un certo tempo segnato da Dio, doveva essere sostenuta da coloro che alla fine l’avrebbero distrutta. E tutto questo è l’adempimento della profezia di San Giovanni sui dieci re: Et virtutem et potentiam suam bestiæ tradent. – Ma ecco un ultimo carattere che, chiaramente marcato in San Giovanni, è anche il più evidente nella storia, e sempre nella persona di questi stessi barbari, nemici giurati di Roma, che venivano a saccheggiare, depredare e devastare, e che finivano per stabilirsi nelle terre dell’Impero distrutto. Combatteranno contro l’Agnello, ma l’Agnello li vincerà: cum Agno pugnabunt, et Agnus vincet eos. E come combatteranno contro l’Agnello? In quanto tutti loro saranno dapprima idolatri; poi, in parte, infettati dall’arianesimo; spesso anche crudeli persecutori. Come, al contrario, saranno superati da Lui? In quanto alla fine diventeranno tutti Cristiani, tutti Cattolici, come i Goti in Spagna, i Franchi e i Burgundi in Gallia e Germania, i Longobardi in Italia, i Sassoni in Inghilterra, gli Unni in Ungheria. Perché tale fu la bella, magnifica, splendida vittoria che era opportuno che l’Agnello riportasse su di loro: ben diversa da quella descritta più avanti (XIX, 11-21), dove vediamo il Fedele e Verace che cavalca sul cavallo bianco, con occhi come una fiamma di fuoco, vestito di una veste macchiata di sangue, avendo in bocca una spada a due tagli, armata per il giudizio, la sconfitta e lo sterminio degli empi. Qui, al contrario, è l’Agnello mite, che senza dubbio ha nella sua faretra frecce affilate per trafiggere i suoi nemici e far cadere i popoli ai suoi piedi (Sal. XLIV, 6), ma frecce d’amore che cambiano i nemici in amici, e ne fanno, come dice espressamente San Giovanni qui (versetto 14), i chiamati, gli eletti e i fedeli: et qui cum eo sunt, vocati, fidèles, et electi (Si veda, specialmente questo passo, la spiegazione di un Commento all’Apocalisse attribuito a Sant’Ambrogio. Migne P. L., t. XVII, col. 914 e 915). – Concludiamo, dunque, che non c’è dubbio che l’oracolo di San Giovanni sulla grande Babilonia avesse davvero per oggetto la caduta dell’antica Roma, pagana e idolatra: dell’antica Roma, dico, che anche dopo che Costantino vi aveva eretto il vessillo della croce, nonostante la grande e gloriosa Chiesa cristiana che aveva in seno, nonostante l’esempio e le difese dei suoi ultimi imperatori, era tuttavia rimasta la prostituta che la profezia ci presenta: sempre attaccata ai suoi vecchi dei, sempre sospirando “dietro a questi amanti impuri“, sempre pronta a darsi a loro alla prima occasione, come apparve sotto Giuliano l’Apostata, sempre protestando contro l’interdetto lanciato sui templi dei suoi idoli, come si vide sotto Teodosio, per esempio, nelle sollecitazioni del Senato per il ripristino dell’altare della Vittoria. (Si vedi su questo argomento la lettera di Sant’Ambrogio all’imperatore Valentiniano. Migne, P, L., t. XVI, col. 961 sqq., e la risposta dello stesso al rapporto di Symmaco, prefetto di Roma, Ibid. 9 col. 971 sqq.), e fino al tempo stesso di Alarico, nelle violente recriminazioni di tutti diffuse e vigorosamente confutate da Sant’Agostino nella sua Città di Dio, che attribuivano all’abbandono dell’antico culto tutte le sventure dell’impero (Orosio, Hist., 1. VII, c. 37. Migne, P. L. xxxi, col. 1159).1). Concludiamo che questa caduta definitiva di Roma pagana, preludio necessario all’instaurazione del regno sociale di Gesù Cristo e della sua Chiesa nel mondo, è il grande e memorabile evento che San Giovanni aveva principalmente in vista: dal che segue, per naturale conseguenza, che è anche ciò che deve servire da chiave a tutto il resto della profezia, sia in ciò che precede che in ciò che segue.
****
E prima di tutto in ciò che precede. Perché tutto ciò che precede, dal luogo in cui iniziano le predizioni apocalittiche, ha una stretta connessione con ciò che abbiamo appena visto riguardo alla condanna e all’esecuzione della grande Babilonia, ed è per questo grande fatto, secondo la felice comparazione di Bossuet, ciò che il corpo di un poema è per la catastrofe che lo finisce e lo dispiega. Di questo non vedrei altra prova, se ce ne fosse bisogno, che la visione che apre il capitolo VI, e che ritorna di nuovo alla fine del capitolo XIX, come per racchiudere nel contesto dello stesso quadro e nell’unità dello stesso dramma, tutta la serie di visioni interposte. All’inizio del capitolo VI, in capo a tutte le visioni del futuro, subito dopo l’apertura del primo sigillo, subito dopo l’apertura del primo sigillo, appare un misterioso cavaliere montato su un cavallo bianco, come quello che avevano i vincitori nel giorno del loro ingresso e trionfo: Guardai, dice San Giovanni (VI, 2), e vidi un cavallo bianco; e Colui che vi sedeva sopra aveva un arco, e gli fu data una corona, e se ne partì come un conquistatore che va a riportare vittorie su vittorie. Et exivit vincens ut, vinceret. Questo misterioso cavaliere è evidentemente Gesù Cristo stesso, che ha già vinto la morte nella sua gloriosa risurrezione, e che è qui rappresentato nell’atto di partire per nuove vittorie, che, naturalmente, non possono essere che vittorie sull’inferno ed i suoi sostenitori, che cospirano per impedire con tutti i mezzi in loro potere l’instaurazione definitiva ed universale del regno di Dio, cioè della Chiesa, nel mondo. Quali saranno allora le visioni che seguiranno, se non tante immagini profetiche dei mezzi provvidenziali da usare per questo stabilimento e trionfo del Cristianesimo, delle sanguinose persecuzioni da subire, dei formidabili ostacoli da superare prima che questo possa essere realizzato, dei vari tipi di avversari da ridurre, e anche dei terribili giudizi che Dio eserciterà sui suoi nemici per l’esecuzione del suo piano? Ecco, dunque, gli oracoli successivi dei sette sigilli, delle sette trombe, delle sette coppe, dei tre “vae” o guai. Ecco la bestia che appare dal capitolo XIII, e prima con le sue sette teste e dieci corna, più tardi (capitoli XIV, XVI) sotto il nome mistico di grande Babilonia; più tardi ancora (capitolo XVII) come un tutt’uno con la prostituta opulenta e crudele, madre degli abomini della terra. Ecco il suo giudizio, la sua condanna, il suo castigo, il suo rovesciamento, che getta il mondo intero, come è stato detto, nella costernazione. Ecco ora, a titolo di epilogo (XIX, 1-8), l’inno di lode che i Santi del cielo cantano a Dio per questa grande opera della sua giustizia, della sua potenza e della sua mirabile provvidenza sulla Chiesa. E infine, per chiudere l’insieme di queste grandiose e terribili scene, la riapparizione del cavaliere che era apparso per la prima volta al levarsi del sipario: “Poi vidi – aggiunge San Giovanni (XIX, 11-16) – il cielo aperto, e apparve un cavallo bianco; e colui che vi sedeva sopra era chiamato il Fedele e Verace che giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco… Era vestito con una veste tinta di sangue, ed è chiamato il Verbo di Dio. E gli eserciti che sono nei cieli lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di puro lino bianco. E dalla sua bocca uscì una spada a doppio taglio per colpire le nazioni… E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti riuniti per fare guerra contro Colui che sedeva sul cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu presa… e gettata nello stagno di fuoco e zolfo. Naturalmente, sarebbe superfluo preoccuparsi di dimostrare più a lungo l’identità del cavaliere presentato qui con quello di prima, poiché è ovvio che, in entrambi i casi, si tratta di uno stesso personaggio, e che questo personaggio è Gesù Cristo. Con questa differenza, però, che all’inizio fu mostrato nell’atto di intraprendere la spedizione, e come nell’abito del guerriero che va alla battaglia, invece ora riappare di nuovo, essendo ancora, se posso esprimermi così, in tutta la foga della lotta, e con i segni sanguinosi della carneficina, ma una volta finiti lotta e carneficina, e nell’atto di consumare la vittoria. In questo modo, tutta la parte dell’Apocalisse che si estende dal capitolo VI al capitolo XIX compreso, ci presenta una raccolta compatta di fatti, eventi e cose, che culmina infine nell’esecuzione della bestia, cioè nel rovesciamento dell’antica Roma, come il termine in cui si compie ciò che San Giovanni aveva in vista, cioè: Gesù Cristo vittorioso, la sua Religione trionfante sugli ostacoli umanamente insormontabili che si opponevano al suo solido e definitivo stabilimento, ormai in grado di prendere nel mondo l’alta direzione degli affari; in una parola, satana espropriato, gettato fuori, e l’idolatria abbattuta con l’impero che la sosteneva. Questo – conclude Bossuet – è ciò che San Giovanni celebra nell’Apocalisse; è qui che ci conduce attraverso una serie di eventi che durano più di trecento anni, ed è qui che finisce finalmente la parte principale della sua predizione – (Così, la prima e principale parte delle predizioni apocalittiche avrebbe già ricevuto, e per molto tempo, almeno per quanto riguarda il suo primo e immediato significato, un pieno e completo compimento. Questo assicurerebbe all’esegeta, nei dati della storia del secondo, terzo e quarto secolo, la più sicura regola di interpretazione. Per segnalare qui, a grandi linee, solo le cose più sorprendenti: in questa luce della storia possiamo vedere in primo luogo, nei capitoli VII e VIII, la vendetta divina, che cade prima sui Giudei, così come poi sui primi autori o istigatori delle persecuzioni contro la Chiesa; Questa vendetta fu sospesa per un momento a favore dei dodicimila segnati di ciascuna delle dodici tribù, che dovevano essere separati dal resto della nazione, ma fu presto nuovamente scatenata, terribile e inesorabile, sotto Traiano e soprattutto sotto Adriano, su quegli sfortunati resti di Israele che la rovina di Gerusalemme sotto Tito aveva risparmiato. Poi nel capitolo IX vediamo, nelle locuste mistiche che escono dal pozzo dell’abisso, un altro tipo di nemico infinitamente più pericoloso, dal quale anche la Chiesa ai suoi inizi doveva trionfare: cioè le prime eresie, la maggior parte delle quali nascevano da opinioni giudaiche, e per questo sono legate nella profezia alle persecuzioni esercitate dagli stessi Giudei. Poi, con il capitolo XI, arriviamo alle persecuzioni romane, che San Giovanni riassume in quella di Diocleziano, la più lunga, la più violenta, la più crudele, la più universale di tutte, e che descrive con caratteri così precisi e particolari che, una volta conosciuta la chiave, ci sembra di vedere svolgersi dei quadri tratti dalla vita degli eventi. Ma più si va avanti, più i soggetti di sorpresa si moltiplicano. Il capitolo XIII ci mostra la bestia, cioè l’idolatria romana, ferita a morte dalla vittoria di Costantino, poi riportata in vita sotto Giuliano e, in questa sorta di resurrezione, ammirata come miracolosa, ricevente i servizi di un’altra bestia, nella quale riconosciamo la filosofia pitagorica, « … che sostenuta dalla magia, faceva concorrere i suoi ragionamenti più speciosi e i suoi prodigi più sorprendenti alla difesa dell’idolatria. » Il resto (XIV-XIX) è finalizzato direttamente al rovesciamento dell’Impero Romano come detto e spiegato sopra).
****
Ed ora, essendo il significato di questa prima e principale parte ben determinato e ben stabilito, il resto non può più fare alcuna difficoltà, perché il resto non è che la continuazione ed il completamento di ciò che precede. Il resto è il capitolo XX, dove San Giovanni, riprendendo la continuazione della sua profezia dalla caduta dell’Impero Romano, srotola la trama fino alla fine dei secoli. E infatti era naturale che, dopo aver descritto profeticamente il primo periodo della Chiesa, le sue prime lotte, le sue prime prove e quella che si potrebbe chiamare la sua prima presa di possesso del mondo, egli descrivesse anche il suo destino nel corso successivo delle epoche. Eppure egli lo fa solo in modo estremamente sommario e, per così dire, in due o tre pennellate. È come un pittore che, dopo aver dipinto con colori vivaci quello che è il soggetto principale del suo quadro, traccia ancora in modo distante e confuso altre cose più lontane da questo oggetto. Tuttavia, qualunque sia l’indeterminatezza con cui lo Spirito di Dio si è compiaciuto di lasciare quest’ultimo schizzo del futuro, noi vediamo molto chiaramente e distintamente segnati in esso altri due tempi della Chiesa che vengono dopo il tempo dei suoi primi inizi: prima, il tempo del suo regno sulla terra (versetti 1-6), e poi il tempo della sua prova suprema e più terribile (versetti 7-10), immediatamente seguito dal giudizio universale di cui San Giovanni, in conclusione, ci dà (versetti 11-15), un’immagine in riduzione. Del regno della Chiesa sulla terra (che sarà anche, come è detto al versetto 4, il regno dei santi martiri, a causa della gloria da cui saranno circondati, dei grandi onori che saranno resi loro, e dei miracoli abbaglianti con cui Dio autorizzerà il loro potere presso di lui), solo una cosa ci è rivelata qui, che sarà relativamente lungo e tranquillo. Relativamente lungo, come si vede dai mille anni attribuitigli dalla profezia, poiché questo numero, per quanto figurativo, non può ovviamente che rappresentare un periodo di durata considerevole. È anche relativamente tranquillo, come appare dall’incatenamento del drago, cioè di satana « … rinchiuso nell’abisso senza fondo, affinché non inganni più le nazioni, finché i mille anni siano compiuti. » Questo, però, deve essere inteso secondo l’ordine attuale della provvidenza, che non implica una totale esclusione dell’azione diabolica nel mondo, e tenendo conto di quel modo di parlare, frequente nella Scrittura, che consiste nel rappresentare una cosa, non tanto secondo ciò che è in sé, quanto secondo ciò che sembra essere in confronto ad un’altra. – Così ora dobbiamo vedere in questo incatenamento di satana un incatenamento relativo, cioè meritevole di questo nome solo in confronto alla libertà che gli era stata lasciata nei tempi antichi, e che gli aveva permesso di stabilire un’idolatria universalmente dominante, corrompendo tutta la terra, ovunque opprimendo e perseguitando i Cristiani. – Per quanto riguarda il tempo dell’ultima prova, che è il tempo dello scatenamento di satana e della persecuzione dell’anticristo, esso è descritto in meno di quattro versetti, ed in termini il cui significato sarebbe forse avventato, soprattutto riguardo a Gog e Magog, cercare di specificare ora. Lasciamo dunque al futuro il compito di sollevare qui il velo, e accontentiamoci di ciò che San Giovanni ha esplicitamente indicato, cioè che questa persecuzione suprema sarà breve (versetto 3), che sarà una persecuzione ancora più di seduzione che di violenza (versetto 7), e che sarà prontamente seguita dalla venuta del Giudice dei vivi e dei morti (versetto 11 e seguenti). Da tutto ciò che si è detto finora, dunque, risulta tutta la verità di ciò che dice Sant’Agostino nel libro XX della Città di Dio, cap. VIII, n. 1: che il tempo abbracciato dal libro dell’Apocalisse va dal primo avvento di Gesù Cristo alla fine del mondo, quando avrà luogo il secondo avvento. « Totum hoc tempus quod liber iste complectitur, a primo scilicet adventu Christi usque in sæculi finem quo erit secundus ejus adventus. » E da questo segue anche, per una necessaria conseguenza, la piena soluzione della prima delle due difficoltà proposte all’inizio di questo articolo, di quella che era presa da quæ oportet fieri cito: poiché si trattava di una lunga serie di eventi che si sarebbero susseguiti nel corso delle epoche, il significato di fieri cito non poteva essere che l’insieme delle predizioni si sarebbe presto realizzato, ma solo, come la natura delle cose indica abbondantemente, che l’inizio e il principio sarebbero presto arrivati. E infatti le predizioni apocalittiche riguardavano eventi che si sarebbero verificati dalla fine del regno di Domiziano – la data della rivelazione a San Giovanni – alla prima metà del quinto secolo, il tempo del crollo dell’Impero Romano, e più tardi, come è stato spiegato, alla fine dei tempi. Anche qui, dunque, l’esegesi modernista è sconfitta in tutte le sue pretese.
LA PARUSIA (10)