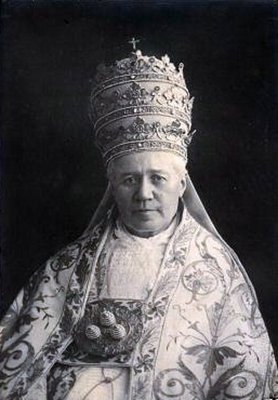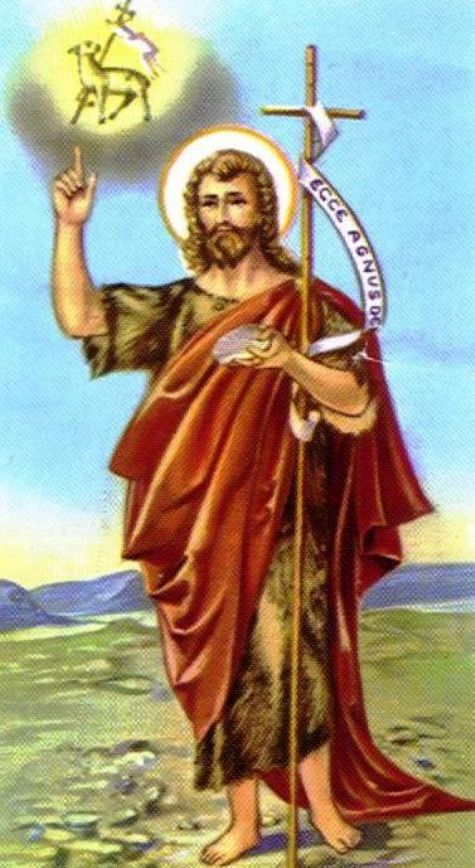DOMENICA II DI AVVENTO (2022)
Stazione a S. Croce in Gerusalemme.
Semid. Dom. privil. Il cl. – Paramenti violacei.
Tutta la liturgia di questo giorno è piena del pensiero di Isaia, (nome che significa: Domini Salus: Salvezza del Signore), che è per eccellenza il Profeta che annuncia l’avvento del regno del Cristo Redentore. Egli predice, sette secoli prima, che « una Vergine concepirà e partorirà l’Emanuele » — che Dio manderà « il suo Angelo, — cioè Giovanni Battista — per preparare la via avanti a sé (Vang.) e che il Messia verrà, rivestito della potenza di Dio stesso, (I e III antif. dei Vespri) per liberare tutti i popoli dalla tirannia di satana. « Il bue — dice ancora il profeta Isaia — riconosce il suo possessore e l’asino la stalla del suo padrone; Israele non m’ha riconosciuto: il mio popolo non m’ha accolto » (I Dom. 1° Lez. ) — « Il germoglio di Jesse — continua — s’innalzerà per regnare sulle nazioni » (Ep.) e « i sordi e i ciechi che sono nelle tenebre (cioè i pagani) comprenderanno le parole del libro e verranno » (Vang.). Allora la vera Gerusalemme (cioè la Chiesa) « trasalirà di gioia » (Com.) perché i popoli santificati da Cristo vi accorreranno (Grad. All). Il Messia — spiega Isaia — « porrà in Sion la salvezza e in Gerusalemme la gloria » — « Sion sarà forte perché il Salvatore sarà sua muraglia e suo parapetto » cioè il suo potente protettore. Così la Stazione è a Roma, nella Chiesa detta di S. Croce in Gerusalemme, perché vi si conservava una grossa parte del legno della Santa Croce, mandata da Gerusalemme a Roma quando fu ritrovata.
Incipit
In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
Adjutórium nostrum ✠ in nómine Dómini.
R. Qui fecit cælum et terram.
Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Joánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum, Deum nostrum.
S. Misereátur nostri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam ætérnam.
R. Amen.
S. Indulgéntiam, ✠ absolutiónem et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus.
R. Amen.
V. Deus, tu convérsus vivificábis nos.
R. Et plebs tua lætábitur in te.
V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.
R. Et salutáre tuum da nobis.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Introitus
Is XXX: 30.
Pópulus Sion, ecce, Dóminus véniet ad salvándas gentes: et audítam fáciet Dóminus glóriam vocis suæ in lætítia cordis vestri.
[Popolo di Sion, ecco il Signore verrà a salvare tutte le genti: il Signore farà udire la gloria della sua voce inondando di letizia i vostri cuori.]
Ps LXXIX:2
Qui regis Israël, inténde: qui dedúcis, velut ovem, Joseph.
[Ascolta, tu che reggi Israele, tu che guidi Giuseppe come un gregge.]
Pópulus Sion, ecce, Dóminus véniet ad salvándas gentes: et audítam fáciet Dóminus glóriam vocis suæ in lætítia cordis vestri.
[Popolo di Sion, ecco il Signore verrà a salvare tutte le genti: il Signore farà udire la gloria della sua voce inondando di letizia i vostri cuori.]
Kyrie
S. Kýrie, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kýrie, eléison.
M. Christe, eléison.
S. Christe, eléison.
M. Christe, eléison.
S. Kýrie, eléison.
M. Kýrie, eléison.
S. Kýrie, eléison.
Gloria
Glória in excélsis Deo. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spíritu ✠ in glória Dei Patris. Amen.
Oratio
Orémus.
Excita, Dómine, corda nostra ad præparándas Unigéniti tui vias: ut, per ejus advéntum, purificátis tibi méntibus servíre mereámur:
[Eccita, o Signore, i nostri cuori a preparare le vie del tuo Unigenito, affinché, mediante la sua venuta, possiamo servirti con anime purificate:]
Lectio
Lectio Epístolæ beáti Pauli Apostoli ad Romános.
Rom XV: 4-13.
Fatres: Quæcúmque scripta sunt, ad nostram doctrínam scripta sunt: ut per patiéntiam et consolatiónem Scripturárum spem habeámus. Deus autem patiéntiæ et solácii det vobis idípsum sápere in altérutrum secúndum Jesum Christum: ut unánimes, uno ore honorificétis Deum et Patrem Dómini nostri Jesu Christi. Propter quod suscípite ínvicem, sicut et Christus suscépit vos in honórem Dei. Dico enim Christum Jesum minístrum fuísse circumcisiónis propter veritátem Dei, ad confirmándas promissiónes patrum: gentes autem super misericórdia honoráre Deum, sicut scriptum est: Proptérea confitébor tibi in géntibus, Dómine, et nómini tuo cantábo. Et íterum dicit: Lætámini, gentes, cum plebe ejus. Et iterum: Laudáte, omnes gentes, Dóminum: et magnificáte eum, omnes pópuli. Et rursus Isaías ait: Erit radix Jesse, et qui exsúrget régere gentes, in eum gentes sperábunt. Deus autem spei répleat vos omni gáudio et pace in credéndo: ut abundétis in spe et virtúte Spíritus Sancti.
“Tutte le cose che furono già scritte, furono scritte per nostro ammaestramento, affinché per la pazienza e per la consolazione delle Scritture noi manteniamo la speranza. Il Dio poi della pazienza e della consolazione vi conceda di avere un medesimo sentimento fra voi, secondo Gesù Cristo. Affinché di pari consentimento, con un sol labbro, diate gloria a Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo. Il perché accoglietevi gli uni gli altri come Gesù Cristo ha accolto voi a gloria di Dio. E veramente io affermo, Gesù Cristo essere stato ministro della circoncisione per la veracità di Dio, per mantenere le promesse fatte ai patriarchi: i gentili poi glorificare Iddio per la misericordia, siccome sta scritto: Per questo io ti celebrerò fra le nazioni e inneggerò al tuo nome. E altrove: Rallegratevi, o genti, col suo popolo. E ancora: “Quante siete nazioni, lodate il Signore, e voi, o popoli tutti, celebratelo. E Isaia dice ancora: Vi sarà il rampollo di Jesse e colui che sorgerà a reggere le nazioni, e le nazioni spereranno in lui. Intanto il Dio della speranza vi ricolmi di ogni allegrezza e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la forza dello Spirito santo. ,, (Ai Rom, XV, 4-13). –
***
L’intenzione di s. Paolo in questa lettera è di far cessare certe controversie domestiche, che lo spirito di gelosia aveva suscitate tra i Giudei ed i Gentili convertiti alla fede. Quelli si gloriavano delle promesse che Dio aveva fatto ai lor padri, di dare il Salvatore, che sarebbe della loro nazione; questi rimproveravano ai Giudei la manifesta ingratitudine della quale si eran fatti colpevoli uccidendo il loro Redentore. S. Paolo dimostra agli uni come agli altri che essi devono tutto alla grazia ed alla misericordia del Salvatore.
Perché Dio è chiamato il Dio della pazienza, della consolazione e della speranza?
Perché la sua longanimità verso i peccatori lo determina ad aspettare la loro conversione con pazienza; perché da Lui viene questa consolazione interiore che sbandisce ogni pusillanimità; e fa insieme trovar gaudio nelle croci; perché Egli è che ci dà la speranza di pervenire, dopo questa vita a godere Lui stesso.
Aspirazione. O Dio di pazienza, di consolazione e speranza, fate che una perfetta rassegnazione al vostro santo volere versi la gioia e la pace nei nostri cuori, e che la Fede, la Speranza e la Carità ci rechino, con la pratica delle buone opere, al possedimento del bene a cui fummo creati, e che ci attende nell’eternità, se adempiremo fedelmente le condizioni alle quali ci è stato promesso.
Graduale
Ps XLIX: 2-3; 5
Ex Sion species decóris ejus: Deus maniféste véniet,
V. Congregáta illi sanctos ejus, qui ordinavérunt testaméntum ejus super sacrifícia.
[Da Sion, ideale bellezza: appare Iddio raggiante.
V. Radunategli i suoi santi, che sanciscono il suo patto col sacrificio. Alleluia, alleluia.]
Alleluja
Allelúja, allelúja,
Ps CXXI: 1
V. Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus. Allelúja.
[V. Mi sono rallegrato in ciò che mi è stato detto: andremo nella casa del Signore. Allelúia.]
Evangelium
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthaeum.
R. Gloria tibi, Domine!
Matt. XI:2-10
In illo tempore: Cum audísset Joánnes in vínculis ópera Christi, mittens duos de discípulis suis, ait illi: Tu es, qui ventúrus es, an alium exspectámus? Et respóndens Jesus, ait illis: Eúntes renuntiáte Joánni, quæ audístis et vidístis. Cæci vident, claudi ámbulant, leprósi mundántur, surdi áudiunt, mórtui resúrgunt, páuperes evangelizántur: et beátus est, qui non fúerit scandalizátus in me. Illis autem abeúntibus, coepit Jesus dícere ad turbas de Joánne: Quid exístis in desértum vidére? arúndinem vento agitátam? Sed quid exístis videre? hóminem móllibus vestitum? Ecce, qui móllibus vestiúntur, in dómibus regum sunt. Sed quid exístis vidére? Prophetam? Etiam dico vobis, et plus quam Prophétam. Hic est enim, de quo scriptum est: Ecce, ego mitto Angelum meum ante fáciem tuam, qui præparábit viam tuam ante te.
“In quel tempo avendo Giovanni udito nella prigione le opere di Gesù Cristo, mandò due de’ suoi discepoli a dirgli: Sei tu quegli che sei per venire, ovvero si ha da aspettare un altro? E Gesù rispose loro: Andate, e riferite a Giovanni quel che avete udito e veduto. I ciechi veggono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risorgono, si annunzia ai poveri il Vangelo; ed è beato chi non prenderà in me motivo di scandalo. Ma quando quelli furono partiti, cominciò Gesù a parlare di Giovanni alle turbe: Cosa siete voi andati a vedere nel deserto? una canna sbattuta dal vento? Ma pure che siete voi andati a vedere? Un uomo vestito delicatamente? Ecco che coloro che vestono delicatamente, stanno ne’ palazzi dei re. Ma pure cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico io, anche più che profeta. Imperocché questi è colui, del quale sta scritto: Ecco che io spedisco innanzi a te il mio Angelo, il quale preparerà la tua strada davanti a te” .
OMELIA
(G. Colombo: Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi; VI ediz. – Soc. Ed. Vita e pensiero.- Milano 1956)
IL PRECURSORE: UOMINI DI CARATTERE
Perché le sue parole non venissero sospettate d’opportunismo o di adulazione, Gesù aspettò che i due discepoli mandati da Giovanni Battista se ne fossero tornati al loro maestro che languiva nelle carceri di Erode. Poi cominciò a parlare di Giovanni alla moltitudine. – « Che cosa vi attirava nel deserto, quando lasciavate le case e. accorrevate in folla? Forse una canna che si piega ad ogni fiato di vento? Forse un uomo effeminato vestito con eleganza e mollezza? ». – No: Giovanni non era un effeminato cortigiano, egli che fin da fanciullo crebbe e si fortificò nelle solitudini di luoghi selvaggi: portava una veste di peli di cammello stretta ai fianchi con una cintola di cuoio; si nutriva con locuste e miele e non beveva mai vino. – Cristiani, Gesù loda Giovanni Battista perché era un uomo di carattere. Chi non ha carattere, non è un uomo, ma una cosa; Dante direbbe che è una pecora matta perché si muove non secondo ragione, ma secondo istinto: l’istinto della paura, l’istinto del piacere. Due cose fanno l’uomo di carattere: convinzione profonda; volontà energica. – 1. CONVINZIONE PROFONDA. Quando Mosè salì sul monte a ricevere gli ordini da Dio, una nube avvolse la vetta del Sinai e nascose i colloqui dell’Eterno con l’uomo. Ma il popolo rimasto alle falde della sacra montagna, col passar dei giorni, cominciò ad annoiarsi dell’attesa, a disinteressarsi di quello che avveniva oltre quella nube che non lasciava trasparir nulla, se non forse qualche lampeggiamento seguito dal brontolare del tuono. Alla fine perse la pazienza di restar fedele, si costruì un vitello d’oro, intorno al quale tutti se la godevano, mangiando e bevendo e ballando. E non pensavano che da un momento all’altro sarebbe potuto tornare Mosè? Ci pensavano, ma dicevano anche: « Di quel Mosè che ci ha liberati dalla schiavitù dell’Egitto e del suo Dio che sta sopra le nuvole, non sappiamo che cosa sia accaduto » (Es., XXXII, 1 ss.). – Noi sentiamo un fremito d’indignazione verso quel popolo sleale e ondeggiante tra il vero Dio e gli idoli, che cento volte prometteva fedeltà e altrettante la trasgrediva. Eppure non è questo il male di moltissimi Cristiani, il male che forse rode anche la nostra vita? Diciamo di essere creature poste sulla terra per il cielo, ma intanto lo dimentichiamo. Diciamo d’aver un cuore destinato ad amare la sola cosa veramente amabile, e intanto sciupiamo il nostro amore in vergognose passioni. Il vero motivo di questo nostro ondeggiare sta nella mancanza di convinzioni profonde. Ne avessimo almeno una, saremmo uomini; e invece siamo canne. La nostra fede ha radici superficiali, come quella del popolo ebraico nel deserto, e, in pratica, diciamo anche noi: « Di quel Gesù che ci ha redenti col sangue ed è salito oltre le nuvole a parlare col suo padre Celeste, non sappiamo che cosa sia accaduto ». Con siffatta perplessità d’idee, è impossibile pretendere d’assomigliare a Giovanni Battista. – Un pomeriggio domenicale, una persona di mondo entrò nella canonica del parroco d’Ars, attratta da quello che si diceva intorno all’austerità di quell’umile prete, alla generosità con cui donava tutto per vivere poi egli stesso in una povertà estrema, allo zelo con cui si prodigava di giorno e di notte per la salvezza delle anime. « Signor Curato, — disse quella persona — crede proprio a tutto quanto dice il Vangelo? ». – « Sì, a tutto ». « Ma è proprio sicuro che dopo la morte ci sarà il Paradiso? ». « Sicurissimo ». « Proprio sicuro, come dopo quest’oggi che è domenica verrà il lunedì? ». « No, molto più sicuro ». « Proprio sicuro come il sole che è tramontato adesso, sorgerà domani mattina? ». « No. Molto, molto più sicuro. Poiché può darsi anche che venga una domenica dopo la quale non ci sia più il lunedì, quale non ci sia un tramonto dopo il quale non ci sia più aurora, un inverno dopo il quale non ci sarà più primavera, ma non può darsi assolutamente che le parole di Cristo non s’avverino ». « Quali parole? ». « Queste: Io sono la Resurrezione e la Vita: chi crede in me, anche se fosse morto, vivrà… Io lo risusciterò nell’ultimo giorno ». – Quella persona partì commossa e persuasa d’aver capito il segreto di quella grande santità. Soltanto una convinzione così profonda poteva dargli la forza di vivere come viveva. Tale profondità di convinzione era quella che condusse Giovanni Battista nel deserto, che gli diede il coraggio di rinfacciare al re il suo nefando peccato, che lo fece intrepido quando si lasciò troncare la testa. Tale profondità di convinzione era quella che sostenne i martiri: Agnese, bella e ricca ereditiera d’una cospicua famiglia romana, che a 13 anni, mentre le fiamme del rogo già la lambivano, esclamava: « Ecco che finalmente io vengo a Voi, Signore, che io amavo, cercavo, desideravo, senza intermissione »; Pancrazio di 14 anni che lasciò sbranare dalle belve la sua giovane vita, ma non sacrificò agli idoli; Policarpo di 85 anni, Simeone di 120, entrambi col corpo tremante di vecchiezza, ma con l’anima immobile nella certezza della fede. Né si creda che questa convinzione capace di sfidare perfino la morte, sia un ricordo archeologico di tempi antichi che non ritornano più. È del nostro tempo il fatto di una fanciulla americana, (Grazia Minford), convertita dal protestantesimo e divenuta suora domenicana. Suo padre morendo le lasciò la somma favolosa di 12 milioni e mezzo di dollari, a patto che abbandonasse il convento. Che cos’ha risposto quella fanciulla? « Il mio Padre del cielo è assai più ricco del mio padre della terra, e mi darà una ricompensa più grande ancora ». Questa è convinzione e forza veramente cristiana! («Schonere Zukunft », 1-5-1927). – Convinzione cristiana spinge ancora tante figliuole a rinunciare a un sogno di felicità, piuttosto che sposare una persona che non rispetterebbe la loro coscienza, a rinunciare a un impiego lucroso piuttosto che sgualcire il candore della loro innocenza in certi uffici. Convinzione cristiana sostiene il padre di famiglia in gravi e lunghi sacrifici piuttosto che violare la legge del Signore. – 2. VOLONTÀ ENERGICA. La volontà energica è una conseguenza naturale della convinzione profonda. L’uomo di carattere sa dimostrare la sua volontà decisa davanti al mondo, a sé, a Dio. – Davanti al mondo. Il mondo ha due armi terribili per trascinare al male: la lusinga e lo scherno. Le lusinghe del mondo sono le amicizie, certe amicizie specialmente; sono i divertimenti, come gli spettacoli licenziosi, i balli, le passeggiate sbrigliate e promiscue. Gli scherni del mondo sono fatti di sorrisi maliziosi, di mormorazioni, di ironia, di disprezzo, e perfino di persecuzioni; poiché spesso i buoni si vedono preclusa la via alle loro legittime aspirazioni, e alle ricompense meritorie. La volontà energica dell’uomo di carattere non cede alle lusinghe, non teme gli scherni: ma va diritta e sicura, ascoltando sempre la voce della coscienza. – Davanti a sé. Un nemico potente è entrato in noi stessi per il peccato originale, ed ha esteso il suo nefasto impero un poco su tutte le facoltà dell’anima. Bisogna riconquistare e difendere la nostra libertà interiore. I cattivi pensieri la minacciano nella nostra mente, i cattivi desideri nel rostro cuore, i cattivi istinti nella nostra carne: quale campo di battaglia aspra e incessante per la volontà! Chi cede è rammollito. – Davanti a Dio. Dio ogni giorno per purificarci o per provarci ci manda la nostra parte di fatica e di sofferenza. È necessaria la volontà energica, che tronchi ogni querela e ogni impazienza, e ci faccia accettare con santa e lieta rassegnazione la sua paterna e misteriosa volontà. La volontà energica sa placare la natura ferita, e la induce a ripetere quella preghiera che, quando è sincera, vuole coraggio e amore: « La tua volontà sia fatta! ».- Santa Giovanna è all’assedio d’Orléans. Sette ore ha combattuto, sempre calma e intrepida, in mezzo alle sue truppe; ora è il momento in cui deve strappare al nemico la famosa bastiglia di Tourelles. Repentinamente si slancia, afferra la scala, l’appoggia alla torre, e sale impetuosa. Una freccia la colpisce in mezzo al petto: sgorga sangue. Ella impallidisce, trema: sospesa a metà della scala, piange di dolore e di paura. Ridiscende e si nasconde a curarsi. Ecco la debolezza umana. Gli Inglesi imbaldanziscono, ed i Francesi spauriti cedono il campo, e suonano la tromba della ritirata. Ma al primo squillo, Giovanna scatta in piedi: ricorda le visioni che ebbe, le voci che udì, e fa una breve preghiera. Poi di colpo si strappa la freccia, e col petto chiazzato di sangue, grida: « Avanti, siamo vincitori! » E vince. – Cristiani, la vita è una battaglia per la conquista del regno di Dio. Se ci capitasse qualche momento di paura e di debolezza, richiamiamo i motivi della nostra fede, ravviviamo le nostre condizioni, e chiediamo forza con la preghiera, Poi come Santa Giovanna andiamo avanti, sicuri che la vittoria è nostra. –PREPARIAMOCI AL SANTO NATALE CON LA FEDE. Due parti ha il brano di Vangelo da commentare: il messaggio di S. Giovanni Battista a Gesù; l’elogio di Gesù per San Giovanni Battista. 1. Da parecchi mesi il Precursore languiva nella fortezza di Macheronte, erma e selvaggia sul mar Morto, dove lo teneva rinchiuso Erode. Venivano i suoi discepoli a trovarlo e non senza amarezza gli raccontavano i primi successi di Gesù. «Maestro, gli dicevano, sai, quell’uomo che era con te al di là del Giordano, a cui tu hai reso testimonianza? ecco battezza anch’egli, e tutti vanno da lui » (Giov., III, 26). – Per quei discepoli affezionati riusciva molto duro vedere il loro maestro prigioniero in una fosca e solitaria torre mentre pensavano che laggiù nella ridente Galilea un altro Maestro predicava alla luce del sole, e la folla lo ascoltava ammirata. E se qualche volta s’imbattevano a passare di là, sapendo che Gesù, con i suoi amici era entrato in qualche casa a mangiare, mossi da invidia e sdegno, si mettevano sulla porta a protestare (Mc., II, 18). – San Giovanni aveva cercato già di dissipare questi sentimenti non generosi, ma tanto naturali e facili a germinare nel cuore dell’uomo; e aveva detto: « Sentite: se una persona si sposa e tutti gli fan festa, il suo amico deve rattristarsi? No; ma l’amico dello sposo, che sta presso di lui, e lo ascolta, si rallegra grandemente nell’udire la voce dello sposo. Questa è la mia gioia: ed è perfetta. Bisogna che egli cresca, e io diminuisca » (Giov. III, 29-30). – Quella volta però in prigione, il Precursore sentendosi incapace a disarmare e a illuminare i suoi amici, ne scelse due e li mandò a interrogare Gesù: « Sei Tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo un altro? » Lo scopo recondito dell’ambasciata fu subito intuito da Gesù che in presenza dei due inviati moltiplicò i miracoli. Al momento di congedarli, disse: « Andate ora, e riferite a Giovanni ciò che avete udito, ciò che avete visto ». Poi, volendo mostrare come leggesse nei loro cuori, aggiunse: « E beati quelli che non si lasciano sconcertare dalla mia maniera di fare! ». 2. Partiti che furono, evitata quindi anche l’apparenza d’adulazione, Gesù rese una magnifica testimonianza al suo Precursore davanti ad una gente che l’aveva conosciuto nel deserto. « Chi siete andati a vedere nel deserto? Forse una canna sbattuta dal vento? ». No. Di canne erano folte le rive del Giordano, senza andarle a cercare lontane nel deserto. Giovanni poi non era certo una canna, lui il predicatore terribile che non infinse, che non tacque, ma andò fin dal Re a rimproverargli l’adulterio. « Chi dunque siete andati a vedere nel deserto? — incalza Gesù con una seconda domanda. — Forse un uomo di lusso vestito alla moda? ». I cortigiani dalle ricche vesti, gli uditori di Gesù sapevano bene che non abitavano il deserto, ma la reggia. Nel deserto, dove da vestire non ci sono che’ pelli ispide, da mangiare che erbe e locuste, da bere che acqua e scarsa ancor quella, non vivono che i ladroni e i profeti. E Giovanni era un profeta, anzi più che un profeta. « Non ‘è sorto un altro tra i figli di donna più grande di lui, — disse Gesù conchiudendone l’elogio. — Egli è l’araldo preannunziato per prepararmi la strada ». Ora che abbiamo raccontato con qualche commento, il Vangelo, fermiamo l’attenzione sulla risposta che il Signore diede ai due inviati. Questa risposta ha per noi una grande importanza. Oggi, come allora, in molti cuori manca la fede, oppure s’è illanguidita, oppure s’è fatta inerte. Anche per questi cuori, perché si ridestino a una fede operosa e amorosa, perché con tale fede si preparino al santo Natale, Gesù incaricò i due discepoli del Battista di riferire quello che udirono e quello che videro. – 1. QUELLO CHE UDIRONO. Certamente udirono quello che Cristo ha detto di sé medesimo. Lo udirono cioè proclamarsi figlio di Dio, Dio uguale al Padre. Il Vangelo non ci riferisce le parole precise pronunciate da Lui in quell’occasione: ma non ci rincresce perché ne abbiamo molte altre equivalenti pronunciate in diverse circostanze. Basterà ricordarne alcune. a) Un giorno l’Apostolo Filippo lo prega di fargli vedere Dio Padre, di cui parlava con tanta affettuosa insistenza. E Gesù: « Filippo, chi vede me, vede anche il Padre. Non credi tu che Io sono nel Padre, e che il Padre è in me?» (Giov., XIV, 9-10). La terra nostra non aveva mai inteso prima d’allora un simile parlare. Non c’è che Dio solo, e niente è simile a Lui in tutto il mondo. Ed ecco che questo uomo, Gesù, afferma d’essere un unico Dio col Padre: di possedere la stessa eternità, la stessa potenza, la stessa scienza, la stessa natura e vita divina. E lo confidò anche a Nicodemo in quella notte in cui l’ammise a un colloquio segreto (Giov., III, 13-18); lo ripeté al cieco nato dopo avergli donata la vista (Giov., IX, 35-37); lo proclamò solennemente alla folla che l’attorniava nel tempio (Giov., X, 30); lo disse in faccia a Caifa, l’ipocrita che cercava un pretesto per scandalizzarsi di lui (Mt. XXVI, 63-64). – b) Non solo Gesù affermò d’essere Dio, ma anche d’avere quei diritti che competono soltanto a Dio. Ad esempio, l’onnipotenza in cielo e in terra. Salutando i suoi discepoli, prima di salire al cielo, disse loro: « Io ho ogni potere, lassù in cielo e quaggiù in terra ». (Mt., XXVIII, 18). – Un altra volta domanda per sé un amore sopra ogni cosa. « Chi non mi ama più di suo padre e di sua madre, di suo figlio e di sua figlia, non è degno di me » (Mt., X, 37). Soltanto Dio può pretendere un simile amore. Gesù voleva appunto dire d’essere Dio. – c) E se l’ha detto, lo è. Era troppo equilibrato, semplice, schietto, buono per illudersi o per illudere. Ma non solo lo disse, lo comprovò coi fatti, e i due inviati del Battista videro cose che non può fare se non colui che ha fatto il mondo e che è il padrone della vita e della morte. – 2. QUELLO CHE VIDERO. Videro Gesù avvicinarsi affettuoso alle pupille spente d’alcuni ciechi, e chieder loro: « Che cosa desiderate? ». « Vedere! Vedere! », « Ebbene, guardate ». Sotto l’impero di quella parola, davanti alle loro facce stupefatte si rivelava per la prima volta la luce del sole e in essa tutte le altre cose belle. Erano scoppi di gioia, parole di riconoscenza interrotte da incomprimibile meraviglia infantile: «Oh gli uomini, sono come alberi che camminano! » (Mc., VIII, 24). – Videro sordomuti gonfiare la gola nello sforzo d’esprimere la parola che non potevano dire e agitare le dita intorno alle orecchie. Gesù, appoggiato un dito tra le sue labbra, l’intinse di saliva, poi toccò la loro bocca e il loro orecchio: « Apriti! » esclamò. D’improvviso come se finalmente un ingorgo maligno fosse travolto, la parola libera e chiara usciva dal loro petto, entrava nel loro timpano. Videro storpi gettare via le grucce e saltare sulle loro gambe. Videro alcuni in un momento guarir dalla lebbra che è inguaribile. Forse videro anche il centurione supplicare il Maestro per un suo carissimo servo che giaceva a letto in condizioni disperate, e Gesù guarirglielo in distanza (Lc. VII, 259). Forse videro anche i funerali dell’unigenito della vedova di Naim. Gesù fermò la barella e comandò alla morte di cedergli la tenera preda. « Fanciullo, ti dico di alzarti! ». E il morto risuscitò (Lc., VII, 11-17). – Questi sono fatti sicuri che non hanno che una sola spiegazione: Gesù è Dio fatto uomo, e rivestito d’un corpo come il nostro. Eppure molti non si lasciano persuadere. Non c’è da stupirsi, quando si pensa che perfino due città di quelle che videro coi loro occhi i miracoli si ostinarono nella incredulità. Gesù abbandonandole rivolse su loro la maledizione: « Guai a te, Corozain! Guai a te, Bethsaida! Se i miracoli che sono stati fatti tra le vostre contrade fossero avvenuti a Tiro e a Sidone, già si sarebbero convertite » (Mt. 11.21). Che vuol dire ciò? Vuol dire che alla buona fede che lo cerca Gesù si presenta con prove certe della sua divinità, ma non s’impone per forza all’ostinazione che lo respinge. – S’avvicina il giorno in cui la Chiesa ricorderà a tutto il mondo il mistero della ancora nascita di Gesù. E la Grazia che da questo mistero sgorgò allora, verrà diffusa a tutti i cuori, nella misura che se ne renderanno capaci. Dio Eterno che nasce bambino per noi! C’è qui un abisso di amore e di degnazione di cui non ci sarà mai possibile vedere il fondo. Santa Maddalena de’ Pazzi con incessante amorosa adorazione ripeteva centinaia di volte al giorno: «Il Verbo si è fatto carne ed abitò tra noi ». S. Alfonso de’ Liguori non sapeva studiare se sul suo tavolo di lavoro non vedeva la cara immagine di Gesù Bambino. Ed infinite volte la baciava, adorando Colui che vi era rappresentato. Cristiani: in questa settimana d’Avvento più volte al giorno, sull’esempio dei Santi, diremo col cuore: « Bambino Gesù, io ti ringrazio d’essere nato per me! ». Ma forse qualcuno penserà: « Come farò a ricordarmelo? ». Ebbene: perché non l’abbiate a dimenticare tre volte al giorno, al mattino, al mezzodì, alla sera, la Chiesa fa suonare le campane dell’Angelo che annunzia l’incarnazione del Verbo. Nessuno dunque si scordi, almeno in questa settimana, che udendo quel suono deve pensare al Figlio di Dio che si fece uomo per la nostra salvezza. — I FRUTTI DELL’AVVENTO DEL SIGNORE.- Se un rincrescimento pungeva ancora Giovanni il Battista, non era per sé, ma per i suoi discepoli: quelli che avevano raccolta la sua parola gridata dalle soglie del deserto, che avevano ricevuto il suo battesimo di penitenza sulle rive del Giordano: i suoi discepoli che non volevano rassegnarsi a separarsi da lui, che ancora venivano a trovarlo in prigione, che per stare con lui trascuravano di seguire il Messia. Ah no! questo era troppo, questo non poteva più permetterlo. Solo Gesù è il Salvatore, solo Gesù bisogna seguire! Per ciò, sentendo imminente la sua tragica morte, mandò due discepoli a Cristo per dirgli. « Sei tu il Messia, o è un altro che dobbiamo aspettare? ». – Giovanni, si capisce, non dubitava nemmeno: egli fino dal seno materno, sobbalzando misteriosamente, l’aveva riconosciuto; egli l’aveva additato alle folle ignoranti; egli l’aveva battezzato mentre la voce dell’Eterno Padre discendeva dal cielo aperto. Ma nella squisitezza della sua fede e del suo amore voleva che i discepoli suoi lo vedessero coi loro occhi, lo udissero con le loro orecchie: così affascinati dal Cristo, si sarebbero staccati da lui senza rimpianti. E Gesù comprese lo scopo di quella ambasciata. Li accolse con affetto e se li tenne con sé amorevolmente facendo molti miracoli in presenza di loro. Poi li congedò con queste parole: « Tornate da Giovanni e ditegli quel che avete udito, quel che avete veduto ». Orbene, Cristiani: la santa Chiesa in principio dell’Avvento, imitando il gesto del Precursore, manda anche noi a considerare i frutti della venuta del Salvatore perché abbiamo a credere più fermamente in Lui, a seguirlo più coraggiosamente. Questi frutti sono molti, ma i principali sono tre: la pace, la luce, l’amore. – 1. LA PACE. Prima ancora che nascesse, da un profeta fu chiamato « principe della pace »; quando nacque, i cori d’Angeli cantarono che «la pace in terra, agli uomini» era discesa. Alla vigilia della morte diceva ai suoi amici: « Me ne vado, ma vi lascio la pace »; risuscitando disse: « Pace a voi ». Gesù Cristo, dunque è la nostra pace. Ipse enim est pax nostra (Eph., II, 14). Perciò non fa meraviglia se, con la sua venuta, mise pace tra Dio e l’uomo, tra l’Angelo e l’uomo, tra uomo e uomo. a) Tra Dio e l’uomo: dal momento che il primo uomo peccò, Dio voltò via la sua faccia sdegnata e abbandonò la nostra natura al giogo del demonio. Passarono migliaia e migliaia d’anni in cui nessun uomo poté, benché santo, entrare in Paradiso: né Adamo, né Mosè, né Isaia, né Davide, alla loro morte, lo trovarono aperto. Finalmente nel seno verginale di Maria la natura divina e la natura umana s’abbracciarono nell’unica Persona nel verbo incarnato. Come Iddio poteva continuare la sua inimicizia con gli uomini, se uomo era anche il suo Figlio Unigenito? – b) Tra l’Angelo e l’uomo. Fino alla venuta di nostro Signore Gesù, gli Angeli trattavano gli uomini come stranieri con superiorità ed asprezza. Perciò quando apparvero ad Abramo, a Loth, a Giacobbe, a Mosè, ad Ezechiele, a Davide gli uomini tremanti si gettavano a terra per adorarli come padroni. Ma dal giorno della venuta del Signore, tutta la schiera angelica ci è diventata benevola ed amica: ai loro occhi cessammo di apparire la razza degradata e maledetta, poiché vedono che il Figlio di Dio ha voluto rivestire umana natura, farsi uomo in carne ed ossa come noi. Se Dio ebbe di noi tanta misericordia da diventare uno dei nostri, gli Angeli come ci potrebbero ancora trattare duramente? Quando a S. Giovanni Evangelista apparì un Angelo, egli, secondo l’uso dell’Antico Testamento, fece per gettarsi sulla nuda terra ad adorarlo. Ma la celeste creatura glielo impedì, dicendo: « Che fài? Io sono come te un servo dell’Altissimo ». – c) Tra uomo e uomo. Prima che il Salvatore discendesse su questa terra, il sentimento più diffuso tra gli uomini era l’odio. I pagani odiavano i Giudei, i Giudei odiavano gli immondi pagani. I Greci chiamavano barbaro chiunque non fosse della loro nazione; i Romani non riconoscevano i diritti se non dei cittadini di Roma. La guerra e l’odio implacabile per i nemici era un vanto. Venne Gesù: e davanti a Lui non ci furono più né Giudei né Gentili, né Greci né barbari, né rivali né nemici, ma tutti gli uomini divennero fratelli suoi, compartecipi della sua natura umana: e perciò figli tutti d’un Padre unico, Iddio. L’uomo dunque da Dio, dagli Angeli, dagli uomini stessi era odiato e disprezzato come un lebbroso. Gesù Redentore, portandoci la pace con Dio, con gli Angeli, con gli uomini, ci ha mondati da quella lebbra. Leprosi mundantur. Ma guai a quelli che ritornano negli odi antichi! per loro il frutto dell’avvento divino è maturato invano. – 2. LA LUCE. Tutti i popoli camminavano nelle tenebre e nell’ombra della morte. In Egitto si adoravano le cipolle e il bue; in Grecia si erano costruite divinità viziose e libidinose; in Roma si incensavano i tiranni crudeli. Le madri uccidevano i loro figliuoli per placare le ire di Baal o di Astharte, idoli sanguinarî. Anche gli uomini più intelligenti d’allora non riuscivano a sapere del loro eterno destino quanto ora ne sa anche l’ultimo dei nostri bambini. Gesù venne: e fu come se si squarciasse la maligna nuvolaglia che ottenebrava il mondo e risplendesse improvvisamente il sole. Sole di giustizia è Gesù! Luce del mondo è Gesù! – Quante meravigliose verità ci ha Egli disvelate riguardo a Dio, all’anima nostra, alla vita eterna… Tutte le cose più utili al nostro vero bene il Vangelo ce le insegna. – I nostri occhi erano ciechi, ed ora vedono. Cæci vident. Eppure ci sono di quelli che la dottrina cristiana hanno dimenticata, che non vogliono più impararla. Eppure ci sono di quelli che vivono solo per mangiare e guadagnare, veri adoratori delle cipolle e del bue; di quelli che vivono per accontentare ogni istinto bestiale, veri adoratori delle passioni immonde; di quelli che i proprî figli non educano cristianamente e sacrificano la loro innocenza al demonio. Guai a questi che ritornano nell’antica tenebrosa ignoranza! per loro il frutto dell’avvento divino è maturato invano. – 3. L’AMORE « Signore, perché sei venuto sulla terra? ». «Sono venuto a portare il fuoco dell’amore sulla terra ghiacciata, e non bramo altro che di incendiarla tutta in questa mistica fiamma ». Anche senza l’Incarnazione, nella sua infinita misericordia, Dio avrebbe saputo trovare il modo di perdonarci e salvarci. Ma era l’amore della sua creatura, che il Creatore dell’universo voleva: e si fece uomo per amore. Nell’Antico Testamento avevano imparato a temerlo e a rispettarlo; lo sentivano presente nel fragore del tuono, nell’urlo della bufera, nell’ardore del fuoco; ma gli uomini non riuscivano ad amare un Dio invisibile. Ma ora Egli si è fatto visibile, e tutto il mondo vede la sua dolce Umanità. « Fratelli, — scriveva S. Paolo — dopo la sua venuta più nessuno può vivere per sé, ma solo per Lui, che visse e morì per noi ». E sorsero allora moltitudini di uomini, di donne, di fanciulli che con desiderio offrirono la loro vita nel martirio. Sorsero allora infinite schiere di Monaci e di Vergini che si ritirarono nei deserti a vivere solo per suo amore, già fatti angeli prima di morire. Sorsero in ogni tempo i Santi che non temettero penitenze e umiliazioni, fatiche e malattie, tribolazioni e persecuzioni, accesi com’erano nell’amore di Cristo, il Dio fatto Uomo. – Senza questo eterno amore, che sarebbero stati gli uomini se non dei cadaveri? – Gesù venne e li risuscitò. Mortui resurgunt. Eppure sono troppi quelli che non amano il Signore: passano lunghe settimane senza un pensiero e un palpito per Lui! Troverete di quelli che neppure una Messa alla festa sanno ascoltare per suo amore; per suo amore non sanno nemmeno compiere una piccola rinuncia. E se si volesse entrare nel segreto delle famiglie, quanti ne trovereste che non sanno più rispettare la castità coniugale e vivono nell’egoismo brutale, dissacrando ogni legge di Dio e di natura! Guai a questi che ritornano nell’antica morte dell’indifferenza e del peccato! Per loro la primavera della redenzione è venuta senza fiori e senza frutti. – Dopo due millenni, nuovamente ci prepariamo al Santo Natale per partecipare maggiormente ai frutti della divina venuta. – S. Gaetano da Thiene sì struggeva in affettuose preghiere; S. Filippo Neri si ritirava nelle catacombe a meditare; San Francesco d’Assisi s’avviava verso Greccio gridando: « Amiamo il Bambino celeste! ». Noi che faremo? Facciamo pace con Dio e con gli Angeli togliendo via i peccati dal cuore, facciamo pace con gli uomini perdonando e chiedendo perdono. Ritorniamo a frequentare la Chiesa, a studiare la dottrina cristiana, ad ascoltare la parola di Dio. Infine, per amore di Gesù che tanto ci amò, facciamo un po’ di penitenza, di elemosina, di mortificazione. – Così la pace, la luce, la carità del nostro Signore ritorneranno in noi.
IL CREDO
Offertorium
Orémus
Ps LXXXIV: 7-8
Deus, tu convérsus vivificábis nos, et plebs tua lætábitur in te: osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam, et salutáre tuum da nobis.
[O Dio, rivolgendoti a noi ci darai la vita, e il tuo popolo si rallegrerà in Te: mostraci, o Signore, la tua misericordia, e concedici la tua salvezza.]
Secreta
Placáre, quǽsumus, Dómine, humilitátis nostræ précibus et hóstiis: et, ubi nulla suppétunt suffrágia meritórum, tuis nobis succúrre præsídiis.
[O Signore, Te ne preghiamo, sii placato dalle preghiere e dalle offerte della nostra umiltà: e dove non soccorre merito alcuno, soccorra la tua grazia.]
Præfatio
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et justum est.
de sanctissima Trinitate
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in uníus singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternǽque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in majestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre quotídie, una voce dicéntes:
[È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: che col Figlio tuo unigénito e con lo Spirito Santo, sei un Dio solo ed un solo Signore, non nella singolarità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Cosí che quanto per tua rivelazione crediamo della tua gloria, il medesimo sentiamo, senza distinzione, e di tuo Figlio e dello Spirito Santo. Affinché nella professione della vera e sempiterna Divinità, si adori: e la proprietà nelle persone e l’unità nell’essenza e l’uguaglianza nella maestà. La quale lodano gli Angeli e gli Arcangeli, i Cherubini e i Serafini, che non cessano ogni giorno di acclamare, dicendo ad una voce:]
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.
Preparatio Communionis
Orémus: Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti audémus dícere:
Pater noster
qui es in cælis. Sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem:
R. Sed líbera nos a malo.
S. Amen.
Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.
Panem cæléstem accípiam, et nomen Dómini invocábo.
V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.
COMUNIONE SPIRITUALE
Communio
Bar V: 5; IV:36
Jerúsalem, surge et sta in excélso, ei vide jucunditátem, quæ véniet tibi a Deo tuo.
[Sorgi, o Gerusalemme, e sta in alto: osserva la felicità che ti viene dal tuo Dio.]
Postcommunio
Orémus.
Repléti cibo spirituális alimóniæ, súpplices te, Dómine, deprecámur: ut, hujus participatióne mystérii, dóceas nos terréna despícere et amáre cœléstia.
[Saziàti dal cibo che ci nutre spiritualmente, súpplici Ti preghiamo, o Signore, affinché, mediante la partecipazione a questo mistero, ci insegni a disprezzare le cose terrene e ad amare le cose celesti.]
PREGHIERE LEONINE (dopo la Messa)
RINGRAZIAMENTO DOPO LA COMUNIONE (1)
ORDINARIO DELLA MESSA