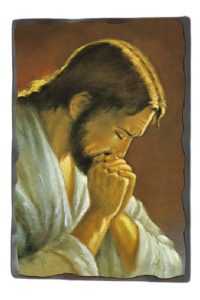DOMENICA XIV DOPO PENTECOSTE (2018)
Incipit
In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
Introitus
Ps LXXXIII:10-11.
Protéctor noster, áspice, Deus, et réspice in fáciem Christi tui: quia mélior est dies una in átriis tuis super mília. [Sei il nostro scudo, o Dio, guarda e rimira il tuo Consacrato: poiché un giorno passato nel tuo luogo santo vale più di mille altri].
Ps LXXXIII:2-3
V. Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútum! concupíscit, et déficit ánima mea in átria Dómini. O Dio degli eserciti, quanto amabili sono le tue dimore! l’ànima mia anela e spàsima verso gli atrii del Signore.
Protéctor noster, áspice, Deus, et réspice in fáciem Christi tui: quia mélior est dies una in átriis tuis super mília. [Sei il nostro scudo, o Dio, guarda e rimira il tuo Consacrato: poiché un giorno passato nel tuo luogo santo vale più di mille altri].
Oratio
Orémus.
Custódi, Dómine, quǽsumus, Ecclésiam tuam propitiatióne perpétua: et quia sine te lábitur humána mortálitas; tuis semper auxíliis et abstrahátur a nóxiis et ad salutária dirigátur. [O Signore, Te ne preghiamo, custodisci propizio costantemente la tua Chiesa, e poiché senza di Te viene meno l’umana debolezza, dal tuo continuo aiuto sia liberata da quanto le nuoce, e guidata verso quanto le giova a salvezza.]
Lectio
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Gálatas.
Gal V: 16-24
“Fratres: Spíritu ambuláte, et desidéria carnis non perficiétis. Caro enim concupíscit advérsus spíritum, spíritus autem advérsus carnem: hæc enim sibi ínvicem adversántur, ut non quæcúmque vultis, illa faciátis. Quod si spíritu ducímini, non estis sub lege. Manifésta sunt autem ópera carnis, quæ sunt fornicátio, immundítia, impudicítia, luxúria, idolórum sérvitus, venefícia, inimicítiæ, contentiónes, æmulatiónes, iræ, rixæ, dissensiónes, sectæ, invídiæ, homicídia, ebrietátes, comessatiónes, et his simília: quæ prædíco vobis, sicut prædíxi: quóniam, qui talia agunt, regnum Dei non consequántur. Fructus autem Spíritus est: cáritas, gáudium, pax, patiéntia, benígnitas, bónitas, longanímitas, mansuetúdo, fides, modéstia, continéntia, cástitas. Advérsus hujúsmodi non est lex. Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixérunt cum vítiis et concupiscéntiis.”
Omelia I
[Mons. Bonomelli: Nuovo saggio di Omelie; vol. IV Omelia III – Torino 1899]
“Camminate secondo lo Spirito e non seguite la concupiscenza della carne; perché la carne appetisce contro lo Spirito e lo Spirito contro la carne, e queste cose sono ripugnanti l’una all’altra, affinché non facciate tutto ciò che volete. Che se siete guidati dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste; queste sono adulterio, fornicazione, immondezza, dissoluzione, idolatria, avvelenamenti, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, dissensioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze e cose a queste somiglianti; delle quali cose vi predico, come ho già predetto, che coloro che le fanno non possederanno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è carità, allegrezza, pace, pazienza, benignità, bontà, fede, mansuetudine, continenza. Contro a queste cose non vi è legge. Ora coloro che appartengono a Cristo han crocifìsso la carne cogli affetti e con le “concupiscenze”„ (Ai Galati, V, 16-24).
Queste sentenze dell’Apostolo si trovano nel capo quinto della sua lettera ai Galati, e appartengono, come dissi altrove, alla terza parte della medesima, la quale versa tutta nella morale; ed è cosa sì manifesta, che ciascuno di voi, in solo udirla, se ne sarà accorto. Il tratto che dobbiamo spiegare si divide in due parti differentissime: nella prima S. Paolo in una rapida enumerazione delle opere della carne, cioè dei peccati che dobbiamo fuggire ed abominare; nella seconda, che ne è l’antitesi, accenna i frutti e le opere dello Spirito, ossia le virtù che dobbiamo esercitare. L’esortazione dell’Apostolo non presenta difficoltà alcuna ed è eminentemente pratica, ed io non farò che amplificarla alquanto, affinché ciascuno di noi più facilmente la venga applicando a se stesso. – Come apprendiamo dalla prima parte della lettera, la Chiesa di Galazia era fieramente lacerata da discordie: chi diceva che per aver salute bisognava osservare tutte le prescrizioni sì gravi della legge mosaica, e nominatamente la circoncisione; chi affermava, e a ragione, che la legge mosaica nella sua parte cerimoniale era abolita da Cristo: quindi contese, ire, discordie, mormorazioni senza fine, tantoché S. Paolo grida loro: “Se voi continuate a mordervi e divorarvi gli uni gli altri, badate che vi struggerete tra voi „ (Capo V, vers. 15). E qui, o carissimi, non sarà superbia, né fuor di luogo una osservazione. Più spesso che non vorremmo siamo noi pure testimoni di dissidi, di lotte, di aperte discordie nella Chiesa: fedeli contro fedeli, fedeli contro parroci e Vescovi, parroci ed anche vescovi dissenzienti tra loro e contendenti sopra alcuni punti forse anche di dottrina. – È certamente doloroso questo spettacolo nella Chiesa: ma non è nuovo: lo vediamo nella Chiesa di Galazia stabilita da S. Paolo e lui vivente. Qual meraviglia che ciò avvenga anche in mezzo a noi? La fede e la grazia non sopprimono le debolezze della nostra intelligenza e volontà, né distruggono le nostre passioni; ci danno solo la forza di combatterle e vincerle. Come furono composte le discordie della Chiesa di Galazia? chi le troncò e vi ristabilì la pace? S. Paolo con la sua autorità di Apostolo. Facciasi altrettanto in mezzo a noi. Se l’autorità del parroco non basta, si ricorra al Vescovo; se quella del Vescovo non basta, si ricorra al Vescovo dei Vescovi, il Papa, o almeno si serbi nell’animo la volontà ferma e sincera di stare al suo giudizio se questo tarda a pronunziarsi, e in questa volontà ferma e sincera, si avrà il mezzo di conservare la pace. – Stando così le cose della Chiesa di Galazia, era naturale che l’Apostolo, volendo farvi alcun riparo, dovesse a quei fedeli inculcare la carità, l’amore scambievole, e perciò ricorda loro che tutta la legge di Cristo si assomma in una sola parola, ed è questa: “Ama il prossimo tuo come te stesso — Omnia lex in uno sermone impletur: Diliges proximum tuum sicut teipsum „ (vers. 14). Posto questo principio fondamentale della vita cristiana, S. Paolo lo viene svolgendo e mostra ciò che esso ripudia e condanna, e ciò che approva ed esige, e qui comincia il nostro commento. – Io vi dico: Camminate secondo lo Spirito e non seguite le concupiscenze della carne; ché la carne appetisce contro lo Spirito, e lo Spirito appetisce contro la carne, essendo se ripugnanti l’una all’altra, affinché non facciate tutto ciò che volete. „ In queste parole del grande Apostolo è compendiata tutta la storia della lotta che ogni uomo sente agitarsi nel fondo del suo cuore, e che manifestandosi al di fuori nelle varie sue forme, diventa lotta sociale. Carissimi! Entriamo in noi stessi, discendiamo nel santuario della nostra coscienza, scrutiamo tutte le pieghe del nostro spirito, ascoltiamo tutti i battiti del nostro cuore; dal dì che la luce della ragione spuntò sul cielo dell’anima nostra sino ad oggi, che vi troviamo noi? Sotto quali forze si svolge la nostra vita? In noi troviamo costantemente due forze, che si contendono il dominio del nostro cuore: guardando in alto, contemplando le cime del mio spirito e ascoltando il grido della mia coscienza, vedo e sento che la virtù è bella e santa cosa; apprezzo e stimo l’umiltà, la modestia, il disinteresse, la temperanza, la mansuetudine; ammiro la purezza, la pazienza, il perdono delle offese, la carità; mi sento compreso di venerazione e tentato d’inginocchiarmi dinanzi a questi angeli di carità che consumano la loro vita in mezzo agli orfanelli, ai derelitti, al capezzale dei poveri e dei morenti. Ma da un’altra parte il vizio, le passioni col loro lenocinio mi tirano a sé: amo grandeggiare, corro dietro alle vanità e alle ricchezze; cedo volentieri al solletico della gola e secondo l’intemperanza; lodo la sincerità e talvolta mentisco; mi irrito con chi mi offende, sono spinto alla vendetta e ne assaporo il piacere; accarezzo l’ozio e la mollezza e vorrei che tutto fosse immolato ai miei voleri. Ho qui dentro una tendenza, una forza indistruttibile che mi porta in alto, verso le altezze della virtù; sento qui dentro un grido, che senza posa mi incoraggia a guadagnarne le vette: e in pari tempo ho qui dentro una tendenza, una forza pur essa indistruttibile, che mi trascina in basso verso gli abissi del vizio; sento qui dentro un grido che mi chiama, mi invita, mi trae a gettarmi in braccio alle passioni ed a sbramare in esse le mie voglie; sono posto tra la virtù ed il vizio, tra il bene ed il male: sono come una nave combattuta da due venti impetuosi e contrari. In me si avvera la sentenza del poeta: “Vedo il bene e l’approvo, eppure mi appiglio al peggio. „ E ancor meglio la sentenza dell’Apostolo: “Sento nelle mie membra un’altra legge o forza che ripugna alla legge o forza della mia mente. „ Che è questo, o cari? D’onde questa lotta in me stesso? Forse vi sono in me due anime, l’una buona, l’altra cattiva? Ma io sento d’essere un solo, sempre quel desso, un solo io indivisibile: sento che le due forze operano sopra di me quasi esternamente, e che è in poter mio seguir l’una o l’altra: anzi sento che la forza che mi inclina al bene, che mi muove verso la virtù e mi invita ai suoi casti amplessi, risponde assai meglio alle mie aspirazioni più nobili, mi fa gustare gioie più pure, mi solleva in una atmosfera più serena e tranquilla, e sgorga quasi dalle viscere del mio essere; mentre quell’altra forza mi avvilisce ai miei occhi stessi, mi fa arrossire, mi agita e mette in tempesta il mio cuore. D’onde adunque, domando ancora una volta, d’onde questa lotta? D’onde queste due forze pugnanti tra loro nell’animo mio? Perché questo duello fra due nemici implacabili, del quale il mio cuore è sempre l’arena? La fede e la ragione congiuntamente ci danno la spiegazione di questo fatto sì doloroso. Esse ci insegnano che la parte inferiore della nostra natura, che è il corpo, tende per se stesso ai piaceri sensibili, che lo allettano e lo traggono a sé; che il corpo, attratto da questi piaceri sensibili, che rispondono alla sua natura, tira con sé più o meno l’anima, che sente nel corpo stesso; ci insegnano che il mondo esterno per mezzo del corpo fa subire all’anima le sue impressioni assai prima ch’essa sia capace di elevarsi al conoscimento delle eterne verità, e perciò il mondo esterno e sensibile esercita sull’anima un fascino, un’azione assai maggiore di quella che sopra di essa eserciti la verità stessa: il senso precede, e per molti anni, la ragione e lo sviluppo della fede, e perciò riesce più vivo. La fede poi ci insegna che l’uomo per sua colpa cadde dallo stato nobilissimo in cui Dio l’aveva creato, ed in lui si diminuì la signoria che aveva sopra di se stesso, e per conseguenza la parte inferiore ribellandosi, cominciò a molestare la superiore, e a far opera a trascinarla dietro a sé sulla via dei piaceri sensibili. Ora l’uomo, collocato tra queste due forze contrarie, che deve fare? A quale delle due deve cedere? Deve seguire le basse voglie della carne, o, combattendo virilmente queste, seguire la voce della coscienza, o, come scrive S. Paolo, lasciarsi guidare dallo Spirito? La fede e la ragione stessa ci fanno sentire il dovere di ubbidire alla voce della coscienza, di seguire lo spirito della grazia divina, e ciò come uomini e molto più come cristiani. Come uomini, guidati dal solo lume della ragione naturale, dobbiamo frenare le incomposte passioni che ci travagliano, e praticare quelle virtù naturali che alle forze della sola natura sono possibili e corrispondenti; come Cristiani poi, rischiarati dal lume della fede ed avvalorati dalla grazia divina, dobbiamo poggiare ben più alto e modellarci sull’esemplare sovrano d’ogni perfezione, che è Gesù-Cristo. – Su dunque, o carissimi figliuoli! In questa lotta incessante e feroce tra lo spirito e la carne, tra la grazia e le passioni, costretti a scegliere il nostro partito, non stiamo in forse un solo istante: gettiamoci animosamente dalla parte dello spirito contro la carne, della grazia contro le passioni, della virtù contro il vizio, di Cristo contro il mondo. Qual gioia più pura, qual gloria più bella del signoreggiare la carne, rintuzzare le passioni, debellare il vizio, soggiogare il mondo e levarci sulle ali dello Spirito verso il cielo, farci belli della bellezza di Dio? È vero, talvolta questa carne che portiamo, aggrava l’anima e ci fa sentire ciò che non vorremmo sentire: “Ut non quæcumque vultis, illa faciatis”; ebbene, santamente vendichiamocene. Come? Col far sentire noi pure alla carne ed alle sue cupidigie ciò che anch’esse non vorrebbero sentire, cioè il freno della mortificazione, il rifiuto del nostro consenso. “Che se poi, cosi continua S. Paolo, siete guidati dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. „ Che significa essa questa sentenza? Eccone il senso: “Se voi, o Galati, seguite i movimenti dello Spirito e ubbidite docilmente alle voci ed agli impulsi della grazia, che viene da Gesù, siete superiori alla legge mosaica, e avete quella forza che non potrete mai avere da quella”. Forse questa sentenza dell’Apostolo può ragionevolmente intendersi in altro senso, che è questo: Se voi vi lasciate condurre dallo Spirito, ossia dalla grazia di Gesù, vi affrancate dalla tirannia della legge della concupiscenza e spezzate il suo giogo; voi, così facendo, non sottostate a nessuna legge, siete veramente liberi, perché quel che fate, non lo fate per forza o per timore, ma perché lo volete voi stessi. Quando, o dilettissimi, sentiamo noi il peso d’una legge e gemiamo sotto di essa? Quando la consideriamo come cosa esterna, impostaci da altri e contraria al nostro volere e, se ci fosse possibile, la vorremmo respingere, anzi, distruggere; ma se la legge che ci è proposta, noi l’accettiamo, l’amiamo, la facciamo nostra, come se fosse opera della nostra volontà, allora non ne sentiamo il peso, la adempiamo con gioia, e lungi dal considerarla come contraria alla nostra libertà, la teniamo in conto di amica fedele, quasi come facente una cosa sola con noi stessi. Vi è un figliuolo, tutto amore e docilità verso il padre suo: questi impose al figlio una serie di opere che comportano molti e non lievi sacrifici: naturalmente al pensiero di questi sacrifici egli prova una viva ripugnanza: si sente spinto a sottrarsi a quel peso: ma egli ama il padre: pensa alla gioia che gli procura con l’ubbidienza pronta e generosa; pensa alla gioia purissima che n’avrà egli stesso, appagando il padre suo, e in un impeto di risoluzione magnanima esclama: Il volere del padre mio è mio, voglio ciò che egli vuole, checché avvenga. — Credete voi, o carissimi, che codesto figliuolo troverà grave l’opera da compire? Io non lo penso: penso per contrario che l’amore del padre facendo suo il volere di lui, allevierà ogni fatica, raddolcirà ogni pena, e quasi convertirà in piacere lo stesso dolore. Vedete certi uomini che si sottopongono volontariamente a durissime fatiche, ad aspri lavori e pericoli. Questi salgono sulle cime più alte delle Alpi, inerpicandosi sui ghiacci e sui burroni: quelli attraversano le sabbie ardenti del deserto: altri s’aprono la via tra montagne di ghiaccio, sotto il polo del nord in mezzo a stenti e pericoli infiniti: un drappello di giovani audaci snida dai loro covi i leoni e le tigri, e ne affronta il furore. Dite loro: Voi avrete sofferto! quali patimenti! quali terrori! Sorridendo vi risponderanno: Oh no! son cose che abbiamo voluto noi: come potevamo lagnarcene? Così è: ciò che vogliamo noi, sia quanto si voglia malagevole e doloroso per sé, torna facile e quasi giocondo a farsi, voi ne converrete. Che il volere di Dio diventi il nostro, e la via che dovremo percorrere sarà piana e spedita! E questo, credo io, ciò che voleva dire san Paolo nella sentenza citata: “Se siete guidati dallo Spirito di Dio, voi non siete sotto la legge — Si Spiritu ducimini, non estis sub lege. „ Uniti a Dio, formando con la conformità al suo volere una cosa sola con Lui, come Lui siete liberi e non soggiacete che alla legge della vostra volontà, perché la vostra volontà è quella di Dio. La legge dello Spirito, ossia la volontà di Dio e la volontà nostra, sono due cose distinte e differenti: necessariamente la volontà nostra soggiace alla volontà di Dio, che si manifesta nella sua legge e ne sente il peso: ma se di queste due cose noi ne facciamo una sola, è chiaro che non vi è più né quella che sovrasta, né quella che soggiace: è una sola cosa e opera a suo agio e diventa legge a se stesso. Congiungi adunque, o cristiano, la tua alla volontà di Dio per forma che sia una sola, e non sarai sotto la legge, e piena sarà la tua libertà. – Procediamo, seguendo l’Apostolo. Dopo aver accennato alle due leggi, od alle due forze che combattono tra loro, che sono la carne da una parte, e lo Spirito o la grazia divina dall’altra, S. Paolo enumera le opere dell’una e dell’altra: dopo averci messi dinanzi questi due alberi, ce ne mostra i frutti, e come i due alberi sono di natura affatto contrari tra loro, cosi affatto differenti e contrari sono i frutti loro. Quali sono i frutti o le opere della carne, ossia della mala concupiscenza, che nella carne s’annida? Udite: “Le opere della carne sono palesi: le quali sono fornicazione, adulterio, impudicizia, dissolutezza. „ Fermiamoci qui Io mi guarderò bene dallo spiegare partitamente il valore di queste parole ad una ad una perché potrei offendere le vostre orecchie e dire cose che sconvengono al carattere di chi vi parla ed al luogo santo, in cui ci troviamo! – Ma se l’Apostolo, divinamente ispirato, le scrisse nella sua lettera, che senza dubbio dovevasi leggere nell’adunanza dei fedeli, non sarà interdetto a noi il ripeterle e dire quel tanto che è necessario e conveniente per mettervi in orrore le opere della carne, fine inteso e voluto dalla Chiesa che oggi ce le fa leggere nella santa Messa. – Primieramente piacciavi osservare che san Paolo, enumerando le opere della concupiscenza, mette in primo luogo i peccati turpi, le brutture del senso. E perché? Perché, credo io, sono questi i peccati più comuni e quelli che tirano in perdizione il maggior numero di anime. In secondo luogo ponete mente come il santo Dottore in quelle quattro parole abbia abbracciato le forme principali che la sozza passione può assumere e purtroppo assume. Che posso io dirvi, o carissimi? Io grido a tutti voi che mi ascoltate: “Fuggite fuggite, detestate, abbominate ogni incontinenza. Siete liberi dai vincoli del matrimonio? Serbate casto il vostro cuore e il vostro corpo, come il tempio del Signore. Siete legati dai vincoli santi del matrimonio? Serbatevi a vicenda la più inviolabile fedeltà, e ricordatevi che la si può ferire e calpestare anche col solo pensiero, col solo affetto e col solo desiderio, come insegna il Vangelo. Siate puri, siate casti, siate incontaminati, sempre, in ogni luogo, anche soli, anche quando nessun occhio umano vi può vedere, perché anche là sta aperto sopra di voi l’occhio di Dio”. Chi può intendere, dirò col Vangelo, intenda! – Dopo aver messo in prima linea i peccati dell’incontinenza, S. Paolo prosegue la enumerazione delle opere della carne, ossia della natura corrotta, e nomina l’idolatria, o servitù degli idoli: Idolorum servitus. Ai nostri giorni e nella nostra società non v’è bisogno alcuno di combattere e riprovare il culto degli idoli, ultimo degradamento al quale possa discendere l’umana ignoranza: questa vergogna del culto degli idoli è scomparsa in mezzo a noi, ma era comune allorché l’Apostolo scriveva la sua lettera. Egli la colloca tra le opere della carne, perché l’idolatria in sostanza è il culto dei sensi: per essa l’uomo spogliò Dio della sua natura spirituale ed invisibile; lo vestì di forme visibili e materiali, umane, e perfino bestiali, anzi brute e insensibili, e gettandosi ai piedi di queste opere delle sue mani, aventi occhi senza vedere, orecchi senza udire, lingua senza favellare, in un vero delirio di cecità e di ignoranza, esclamò: “Voi siete il mio dio; io vi adoro. „ Tanto pervertimento di mente e di cuore a noi sembra incredibile: eppure non lo vediamo noi, sotto altra forma, quasi comune nella società nostra cristiana? L’avaro che altro fa se non adorare le sue ricchezze? Il superbo, il goloso e il dissoluto, non prestano essi culto, non offrono essi sacrifici (e quali!) alla propria ambizione, al cibo ed alla bevanda di cui sono ghiotti, e agli oggetti dei brutti loro amori? Aveva ben ragione il Poeta di gridare:
Fatto vi avete Dio d’oro e d’argento:
E che altro è da voi all’idolatre,
Se non ch’egli uno e voi n’orate cento?
(Dante, inferno, c. XIX, v. 112 e segg.)
– Fine dunque, fine ad ogni idolatria! Creati per conoscere, amare ed adorare Dio solo nostro Creatore, che è nei cieli, non sia mai che facciamo oltraggio a Lui e a noi stessi, amando disordinatamente e quasi adorando le sue creature e spesso inferiori a noi. Dopo l’idolatria S. Paolo colloca tra le opere della carne ì veneficii od avvelenamenti. Trovando qui dopo l’idolatria ricordato dall’Apostolo il delitto orribile dell’avvelenamento ” veneficia, „ è forza il credere che fosse non raro. È cosa che riempie l’animo di spavento il pensare che nella società greco-romana dei tempi di S. Paolo, in mezzo al fascino delle ricchezze, delle lettere, delle arti, delle grandezze di quella civiltà, gli avvelenamenti, congiunti quasi sempre col tradimento, fossero pressoché comuni. Eppure la storia stessa profana l’attesta; né deve recarci meraviglia, sapendo troppo bene come la raffinatezza del lusso, delle arti, e le strabocchevoli ricchezze ingenerino i massimi corrompimenti del costume e spingano a delitti senza nome. Se i delitti di sangue, i suicidi e omicidi non sono infrequenti nella nostra società cristiana, che si dà vanto di civiltà matura, che vorrà essere stato della pagana? – S. Paolo continua nella trista enumerazione, e dice: ” Pur opere della carne sono ire, contese, gelosie, sdegni, risse, dissensioni, sètte, invidie, omicidi. „ Tutte le passioni che tormentano la povera nostra natura si riducono a due, a quella che dicesi concupiscibile ed all’altra, che chiamasi irascibile. Noi tutti senza eccezione, e sempre, desideriamo e procuriamo di acquistare ciò che ci diletta e ci giova, onori, ricchezze, piaceri e andate dicendo: ecco la passione concupiscibile; noi tutti egualmente respingiamo ed odiamo ciò che ci impedisce il possesso di questi beni o riputiamo beni: ecco la passione irascibile; con la prima tiriamo a noi il piacere, con la seconda respingiamo tutto ciò che ce lo contende. Anzi, se ragioneremo sottilmente, comprenderemo che le due passioni, concupiscibile ed irascibile, si riducono ad una sola, come insegna S. Tommaso, ed è l’amore. Noi amiamo e vogliamo il bene, anche quando ci appigliamo al male, perché lo apprendiamo sempre come bene. È questo stesso amore che ci porta al bene, quello che ci fa odiare e combattere gli ostacoli che si frappongono al bene, onde l’odio stesso è amore, amore del bene, che non vuole il suo contrario. – S. Paolo, nella prima parte or ora spiegata, enumera le opere della carne spettanti alla passione concupiscibile; qui enumera le principali che si riferiscono alla irascibile. Vuole che sbandeggiamo l’ira, che ci spinge alla vendetta, a volere o fare il male del prossimo: vuole che sbandeggiamo le contese, le gelosie, gli sdegni, le risse, le dissensioni, le sette, le invidie, gli omicidi. „ che sono tutte cose, le quali rompono la carità, seminano gli odii, mettono sossopra le famiglie, le parrocchie e la stessa società. Tutti questi disordini, contro dei quali il grande Apostolo levava la sua voce e voleva fossero tolti di mezzo alla Chiesa primitiva, ohimè! li vediamo turbare ed avvelenare le nostre famiglie, le nostre parrocchie e la nostra società, ancorché tutte cristiane. Quante contese e gare e sdegni! risse e dissensioni e partiti rabbiosi! Giriamo intorno gli sguardi, porgiamo orecchio allo strepito che ci assorda, e troveremo che anche al presente, come ai tempi di san Paolo, noi ci mordiamo e ci divoriamo gli uni gli altri. E siamo fratelli, figli dello stesso Padre, che è nei cieli, e della stessa madre, che è la Chiesa! Quale vergogna! quale vituperio! – Né qui si arresta S. Paolo, ma, come suole, nella sua foga, enumera altre opere malvagie della carne: “Ubriachezze, gozzoviglie e somiglianti — Ebrietates, comessationes et his similia. „ Queste parole cadute dalla penna dell’Apostolo ci richiamano alla mente uno spettacolo doloroso, che quasi ogni giorno ci sta sotto gli occhi. Molti soffrono la fame, non hanno con che coprire la loro nudità, albergano in miserabili tuguri, o piuttosto tane, ed altri seggono a laute mense, si ubriacano, spendono somme favolose in lusso, in passatempi, in sozzi piaceri! E l’ubriachezza che toglie all’uomo ciò che lo fa uomo, la ragione (lasciate che lo dica francamente), è più comune tra voi, o poveri, che tra i ricchi, Povertà ed ubriachezza! non si può immaginare accoppiamento più brutto di questo. Genitori ubriachi alla bettola, mogli e figliuoli piangenti di fame e freddo a casa! Sono disordini, sono mali che stringono il cuore e che sembrano impossibili in una società cristiana. Ma ponetevelo ben addentro nell’animo, grida qui indignato il santo Apostolo: “Ve lo dissi, ed ora ve lo ridico, tutti quelli che operano queste cose non possederanno il regno di Dio. „ Non illudiamoci, o fratelli miei: quanti si renderanno colpevoli di questi peccati, saranno inesorabilmente condannati da Dio alle pene eterne (Alcune delle colpe commemorate da S. Paolo in molti casi possono essere semplici peccati veniali, come le contese, le ire, le gelosie, le invidie ecc.; ma, in certe circostanze possono essere gravi. Dalla sentenza, con cui chiude la enumerazione, si rileva, che S. Paolo le considera nei casi che le costituiscono colpe gravi). E sentenza dell’Apostolo, è dottrina del Vangelo, e non ne cadrà invano una sola sillaba: riflettiamoci sopra, come vuole la grandezza della pena intimata. Chi ha qualche famigliarità con lo stile di S. Paolo, si accorge facilmente ch’egli ama le antitesi, ossia quella maniera di dire, per la quale ad una cosa si mette di fronte la contraria, e qui ne abbiamo una prova. Dopo aver fatto passare sotto i nostri occhi la lunga e brutta serie delle opere o peccati della carne o delle passioni, ora ci schiera dinanzi una serie quasi eguale delle opere o dei frutti dello Spirito, o della grazia di Dio in quelli che la posseggono. Udiamolo. – Il frutto dello Spirito è carità, gaudio, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, mansuetudine, continenza, modestia. „ Vedete, carissimi, un albero coperto di fiori e di fratti: quei fiori e frutti donde germogliano? Donde traggono il succo vitale che li nutre e li fa vigoreggiare? Dalla radice, dal seme che gli diede la vita. Vedete un uomo adorno di tutte le virtù cristiane: donde queste virtù e gli atti, nei quali si vanno svolgendo le stesse virtù? Dallo Spirito di Dio, dalla grazia, che ne è il primo germe. S. Paolo, volendo porci innanzi i fiori e i frutti benedetti della grazia divina, come ci ha messi innanzi i frutti amari e mortiferi della concupiscenza, comincia dalla carità, che è la regina di tutte le virtù, e sulla quale, come sul suo fondamento, poggiano tutte le altre, quasi rami sul loro tronco: carità verso Dio e verso il prossimo, carità ricca non di sole parole, ma di opere. Frutto di questa carità è il gaudio, cioè quella coscienza netta, serena, tranquilla, che spande nell’anima una gioia soavissima, e che brilla eziandio al di fuori e soprattutto negli occhi. Inseparabile compagna di questa coscienza pura e contenta di sé è la pace interna, che sta riposta nell’equilibrio di tutte le potenze dell’anima, o, come scrive S. Agostino, nella tranquillità dell’ordine, per cui tutto è composto in un’armonia inalterabile. Col gaudio e con la pace vanno congiunte la longanimità e la benignità, che ci rendono facili al compatimento, dolci ed umili nella parola, nel tratto, in ogni cosa, con ogni classe di persone, anche coi tristi, coi malevoli, coi nemici stessi. Con questi doni dello Spirito di Dio si accompagnano la bontà, che ci porta a far bene a tutti, e la mansuetudine, che fa soffrire ogni cosa senza fiele e con la serenità sulla fronte; vengono poi la fedeltà, nemica della frode e della menzogna, che ci rende leali osservatori delle promesse fatte e dei doveri assunti: la modestia, che dà a tutti i nostri atti esterni la giusta misura, e finalmente la continenza, che mette il freno a tutte le nostre voglie, fermo l’occhio nella regola infallibile della fede. – Non è a credere, o dilettissimi, che qui san Paolo abbia voluto ricordare tutti i doni dello Spirito di Dio e i frutti della sua grazia; no, ha ricordato soltanto i principali, come gli si affacciavano alla mente e come tornava più utile ai Galati, turbati, allora da intestine discordie. – In questa sì bella enumerazione noi pure abbiamo molto da apprendere: essa mi pare somigliante ad una lauta mensa, su cui sono imbandite molte e squisite vivande: ciascuno prende ciò che maggiormente gli piace e giova; lo stesso facciamo noi, fermando la nostra attenzione su quella virtù, che risponde meglio ai bisogni speciali di ciascuno di noi. “Contro a siffatte cose, dice S. Paolo, non vi è legge. „ Fate che un uomo operi secondo questo Spirito del Vangelo e dia questi frutti di vita, qual legge mai lo potrà biasimare o condannare? Di qual legge volete voi che abbia bisogno? Egli è legge a se stesso e non ha nulla a temere, perché adempie perfettamente ciò che la legge prescrive. – “Ora quelli che appartengono a Cristo, conchiude S. Paolo, hanno crocifissa la loro carne con i vizi e con la concupiscenza. „ Gesù Cristo, così mi sembra ragionare l’Apostolo, Gesù Cristo tolse sopra di sé la pena ch’era dovuta ai nostri peccati, e sulla croce scontò nella sua carne santa le nostre colpe: Egli crocifisse per noi la sua carne. Ora che dobbiamo far noi? Questa carne è il fomite delle nostre passioni: in essa si appiatta la concupiscenza con tutti i vizi, dei quali è madre feconda: essa senza tregua combatte lo Spirito. – Noi dobbiamo metterci dalla parte dello Spirito, dalla parte cioè di Cristo, e combattere questa carne, questa concupiscenza, che giorno e notte ci insidia e tormenta. Come Cristo confìsse alla croce il suo corpo, così noi mettiamo in croce la carne con i suoi vizi e le sue concupiscenze, ed allora mostreremo d’essere veramente discepoli di Cristo e suoi soldati. E come la porremo in croce? Porse materialmente, come fece Gesù Cristo? No, ma moralmente, come a noi ora è possibile e imposto. La concupiscenza ti gonfia con la vanità, con l’orgoglio, con l’ambizione? E tu con l’umiltà la schiacci. Ti invita, ti spinge ad accumulare ricchezze, non badando che talvolta sono il prezzo della iniquità, il frutto di chi soffre la fame? E tu le volgi le spalle e sii largo coi poverelli. Ti trae a trasmodare nel mangiare e bere e quasi, come scrive altrove lo stesso Apostolo, a farti Dio del ventre? tu resisti all’abbietta voglia e tieniti saldo nei confini della temperanza e castiga la gola. Ti solletica con la mollezza dell’ozio? Ti punge con lo stimolo dell’invidia? ti accende in cuore il fuoco dell’ira e dell’odio? Ti accarezza e tenta sedurti con le blandizie e con i sozzi piaceri del senso? E tu sventa le insidie, rigetta gli assalti, reprimi e calpesta l’implacabile nemica sotto qualunque forma si presenti. Con il timore dei divini giudizi, con la vigilanza costante sopra i tuoi sensi, con la preghiera, con la mortificazione, con la penitenza raffrena e crocifiggi la concupiscenza, ed apparterrai al numero di coloro che sono di Cristo.
Graduale
Ps CXVII:8-9
Bonum est confidére in Dómino, quam confidére in hómine. È meglio confidare nel Signore che confidare nell’uomo.
V. Bonum est speráre in Dómino, quam speráre in princípibus. Allelúja, allelúja [È meglio sperare nel Signore che sperare nei príncipi. Allelúia, allelúia].
Alleluja
XCIV:1.
Veníte, exsultémus Dómino, jubilémus Deo, salutári nostro. Allelúja. [Venite, esultiamo nel Signore, rallegriamoci in Dio nostra salvezza. Allelúia.]
Evangelium
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum S. Matthæum.
R. Gloria tibi, Domine!
Matt VI: 24-33
“In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Nemo potest duóbus dóminis servíre: aut enim unum ódio habébit, et álterum díliget: aut unum sustinébit, et álterum contémnet. Non potéstis Deo servíre et mammónæ. Ideo dico vobis, ne sollíciti sitis ánimæ vestræ, quid manducétis, neque córpori vestro, quid induámini. Nonne ánima plus est quam esca: et corpus plus quam vestiméntum? Respícite volatília coeli, quóniam non serunt neque metunt neque cóngregant in hórrea: et Pater vester coeléstis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis? Quis autem vestrum cógitans potest adjícere ad statúram suam cúbitum unum? Et de vestiménto quid sollíciti estis? Consideráte lília agri, quómodo crescunt: non labórant neque nent. Dico autem vobis, quóniam nec Sálomon in omni glória sua coopértus est sicut unum ex istis. Si autem fænum agri, quod hódie est et cras in clíbanum míttitur, Deus sic vestit: quanto magis vos módicæ fídei? Nolíte ergo sollíciti esse, dicéntes: Quid manducábimus aut quid bibémus aut quo operiémur? Hæc enim ómnia gentes inquírunt. Scit enim Pater vester, quia his ómnibus indigétis. Quaerite ergo primum regnum Dei et justítiam ejus: et hæc ómnia adjiciéntur vobis”.
Omelia II
[Mons. G. Bonomelli: ut supra Omelia IV .- Torino 1899 – Impr.]
“Gesù disse ai suoi discepoli: Nessuno può servire a due padroni; perciocché o avrà in odio l’uno ed amerà l’altro, ovvero aderirà all’uno e disprezzerà l’altro; non potete servire a Dio ed a mammona. Per questo vi dico: Non siate angustiati per il cibo per la vostra vita, né del vestito per la vostra persona. La vita non è forse da più del cibo, e la persona non è da più del vestito? Guardate gli uccelli dell’aria, come non seminano, né mietono, né ripongono sui granai; eppure il Padre vostro celeste li pasce. Ora non siete voi forse da più senza confronto di essi? E chi di voi può, con l’affannarsi, aggiungere un cubito alla sua statura? E del vestito a che mostrarvi ansiosi? Vedete i gigli del campo, come crescono: essi non lavorano e non filano; eppure io vi dico, che nemmeno Salomone, con tutta la sua magnificenza, andò vestito come uno di questi. Se pertanto Iddio veste in tal modo l’erba del campo, che oggi è, e domani è gettata nel forno, non lo farà egli più assai per voi, uomini di poca fede? Non vogliate adunque angustiarvi, dicendo: Che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo? Di tutte queste cose si danno affannosa cura i pagani; ma il Padre vostro vede che ne avete bisogno. Cercate adunque anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte „ ( San Matteo, VI, 24 – 33). Fin qui l’odierno Vangelo. – Sulla sponda destra del lago di Tiberiade o Genesaret, a tre ore da Cafarnao, sorge una collina solitaria, fiancheggiata da due alture: ai piedi di quella collina si stende una bella prateria. Tutto intorno la pianura è verdeggiante, e al tempo delle messi somiglia un oceano di spighe, che l’aria mollemente fa ondeggiare. A tramontana si vede biancheggiare la vetta del Libano, e ad oriente, chiuso tra le rive, coperte un tempo, di oleandri, di vigne e di olivi, ora nude e squallide, increspa le sue onde azzurre il lago. La collina nel mese di aprile, è seminata di gigli, e sciami di uccelli, lietamente cantando, volteggiano per quell’aria tranquilla ed imbalsamata della fragranza, di primavera. Su quella collina secondo un’antica e rispettabile tradizione, Gesù tenne il discorso che si chiama del monte. E da quel discorso è tolto il brano che avete udito. Esso è d’una bellezza e soavità inarrivabile: è, direi quasi, un inno, un cantico innalzato alla Provvidenza; nelle sentenze, che verremo meditando, si sente traboccare tutta l’anima di Gesù, che riposa e si delizia nella confidenza illimitata e nell’amore infinito del Padre suo, che non vede e non ama che Lui e tutti quelli che si raccolgono sotto le ali della sua provvidenza. Mi tarda di farvi gustare le dolcezze ineffabili di questo tratto dell’Evangelo. – “Nessuno può servire a due padroni, perché o avrà in odio l’uno, ed amerà l’altro; ovvero aderirà all’uno, e disprezzerà l’altro; non potete servire a Dio ed a mammona. „ Gesù Cristo stabilisce una dottrina, che basta annunziarla per dimostrarla. Non è possibile servire a due padroni, s’intende, che siano tra loro contrari. E perché? Perché, essendo tra loro contrari, andando avverso dell’uno, sarà forza offendere l’altro; stando con l’uno, l’altro naturalmente si considererà abbandonato e disprezzato. E chi sono codesti due padroni tra loro contrari, ai quali è affatto impossibile il servire? Gesù Cristo lo dice chiaramente nell’ultima sentenza di questo versetto: “Non potete servire a Dio ed a mammona. „ Chi sia Dio, non occorre il dirlo. Chi è mammona? E una parola fenicia, nota in Palestina, che significa ricchezza o danaro; perciò la sentenza di Cristo si può tradurre così: ” Non potete servire ad un tempo stesso a Dio ed alla ricchezza, ai beni della terra. „ Osservate che Gesù non disse: Non potete tener il danaro o le ricchezze, o i beni di questa terra; non potete usarli, né conservarli od accrescerli; ma disse: Non potete servire a Dio e servire insieme alle ricchezze, quasi pareggiandole a Dio, ed anziché essere padroni delle ricchezze, farvi vergognosamente loro servi. Quanta verità! Quanta sapienza in queste parole! Vediamo di penetrarne il senso. – L’uomo è creato da Dio in modo, che ha bisogno di moltissime cose: ha bisogno di cibo, di bevanda, di vesti, di casa; ha bisogno di chi gli fornisca gli strumenti per procurarsi tutte queste ed altre cose, che non importa ricordare. Come averle? Come indurre gli altri a cederle a nostro uso o proprietà? Col dare a loro ciò di cui anch’essi hanno bisogno; così si stabilì a principio lo scambio delle cose. Ma per rendere più facile e comune questo scambio necessario delle cose, si trovò il danaro, che per comune consenso è l’equivalente di tutte; onde col danaro avete il cibo, la bevanda, le vesti, la casa, gli animali, i campi, i passatempi, tutto che volete; ed in questo senso la Scrittura stessa ci dice che: “Al danaro tutto obbedisce — Pecunim omnia obediunt „ (Eccle. x). Ora siccome l’uomo ha bisogno di molte cose che soddisfino ai suoi bisogni legittimi; non basta, siccome ha bisogno di infinite cose per procurarsi tutti i piaceri, dei quali è ghiotto, siano leciti, siano illeciti, così volge tutti i suoi sforzi all’acquisto del danaro, perché con questo tutto può avere, o almeno crede di poter avere. Il perché in qualche senso possiamo dire, che tutti gli amori dell’uomo verso i beni della terra sì concentrano in un solo amore, l’amore della ricchezza, attesoché questa nella universale estimazione equivale a tutte le cose. Ecco, o carissimi, la ragione di questa fame e sete rabbiosa delle ricchezze, onde si struggono pressoché tutti gli uomini: ecco perché per un po’ d’oro non badano a coscienza, a leggi, ad onore, e nemmeno alla salute ed alla vita stessa del corpo, che pure sì ardentemente amano. La qual fame e sete dell’oro trova il suo stimolo non solo nei piaceri che procura direttamente a chi li vuol godere per sé, ma trova un complice potentissimo nelle incertezze dell’avvenire, nel timore di bisogni futuri, nell’amore dei figli, dei nipoti e perfino nei desideri e disegni della beneficenza. Io non esito a dire, che la cupidigia del danaro, qual mezzo sicuro per giungere ai piaceri, in fondo in fondo è la prima e più terribile delle passioni che tiranneggiano la natura umana; non è la prima qual fine, ma sì qual mezzo al fine, e chi studierà bene la storia e la natura umana, senza dubbio dovrà meco convenire, onde è vera quella doppia sentenza dello Spirito Santo, che disse: “Radice d’ogni male è la cupidigia dell’avere; „ e: ” Non vi è uomo più malvagio dell’avaro. „ E perfino il sommo dei poeti pagani ebbe a chiamare esecrabile, la fame dell’oro: Auri sacra fames; e un altro poeta cantò che l’oro è il Dio degli uomini, la maestà suprema (Petronio e Giovenale). — Era dunque troppo giusto che Gesù Cristo, conoscitore infallibile del cuore umano, sfolgorasse questa malnata passione, che si mette per poco a fianco di Dio ed osa dividere con lui l’impero sull’animo nostro, ammonendoci: ” Non potete servire a Dio ed a mammona. „ – Seguitiamo il nostro commento. La ragione, o pretesto, che si suole mettere innanzi dagli avari, che servono alle ricchezze e non dicono mai basta, suole essere questa: — Noi ne abbiamo bisogno per noi, pei nostri figli: abbiam bisogno di vivere, del pane e del vestito e di tante altre cose: queste come provvederle senza l’oro? Servire alle ricchezze è una necessità, come è una necessità l’aria per respirare —. Gesù previene questa difficoltà, e risponde con una eloquenza sì naturale, che nulla di più bello. Voi dite: Senza danaro come ci nutriremo? come ci vestiremo? ” Per questo io vi dico: Non siate angustiati per l a vostra vita, né del vestito per la vostra persona.„ Vogliate por mente che Gesù non disse: Non vi date pensiero alcuno del cibo e del vestito; non curate di provvedere il necessario; lasciate il lavoro, non arate i vostri campi, non li seminate, non potate le vostre viti, riposate in un ozio beato. No, non disse, né poteva dir questo Egli che lavorò fino a 30 anni in una povera officina; Egli che allora lavorava, ammaestrando il popolo; Egli che volle il lavoro qual condizione della vita, e lo santificò in se stesso; ma disse solo: “Non siate ansiosi od angustiati — Ne sollicìti sitis. „ Non la cura affannosa, la febbre del lavoro per arricchire, che è ben altra cosa del lavoro onesto inteso a provvedere il necessario, ed anche il conveniente, ma non il superfluo. La dottrina di Cristo è questa: Lavorate onestamente e cristianamente per vivere voi ed i vostri figli, e soccorrere altri se ne hanno bisogno; provvedete pur anche alle incertezze dell’avvenire, ma non vogliate servire alla insaziabile cupidigia di accumulare ricchezze: lavorate secondo il vostro stato e le vostre forze, e poi con serena e figliale confidenza rimettetevi alla bontà infinita del Padre vostro Iddio. E perché? Perché Dio ci ha data la vita, e la vita è da più del cibo e del vestito: ora chi dà il più, deve dare il meno: chi ci ha data la vita, che è il più, non può essere scarso nel darci il cibo ed il vestito, che sono il meno. È un argomento semplicissimo e che non ammette replica. Dov’è l’uomo che fabbrichi la casa, e poi non si curi di conservarla? Che abbia comperato il cavallo, e che non lo alimenti e custodisca ? Dov’è il padre che rifiuti il pane ai suoi figli? L’autore e padrone d’una cosa qualunque, anche di pochissimo valore, è sollecito di conservarla: noi tutti siamo opere, anzi figli di Dio, da Lui teneramente amati; come volete che ci dimentichi e non provveda ai nostri bisogni? Qui, Gesù Cristo, rincalzando l’argomento, ricorre ad una graziosissima immagine. Egli parlava all’aperto, dalla collina su cui era seduto (capo V, 1); forse in quell’istante alcuni augelletti passarono sopra il suo capo, o fecero udire i loro lieti gorgheggi dagli alberi vicini” il divino Maestro, continuando il suo discorso, ed avvivandolo con una immagine bellissima e che cadeva sotto gli occhi dei suoi uditori, levò la mano e gli occhi, e disse: “Guardate gli uccelli dell’aria, come non seminano, né mietono, né ripongono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li pasce. Ora non siete voi forse assai più di loro? „ In questa immagine, in queste parole, che dovette pronunziare con gli occhi scintillanti d i gioia e con accento d’inesprimibile tenerezza, tutto rivela il candore dell’anima di Gesù e la bontà del suo cuore divino. Gli uccelli spiegano alla luce del sole la ricchezza delle loro piume: chi le ha lavorate con tanta varietà e vaghezza di tinte? Chi li ha vestiti con tanta pompa? Dio, solo Dio. Essi non lavorano, non mietono, non ripongono provvigioni pure vivono; l’aria, gli alberi e la terra forniscono loro il cibo necessario: la terra è perpetuo banchetto imbandito per essi, e l’acqua del ruscello o del lago li disseta. Chi li nutre? “È il Padre vostro celeste „ che li provvede e non ne lascia perire un solo di fame. Notate quella forma sì affettuosa di dire: “E il Padre vostro che li nutre; „ come se dicesse: Dio non è padre di questi augelletti, ma sì è Padre di voi, uomini; ora s’Egli pasce queste creature sì piccole, di sì poco valore, e delle quali non è padre, come non dovrà pascere voi, che siete da tanto più di loro, che siete le opere più grandi delle sue mani, voi, dei quali Egli si dichiara Padre? Non si può immaginare argomento di questo più semplice e più efficace per dimostrare la cura paterna che Dio ha e deve avere di ciascuno di noi. Gesù passa ad un’altra prova pur essa in sommo grado popolare. Chi di voi, domandava Cristo ai suoi uditori, chi di voi, per affannarsi che faccia, può aggiungere un cubito alla propria statura? „ Nessuno: voi non potete aggiungere una sola linea alla vostra statura; non potete nemmeno, diceva in altro luogo del Vangelo, far nero o bianco un solo capello del vostro capo. Impotenti a far questo, a che vi affannate tanto per le cose della terra? Assai volte non è in poter vostro mutarle, crescerle, diminuirle, averle o non averle; dunque chetatevi, e, fatto ciò che per voi è possibile, lasciatene la cura a Dio, Padre vostro. Di due cose soprattutto gli uomini sono angustiati, del cibo e del vestito, e sono veramente le principali quanto ai bisogni del corpo. Sopra, coll’immagine degli uccelli, Gesù ha provato che non dobbiamo angustiarci del cibo: ora, quanto al vestito, adopera un’altra similitudine non meno felice e graziosa. La terra intorno era coperta d’un verde tappeto, ed in mezzo ai fiori, ond’era smaltata, apparivano qua e là i candidi gigli. Vedendoli, Gesù proseguì il suo parlare: “E del vestito, perché vivere in angustia? Vedete i gigli del campo (e li additava), come crescono: essi non lavorano e non filano; eppure io vi dico, che nemmeno Salomone, con tutta la sua magnificenza, andò vestito come uno di questi. „ Quanta semplicità, quanta grazia e quanta verità in questa espressione del divino Maestro! Voi, così Egli, vi date grande affanno per il vestito: vedete questi gigli come son belli, candidi come la neve! Essi certamente non hanno lavorato, né filato quei sottilissimi fili, onde si intessono le loro foglie: essi non hanno lavorato la loro corolla, né architettato quel loro calice dai contorni sì perfetti e simmetrici. Vedeteli: essi sono senza confronto più belli, più magnifici di quelli, ond’era trapuntato il manto di Salomone, allorché compariva in tutto lo splendore della regale sua maestà (Si dice che i re antichi ed anche Salomone portassero il manto ornato di gigli, come già i re Borboni. Può essere, ed allora le parole di Cristo quadrano a capello). Eppure, argomenta nuovamente Cristo, che cosa sono questi gigli? Sono un po’ d’erba, là quale oggi è, e domani è gettata nel forno. Ora se Dio veste di tanta bellezza quest’erba che vedete, che non serve a nulla, che ha la vita di pochi giorni, come con maggior cura non vestirà voi, suoi figliuoli? — È sempre lo stesso argomento; se Dio è sì largo con creature sì spregevoli, come non lo sarà maggiormente coll’uomo, capolavoro delle sue mani? Qui, a modo di dolce rimprovero, Gesù aggiunge queste parole: “Uomini di poca fede. „ – Voleva dire: Sarebbe ben debole la vostra fede, o figliuoli; mostrereste di conoscere ben poco Dio e il suo cuore paterno, e gli fareste offesa ben grave, se vi fosse possibile il pensare e credere che Quegli, il quale ha tanta e sì tenera cura delle più piccole tra le sue creature, avesse a dimenticare voi, suoi figli dilettissimi e lasciarvi in difetto delle cose necessarie. Non vi è uomo e cristiano, che consideri e comprenda alcun poco questa sentenza sì cara, e non sentasi commosso e confortato a riporre in Dio ogni fiducia. – Segue un versetto, che è il compendio naturale delle medesime. “Non vogliate adunque angustiarvi dicendo: Che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo? „ Giova qui ribadire ciò che sopra già dissi, perché è cosa pratica ed importante: Gesù Cristo, predicando la necessità di collocare ogni nostra speranza in Dio e nella sua provvidenza, non intende di inculcare l’ozio e l’inerzia, quasi eliminando la parte, e grandissima, che ha l’uomo di stabilire, con l’uso della propria libertà, le sue sorti sulla terra ed in cielo: nulla di più contrario alla dottrina del Vangelo di quel cieco fatalismo, che condanna l’uomo alla in operosità e tutto aspetta da Dio; siffatta dottrina, propria dei Musulmani e dei Bramini dell’India, è un insulto al Vangelo ed alla coscienza nostra, e importa la negazione di ciò che forma la grandezza dell’uomo, la libertà. Gesù Cristo vuole che l’uomo dal canto suo faccia tutto ciò che è in suo potere, proscrivendo solo quell’ansia, quella inquietudine e quell’affannarsi per le cose di quaggiù, che proviene dal manco di fede nella Provvidenza divina, e per questo ripete ancora ciò che disse sopra nel versetto ventesimoquinto: ” Non vogliate angustiarvi, dicendo, che mangeremo o che berremo, o di che ci vestiremo? „ A che serve l’angustiarsi? Accresce le nostre pene interne, turbando la pace dello spirito, ed offende Dio nostro Padre, mostrando col che dubitiamo o della sua potenza o della sua bontà. – Il Salvatore continua il suo discorso condannando ancora più vivamente questo affannarsi per le cose terrene. Sapete voi, così Egli, ciò che fate allorché vi mostrate sì inquieti e ansiosi per questi beni materiali, che pur vi sono necessari? Voi allora, sappiatelo bene, fate come i pagani: ” Di tutte queste cose si danno briga affannosa i pagani. „ I pagani, o non avevano un’idea della Provvidenza, o l’avevano imperfettissima; come non avevano idea di Dio, o l’avevano imperfetta e contraddittoria. Senza idea di Dio e della sua provvidenza, o con idee false e contraddittorie, era cosa naturale che quei poveri pagani fossero tutto affanno in pensare e procurare i beni della terra, non potendo contare sulla provvidenza di Dio. Essi meritavano qualche compatimento per la ignoranza, in cui si trovavano: ora volete voi, educati alla scuola della fede, voi, figli di Dio, fare come i pagani? Sarebbe una vergogna e una colpa inescusabile. Voi sapete che “il Padre vostro vede che di tutte queste cose avete bisogno — Scit enim Pater vester quia his omnibus indigetis. Ma basta egli che Iddio conosca i nostri bisogni perché siamo sicuri del suo aiuto? E perché nostro Signore non aggiunse la promessa, che al conoscimento dei nostri bisogni sarà unito il suo soccorso? Miei cari! Allorché si tratta degli uomini il conoscere i bisogni è necessario, ma non basta se fanno difetto il potere e il volere di provvedervi; ma quando si tratta di Dio, nel quale al conoscimento perfettissimo delle cose sono pari la potenza e la volontà, basta il dire: “Il Padre vostro sa che di queste cose abbisognate. „ Egli è Onnipotente e buono, infinitamente buono, e perciò nell’atto che conosce i nostri bisogni, e può e vuole aiutarci. È egli possibile che un padre sappia che il figliuolo suo ha bisogno di pane e di vesti, e potendo, non voglia dar quello e queste ? Ora Dio è il Padre nostro: tutto può, e ci ama dell’amore più tenero, di un amore infinito, comparato al quale l’amore di tutti insieme i padri della terra, è nulla; dunque non può non stendere la mano soccorrevole. – Udite come in altro luogo parla Gesù Cristo: “Se tra voi un figlio chiede al padre un pane, gli darà questi forse una pietra? E se un pesce, gli darà forse per pesce un serpente? O se chiede un uovo, gli darà forse in mano uno scorpione? Se pertanto voi che siete cattivi, sapete dare buone cose ai vostri figli, quanto più il Padre vostro dal cielo darà spirito buono a quelli che glielo domandano? „ Queste parole dipingono il cuore paterno di Dio verso di noi suoi figliuoli. – Qui prevedo due difficoltà che vi si affaccino, ed alle quali è prezzo dell’opera rispondere brevemente. Voi dite: Se Dio sa (e chi ne può dubitare?) i nostri bisogni, non occorre che lo preghiamo: e come avviene che conoscendoli e pregato da noi, non rare volte non ci ascolta, non ci soccorre e ci lascia soffrire? Sa i nostri bisogni meglio che non li conosciamo noi, eppure vuole che li confessiamo e lo preghiamo; lo vuole, perché è bene per noi che lo preghiamo; ed è bene per noi perché con la preghiera eccitiamo la fede, ravviviamo la speranza in Lui, esercitiamo l’umiltà, e in qualche modo meritiamo ciò che domandiamo. Vuol essere pregato, non per bisogno ch’Egli n’abbia, ma sì per il bene nostro. Talvolta poi, anche pregato, non ci esaudisce, e ci lascia lottare coi bisogni, che ci assediano, è vero: ma perché? Non perché ignori i nostri bisogni, o quasi si diletti del nostro patire, Egli che ci ama come suoi tìgli, ma perché nella sua sapienza trova più utile per noi il soffrire e lasciarci alle prese con le nostre privazioni e coi nostri bisogni; perché ci porge occasione di esercitare la pazienza: perché così ci costringe a raddoppiare i nostri sforzi, a perseverare nella preghiera; perché così ci addestra ai forti combattimenti della virtù, accresce i nostri meriti e ci viene staccando dall’amore sregolato della terra e quasi sforzandoci a volgere i nostri pensieri e desideri al cielo. Ah! dunque, o dilettissimi, quando lottate con le necessità della vita, quando la povertà vi stringe, e vedete i figli, la moglie, le persone a voi più care soffrire la fame, non potersi difendere dal freddo, ricordatevi che Dio sa tutto questo, tiene i suoi occhi pieni d’ amore sopra di voi, e, se è lecito il dirlo, soffre con voi e per voi, e se vi lascia nelle vostre angustie, credetelo, lo fa perché vi ama e vuole arricchirvi di beni maggiori e migliori: è un padre che nega al figliuolo suo un frutto desiderato, perché sa che gli nuocerebbe. – Il discorso di Gesù Cristo si chiude con una sentenza bellissima, che vorrei non dimenticaste mai; è questa: ” Cercate adunque in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. „ Gesù Cristo vuole che sopra tutto cerchiamo il regno dei cieli, cioè la vita eterna e la sua giustizia, cioè la grazia, qual mezzo indispensabile per giungere alla vita eterna. Così vuole Gesù Cristo, e così vuole altresì il vero nostro bene. La ragione e la fede esigono che noi siamo solleciti maggiormente i n procurarci quei beni che sono i più necessari per noi e per se stessi più nobili e più eccellenti: è verità evidente, che non abbisogna di prova. – Ora che vediamo noi, o dilettissimi? Che accade continuamente intorno a noi? Ohimè! E pur forza confessarlo: la maggior parte dei cristiani, anche di quelli che con 1’esempio dovrebbero andare innanzi agli altri, tiene contrario cammino. Cristo dice: ” Cercate in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte; „ ed essi cercano in primo luogo queste cose, cioè le cose del tempo, sperando ed avendo la pretensione che il regno di Dio e la sua giustizia saranno dati per giunta. Quale stravolgimento di idee! quale dimenticanza della sentenza evangelica! Correre dietro a queste cose misere della terra, come se queste dovessero formare la nostra felicità, e mettere in secondo luogo quelle del cielo, che sole meritano tutto il nostro amore ed i nostri sforzi! Dio ci fa la generosa promessa di darci quasi in sovrappiù il necessario della vita, a patto che ci volgiamo a Lui con tutto il nostro cuore, e noi non curare la promessa e respingere l’offerta! Ci offre un cambio per noi vantaggiosissimo, dicendoci: ” Voi pensate a me, ed io penserò a voi; voi servite a me con la mente e col cuore, ed io servirò voi quanto al corpo „ e noi rifiutarlo villanamente! Non dimentichiamo mai che il corpo è ordinato all’anima, e che i beni di quaggiù sono mezzi per giungere al fine, che è la vita eterna; non vogliamo capovolgere ogni cosa, ponendo il fine al luogo dei mezzi, l’anima al luogo del corpo. E qui, sul finire dell’ omelia, non vi sia di peso che rettifichi un’idea, che è entrata in alcuni, anche buoni cristiani, e che non è conforme all’insegnamento del Vangelo. Iddio, nell’antica legge, agli Ebrei che la osservavano fedelmente, aveva promessa, oltre il premio in cielo, la ricompensa anche in terra nell’abbondanza dei beni materiali. Sembra che alcuni, per mancanza di istruzione, o riflessione, credano quella promessa di beni materiali potersi e doversi estendere anche nella legge di grazia, e si appoggiano a questa sentenza di Gesù Cristo. Ma è un errore, e vuolsi schivare con ogni cura. In questa sentenza Gesù Cristo ci dice soltanto, che facendo dal canto nostro ciò che possiamo e dobbiamo, e servendolo fedelmente (e per servirlo fedelmente bisogna lavorare ciascuno nel suo stato), ci darà queste cose in aggiunta . Ma quali sono queste cose ch’Egli ha nominato? Leggete attentamente il Vangelo sopra citato, e vedrete che sono il cibo ed il vestito necessario, non le ricchezze: quelli, non queste, promette, e quelli non ci verranno meno. Gesù Cristo è venuto sulla terra, ha predicato il Vangelo a tutti; ha promesso ai suoi fedeli seguaci non onori, non piaceri, non ricchezza, non lunga vita, non sanità sulla terra, ma ha predicato il distacco dalle ricchezze, lo spirito di povertà, la mortificazione, l’amore al lavoro: e ha promesso il necessario, cioè il vitto ed il vestito. Avendo di che nutrirci e di che coprirci, esclamava il suo grande Apostolo san Paolo, non domandiamo altro: Questo ci basti: “Habentes quibus vescimur et quibus tegamur, his contenti simus”.
Credo …
Offertorium
Orémus
Ps XXXIII:8-9
Immíttet Angelus Dómini in circúitu timéntium eum, et erípiet eos: gustáte et vidéte, quóniam suávis est Dóminus. [L’Angelo del Signore scenderà su quelli che Lo temono e li libererà: gustate e vedete quanto soave è il Signore].
Secreta
Concéde nobis, Dómine, quǽsumus, ut hæc hóstia salutáris et nostrórum fiat purgátio delictórum, et tuæ propitiátio potestátis. [Concédici, o Signore, Te ne preghiamo, che quest’ostia salutare ci purifichi dai nostri peccati e ci renda propizia la tua maestà].
Communio
Matt VI:33
Primum quærite regnum Dei, et ómnia adjiciéntur vobis, dicit Dóminus. [Cercate prima il regno di Dio, e ogni cosa vi sarà data in più, dice il Signore.]
Postcommunio
Orémus.
Puríficent semper et múniant tua sacraménta nos, Deus: et ad perpétuæ ducant salvatiónis efféctum. [Ci purífichino sempre e ci difendano i tuoi sacramenti, o Dio, e ci conducano al porto dell’eterna salvezza].