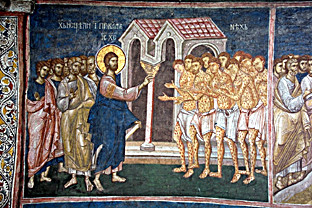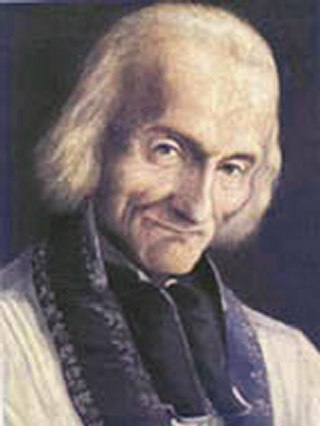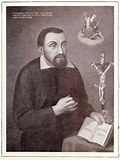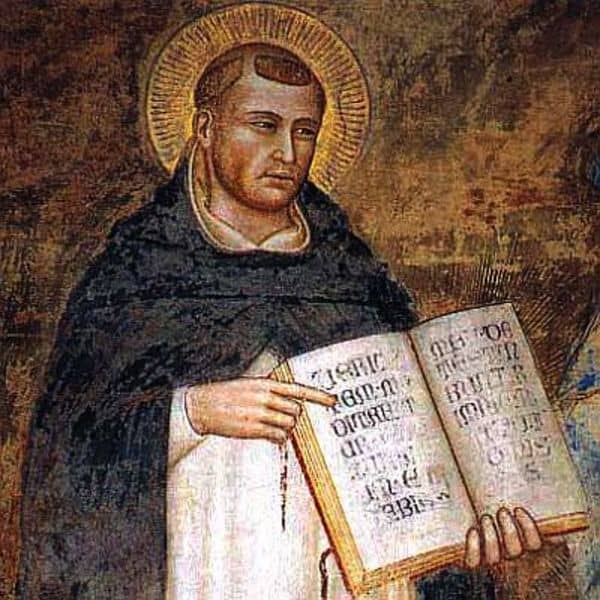LA SUMMA PER TUTTI (15)
R. P. TOMMASO PÈGUES: LA SOMMA TEOLOGICA DI S. TOMMASO DI AQUINO IN FORMA DI CATECHISMO PER TUTTI I FEDELI
PARTE SECONDA
SEZIONE SECONDA
Idea particolareggiata del ritorno dell’uomo verso Dio.
Capo XLIX
La temperanza. – L’astinenza. – Il digiuno. – Vizio opposto: la gola.
1283. Quale è l’ultima delle grandi virtù morali che devono assicurare la perfezione della vita dell’uomo nel suo viaggio di ritorno verso Dio?
È la virtù della temperanza (CXLICLXX).
1284. Che cosa intendete per virtù della temperanza?
Intendo quella virtù che mantiene in tutte le cose la parte affettiva sensibile nell’ordine della ragione, affinché non si lasci andare illecitamente ai piaceri riguardanti più particolarmente il senso del tatto, negli atti necessari alla conservazione della vita corporale (CXLI, 1-5).
1285. Quali sono queste specie di piaceri?
Sono i piaceri della mensa e del matrimonio.
1286. Che nome prende la virtù della temperanza in materia di piaceri della mensa?
Si chiama astinenza o sobrietà (CXLVICXLIX).
1287. In che consiste l’astinenza?
Consiste nel regolare la parte affettiva sensibile rispetto al bere ed al mangiare, perché vi si comporti conforme a ciò che detta la ragione (CXLVI, 1).
1288. Quale è la forma speciale che può rivestire la pratica della virtù dell’astinenza?
È la forma del digiuno (CXLVII).
1289. Che cosa intendete per digiuno?
Intendo la rinunzia ad una parte di ciò che normalmente è richiesto per la propria alimentazione quotidiana (CXLVII, 1, 2).
1290. Ma non è cosa illecita questa?
No; al contrario il digiuno può essere cosa eccellente, perché serve a reprimere la concupiscenza, rende lo spirito più libero di attendere alle cose di Dio, e permette di soddisfare per il peccato (CXLVII, 1).
1291. Che cosa occorre perché il digiuno sia cosa buona ed eccellente?
Occorre che sia sempre regolato dalla prudenza e dalla discrezione, e non abbia mai a compromettere la salute o riuscire un ostacolo per i doveri del proprio stato (CXLVII, art. 1 ad 2).
1292. Ogni uomo che abbia l’uso di ragione è tenuto al digiuno?
Ogni uomo che abbia l’uso di ragione è tenuto ad una certa forma di digiuno o di
privazione proporzionata al bisogno della virtù nella vita morale; ma non al digiuno prescritto dalla Chiesa (CXLVII, 3-4).
1293. Che cosa intendete per digiuno prescritto dalla Chiesa?
Intendo una forma speciale di digiuno determinata dalla Chiesa, e prescritta a partire
da una certa età per certi giorni dell’anno (CXLVII, 5-8).
1294. In che cosa consiste questa forma speciale di digiuno?
Consiste nel fare un solo pasto propriamente detto nella giornata (CXLVII, 6).
1295. L’ora ed il momento di questo pasto sono cosa assolutamente fissa ed immutabile?
No; perché si può fare a mezzogiorno o la sera.
1296. Si può prendere qualche cosa fuori di questo pasto propriamente detto?
Sì; si può prendere qualche cosa la mattina sotto forma di leggerissimo anticipo,
e la sera sotto forma di colazione (Codice, can, 1251).
1297. Chi è tenuto al digiuno prescritto dalla Chiesa?
Tutti i Cristiani battezzati che hanno compiuto il loro ventunesimo anno, fino alla età di cinquantanove anni parimente compiuti (Codice, can. 1254).
1298. Che cosa occorre per non digiunare quando si è in queste condizioni?
Bisogna essere impediti da una manifesta ragione di salute o di lavoro; e nel dubbio occorre la dispensa della legittima autorità (CLXVII, 4).
1299. Chi può dare questa dispensa?
Praticamente basta chiederla al proprio superiore ecclesiastico immediato.
1300. Quali sono i giorni in cui si è obbligati al digiuno ecclesiastico?
Tutti i giorni di Quaresima, eccetto la domenica; il mercoledì, venerdì e sabato dei Quattro Tempi dell’anno; e le vigilie della Pentecoste, dell’Assunzione [commutata alla vigilia dell’Immacolata -ndr.-], di Tutti i Santi e del Natale. Se queste vigilie cadono in domenica non si è obbligati ad anticiparle (Codice, can. 1252).
1301. Non vi è una legge ecclesiastica per l’astinenza, distinta dalla legge del digiuno?
Sì; e questa legge consiste nell’obbligo di astenersi dalla carne e dal brodo di carne in tutti i venerdì dell’anno; e durante la Quaresima, il mercoledì delle Ceneri ed ogni sabato fino al mezzogiorno del Sabato Santo. Finalmente il mercoledì ed il Sabato dei Quattro Tempi (Codice, can. 1250-1252).
1302. Chi è tenuto alla legge dell’astinenza?
Tutti i fedeli che hanno compiuto il settimo anno di età (Codice, can. 1254).
1303. Qual è il vizio opposto alla virtù dell’astinenza?
È il vizio della gola (CXLVIII
1304. Che cosa intende per vizio di gola?
Intendo una propensione disordinata verso il bere ed il mangiare (CXLVTIII, 1:
1305. Questo vizio ha diverse specie?
Sì; perché questa tendenza disordinata al bere ed al mangiare può riferirsi alla natura dei cibi, alla loro qualità, alla loro quantità, alla loro preparazione, o anche al fatto stesso di prenderli senza attendere l’ora voluta, o mangiando con troppa avidità (CXLVIII, 4).
1306. La gola è un vizio capitale?
Sì; la gola è un vizio capitale, perché inclina ad uno di quei piaceri che sono di natura tale da provocare maggiormente il desiderio dell’uomo e farlo agire secondo essi (CXLVII, 5).
1307. Quali sono gli effetti della gola?
Sono la ebetudine dello spirito riguardo alle cose della intelligenza; la gioia insensata: la intemperanza di linguaggio, la scurrilità e la impurità (CXLVIII, 6).
1308. Sono vizi questi particolarmente lascivi; e perché provengono specialmente dalla gola?
Questi vizi sono particolarmente lascivi perché implicano maggiormente una diminuzione o una quasi assenza della ragione; e provengono dalla gola perché la ragione, quasi assopita e addormentata sotto l’azione delle smoderatezze di essa, non tenendo più il governo di una mano ferma, tutto nell’uomo declina (Ibid).
Capo L.
La sobrietà. – Vizio opposto: la ebrietà.
1309. Oltre l’astinenza, vi è un’altra virtù che aiuta l’uomo a prevenire tali effetti?
Sì; vi è la virtù della sobrietà (CXLIX)
1310. Che cosa intendete per virtù della sobrietà?
Intendo una virtù speciale, che ha per proprio oggetto di fare sì che l’uomo non usi se non come conviene, di ogni bevanda capace di inebriare (CXLIX, 1-2),
1311. Qual è il vizio opposto a questa virtù?
È il vizio di passare la misura nell’uso di tali bevande, fino a cadere in istato di ebrietà od ubriachezza (CL).
1312. Che cosa intendete per istato di ebrietà od ubriachezza?
Intendo uno stato fisico nel quale le bevande eccessive hanno fatto perdere l’uso della ragione (CL, 1).
1313. Tale stato di ebrietà od ubriachezza è sempre peccato?
Tale stato è sempre peccato quando uno vi è caduto per propria colpa, non cessando di bere eccessivamente allorché poteva e doveva diffidare della natura inebriante della bevanda (CL, 1).
1314. Che cosa si richiede perché questo stato sia peccato mortale?
Si chiede che sia stato previsto che sia stato previsto che l’eccesso della bevanda poteva cagionare la ubbriachezza, e si sia accettata questa. Possibile conseguenza, piuttosto che rinunziare al piacere trovato nella bevanda stessa (CI 2)
1315. Quando questo peccato diventa abitudine, come si chiama?
Si chiama vinolenza.
1316. La vinolenza è un vizio particolarmente lascivo e degradante?
Sì; la vinolenza è un vizio particolarmente degradante; perché priva scientemente l’uomo della ragione, mettendolo in modo più o meno ripetuto e frequente in uno stato inferiore anche a quello del bruto, che mantiene almeno sempre il suo istinto per regolarsi (CL, 3).
Capo LI.
La castità, – La verginità. – Vizio opposto: la lussuria.
1317. Accanto alla virtù dell’astinenza e della sobrietà, quale è altra grande virtù che forma una Specie a parte della temperanza?
È la virtù della castità (CLI).
1318. Che cosa intendete per virtù della castità?
Intendo quella perfezione della facoltà affettiva sensibile, che rende l’uomo padrone di tutti i moti che portano alle cose del matrimonio (CLI, 1).
1319. Nell’ordine della castità vi è una virtù speciale che ne è il coronamento e la più alta perfezione?
Sì; la verginità (CLIL),
1320. Che cosa intendete per verginità?
Intendo il fermo ed assoluto proposito santificato da un voto, di rinunziare per sempre ai piaceri del matrimonio (CLII, 1-3).
1321. Qual è il vizio opposto alla virtù della castità?
È la lussuria (CLII).
1322. In che consiste la lussuria?
La lussuria consiste nell’usare con azioni, con desideri o con pensieri voluti e compiacenti, delle cose che la natura ha ordinato alla conservazione della specie umana, contrariamente all’ordine naturale ed alla onestà che regola l’uso delle cose stesse, per il godimento che vi è annesso (CLIII, 1-3).
1323. Il vizio della lussuria ha varie specie?
Sì; questo vizio ha tante specie, quanti possono essere i disordini distinti nelle cose della lussuria (CLIV).
1324. Quali sono queste specie di disordine nelle cose della lussuria?
Sono la semplice fornicazione, direttamente opposta al retto ordine delle cose del matrimonio in ciò che riguarda il loro fine, cioè la procreazione e la educazione dei figli che verranno: il vizio contro natura, cosa più grave di tutte in questo ordine, che si oppone direttamente e totalmente al fine principale ed essenziale del matrimonio, cioè alla venuta stessa dei figli; l’incesto, l’adulterio, lo stupro ed il ratto, che si basano sull’abuso di persone prossime parenti, o maritate, o sotto la tutela del padre che si inganna o a cui si fa violenza; e finalmente il sacrilegio, che è l’abuso di persone consacrate a Dio (CLIV, 1-12).
1325. Il vizio della lussuria, in ciò che costituisce la sua base essenziale che si trova in ciascuna delle sue specie, e che non è altro che il godimento illecito dei piaceri annessi alle cose del matrimonio, è un vizio capitale?
Sì; la lussuria è un vizio capitale in causa di quello appunto che ha di particolarmente veemente nel proprio oggetto, per cui gli uomini vi si sentono estremamente inclinati (CLIII, 4).
1326. Quali sono le conseguenze della lussuria?
Sono l’accecamento dello spirito, la precipitazione, la inconsideratezza, la incostanza, l’amore di sé, l’odio a Dio, l’attaccamento alla vita presente, l’orrore della vita futura (CLIII, 5).
1327. Queste conseguenze della lussuria hanno tutte un carattere comune e particolarmente grave?
Sì; esse hanno tutte benché in diversi gradi questo di comune, che implicano l’assorbimento dello spirito da parte della carne; e ciò che forma la gravità speciale di ciascuna di esse e della lussuria che ne è la madre, è appunto questo, che l’uomo precipita dalla sua sovranità, per cadere al di sotto dei bruti animali privi di ragione (CLVIII, 5, 6).
Capo LII.
Virtù annesse alla temperanza: la continenza. – Vizio opposto: la incontinenza.
1328. Oltre alle virtù che hanno natura di specie rispetto alla temperanza, vi sono altre virtù che in relazione ad essa hanno natura di virtù annesse?
Sì; vi sono le virtù che imitano il suo atto, ossia il suo modo di agire, cioè la modeazione di ciò che per natura tende a trascinare, ma in materie meno difficili a padroneggiarsi; oppure che non toccano la perfezione del suo atto (CLV).
1329. Quali sono queste altre virtù?
Sono la continenza, la clemenza, la mansuetudine e la modestia (CLV -CLXX).
1330. Che cosa intendete per continenza?
Intendo quella virtù, imperfetta del resto nella sua ragione di virtù, che consiste nel preferire di non seguire i moti violenti della passione che trascinerebbe, ma che non si segue per un motivo di ragione (CLV, 1).
1331. Perché dite che è cosa imperfetta nell’ordine della virtù?
Perché la virtù perfetta suppone e tiene sottomessi i moti della passione, mentre la continenza non fa che resistere loro (Ibid.).
1332. Questa virtù imperfetta ha un vizio che le si oppone?
Sì: la incontinenza (CLVI).
1333. In che consiste la incontinenza?
Consiste in questo, che l’uomo cede alla violenza della passione ed in qualche modo se ne lascia guidare (CLVI, 1).
1334. Tra l’intemperante e l’incontinente chi pecca più gravemente?
L’intemperante; perché per la stessa ragione che la continenza è meno perfetta della temperanza nell’ordine della virtù, nell’ordine del vizio la incontinenza è meno perfetta, ossia meno malvagia, della intemperanza (CLVI, 3).
Capo LIII.
La clemenza e la mansuetudine. Vizi opposti: la collera, la crudeltà o ferocia.
1385. Che cosa intendete per clemenza e mansuetudine?
La clemenza e la mansuetudine sono due virtù, delle quali l’una modera e regola la punizione esterna perché non passi i limiti della ragione; e l’altra, il moto interno della passione che è la collera (CLVII, 1).
1336. La clemenza e la severità sono opposte tra loro, come pure la mansuetudine e la vendetta?
Niente affatto; perché non hanno lo stesso motivo, ed in certi casi e per motivi differenti tendono tutte a ciò che è secondo ragione (CLVII, 2 ad 1) x
1337. Quali sono i vizi opposti alla clemenza ed alla mansuetudine?
Sono la collera nel senso peccaminoso della parola; e la crudeltà, ossia ferocia (CLVIII, CLIX).
1338. Che cosa intendete per collera nel senso peccaminoso della parola?
Intendo un moto dell’appetito irascibile, diretto ad una vendetta ingiusta, oppure anche giusta ma con troppa eccitazione (CLVIII, 2).
1339. Vi sono diverse specie di collera?
Sì; ve ne sono tre specie: la collera degli «irritabili», che vanno in collera per un nonnulla; la collera degli «aspri», che conservano lungamente la memoria delle ingiurie; e la collera degli «intrattabili», che perseguono senza a indugio la esecuzione della vendetta (CLVIII, 5).
1340. La collera è un peccato capitale?
Si la collera è un peccato capitale, perché il suo oggetto è cosa alla quale gli uomini sono specialmente inclinati, cioè la vendetta ed il male, sotto la ragione di un bene giusto ed onesto (CLVIII, 6).
1341. 1341. Quali sono le conseguenze della collera?
Sono la indignazione, il gonfiamento del cuore, il clamore, la bestemmia; l’ingiuria e le risse (CLVII, 7).
1342. Può esservi un vizio opposto alla collera?
Sì; consiste nella mancanza del moto di collera quando la ragione lo comanda, e che deve essere effetto della giusta volontà di punire (CLVII, 8).
1343. Che cosa intendete per crudeltà, vizio che si oppone alla clemenza?
Intendo quella specie di « crudezza » d’animo, per la quale si è inclinati ad aumentare la pena oltre i giusti limiti stabiliti dalla ragione (CLXI, 1).
1344. E la ferocia che cosa sarà?
La ferocia è quel qualche cosa di selvaggio, di assolutamente inumano, per cui uno si diletta della pena o vi trova piacere sotto la sola ragione di male; è un compiacersi della sofferenza altrui, non sotto l’aspetto di giusto castigo, ma sotto il solo aspetto di pena e di sofferenza. La ferocia si oppone al dono della pietà (CLIX, 2).
1345. È cosa possibile questa?
Per quanto possa sembrare impossibile, la natura umana depravata può arrivare a tale eccesso; e si sono vedute nazioni intere, anche apparentemente le più civili, , trovare il loro supremo piacere in ciò che di più feroce avevano gli spettacoli dell’anfiteatro.
Capo LIV.
La modestia. – La umiltà. – Vizio opposto: l’orgoglio, il peccato di Adamo e di Eva, il naturalismo ed il laicismo.
1346. Quale è l’ultima delle virtù annesse alla temperanza?
È la modestia (CLX-CLXX).
1347. Che cosa intendete per modestia?
Intendo la virtù che consiste nel raffrenare e regolare la parte affettiva in cose meno difficili di quelle che sono oggetto della temperanza ed anche della continenza, della clemenza e della mansuetudine (CLX,1, 2)
1348. Quali sono le altre cose meno difficili a dominarsi, a moderarsi e regolarsi, quanto ai moti della parte affettiva che portano ad esse?
In ordine di decrescenza sono il desiderio della propria eccellenza, il desiderio di conoscere, i moti o le azioni esterne del corpo, e finalmente la divisa esteriore riguardo al modo di vestirsi (CLX, 2).
1349. Quali sono le virtù che regolano la parte affettiva in relazione a queste diverse cose?
Sono la umiltà, la studiosità e la diligenza nello studio, la modestia in senso stretto (CLX, 2).
1350. Che cosa intendete per umiltà?
Intendo quella virtù per la quale l’uomo, avuto riguardo al sovrano dominio di Dio, reprime in sè e regola l’aspirazione ad eccellere, in modo da non tendere a più di quello che gli appartiene o gli conviene, secondo il grado od il posto che Dio gli ha assegnato (CLXI, art. 1, 2).
1351. Che cosa segue da ciò nei rapporti dell’uomo con gli altri?
Ne segue che l’uomo non giudica essere dovuto a sè qualche cosa, considerato in se stesso ed in quanto si sottrae all’azione ed al dominio di Dio, perché da se stesso non ha niente se non il peccato. Al contrario giudica che tutto sia dovuto agli altri, nella misura stessa del bene che essi ricevono da Dio e che li fa sottostare al dominio di Lui. Che se si tratta di ciò che egli stesso ha da Dio, per cui esso pure sta sottomesso al dominio di Lui, non vorrà altro che ciò che gli compete, al suo posto e nel suo ordine, fra tutti gli altri esseri che parimente dipendono dal dominio di Dio (CLXI, 3).
1352. Dunque l’umiltà è una questione di stretta verità, ed è secondo verità che per essa l’uomo può e deve tenersi al di sotto di tutti gli altri?
Sì: l’umiltà è una questione di stretta verità; ed è secondo verità che per essa l’uomo può e deve tenersi al di sotto di tutti gli altri, nel senso che abbiamo precisato (Ibid.).
1353. Come si chiama il vizio opposto all’umiltà?
Si chiama orgoglio (CLXII).
1354. Che cosa intendete per orgoglio?
Intendo quel vizio speciale ed in certo modo generale, che in onta a Dio ed alla regola di subordinazione stabilita da Lui nell’opera sua e nel suo dominio, intende di dominare su tutti e di preferirsi a tutti, considerandosi a tutti superiore in eccellenza (CLXII, 1, 2).
1355. Perché dite che questo vizio è speciale ed in certo modo anche generale?
Perché ha un oggetto proprio e distinto che è la propria eccellenza; e l’amore e la ricerca della propria eccellenza, in onta a Dio ed alla regola da Lui stabilita, conduce l’uomo a commettere tutti gli altri peccati (Ibid.).
1356. È un gran peccato questo?
È il maggiore di tutti i peccati per il disprezzo di Dio che implica direttamente; e da questo lato costituisce la maggiore gravità di tutti gli altri peccati, per quanto gravi possano essere già di per se stessi (CLXII
1357. L’orgoglio è il primo di tutti i peccati?
Sì; l’orgoglio è il primo di tutti i peccati, perché, sempre in ragione del disprezzo di Dio che esso implica, perfeziona e completa la natura di peccato in tutti gli altri per cui l’uomo si allontana da Dio: dimodochè non può darsi alcun peccato grave che non implichi o non presupponga l’orgoglio, benché non sia sempre in se stesso, o rispetto al motivo che lo specifica, un peccato di orgoglio (CLXII, 7).
1358. L’orgoglio è un peccato capitale?
L’orgoglio è più che un peccato capitale; perché è il capo e come il sovrano di tutti gli altri vizi e peccati (CUXII, 8).
1359. I nostri primi genitori, nel loro primopeccato, peccarono di orgoglio?
Sì; nel loro primo peccato i nostri primi genitori peccarono di orgoglio, come in cielo avevano peccato di orgoglio gli angeli malvagi (CLXII, 1).
1360. Ma Adamo ed Eva, nel loro primo peccato, non peccarono piuttosto di gola o di disobbedienza o di vana curiosità di fronte alla scienza di Dio, e di mancanza di fede alla parola di Lui?
Tutti questi peccati che infatti possono trovarsi nel peccato dei nostri primi padri, non furono che una conseguenza del peccato di orgoglio, senza il quale nessun altro peccato poteva da essi commettersi (CLXIII, 1).
1361. Perché dite che senza il peccato di orgoglio nessun altro peccato poteva commettersi dai nostri primi padri?
Perché il loro stato di integrità faceva sì che in essi tutto fosse perfettamente sottomesso e subordinato, fintantoché il loro spirito fosse rimasto soggetto a Dio; ed il loro spirito stesso non poté sottrarsi a Dio che per un motivo di orgoglio, volendo attribuirsi una eccellenza. che non era affatto loro dovuta. (CLXII, 1, 2).
1362. Il peccato di naturalismo e di laicismo che oggi regna un poco dappertutto, specialmente dopo la Riforma protestante, la Rinascenza pagana, l’empia Rivoluzione del secolo decimottavo, non è esso pure specialmente un peccato di orgoglio?
Sì; ed è ciò che ne forma la eccezionale gravità; perché è una imitazione del disprezzo e della ribellione che furono prima il peccato di satana degli angeli malvagi, e poi il peccato dei nostri primi padri.
Capo LV.
La studiosità. – Vizio opposto: la curiosità.
1363. Che cosa intendete per studiosità, che la seconda delle virtù annesse alla temperanza sotto il nome e la influenza della modestia?
Intendo quella virtù che modera nell’uomo conforme alla retta ragione, il desiderio di conoscere e di imparare (CLXVI, 1).
1364. E come si chiama il vizio opposto?
Si chiama curiosità (CLXVII).
1365. Che cosa è dunque la curiosità?
La curiosità è il desiderio disordinato di conoscere e di sapere ciò che non è di propria competenza, o che può essere pericoloso a sapersi, data la propria fragilità (CLXVII, 1, 2).
1366. Si può peccare facilmente di curiosità?
Sì; il peccato di curiosità si può commettere e si commette frequentissimamente nell’ordine di ogni cognizione in generale, come nell’ordine più speciale delle cognizioni che possono interessare i sensi e le passioni (CLXVII, art. 1, 2).
1367. Appartiene a questo peccato il desiderio smoderato di leggere soprattutto appendici e romanzi, e di assistere a feste profane e spettacoli, come teatri, cinematografi e cose simili?
Sì; tutto questo appartiene al peccato di curiosità, al tempo stesso che appartiene anche al peccato di sensualità e di lussuria; e non sarebbe mai troppo l’impegno messo a porvi rimedio.
Capo LVI.
La modestia esteriore.
1368. Quale è l’ultima delle virtù annesse alla temperanza, sotto il nome generale di modestia?
È la virtù speciale della modestia, che va sotto questo nome nel suo stretto senso (CLXVII – CLXX).
1369. Che cosa intendete per questa virtù?
Intendo quella finitezza di perfezione nelle disposizioni affettive del soggetto, per cui tutto nel suo esterno, si tratti dei suoi gesti e dei suoi movimenti, delle sue parole, del tono della voce, del vestito, del portamento, delle sue maniere ecc., è ciò che deve essere secondoché conviene alla persona, all’ambiente, allo stato, all’azione che si fa; cosicché niente stona e niente contrasta; e tutto, nell’esterno stesso del soggetto, apparisce in una somma e perfetta armonia. A questo titolo la virtù della modestia si collega con l’affabilità, l’amicizia e con la verità (CLXVIII, 1).
1370. Si deve attribuire alla virtù della modestia ciò che può avere attinenza col giuoco col divertimento e con la ricreazione, nella economia della vita umana?
Sì; e questa virtù prende allora un nome speciale, quello di « eutrapelia », virtù per la quale si scherza, ci si diverte e ci si ricrea come si conviene, evitando da un lato l’eccesso, e dall’altro il difetto contrario (CLXVIII, 2-4).
1371. La modestia comprende anche ciò che ha attinenza con la divisa esterna, cioè col vestito?
Sì; la modestia si estende anche a ciò che riguarda il vestito, cioè la divisa esterna, ed allora appunto prende in senso affatto stretto il nome di modestia (CLXIX).
1372. E che cosa fa la modestia a questo proposito?
Fa che il moto affettivo interno sia quello che deve essere rispetto alla divisa esterna, ossia al vestire; e per essa si conserva quella misura perfetta che esclude insieme troppa ricercatezza e la negligenza sconveniente (CLXIX, 1).
1373. Peccano specialmente contro la modestia le persone mondane che non osservano alcuna misura negli eccessi della moda, e possono divenire per questo occasione di peccato per gli altri?
Sì; queste specie di persone peccano specialmente contro la virtù della modestia, al tempo stesso che peccano anche contro la castità; e non sarebbe mai troppo il biasimo contro gli eccessi che in questo senso si commettono (CLXIX, 2).
Capo LVII.
Del dono corrispondente alla virtù della temperanza.
1374. Fra i doni dello Spirito Santo, ve ne è qualcuno che corrisponda alla virtù della temperanza?
Sì; vi è il dono del timore (CXLI, 1ad 3).
1375. Ma non si è detto prima che il dono del timore corrisponde alla virtù teologale della speranza?
Il dono del timore infatti corrisponde simultaneamente alla virtù teologale della speranza ed alla virtù cardinale della temperanza; ma non sotto il medesimo aspetto ed allo stesso titolo (Ibid.).
1576. In che consiste questa differenza?
Consiste in questo, che il dono del timore corrisponde alla virtù teologale della speranza in quanto ché l’uomo rispetta Dio direttamente per la sua infinita grandezza ed evita per questo di offenderlo. Corrisponde poi alla virtù cardinale della temperanza, inquantoché la riverenza ed il rispetto che ispira verso la grandezza di Dio, fa che si rifugga da ciò che inclina di più ad offendere Dio, vale a dire dai piaceri dei sensi (Ibid.).
1377. Ma la virtù della temperanza non porta già ad evitare tutto questo?
Sì; ma in misura incomparabilmente meno perfetta. Essa infatti non porta ad evitare ciò se non in una misura e secondo un modo che è frutto dell’uomo operante da sé alla luce della ragione o della fede; mentre il dono del timore lo fa evitare nella misura e secondo il modo che è frutto dello Spirito Santo stesso, movente personalmente l’uomo con la sua azione onnipotente, e conducendolo, in ordine al rispetto ed alla riverenza che gli ispira la Maestà divina, a riguardare come fango i piaceri sensuali e quanto con essi ha attinenza.
Caro LVIII.
Precetti relativi alla temperanza ed alle sue parti.
1378. Nella legge divina abbiamo qualche precetto che ha attinenza con la temperanza?
Sì; abbiamo nello stesso Decalogo due precetti che hanno attinenza con la virtù della temperanza (CLXX).
1379. Quali sono questi due precetti?
Sono il sesto ed il nono: «Non commetterai adulterio»; e «Non desidererai la donna del prossimo tuo ».
1380. Perché non si parla che di adulterio; e perché in materia di adulterio vi sono nel Decalogo due precetti distinti?
Perché di quanto ha attinenza con la temperanza l’adulterio è ciò che più interessa le relazioni dell’uomo col prossimo, specialmente dal punto di vista della giustizia, che è quello dei precetti del Decalogo. E se a questo proposito si danno due precetti distinti, si è per la importanza che vi è di frenare fino nella sua prima origine il gran male dell’adulterio (CLXX, 1).
1381. Fra i precetti del Decalogo ve ne è qualcuno che abbia attinenza con le parti della temperanza?
No; non esistono precetti che abbiano direttamente questa attinenza, perché dette parti non interessano affatto da se stesse i rapporti dell’uomo con Dio o col prossimo. Tuttavia le diverse parti della temperanza ne sono riguardate indirettamente a motivo dei loro effetti, sia nei precetti della prima tavola che in quelli della seconda. Infatti, a motivo dell’orgoglio, l’uomo non rende a Dio né al prossimo gli omaggi ed il culto che loro è dovuto; ed a motivo della collera, opposta alla mansuetudine, l’uomo se la prende con la persona del prossimo fino ad attentarne alla vita nell’omicidio (CLXX, 2).
1382. Per ciò che riguarda il lato positivo dei precetti relativi sia alla temperanza che alle sue divisioni, non sarebbe stato a proposito che fosse indicato nel Decalogo?
No; perché il Decalogo doveva contenere soltanto i primi precetti della legge divina applicabili a tutti gli uomini ed in tutti i tempi; e ciò che si riferisce al lato positivo di queste virtù, come l’astinenza, il modo esterno di parlare, di agire, di comportarsi etc., può variare assai secondo i diversi uomini, nei diversi tempi e nei diversi luoghi (CLXX, 1 ad 3).
1383. A chi appartiene determinare queste cose con speciale autorità, nella nuova legge?
Appartiene alla Chiesa di determinare su ciò, con opportuni precetti, la condotta dei fedeli.
1384. Nella spiegazione della divina legge contenuta nella Santa Scrittura si fa un invito speciale sotto forma di preghiera, di appoggiarsi al dono del timore in quanto corrisponde alla temperanza?
Sì; è il bellissimo testo del salmo CXVIII, vers. 120: « Confige timore tuo carnes meas: Il tuo timore, o Signore, reprima le ribellioni della mia carne».
Capo LIX.
Sufficienza delle virtù e loro compito. – Duplice vita: attiva e contemplativa; lo stato di perfezione. – La vita religiosa: le famiglie religiose nella Chiesa.
1385. Abbiamo ora la conoscenza sufficiente di tutte le virtù che l’uomo può essere chiamato a praticare per guadagnare il cielo, e dei vizi che deve fuggire per non esporsi a. perdere il paradiso e cadere nell’inferno?
Sì; noi abbiamo ora tale sufficiente conoscenza. Conosciamo infatti le tre grandi virtù della fede, della speranza e della carità, che permettono all’uomo di conseguire il suo ultimo fine soprannaturale come deve raggiungerlo su questa terra, affinché il fine stesso diriga e domini la sua vita morale. Conosciamo pure le altre quattro grandi virtù morali cardinali, che sono la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza con tutte le virtù annesse, considerate non soltanto nell’ordine naturale e sotto la ragione di virtù acquisite, ma più ancora nell’ordine soprannaturale e sotto la loro ragione di virtù infuse proporzionate alle virtù teologali, che permettono all’uomo di ordinare tutto come deve nella sua vita morale, sia riguardo agli altri sia riguardo a se stesso, per essere in tutte le cose in armonia col suo fine soprannaturale. Cosicché basta all’uomo di praticare tutte queste virtù in unione coi doni corrispondenti, per essere sicuro di conseguire la visione di Dio, che noi sappiamo dovere essere la sua felicità nel cielo per tutta la eternità: con questo solamente che se pecca contro una qualunque di queste virtù, bisognerà che con una nuova virtù di cui parleremo nella Terza Parte e che sarà la penitenza, soddisfaccia per il suo peccato, in unione con la soddisfazione di Gesù Cristo.
1386. La pratica di questo insieme di virtù e di doni che costituisce veramente la vita dell’uomo sulla terra, non può presentarsi sotto due forme distinte ed in qualche modo separate?
Sì: e queste due forme sono la vita contemplativa e la vita attiva (CLXXIX-CLXXXII).
1387. Che cosa intendete per vita contemplativa?
Intendo quella forma di vita in cui l’uomo, con l’anima libera dalle passioni viziose e dal tumulto delle azioni esteriori, sotto l’impulso dell’amore di Dio, passa il suo tempo, nella misura del possibile su questa terra nella contemplazione di Dio in Se stesso e nelle opere sue, godendo della visione di Dio che egli ama, e trovando in tale fruizione di Dio la sua più alta perfezione, che lo fa vivere separato da qualsiasi altra cosa fuori di Dio (CLXXX, 1-8).
1388. Questa vita contemplativa suppone tutte le virtù? Sì; questa vita contemplativa suppone tutte le virtù e concorre a perfezionarle; ma essa stessa consiste in una certa azione propria ove intervengono tutte le virtù intellettuali e teologali, rimanendo sempre nel più alto grado alla mercè dell’azione personale dello Spirito Santo per mezzo dei doni (CLXXX, 2).
1389. E la vita attiva che cosa comprende?
La vita attiva comprende propriamente tutti gli atti delle virtù morali, e specialmente gli atti della virtù della prudenza; perché suo proprio oggetto è la disposizione in quelle stesse ed in quanto conviene all’ordine della vita presente, nelle necessità della vita terrestre, di tutte le cose che hanno attinenza con questa vita stessa (CLXXXI, 1-4).
1390. Di queste due vite quale è la più perfetta?
La più perfetta è incontestabilmente la vita contemplativa, perché è quella che dà su questa terra come una anticipazione del paradiso (CLXXXII, 1).
1391. Ciascuna di queste due vite, ossia la pratica delle virtù e dei doni che esse implicano, non possono trovarsi come in una duplice condizione tra gli uomini?
Sì; esse possono trovarsi secondo la condizione comune, oppure come poste in uno stato di perfezione.
1392. Che cosa intendete per istato di perfezione?
Intendo una certa condizione di vita per cui l’uomo si trova posto in modo stabile, permanente ed immutabile, fuori dei legami che lo rendono schiavo delle necessità della vita presente, e libero di attendere esclusivamente e con tutto se stesso alle cose di Dio e della divina carità (CLXXXIII, 1, 4).
1393. Questo stato di perfezione è la stessa cosa che la perfezione stessa?
No; perché la perfezione consiste in qualche cosa di interiore; mentre lo stato di perfezione di cui si parla consiste in una condizione di vita, considerata piuttosto in ordine ad un insieme di atti esteriori (CLXXXIV, 1).
1394. Si può avere la perfezione delle virtù e dei doni, ossia della vita della divina carità senza essere nello stato di perfezione; e viceversa, si può essere nello stato di perfezione senza avere la perfezione della carità?
Sì; queste due cose sono possibili (CLXXXIV, 4).
1395. Perché dunque ricorrere allo stato di perfezione?
Perché di per sé lo stato di perfezione facilita mirabilmente l’acquisto della perfezione stessa. Generalmente, infatti, la perfezione si trova nello stato di perfezione.
1396. Che cosa è dunque che costituisce lo stato di perfezione?
È il fatto di obbligarsi perpetuamente, sotto una certa forma solenne, alle cose che appartengono alla perfezione, in quanto riguardano l’ordinamento esteriore della propria vita (CLXXXIV, 4).
1397. Chi si trova dunque in questo stato di perfezione?
I Vescovi ed i Religiosi (CLXXXIV, 5).
1398. Perché i Vescovi sono nello stato di perfezione?
Perché essi dal momento che assumono l’ufficio ed il dovere pastorale, si obbligano a dare la propria vita per le pecorelle, e ciò avviene mediante la solennità della consacrazione (CLXXXIV, 6).
1399. Ed in quanto ai Religiosi, per che cosa si trovano nello stato di perfezione?
Perché essi si astringono, sotto forma di voto perpetuo, ad abbandonare le cose del secolo di cui potrebbero usare lecitamente, per attendere più liberamente alle cose di Dio. E ciò essi fanno con una certa solennità di professione o di benedizione (CLXXXIV, 5).
1400. Di questi due stati di perfezione quale è il più perfetto?
Quello dei Vescovi (CLXX.XIV, 7).
1401. Perché lo stato di perfezione dei Vescovi è più perfetto di quello dei religiosi?
Perché sta a questo ultimo, come chi dà, sta a chi riceve. I Vescovi infatti debbono per lo stato loro possedere la perfezione che i religiosi per lo stato loro tendono ad acquistare (CLXXXIV, 7).
1402. In qual modo i religiosi tendono per lo stato loro ad acquistare la perfezione?
I religiosi tendono per lo stato loro ad acquistare la perfezione, inquantoché essi per i tre voti di povertà, di castità e di obbedienza, si trovano nella felice impossibilità di peccare, e nella felice necessità di bene agire in tutte le cose (CLXXXVI, 1-10).
1403. Questi tre voti sono essenziali per lo stato di perfezione dei religiosi?
Sì; questi tre voti sono essenziali per lo stato di perfezione dei religiosi; cosicché senza di essi lo stato religioso non potrebbe esistere (CLXXXVI, 2-7).
1404. Può esservi diversità tra le famiglie religiose aventi tutte le condizioni essenziali dello stato religioso?
Sì; può esservi diversità tra le famiglie religiose aventi tutte le condizioni essenziali dello stato religioso (CLXXXVII).
1405. In che cosa consisterà la diversità delle famiglie religiose, quando tutte convengano nelle condizioni essenziali dello stato religioso?
Consisterà in questo, che essendovi diverse cose nelle quali l’uomo può votarsi totalmente al servizio di Dio, l’uomo può disporsi a questo in diverse maniere e secondo esercizi diversi (CLXXXVII, 1).
1406. Quali sono le due grandi forme di famiglie religiose?
Le due grandi forme di famiglie religiose sono quelle derivanti dalle due grandi condizioni di vita di cui abbiamo parlato: la vita contemplativa e la vita attiva (CLXXXVIII, art. 2-6).
1407. Vi sono dunque famiglie religiose di vita attiva ed altre di vita contemplativa?
Sì; vi sono famiglie religiose di vita attiva ed altre di vita contemplativa.
1408. Che cosa intendete per famiglie religiose di vita attiva?
Intendo quelle famiglie religiose dove la maggior parte delle azioni dei membri che le compongono, è ordinata a servire il prossimo per amor di Dio (CLXXXVII, 2). i
1409. E che cosa intendete per famiglie religiose di vita contemplativa?
È Intendo quelle famiglie religiose dove la totalità delle azioni dei membri che le compongono, è ordinata al servizio di Dio stesso (CLXXXVIII, 2 ad 2).
1410. Di queste due specie di famiglie religiose quali sono le più perfette?
Sono quelle di vita contemplativa; con questo nondimeno che le più perfette di tutte sono quelle di cui la parte principale è votata alla contemplazione delle cose divine, al culto ed al servizio di Dio in Se stesso, ma per riversare poi sul prossimo la soprammisura della loro contemplazione, ed attirare il prossimo stesso al culto ed al servizio di Dio (CLXXXVII, art. 6).
1411. La esistenza delle diverse famiglie religiose nella Chiesa ed in mezzo al mondo è un bene molto grande?
Niente di più prezioso che la esistenza delle diverse famiglie religiose nella Chiesa ed in mezzo al mondo. Perché oltre a formare i focolari scelti dove si praticano nella loro massima perfezione tutte le virtù, esse hanno per effetto di contribuire al più gran bene della umanità con le loro opere di carità e di apostolato, e con la loro vita di immolazione a Dio.
1412. Donde viene alle famiglie religiose nella Chiesa la loro eccellenza in ciò che riguarda la pratica di tutte le virtù. fino alla più alta perfezione?
Tale eccellenza viene loro dall’applicarsi ostensibilmente e per vocazione o di ufficio a camminare nella via dove ogni uomo deve camminare per praticare queste stesse virtù e conseguire la felicità del cielo.
Quale è la via fuori della quale non è possibile nessun cammino verso Dio con la pratica delle virtù?
Questa via non è altri che Gesù Cristo mistero stesso del Verbo fatto carne. Ora ci resta di occuparci di Lui; e questo formerà la materia della nostra « Terza Parte ».