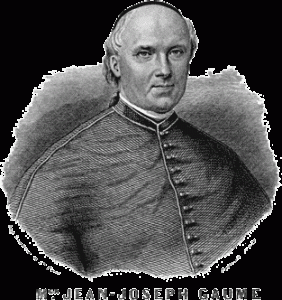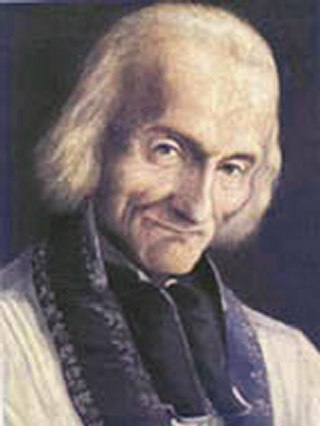DOMENICA XXII DOPO PENTECOSTE (2021)
(Messale Romano di S. Bertola e G. Destefani, comm. di D. G. LEFEBVRE O. S. B; L. I. C. E. – R. Berruti & C. Torino 1950)
Semidoppio. – Paramenti verdi.
In quest’epoca le letture dell’Officiatura sono spesso tolte dal Libro dei Maccabei. Giuda Maccabeo, avendo udito quanto potenti fossero i Romani e come avessero sottomesso dei paesi assai lontani ed obbligato tanti re a pagar loro un tributo annuale, e d’altra parte sapendo che essi solevano acconsentire a quanto veniva loro chiesto e che avevano stretto amicizia con tutti coloro che con essi si erano alleati, mandò a Roma alcuni messi per fare amicizia ed alleanza con loro. Il Senato romano accolse favorevolmente la loro domanda e rinnovò più tardi questo trattato di pace con Gionata, e poi con Simeone che succedettero a Giuda Maccabeo, loro fratello. Ma ben presto la guerra civile sconvolse questo piccolo regno, poiché dei fratelli si disputarono tra di loro la corona. Uno di questi credette fare una mossa abile chiamando i Romani in aiuto; essi vennero infatti e nel 63 Pompeo prese Gerusalemme. Roma non soleva mai rendere quello che le sue armi avevano conquistato e la Palestina divenne quindi e restò una provincia romana. Il Senato nominò Erode re dei Giudei ed egli, per compiacere costoro, fece ingrandire il Tempio di Gerusalemme e fu in questo terzo tempio che il Redentore fece più tardi il suo ingresso trionfale. Da quel momento il popolo di Dio dovette pagare un tributo all’imperatore romano ed è a ciò che allude il Vangelo di oggi. Questo episodio avvenne in uno degli ultimi giorni della vita di Gesù. Con una risposta piena di sapienza divina, il Maestro confuse i suoi nemici, che erano più che mai accaniti per perderlo. L’obbligo di pagare un tributo a Cesare era tanto più odioso ai Giudei in quanto contrastava allo spirito di dominio universale che Israele era convinto di aver ricevuto con la promessa. Quelli che dicevano che si doveva pagarlo, avevano contro di loro l’opinione pubblica, quelli che dicevano che non si dovesse farlo incorrevano nell’ira dell’autorità romana imperante e dei Giudei che erano a questa favorevoli e che si chiamavano erodiani. I farisei pensavano dunque che forzare Gesù a rispondere a questo dilemma voleva sicuramente dire perderlo, sia davanti al popolo, sia davanti ai Romani, e che tanto dagli uni come dagli altri avrebbero potuto farlo arrestare. Per essere sicuri di riuscirvi gli mandarono una deputazione di Giudei che appartenevano ai due partiti, « alcuni dei loro discepoli con degli erodiani », dice S. Matteo. Questi uomini, per ottenere una risposta, cominciarono col dire a Gesù che sapevano come egli dicesse sempre la verità e non fosse accettatore di persone; poi gli tesero un tranello: « È permesso o no pagare il tributo a Cesare?». Gesù, conoscendo la loro malizia, disse loro: « Ipocriti, perché mi tentate?» Poi, sfuggendo loro destramente, domandò che gli mostrassero la moneta del tributo, per forzarli, come sempre faceva in queste circostanze, a rispondere essi stessi alla loro domanda. Infatti, quando i Giudei gli ebbero presentato un danaro che serviva per pagare il tributo: « Di chi è questa effigie e questa iscrizione? » chiese loro. «Di Cesare», risposero quelli. Bisognava infatti per pagare il tributo, cambiare prima la moneta nazionale in quella che portava l’effigie dell’imperatore romano. Con questo scambio i Giudei venivano ad ammettere di essere sotto la dominazione di Cesare, poiché una moneta non ha valore in un paese se non porta l’effigie del suo sovrano. Acquistando dunque quel denaro con l’impronta di Cesare, riconoscevano essere egli il signore del loro paese, al quale essi avevano l’intenzione di pagare il tributo. « Rendete dunque a Cesare — disse loro Gesù — quello che è di Cesare ». Ma allora il Maestro, diventando ad un tratto il giudice dei suoi interlocutori interdetti, aggiunse: « Rendete a Dio quello Che è di Dio ». Ciò vuol dire: che appartenendo l’anima umana a Dio, che l’ha fatta a propria immagine, tutte le facoltà di quest’anima devono far ritorno a Lui, pagando il tributo di adorazione e di obbedienza. « Noi siamo la moneta di Dio, coniata con la sua effigie . dice S. Agostino – e Dio esige il suo denaro, come Cesare il proprio » (In JOANN.). « Diamo a Cesare la moneta che porta l’impronta sua, aggiunge S. Girolamo,, poiché non possiamo fare diversamente, ma diamoci anche spontaneamente, volontariamente e liberamente a Dio, poiché l’anima nostra porta l’immagine sfolgorante di Dio e non quella più o meno maestosa di un imperatore ». (In MATT.). – « Questa immagine, che è l’anima nostra – dice ancora Bossuet – passerà un giorno di nuovo per le mani e davanti agli occhi di Gesù Cristo. Egli dirà ancora una volta guardandoci: Di chi è quest’immagine e quest’iscrizione? E l’anima risponderà: di Dio. È per Lui ch’eravamo stati fatti: dovevamo portare l’immagine di Dio, che il Battesimo aveva riparato, poiché questo è il suo effetto e il suo carattere. Ma che cosa è diventata questa immagine divina che dovevamo portare? Essa doveva essere nella tua ragione, o anima cristiana! e tu l’hai annegata nell’ebbrezza; tu l’hai sommersa nell’amore dei piaceri; tu l’hai data in mano all’ambizione; l’hai resa prigioniera dell’oro, il che è un’idolatria; l’hai sacrificata al tuo ventre, di cui hai fatto un dio; ne hai fatto un idolo della vanagloria; invece di lodare e benedire Iddio notte e giorno, essa si è lodata e ammirata da sé. In verità, in verità, dirà il Signore, non vi conosco; voi non siete opera mia, non vedo più in voi quello che vi ho messo. Avete voluto fare a modo vostro, siete l’opera del piacere e dell’ambizione; siete l’opera del diavolo di cui avete seguito le opere, di cui, imitandolo, vi siete fatto un padre. Andate con lui, che vi conosce e di cui avete seguito le suggestioni; andate al fuoco eterno che per lui è stato preparato. O giusto Giudice! dove sarò io allora? mi riconoscerò io stesso, dopo che il mio Creatore non mi avrà riconosciuto? » (Medit. sur l’Èvangile, 39e jour) In questo modo dobbiamo interpretare il Vangelo, in questa Domenica, che è una delle ultime dell’anno ecclesiastico e che segna per la Chiesa gli ultimi tempi del mondo. Infatti, a due riprese, l’Epistola parla dell’Avvento di Gesù, che è vicino. S. Paolo prega Dio che ha cominciato il bene nelle anime di compierlo fino al giorno del Cristo Gesù », poiché è da Lui che viene la perseveranza finale. E l’Apostolo invoca appunto questa grazia: che « la nostra carità abbondi vieppiù in cognizione e discernimento, affinché siamo puri e senza rimproveri nel giorno di Gesù Cristo » (Epistola). In questo terribile momento, infatti se il Signore tiene conto delle nostre iniquità, chi potrà sussistere davanti a Lui? (Introito). « Ma il Signore è il sostegno e il protettore di coloro che sperano in Lui » (Alleluia), poiché « la misericordia si trova nel Dio d’Israele» (Intr., Segret.). E noi risentiremo gli effetti di questa misericordia se saremo noi stessi misericordiosi verso il prossimo. « Come bello è soave è per i fratelli essere uniti! » dice il Graduale. E dobbiamo esserlo soprattutto nella preghiera, all’ora del pericolo, poiché se gridiamo verso il Signore, Egli ci esaudirà » (Com.). E la preghiera eminentemente sociale e fraterna, alla quale Dio è più specialmente propizio, è la preghiera della Chiesa, sua sposa, che Egli ascolta ed esaudisce come fece il re Assuero, allorché, come ricorda l’Offertorio, la sua sposa Ester si rivolse a Lui per salvare dalla morte il popolo di Dio (v. 19a Domenica dopo Pentecoste).
Il dono della perseveranza nel bene ci viene da Dio. San Paolo domanda a Dio di accordarlo ai Filippesi, che gli sono sempre stati uniti nelle sue sofferenze e nelle sue fatiche apostoliche e che egli ama, come Cristo Gesù stesso li ama. La loro carità dunque cresca continuamente, affinché il giorno dell’avvento di Gesù, colmi di buone opere, rendano gloria a Dio.
« Se noi siamo attaccati ai beni che dipendono da Cesare, dice S. Ilario, non possiamo lamentarci dell’obbligo di rendere a Cesare quello che è di Cesare; ma dobbiamo anche rendere a Dio quello che gli appartiene in proprio, cioè consacrargli il nostro corpo, l’anima nostra, la nostra volontà » (Mattutino).
Incipit
In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
Introitus
Ps. CXXIX: 3-4
Si iniquitátes observáveris, Dómine: Dómine, quis sustinébit? quia apud te propitiátio est, Deus Israël.
[Se tieni conto delle colpe, o Signore, o Signore chi potrà sostenersi? Ma presso di Te si trova misericordia, o Dio di Israele.]
Ps CXXIX: 1-2
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi vocem meam.
[Dal profondo Ti invoco, o Signore: O Signore, esaudisci la mia supplica.]
Si iniquitátes observáveris, Dómine: Dómine, quis sustinébit? quia apud te propitiátio est, Deus Israël.
[Se tieni conto delle colpe, o Signore, o Signore chi potrà sostenersi? Ma presso di Te si trova misericordia, o Dio di Israele.]
Oratio
Orémus.
Deus, refúgium nostrum et virtus: adésto piis Ecclésiæ tuæ précibus, auctor ipse pietátis, et præsta; ut, quod fidéliter pétimus, efficáciter consequámur.
[Dio, nostro rifugio e nostra forza, ascolta favorevolmente le umili preghiere della tua Chiesa, Tu che sei l’autore stesso di ogni pietà, e fa che quanto con fede domandiamo, lo conseguiamo nella realtà.]
Lectio
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Philippénses
Phil I: 6-11
“Fratres: Confídimus in Dómino Jesu, quia, qui cœpit in vobis opus bonum, perfíciet usque in diem Christi Jesu. Sicut est mihi justum hoc sentíre pro ómnibus vobis: eo quod hábeam vos in corde, et in vínculis meis, et enim defensióne, et confirmatióne Evangélii, sócios gáudii mei omnes vos esse. Testis enim mihi est Deus, quómodo cúpiam omnes vos in viscéribus Jesu Christi. Et hoc oro, ut cáritas vestra magis ac magis abúndet in sciéntia et in omni sensu: ut probétis potióra, ut sitis sincéri et sine offénsa in diem Christi, repléti fructu justítiæ per Jesum Christum, in glóriam et laudem Dei”.
(“Fratelli: Abbiam fiducia nel Signore Gesù, che colui il quale ha cominciato in voi l’opera buona la condurrà a termine fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è ben giusto ch’io nutra questi sentimenti per voi tutti; poiché io vi porto in cuore, partecipi come siete del mio gaudio, e nelle mie catene, e nella difesa e nel consolidamento del Vangelo. Mi è, infatti, testimonio Dio come ami voi tutti nelle viscere di Gesù Cristo. E questa è la mia preghiera: che il vostro amore vada crescendo di più in più in cognizione e in ogni discernimento, si da distinguere il meglio, affinché siate puri e incensurati per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia, mediante Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio”).
AUGURI CRISTIANI DI UN APOSTOLO.
Che cosa dobbiamo noi Cristiani desiderare ed augurare a noi stessi e agli altri? dico così: a noi e agli altri, perché dovendo noi amare il prossimo come noi stessi, s’ha da desiderare agli altri ed augurare né più, né meno di quello che desideriamo ed auguriamo a noi. È un problema molto pratico, se si consideri il gran numero d’auguri che per consuetudine antica, si cambiano in mille circostanze diverse, anche fra noi Cristiani. I quali spesso, troppo spesso, ci auguriamo, quello stesso che si augurano fra di loro i pagani, come se il Cristianesimo non esistesse, come se nelle fatti specie non avesse un bel nulla da insegnarci. Opportunissima è al proposito l’Epistola paolina di questa domenica, nella quale San Paolo lascia libero sfogo al suo grande cuore. E dice ai suoi figli, ai Cristiani da lui convertiti, da lui rigenerati al fonte battesimale, quale sia l’oggetto precipuo e costante delle sue preghiere per loro. La preghiera, giova ricordarlo tra parentesi, è la forma cristiana dell’augurio. Il pagano augura, il Cristiano prega. Ordunque che cosa augura e prega il grande Apostolo ai suoi cari? Una carità in un aumento costantemente progressivo. «Chiedo a Dio che la vostra carità abbondi più e più». Che cosa auguriamo noi istintivamente a quelli che amiamo? Lo si sa: salute e felicità. E dicendo salute, quando parliamo il linguaggio comune, fondato sulla comune psicologia, intendiamo la salute del corpo, e la felicità del tempo. Ebbene: noi Cristiani sappiamo che c’è una salute più preziosa della corporea: è la salute dell’anima; c’è una felicità più vera della comunemente intesa, è la felicità spirituale ed eterna. Tutto questo è nella carità. La carità cristiana, amore fervido di Dio e dei fratelli, unico moto con due poli ed estremità, la carità; l’ardore di essa è la vita dell’anima. Si vive di carità; senza essa si muore, muore la parte più vera, più intima, più umana di noi: «qui non diligîit, manet in morte. » E questo amore divino, divino sempre, divino ancora quando sembra diventare umano, è la gioia più profonda ed indistruttibile. L’amore profano con le sue gioie è un abbozzo della gioia che porta nell’anima l’amore celeste. Desiderare la carità agli altri (e a noi) significa desiderare (e chiedere, per conseguenza), la vita, la salute più vera e la felicità più completa. Lo sentiamo noi questo? ne siamo noi veramente convinti? Ecco, se mai, una buona occasione per ridestare in noi questa convinzione, per rettificare nella nostra anima, come dicono oggi, la scala dei valori. In cima a questa benedetta scala, che regola poi in pratica i moti, i voli della nostra anima; in cima la carità. Nella quale non si progredisce mai abbastanza e bisogna progredire sempre. Quando si è convinti della preziosità di una cosa qualsiasi, non se ne ha, non si crede mai di averne abbastanza, se ne desidera sempre di più. La carità è il nostro tesoro per eccellenza, il vero tesoro cristiano. Paolo la desidera, la prega ai fedeli sempre maggiore, in aumento continuo e indefinito. E sempre meglio. Fiamma più ardente e fiamma più pura. Progresso in quantità e in qualità. In che cosa l’Apostolo faccia consistere il miglioramento qualitativo, non è chiarissimo. Ma tra le interpretazioni in cui s’indugiano i critici, gli esegeti, la migliore mi par questa: la nostra carità S. Paolo desidera e prega diventi sempre più conscia (questo significa quello che il testo chiama progresso in scientia), alimentata cioè da una conoscenza sempre più chiara, esatta, profonda di Dio, Signor Nostro. – Meglio si vede una cosa o persona bella e più acceso ne ferve in noi il desiderio, nell’ordine naturale. Lo stesso nell’ordine soprannaturale: più, meglio, si conosce Dio e più e meglio lo si ama. E anche il prossimo nostro lo amiamo tanto più quanto più lo guardiamo, e vediamo in una luce divina colta, afferrata bene dal nostro occhio interiore. Ma lì nel prossimo ci vuol giudizio. San Paolo dice proprio: la carità divina verso Dio sempre più conscia; la carità verso il prossimo sempre più giudiziosa. Non si potrebbe dire di meglio.
P. G. Semeria: Le epistole delle Domeniche, Op. naz. Per il mezzogiorno d’Italia, Milano, 1939.
(Nihil obstat sac. P. De Ambroggi – Imprim. P. Castiglioni vic. Gen. Curia Arch, Mediolani, 1-3-1938)
Graduale
Ps CXXXII: 1-2
Ecce, quam bonum et quam jucúndum, habitáre fratres in unum!
[Oh, come è bello, com’è giocondo il convivere di tanti fratelli insieme!]
V. Sicut unguéntum in cápite, quod descéndit in barbam, barbam Aaron.
[È come l’unguento versato sul capo, che scende alla barba, la barba di Aronne. ]
Alleluja
Allelúja, allelúja
Ps CXIII: 11
Qui timent Dóminum sperent in eo: adjútor et protéctor eórum est. Allelúja.
[Quelli che temono il Signore sperino in Lui: Egli è loro protettore e loro rifugio. Allelúia.]
Evangelium
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthæum.
Matt XXII: 15-21
In illo témpore: Abeúntes pharisæi consílium iniérunt, ut cáperent Jesum in sermóne. Et mittunt ei discípulos suos cum Herodiánis, dicéntes: Magíster, scimus, quia verax es et viam Dei in veritáte doces, et non est tibi cura de áliquo: non enim réspicis persónam hóminum: dic ergo nobis, quid tibi vidétur, licet censum dare Caesari, an non? Cógnita autem Jesus nequítia eórum, ait: Quid me tentátis, hypócritæ? Osténdite mihi numísma census. At illi obtulérunt ei denárium. Et ait illis Jesus: Cujus est imágo hæc et superscríptio? Dicunt ei: Caesaris. Tunc ait illis: Réddite ergo, quæ sunt Caesaris, Caesari; et, quæ sunt Dei, Deo.
( “In quel tempo, i Farisei ritiratisi, tennero consiglio per coglierlo in parole. E mandano da lui i loro discepoli con degli Erodiani, i quali dissero: Maestro, noi sappiamo che tu sei verace, e insegni la via di Dio secondo la verità, senza badare a chicchessia; imperocché non guardi in faccia gli uomini. Spiegaci adunque il tuo parere: È egli lecito, o no, di pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù conoscendo la loro malizia, disse: Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un danaro. E Gesù disse loro: Di chi è questa immagine e questa iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio”).
OMELIA
(Discorsi di s. G. B. M. VIANNEY Curato d’Ars – vol. IV, 4° ed. Torino, Roma; Ed. Marietti, 1933)
Sulla restituzione.
Reddito ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari: et quæ sunt Dei, Deo.
(MATTH. XXII, 21).
Dare a Dio quello ch’è di Dio, ed al prossimo quello che gli è dovuto; niente di più giusto, niente di più ragionevole. Se tutti i Cristiani seguissero questa via, l’inferno non avrebbe più alcun abitatore, ed il cielo sarebbe popolato. Ah! volesse Iddio, ci dice il gran S. Ilario, che gli uomini non perdessero mai di vista questo precetto! Ma, ahimè! quanti si illudono! Essi passano la loro vita rubando all’uno, ed ingannando l’altro. Si, F. M., non vi è cosa più comune delle ingiustizie, non vi è cosa più rara delle restituzioni. Il profeta Osea aveva ben ragione di dire che le ingiustizie ed i latrocini coprivano la faccia della terra, e che assomigliavano al diluvio che aveva distrutto l’universo (Os. IV, 2). E disgraziatamente quanti sono i colpevoli altrettanti sono quelli che non vogliono riconoscersi tali. Mio Dio! quanti ladri farà scoprire la morte! Per convincervene, F. M., vi mostrerò:
1° che i beni di mal acquisto non portano fortuna;
2° in quanti modi si reca danno al prossimo;
3° come ed a chi dovete restituire ciò che non vi appartiene.
I. — Noi siamo sì ciechi, che passiamo tutta la vita nel cercare di ammassare beni che poi, nostro malgrado, perderemo, e trascuriamo quelli che potremo conservare per tutta l’eternità. Le ricchezze di questo mondo per un Cristiano sono degne soltanto di disprezzo, e noi invece corriamo precisamente dietro ad esse. L’uomo è dunque un insensato, perché agisce in un modo tutto contrario al fine per cui Dio l’ha messo al mondo. Non voglio parlarvi, F. M., di coloro che prestano ad usura, al sette, otto, nove e dieci per cento; lasciamoli da una parte. Bisognerebbe, per far sentir loro tutta l’enormità della loro ingiustizia e crudeltà, che uno di quei vecchi usurai, che da tre o quattro mila anni bruciano nell’inferno, venisse a raccontar loro i tormenti che soffre a causa delle sue innumerevoli ingiustizie. No, non è questo il mio assunto. Costoro sanno che fanno male e che Dio non perdonerà loro mai, se non restituiscono a quelli che hanno danneggiato. Tutto ciò che potrei dire servirebbe soltanto a renderli più colpevoli. Entriamo invece in certi particolari che riguardano la maggior parte dei Cristiani. – Dico anzitutto che i beni acquistati ingiustamente non arricchiscono mai chi li possiede. Al contrario saranno una sorgente di maledizioni per tutta la sua famiglia. Mio Dio! quanto è cieco l’uomo! Egli è perfettamente convinto che viene in questo mondo per brevissimo tempo; ad ogni istante ne vede partir uomini più giovani e più robusti di lui; non importa; ciò non gli fa aprire gli occhi. Può ben dirgli lo Spirito Santo, per bocca di Giobbe, che egli è venuto nel mondo sprovvisto di tutto e che se ne andrà nella stessa condizione (Job I, 21); che tutti questi beni dietro ai quali egli corre, lo abbandoneranno quando meno vi penserà; tutto questo non vale a trattenerlo. S. Paolo afferma che chi vuol diventar ricco per vie ingiuste, non tarderà a cadere in grandi traviamenti; e di più non vedrà mai la faccia di Dio (I Tim. VI, 9). E questo è così vero, che un avaro, od anche, se volete, una persona arricchita per frode o con male arti, senza un miracolo della grazia non si convertirà quasi mai, tanto questo peccato acceca chi lo commette. Ascoltate come san Agostino parla a quelli che ritengono beni altrui (Ep CLIII ad Macedonium, c. VI, 22). Potrete ben confessarvi, dice, far penitenze e piangere i vostri peccati, se non restituite, quando potete, Iddio non vi perdonerà mai. Tutte le vostre confessioni e comunioni non saranno che sacrilegi l’un sopra l’altro. O rendete quello che non è vostro, o risolvetevi di andar a bruciare nell’inferno. Lo Spirito Santo non ci proibisce solo di prendere e desiderare i beni del prossimo, manon vuole nemmeno che li guardiamo nel timore che questa vista vi ci faccia mettere sopra le mani. Il profeta Zaccaria ci dice che la maledizione di Dio resterà sulla casa di chi ruba, fino a che essa non sarà distrutta (Zach. V, 3,4). Ed io aggiungo, che non solo i beni acquistati con frode o con male arti non vi daranno alcun profitto, ma saranno la causa che abbiate da quelli legittimamente acquistati, e che si abbrevino i vostri giorni. Se ne dubitato, ascoltatemi un momento e ne sarete persuasi. Leggiamo nella sacra Scrittura, che il re Acabbo volendo allargare il suo giardino, andò da un uomo chiamato Naboth, per domandargli di vendergli la sua vigna. “No, gli disse Naboth, è l’eredità dei miei padri, e voglio conservarla.„ Il re fu così indispettito per questo rifiuto, che ne ammalò. Non poteva né bere, né mangiare, e si mise a letto. La regina venne, e gli domandò la causa della sua malattia. Le rispose il re che voleva allargare il giardino, e che Naboth erasi rifiutato di vendergli la sua vigna. « Ecchè! disse la regina, dov’è dunque la vostra autorità? Non inquietatevi tanto; io ve la farò avere. E s’affrettò a cercare qualcuno che, corrotto con denaro, testimoniasse che Naboth aveva bestemmiato contro Dio e contro Mosè. Il povero uomo poté ben difendersi, affermando che era innocente del delitto di cui lo si accusava, invano; non gli si volle credere: fu trascinato dalla folla e lapidato. La regina vistolo immerso nel proprio sangue, corse dal re annunciandogli di impossessarsi pure della vigna, poiché colui che aveva ardito rifiutargliela era morto. A questa notizia il re guarì, e corse come un pazzo ad impossessarsi della vigna. Lo sciagurato non pensava che qui appunto l’aspettasse Iddio per punirlo. Il Signore chiamò il suo profeta Elia, e gli ordinò d’andare dal re a dirgli da parte sua che, nel luogo stesso dove i cani avevano leccato il sangue di Naboth, leccherebbero anche il suo, e che nessuno dei suoi figli regnerebbe dopo di lui. Lo mandò poi dalla regina Gezabele per annunziarle che, in punizione del suo delitto, i cani la mangerebbero. Come il profeta aveva predetto, così avvenne. Il re fu ucciso in un combattimento, ed i cani leccarono il suo sangue. Il nuovo re chiamato Jehu, entrando nella città, vide una donna affacciata ad una finestra. Ella s’era vestita come una dea, sperando affascinare il cuore del nuovo re. Questi domandò chi fosse. Gli fu risposto che era la regina Gezabele. Subito comandò di gettarla dalla finestra; e uomini e cavalli la calpestarono sotto i loro piedi. Alla sera, quando si volle darle sepoltura, non si trovò di lei che qualche misero avanzo: i cani avevano mangiato il resto. “Ah! esclamò Jehu, ecco adempiuta la parola del profeta.„ (IV, Reg. IX). Il re Acabbo lasciava settanta figli, tutti principi; il nuovo re ordinò che a tutti fosse mozzata la testa, e che le teste fossero raccolte in panieri alle porte della città, per mostrare con uno spettacolo così orrendo quali disgrazie attirino sui figli le ingiustizie dei genitori (IV, Reg. X, 7). S. Vittore ci racconta un esempio che non è meno sorprendente. Un uomo, egli dice, era entrato nel granaio del suo vicino per rubargli del grano. Nel momento in cui s’impadroniva del sacco, il demonio s’impadronì di lui, e lo trascinò davanti a tutti come se lo portasse all’inferno (Vedere nel RIBADENEIRA, al 26 Febbraio la vita di san Vittore d’Arcis-sur-Aube.). Dio mio, come è cieco l’uomo, che vuol dannarsi per sì poca cosa. – La seconda ragione che ci deve far temere d’impossessarci dei beni altrui, è che questa colpa ci trascina all’inferno. Il profeta Zaccaria dice che, in una visione, Iddio gli fece vedere un libro, dove era scritto che mai i rapitori dei beni altrui vedranno Dio, e che essi saranno gettati nelle fiamme. Eppure, F. M., vi sono alcuni talmente ciechi che preferirebbero morire e dannarsi, anziché restituire le ricchezze mal acquistate, anche se la morte fosse sul punto di strapparle loro dalle mani. Un uomo aveva passato la sua vita rubando e saccheggiando… Aveva appena trent’anni, quando fu preso da una malattia, della quale poi morì. Uno dei suoi amici, vedendo ch’egli non domandava il sacerdote, andò egli stesso a cercarne uno. “Amico, gli dice il prete, mi sembrate molto aggravato. Non pensavate dunque a chiamarmi? Volete confessarvi? — Ah! Reverendo, rispose l’ammalato smarrito, mi credete dunque già spacciato? — Ma, amico, più conoscenza avrete, e meglio riceverete i Sacramenti. — Non me ne parlate; in questo momento sono stanco; quando starò meglio verrò io stesso in chiesa. — No, amico, se aveste a morire senza Sacramenti, ne sarei troppo addolorato. Siccome sono qui, non me ne andrò finché non vi siate confessato.„ Vedendovisi costretto, acconsente; ma come lo fa? come una persona che avendo dei beni altrui non vuol restituirli. Non ne dice nulla… – “Se peggiorerete verrò a portarvi il Viatico.„ Infatti l’ammalato si avvicina alla morte: si corre ad avvertire il prete che il suo penitente sta per spirare, ed egli si affretta ad accorrere. Quando l’ammalato sentì il campanello, domandò che cos’era, e sapendo che il signor Parroco gli portava il Viatico: “Ecché! esclamò, non vi avevo detto, che non volevo riceverlo? Ditegli pure che non venga avanti.„ Frattanto entrò il sacerdote, ed accostandosi al letto di lui, gli dice: “Voi non volete dunque ricevere il buon Dio, che vi consolerebbe, e che vi aiuterebbe a sopportare le vostre pene? — No, no, ho già fatto troppo male. — Ma scandalizzerete tutta la parrocchia. — Eh! che m’importa che tutti sappiano ch’io mi son dannato? — Se non volete ricevere i Sacramenti, non potrete essere sepolto cristianamente. — Un dannato merita forse di essere sepolto tra i santi? Quando il demonio si sarà impossessato della mia maledetta anima, gettate il mio corpo ai lupi, come quello d’un animale… „ E vedendo sua moglie piangente: “Tu piangi? consolati; se mi hai accompagnato per andare di notte a rubare ai vicini, non tarderai a raggiungermi nell’inferno. „ E gridava disperato: “Ah! orrori dell’inferno, aprite i vostri abissi, venite a strapparmi da questo mondo; io non posso più reggere. „ E muore con segni visibili di riprovazione. — Ma, mi direte, egli aveva certo commesso grandi peccati. — Ahimè! amico, se osassi, vi direi ch’egli faceva quello che fate quasi tutti; ora rubava un fascio di legna, ora una bracciata di fieno, ovvero un covone di grano.
II. — Se volessi, F. M., esaminare la condotta di quelli che sono qui presenti, forse non troverei altro che ladri. Vi stupisce questo? Ascoltatemi un momento e converrete con me che ciò è vero. S’io comincio coll’esaminare la condotta dei servitori, li trovo colpevoli verso i padroni e verso i poveri. I servi sono colpevoli verso i padroni e, per conseguenza obbligati a restituire, tutto il tempo di più dell’occorrente che hanno impiegato per riposarsi o che hanno sciupato nelle osterie; se hanno lasciato andar in rovina e rubare i beni dei loro padroni, e se potendo impedirlo non l’abbiano fatto. Parimente, se, un servo offrendo l’opera sua ha assicurato che era capace di far certi lavori, sapendo benissimo ch’egli non li conosceva o padrone della perdita che deriva dalla sua ignoranza o dalla sua debolezza. Di più, ruba ai poveri tutte le volte che spende il denaro nel giuoco, all’osteria, o in altre cose inutili. — Ma, mi direte, questo denaro è mio, è il mio guadagno. — Vi risponderò: Voi avete lavorato per guadagnarlo, è vero; eppure siete colpevoli. Ascoltatemi e capitemi bene. Forse i vostri genitori sono tanto poveri da essere obbligati a ricorrere alla carità pubblica; se voi aveste conservato il vostro guadagno, potreste sollevarli; siete nell’impossibilità di farlo; non è rubare ai poveri? Una serva od un domestico hanno sprecato tutto il loro denaro, l’una nel comperare oggetti di vanità, l’altro nelle osterie e nei giuochi; se il buon Dio manda loro qualche malattia od infermità, sono obbligati di andar all’ospedale a mangiare il pane dei poveri; oppure aspetteranno che una persona caritatevole tenda loro la mano, dando ad essi quello che verrà a mancare ad altri che sono più disgraziati. Se contraggono matrimonio, eccoli ridotti in miseria insieme coi loro figliuoli. Perché tutto questo? Perché da giovani non hanno saputo metter nulla da parte. Non è vero, sorella mia, che se si riflettesse un po’, la vanità non andrebbe tant’alto? E il più desolante si è, che voi non solo sprecate un bene che poi vi mancherà, ma perdete la vostra anima. – Ma ecco un peccato tanto più deplorevole quanto è più comune: quello dei fanciulli e dei servitori che rubano ai loro genitori padroni. I fanciulli non devono mai nulla prendere ai genitori col pretesto che non è abbastanza. Quando i vostri genitori vi hanno nutriti, vestiti ed istruiti, non vi devono più nulla. Del resto quando un ragazzo ruba ai suoi genitori, lo si considera capace di tutto. Tutti lo fuggono e lo disprezzano. Un servo mi dirà: “Non vengo pagato delle mie fatiche, bisogna dunque che mi ricompensi. — Se non siete pagato delle vostre fatiche, amico mio, perché restate presso questi padroni? Quando vi siete presentato, sapevate quale era il vostro guadagno, e quanto potevate meritare; dovevate indirizzarvi dove avreste potuto guadagnare di più. E quelli che ricevono in custodia quanto i servi rubano ai loro padroni od i figli ai genitori, stiano bene attenti! Quando pure quegli oggetti fossero stati presso di loro solo cinque minuti: e quand’anche non ne conoscessero il valore, questi nasconditori sono obbligati a restituirli, sotto pena di dannarsi, se i colpevoli non li restituiscono essi stessi. Alcuni, compreranno qualche oggetto da un figlio di famiglia o da un domestico; ora, quando pure lo pagassero più di quello che vale, sono obbligati di restituire al padrone l’oggetto od il suo valore; altrimenti saranno gettati nell’inferno. Se avete consigliato ad una persona di rubare, quand’anche voi non ne aveste ricavato alcun profitto, se il ladro non restituisce, tocca a voi di farlo; altrimenti è inutile sperare il cielo. I furti più comuni si fanno nelle vendite e nelle compere. Entriamo nei particolari, affinché conosciate il male che avete fatto, e, nel medesimo tempo possiate correggervene. Quando portate a vendere le vostre derrate, vi si domanderà se le vostre uova ed il vostro burro sono freschi, e vi affretterete di rispondere: Sì; mentre sapete benissimo che è vero il contrario. Perché lo dite, se non per rubare due o tre soldi ad una povera madre di famiglia che, forse li ebbe in prestito per preparare il pranzo? Un’altra volta sarà vendendo il cotone. Voi avrete la precauzione di nascondere in mezzo il più piccolo ed il più brutto. Forse direte: Se non facessi così non ne venderei tanto. — Cioè se vi diportaste da buon Cristiano non rubereste come fate. Un’altra volta, vi siete accorto che nel conto vi fu dato più di quanto vi si doveva, ma non avete detto nulla. — Tanto peggio per quella persona; non è mio sbaglio. — Ah! amico mio, verrà un giorno in cui vi si dirà forse con più ragione: Tanto peggio per te!… Il tale vuol comperare da voi del grano, del vino o delle bestie, e vi domanderà se quel grano è buono. Senza esitare l’assicurate di sì. Il vino lo mescolate con dell’altro cattivo e lo vendete come se fosse buono. Se non siete creduto, giurate; e non una, ma anche venti volte date la vostra anima al demonio. Ah amico mio, non fa bisogno che ti affatichi tanto per darti a lui; già da molto tempo gli appartieni! Questa bestia, vi si chiederà, ha qualche difetto? Non dovete ingannarmi; ho preso in prestito questo denaro, e se mi ingannate sono in miseria. — No, no, rispondete, questa bestia è sanissima. Se la vendo, non lo faccio senza rincrescimento; se potessi altrimenti certo non la venderei. Ed infatti la vendete solo perché non val nulla, e non può più servirvi. — Io faccio come fanno tutti; peggio per chi resta ingannato. Sono stato ingannato e cerco d’ingannare, altrimenti perderei troppo. — Ma, amico, gli altri si dannano e bisogna che vi danniate anche voi? gli altri vanno all’inferno, e dovete proprio andarvi insieme? Voi preferite avere qualche soldo di più e andar a bruciare nell’inferno per tutta l’eternità? Ebbene! vi dico che se avete venduto una bestia con dei difetti nascosti, siete obbligati a ricompensare il compratore della perdita che quei difetti possono avergli recato; altrimenti vi dannerete. — Ah! se voi foste al nostro posto, fareste come noi. — Sì, senza dubbio, farei come voi se, come voi, volessi dannarmi; ma, volendo salvarmi, farei tutto il contrario di quello che voi fate. Altri passando per un prato, per un campo di rape, per un orto non si faranno scrupolo di riempire i loro grembiuli di erbe o di rape e di portar via i panieri e le tasche piene di frutta. I genitori vedranno ritornare i figli colle mani piene di cose rubate e li rimprovereranno ridendo: — Ehei! è troppo, sai! — F. M, se rubate ora un soldo, ora due, ben presto avrete accumulato la materia d’un peccato mortale. D’altra parte, potete commettere peccato mortale anche prendendo un centesimo, se avete intenzione di rubare tre lire. Che debbono dunque fare i genitori quando vedono i figli con qualche oggetto rubato? ecco. Debbono obbligarli ad andare essi stessi a restituirli a quelli cui li hanno rubati. Una o due volte basteranno per correggerli. Un esempio mostrerà come dovete essere fedeli in questo. Si racconta che un fanciullo dai nove ai dieci anni cominciava a commettere piccoli furti, come di frutta o d’altre cose di lieve valore. E andò sempre aumentando i suoi furti fino a che più tardi lasciò la vita sul patibolo. Prima di morire, domandò ai giudici, che si facessero venire i suoi genitori; quand’essi furono presenti: “O padre e madre sciagurati, esclamò, voglio che tutti sappiano che voi siete la causa della mia morte infame. Voi siete disonorati davanti al mondo; ma siete dei disgraziati! se m’aveste corretto quando cominciavo a commettere i miei piccoli furti, non avrei certo commessi quelli che mi hanno condotto su questo patibolo. „ Dico, F. M., che i genitori debbono essere molto circospetti riguardo ai loro figli, quando pure dimenticassero di aver un’anima da salvare. Si vede infatti, ordinariamente, che quali sono i genitori, tali sono i figli. Ogni giorno si sente dire: Il tale ha dei figli che ripeteranno quello che ha fatto lui quand’era giovane. — Questo non vi riguarda, mi direte, lasciateci tranquilli, non venite a disturbarci; noi non pensavamo più a questo e voi venite a ricordarcelo. Il fuoco dell’inferno non è dunque abbastanza rigoroso, e l’eternità abbastanza lunga, perché ci facciate soffrire così in questo mondo? — È vero, F. M., ma è perché non vorrei vedervi dannati. — Ebbene, peggio per noi; se noi facciamo il male, non ne porterete voi la pena. — Contenti voi, tanto meglio!… Altra volta, sarà un calzolaio che adopererà cuoio cattivo e filo scadente e lo farà pagare come buono. Oppure sarà un sarto, che col pretesto di non ricevere un buon prezzo di fattura, riterrà senza dir nulla un pezzo di stoffa. Dio mio! quanti ladri scoprirà la morte!… Ovvero un tessitore che guasta una parte del filo, piuttosto di affaticarsi a districarlo; oppure ne metterà di meno e, senza dir nulla, nasconderà quello che gli venne dato. Ecco una donna cui si darà della canapa da filare; essa ne getterà via una parte col pretesto che non è ben pettinata, poi ne nasconderà un poco per sé e, mettendo il filo in un luogo umido, il peso sarà ancora uguale. Essa forse non pensa che questo filo appartiene ad un povero domestico, il quale non potrà servirsene, perché già mezzo marcio: essa, dunque, sarà la causa di molte sue maledizioni contro il padrone che gli avrà dato questa canapa in compenso del salario; un pastore sa benissimo che non è permesso condurre a pascolare in quel prato od in quel bosco; non importa: gli basta non esser visto. Un altro sa che è proibito raccogliere il loglio tra quel grano, perché è fiorito; ed egli guarda se nessuno lo vede e vi entra. Ditemi, F. M., sareste contenti se il vostro vicino facesse così con voi? No, senza dubbio: ebbene credetemi: colui che… Se esaminiamo ora la condotta degli operai, ne troviamo una parte che sono ladri; e ne sarete subito convinti. Se si fanno lavorare a cottimo, sia a zappare, sia a scavare, sia per qualunque altro lavoro, ne faranno male la metà, e non mancheranno di farsi ben pagare. Presi a giornate, si accontentano di lavorar bene quando il padrone li osserva, e poi si mettono a chiacchierare o ad oziare. Un servo non si farà scrupolo di ricevere e trattar bene i suoi amici in assenza dei padroni pur sapendo che essi non lo tollererebbero. Altri fanno grosse elemosine per essere in voce di persone caritatevoli. Non dovrebbero invece farle col loro guadagno che sì spesso sciupano in vanità? Se questo vi è capitato, non dimenticate l’obbligo che avete di restituire a chi spetta quanto avete dato ai poveri all’insaputa e contro la volontà dei vostri padroni. Può esservi pure un primo servo cui il padrone ha affidata la sorveglianza sugli altri domestici o sugli operai, e che, domandato da loro darà ad essi vino o qualche altra cosa: attenti bene: se sapete dare, bisognerà saper restituire sotto pena di dannazione. Un uomo d’affari sarà stato incaricato di comperare del grano, del fieno o della paglia, e dirà al mercante: “Fatemi una quietanza su cui noterete pel mio padrone qualche misura di più di grano; dieci, dodici quintali di paglia e di fieno più di quanto m’avete dato. Ciò non può far danno. „ Ora se quel povero cieco fa una tale quietanza, è obbligato lui stesso a restituire il denaro che quest’uomo fa spendere in più al suo padrone, altrimenti deve risolversi ad andare a bruciare nell’inferno. – Se ci volgiamo ora dalla parte dei padroni, credo che non mancheremo di trovarvi dei ladri. Infatti, quanti padroni non danno ai loro dipendenti tutto ciò che è stato convenuto; e che, avvicinandosi la fine dell’anno fanno ogni possibile per licenziarli affine di non doverli pagare. Se una bestia muore, malgrado tutte le cure da parte di chi ne era incaricato, gliene riterranno il valore sul suo salario; così che quel poveretto avrà lavorato tutto l’anno, ed alla fine si troverà colle mani vuote. Quanti avendo promesso della tela, la faranno fare più corta o di filo peggiore, od anche la fanno aspettare per parecchi anni; così che bisogna citarli in giudizio per obbligarli a pagare. Quanti infine coltivando, falciando, mietendo oltrepassano i propri confini; oppure tagliano al loro vicino un alberello per fare il manico alla zappa, ovvero un vinciglio per legare il covone, o farne una corda per la loro carretta. Non avevo ragione di dire, F. M., che esaminando da vicino la condotta della gente del mondo, non troveremmo altro che ladri e mariuoli? Non mancate di esaminarvi su quanto ho detto; e se la vostra coscienza vi rimorde, affrettatevi a riparare il male che avete fatto, e mentre ne siete ancora in tempo, restituite subito, se potete, od almeno lavorate con tutte le vostre forze per restituire ciò che avete male acquistato. Ricordatevi di dire nelle vostre confessioni quante volte avete trascurato di restituire essendo in grado di farlo; poiché avendovene Dio dato il pensiero, sono tante grazie disprezzate. – Vi parlerò anche d’un furto assai comune nelle famiglie, quando certi eredi, al tempo della divisione, nascondono più roba che possono. Questo è un vero rubare e si è obbligati a restituire, altrimenti si è dannati. Vi ho detto in principio, che nulla è più comune della ingiustizia, e nulla è più raro della restituzione: sono pochi, come vedete, quelli che non hanno nulla sulla coscienza. Ebbene! dove sono quelli che restituiscono? Io non lo so. Eppure, F. M., quantunque siamo obbligati a restituire i beni mal acquistati sotto pena di dannarci, quando lo facciamo Dio non lascia di ricompensarcene. Un esempio ve lo proverà chiaramente. Un fornaio, che da molti anni aveva usato falsi pesi e false misure, volendo acquietare la sua coscienza, consultò il proprio confessore, che lo consigliò di usare, per qualche tempo, pesi un po’ più abbondanti. Essendosene sparsa la voce, il concorso dei clienti diventò grandissimo, e, sebbene guadagnasse poco, Dio permise che restituendo, aumentasse considerevolmente la sua fortuna.
III. — Ora, direte voi, possiamo sperare di conoscere, almeno superficialmente, il modo con cui possiamo commettere ingiustizia. Ma come ed a chi bisogna restituire? — Volete restituire? Ebbene! ascoltatemi un momento e lo saprete. Non bisogna accontentarsi di rendere la metà, né i tre quarti; ma tutto, se lo potete, altrimenti vi dannerete. Vi sono di quelli che, senza cercare il numero delle persone alle quali hanno recato danno, faranno qualche elemosina, o faranno celebrare qualche messa; e dopo questo, si crederanno sicuri in coscienza. È vero, le elemosine e le messe sono buonissime cose, ma bisogna che siano fatte col vostro denaro, e non con quello del vostro prossimo. Questo denaro non è vostro; rendetelo al suo padrone, e poi date del vostro, se volete; farete benissimo. Sapete come chiama queste elemosine S. Gio. Crisostomo? le elemosine di Giuda e del demonio. Quando Giuda ebbe venduto nostro Signore, vedendolo condannato, corse a restituire il denaro ai dottori; questi, sebbene avarissimi, non vollero accettarlo; ne comperarono un campo per seppellirvi i forestieri. — Ma, mi direte, quando i danneggiati sono morti, a chi bisogna restituire? Non si può ritenersi il denaro o darlo ai poveri? Amico, ecco ciò che dovete fare. Se hanno dei figli, dovete restituire a loro; se non ne hanno, ai parenti, agli eredi; se non hanno parenti né eredi, andate dal vostro pastore ed egli vi dirà ciò che dovete fare. Altri dicono: Io ho danneggiato il tale, ma egli è ricchissimo, soccorrerò una persona povera che ha molto maggior bisogno. — Amico, a questa persona date del vostro; ma restituite al vostro prossimo ciò che gli avete rubato. — Egli l’adoprerà malamente. — Ciò non v’importa: dategli il suo, pregate per lui e state tranquillo. Ahimè! oggi la gente del mondo è così avara, così attaccata ai beni della terra, che, credendo di non averne mai abbastanza, fa a chi sarà più accorto ed ingannerà meglio degli altri. Ma voi, F. M., non dimenticatevi che se per colpa vostra ad alcuno avete recato danno, quand’anche aveste dato il doppio ai poveri, se non restituirete al padrone ciò che avete rubato, vi dannerete. Io non so se la vostra coscienza è tranquilla; ne dubito molto … Ho detto che il mondo è pieno di ladri e di imbroglioni. I mercanti rubano ingannando coi pesi e colle misure; essi approfittano della semplicità d’una persona per vendere più caro, e per comperare a miglior prezzo; i padroni rubano ai loro dipendenti facendo perdere loro una parte del salario; altri, facendoli aspettare per un tempo considerevole, diminuendo perfino un giorno di malattia, come se avessero preso il male in casa di un vicino e non al loro servizio!… Da parte loro i domestici rubano ai padroni o non facendo il lavoro stabilito, o lasciandone rovinare colpevolmente gli averi; un operaio si fa pagare mentre il lavoro è fatto per metà. Quelli che tengono le osterie, questi serbatoi d’iniquità, porte d’inferno, calvari dove Gesù Cristo è incessantemente crocifisso, scuole infernali dove satana insegna la sua dottrina, dove si distruggono la religione e la morale, gli osti, dico, rubano il pane d’una povera donna e dei suoi figli dando del vino a questi ubbriaconi, che la domenica sprecano tutto il guadagno della settimana. Un mezzadro distrarrà mille cose per sé, prima di dividere col padrone, e non ne terrà conto. Dio mio, dove siamo? Quante cose da giudicare dopo la morte!… Se la loro coscienza grida troppo forte, costoro andranno dal ministro del Signore. Vorrebbero ottenere la remissione del loro debito; se invece vengono sollecitati a restituire, troveranno mille pretesti per provare che altri hanno recato danno anche a loro e che per ora non possono. Ah! io non so se il buon Dio si accontenterà delle vostre ragioni! Se voleste diminuire un po’ quelle vanità, quelle golosità, quei giuochi; andare un po’ meno all’osteria e al ballo e raddoppiare il vostro lavoro, avreste ben presto pagata una parte dei vostri debiti. Ricordatevi, che se non fate il possibile per restituire a ciascuno quanto gli dovete, qualsiasi penitenza facciate, non tralascerete di cadere nell’inferno: statene sicuri!… Troverete molti così ciechi da dire che i figli lo faranno dopo la loro morte. I vostri figli. amico mio, lo faranno al pari di voi. Del resto, volete che della vostr’anima abbiano più cura i vostri figli di voi? Vi dannerete; ecco ciò che vi toccherà. Ditemi, avete soddisfatto voi piccole ingiustizie dei vostri genitori? Ve ne siete ben guardati, ed i vostri poveri genitori sono all’inferno per non aver restituito quand’erano vivi, fidandosi troppo della vostra buona volontà. Infine, per tagliar corto, quanti tra quelli che m’ascoltano, incaricati dai loro genitori, forse più di venti anni fa, di far elemosine o celebrare messe, l’han fatto? se ne sono ben guardati! Preferiscono allargare le loro possessioni, frequentare i giuochi e le osterie, comperare vanità alle loro figliuole. – S. Antonino racconta che un usuraio preferì morire senza Sacramenti piuttosto che restituire ciò che non gli apparteneva. Egli non aveva che due figli; uno temeva Dio, l’altro no. Quello che si dava pensiero della salute della sua anima fu così commosso dallo stato sciagurato in cui era morto suo padre, che dopo aver usata una parte della sua fortuna per riparare le ingiustizie del padre, si fece monaco per non aver più nulla a cui pensare fuorché a Dio solo. L’altro invece dissipò tutto il suo denaro in stravizi e morì improvvisamente. Ne fu portata la notizia al religioso il quale si mise subito in orazione. Vide in spirito la terra spalancata e, nel suo centro, una profonda voragine da cui uscivano fiamme. In mezzo a queste fiamme suo padre e suo fratello bruciavano e si maledicevano l’un l’altro. Il padre malediceva il figlio, poiché volendo egli lasciargli molte ricchezze, non aveva temuto di dannarsi per lui, ed il figlio rimproverava al padre i cattivi esempi ricevuti. Dovrò io parlarvi di quelli che aspettano fino alla loro morte prima di restituire? Vi proverò con due esempi che, in quel momento, o non lo vorrete, o, quand’anche lo vorreste, non lo potrete più.
1° Non lo vorrete. Si racconta che stando per morire un padre di numerosa famiglia, i suoi figli gli dissero: “Padre, lo sapete, queste ricchezze che ci lasciate, non sono nostre, bisognerebbe restituirle. — Figli miei, disse il padre, se restituissi tutto ciò che non è mio, non vi resterebbe quasi nulla. — Padre, piuttosto che vi danniate, noi preferiamo lavorare per guadagnarci da vivere. — No, figli miei, non voglio restituire; voi non sapete che cos’è l’esser poveri. — Se non restituite, andrete all’inferno. — No, non restituirò nulla. „ E morì dannato… Dio mio! quanto il peccato d’avarizia acceca l’uomo!
2° Ho detto che, in quel momento quand’anche il voleste, non lo potrete. Un missionario racconta che un padre, vedendo la sua fine prossima, fece venire i figli vicino al suo letto, e disse loro: “Figli miei, sapete che io ho danneggiato molta gente; se non restituisco sono perduto. Andate in cerca di un notaio che abbia da ricevere le mie disposizioni. — Ecchè! padre, gli risposero i figli, vorreste disonorare voi e noi, facendovi passare per uomo disonesto? Vorreste ridurci in miseria e costringerci a mendicare il pane? — Ma, figli miei, se non restituisco mi dannerò! „ Ed uno di quegli empi figliuoli non temette di dirgli: “Padre, voi dunque temete l’inferno? Via, si abitua a tutto: in otto giorni vi sarete già avvezzo… „ – Ebbene, F. M., che cosa concluderemo da tutto questo? Che voi siete estremamente ciechi! Voi perdete le vostre anime per lasciare qualche palmo di terra, o un po’ dibeni di fortuna ai vostri figli, i quali lungi, dall’esservene grati, si rideranno di voi, mentre voi brucerete nell’inferno. Finisco dicendo che siamo insensati non pensando che ad ammassare ricchezze, le quali ci rendono infelici mentre le accumuliamo, per tutto il tempo che le possediamo, quando le lasciamo ed anche per tutta l’eternità. Siamo più saggi, F. M., attacchiamoci a quei beni che ci accompagneranno nell’altra vita e formeranno la nostra felicità nei giorni senza fine: ciò che vi auguro…
Credo
IL CREDO
Offertorium
Orémus
Esth XIV: 12; 13
Recordáre mei, Dómine, omni potentátui dóminans: et da sermónem rectum in os meum, ut pláceant verba mea in conspéctu príncipis.
[Ricòrdati di me, o Signore, Tu che dòmini ogni potestà: e metti sulle mie labbra un linguaggio retto, affinché le mie parole siano gradite al cospetto del príncipe.]
Secreta
Tua, Dómine, propitiatióne, et beátæ Maríæ semper Vírginis intercessióne, ad perpétuam atque præséntem hæc oblátio nobis profíciat prosperitátem et pacem.
[Per la tua clemenza, Signore, e per l’intercessione della beata sempre vergine Maria, l’offerta di questo sacrificio giovi alla nostra prosperità e pace nella vita presente e nella futura.]
COMUNIONE SPIRITUALE
Communio
Ps XVI: 6
Ego clamávi, quóniam exaudísti me, Deus: inclína aurem tuam et exáudi verba mea.
[Ho gridato verso di Te, a ché Tu mi esaudisca, o Dio: porgi il tuo orecchio ed esaudisci le mie parole.]
Postcommunio
Orémus.
Súmpsimus, Dómine, sacri dona mystérii, humíliter deprecántes: ut, quæ in tui commemoratiónem nos fácere præcepísti, in nostræ profíciant infirmitátis auxílium.
[Ricevuti, o Signore, i doni di questo sacro mistero, umilmente Ti supplichiamo: affinché ciò che comandasti di compiere in memoria di Te, torni di aiuto alla nostra debolezza.]
PREGHIERE LEONINE (dopo la Messa)
RINGRAZIAMENTO DOPO LA COMUNIONE (1)
ORDINARIO DELLA MESSA