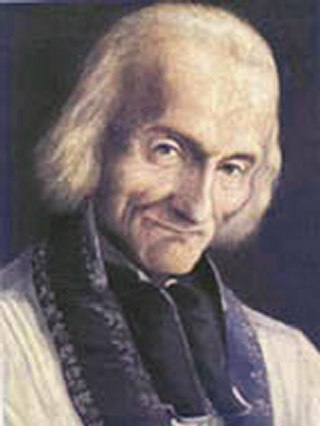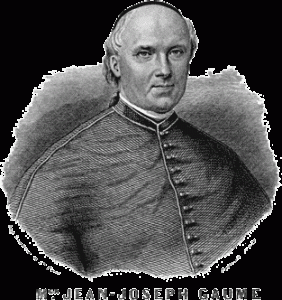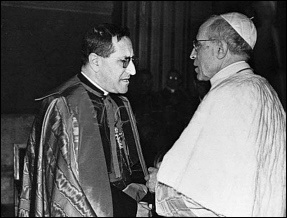XXIV ED ULTIMA DOMENICA DOPO PENTECOSTE. (2021)
(Messale Romano di S. Bertola e G. Destefani, comm. di D. G. LEFEBVRE O. S. B; L. I. C. E. – R. Berruti & C. Torino 1950)
Semidoppio. – Paramenti verdi.
Quest’ultima settimana chiude l’anno ecclesiastico, e con essa si chiude la storia del mondo, iniziatasi coll’Avvento. Perciò in questa domenica la Chiesa fa leggere nel Breviario il libro del Profeta Michea (contemporaneo di Osea e di Isaia) con il commento di S. Basilio, che tratta del giudizio universale, e nel Messale il Vangelo dell’Avvento del Giudice divino. « Ecco, dice Michea, che il Signore uscirà dalla sua dimora; e camminerà su le alture della terra; le montagne si scioglieranno sotto i suoi passi e le valli fonderanno come la cera dinanzi al fuoco, e spariranno come l’acqua su un pendìo. E tutto questo per causa dei peccati d’Israele ». Dopo questa minaccia il Profeta continua con promesse di salvezza « Ti radunerò totalmente, Giacobbe, riunirò quello che resta d’Israele; lo radunerò come un gregge nell’ovile». Gli Assiri hanno distrutto Samaria, i Caldei hanno devastato Gerusalemme, il Messia riparerà tutte queste rovine. Michea annunzia che Gesù Cristo nascerà a Gerusalemme e che il suo regno, che è quello della Gerusalemme celeste, non avrà fine. I profeti Nahum, Habacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria e Malachia, i libri dei quali si leggono nell’ufficiatura della settimana, confermano quanto ha detto Michea. Gesù nel Vangelo comincia con l’evocare la profezia di Daniele, che annunzia la rovina totale e definitiva del tempio di Gerusalemme e della nazione giudea per opera dell’esercito romano. Questa abominazione della desolazione è il castigo in cui il popolo di Israele ha incorso per la sua infedeltà, che è giunta al colmo, quando ha rigettato Cristo. Questa profezia si realizzò infatti qualche anno dopo la morte del Salvatore, allorché la tribolazione arrivò a tal punto, che se avesse durato ancora più a lungo nessun giudeo sarebbe sfuggito alla morte. Ma per salvare coloro che si convertirono in seguito ad una si rude lezione, Dio abbreviò l’assedio di Gerusalemme. Così farà alla fine del mondo, di cui è figura la distruzione di questa città. Al momento del Secondo Avvento di Cristo vi saranno senza dubbio tribolazioni ancor più terribili. «Molti impostori, fra i quali l’anticristo, faranno prodigi ancora più satanici per farsi credere il Cristo; allora, l’abominazione della desolazione regnerà in altro modo nel tempio, poiché, spiega S. Girolamo « sorgerà, secondo quanto dice S. Paolo, l’uomo dell’iniquità e dell’opposizione contro tutto quello che è chiamato Dio ed è adorato e spingerà l’audacia fino a sedersi nel tempio stesso di Dio ed a farsi passare egli stesso per Dio » – « Verrà accompagnato dalla potenza di satana per far perire e gettare nell’abbandono di Dio quelli che l’avranno accolto » (3° Notturno). Ma qui ancora, continua S. Girolamo, Dio abbrevierà questo tempo, affinché gli eletti non siano indotti in errore (id.). Del resto, non vi lasciate ingannare, dice il Salvatore, poiché il Figlio dell’uomo non apparirà, come la prima volta, nel velo del mistero e in un angolo remoto del mondo, ma in tutto il suo splendore e dappertutto contemporaneamente e con la rapidità della folgore. Allora tutti gli eletti andranno incontro a Lui, come gli avvoltoi verso la preda. Compariranno, allora, nel cielo, il segno sfolgorante della croce e il Figlio dell’Uomo che verrà con grande potenza, e con grande maestà (Vangelo). – « Quando vi prende la tentazione di commettere qualche peccato, dice S. Basilio, vorrei che pensaste a questo terribile tribunale di Cristo, dove Egli siederà come giudice sopra un altissimo trono; davanti a questo comparirà ogni creatura tremante alla sua gloriosa presenza; là renderemo uno per uno, conto delle azioni di tutta la nostra vita. Subito dopo, coloro che avranno commesso molto male durante la loro vita, si vedranno circondati da terribili e orribili demoni, che li precipiteranno in un profondo abisso. Temete queste cose, e, penetrati da questo timore, usatene come un freno per impedire all’anima vostra di esser trascinata dalla concupiscenza a commettere il peccato» (3″ Notturno). La Chiesa ci esorta perciò nell’Epistola, per bocca dell’Apostolo, a condurci in modo degno del Signore e a portar frutto in ogni sorta di buone opere, affinché, fortificati dalla sua gloriosa potenza, sopportiamo tutto con pazienza e con gioia, ringraziando Dio Padre che ci ha fatti capaci di aver parte all’eredità dei Santi, ora in ispirito, e all’ultimo giorno in corpo e in anima, per il Sangue redentore del suo Figlio diletto. Dio, che ci ha detto per bocca di Geremia di nutrire pensieri di pace e non di collera (Introito), e che ha premesso di esaudire le preghiere fatte con fede (Com.), ci esaudirà e ci affrancherà dalle concupiscenze terrene (Secr.) facendo cessare la nostra cattività (Intr. e Vers.) e aprendoci per sempre il cielo ove il trionfo del Messia troverà la sua gloriosa consumazione. – Vincitore assoluto sui suoi nemici, che risusciteranno per il loro castigo, e Re senza contestazione di tutti gli eletti, che hanno creduto nel suo avvento e che risusciteranno per essere gloriosi nel corpo e nell’anima per tutta l’eternità. Gesù Cristo rimetterà al Padre questo regno, che ha conquistato a prezzo del sul Sangue, come omaggio perfetto del capo e dei suoi membri. E sarà allora la vera Pasqua, il pieno passaggio nella vera terra promessa e la presa di possesso, per sempre, da parte di Gesù ed il suo popolo del regno della Gerusalemme celeste, dove, nel Tempio, che non è stato fatto da mano di uomo, regna sovrano Dio in cui metteremo tutta la nostra gloria ed il cui Nome celebreremo eternamente (Grad.). E per mezzo del nostro Sommo Sacerdote Gesù noi renderemo un eterno omaggio alla SS. Trinità dicendo: « Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio ed ora e sempre e nei secoli, così sia. »
Rendiamo infinite grazie a Dio Padre per averci riscattato per mezzo di Gesù Cristo dalla schiavitù del demonio e delle sue opere tenebrose ed averci resi degni di partecipare con Lui alla gloria del suo regno celeste, che è l’eredità dei Santi nella luce.
Gesù è venuto nell’umiliazione, e tornerà nella gloria. Il suo Primo Avvento ebbe per scopo di prepararci al secondo. Coloro che l’avranno accolto nel tempo, saranno da Lui accolti quando entreranno nell’eternità; quei che l’avranno misconosciuto saranno rigettati. Perciò i Profeti non hanno separato i due avventi del Messia, poiché sono i due atti di un medesimo dramma divino. Così pure Nostro Signore non separa la rovina di Gerusalemme dalla fine del mondo, poiché il castigo che colpì i Giudei deicidi è la figura del castigo eterno, che toccherà a tutti quelli che avranno rigettato il Salvatore. Questo primo avvento ha già avuto luogo, il secondo si effettuerà: prepariamoci; la lettura del Vangelo di oggi, tende appunto a questo.
Incipit
In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
Introitus
Ier XXIX: 11; 12; 14
Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis.
[Dice il Signore: Io ho pensieri di pace e non di afflizione: mi invocherete e io vi esaudirò: vi ricondurrò da tutti i luoghi in cui siete stati condotti.]
Ps LXXXIV: 2
Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob.
[Hai benedetta la tua terra, o Signore: hai distrutta la schiavitú di Giacobbe.]
Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis.
[Dice il Signore: Io ho pensieri di pace e non di afflizione: mi invocherete e io vi esaudirò: vi ricondurrò da tutti i luoghi in cui siete stati condotti.]
Oratio
Orémus.
Excita, quǽsumus, Dómine, tuórum fidélium voluntátes: ut, divíni óperis fructum propénsius exsequéntes; pietátis tuæ remédia maióra percípiant.
[Eccita, o Signore, Te ne preghiamo, la volontà dei tuoi fedeli: affinché dedicandosi con maggiore ardore a far fruttare l’opera divina, partécipino maggiormente dei rimedi della tua misericordia.]
Lectio
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Colossénses.
Col 1: 9-14
“Fratres: Non cessámus pro vobis orántes et postulántes, ut impleámini agnitióne voluntátis Dei, in omni sapiéntia et intelléctu spiritáli: ut ambulétis digne Deo per ómnia placéntes: in omni ópere bono fructificántes, et crescéntes in scientia Dei: in omni virtúte confortáti secúndum poténtiam claritátis eius in omni patiéntia, et longanimitáte cum gáudio, grátias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctórum in lúmine: qui erípuit nos de potestáte tenebrárum, et tránstulit in regnum Fílii dilectiónis suæ, in quo habémus redemptiónem per sánguinem eius, remissiónem peccatórum”.
(“Fratelli: Non cessiamo di pregare per voi, e di chiedere che abbiate la piena cognizione della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, affinché camminiate in maniera degna di Dio; sì da piacergli in tutto; producendo frutti in ogni sorta di opere buone, e progredendo nella cognizione di Dio; corroborati dalla gloriosa potenza di lui in ogni specie di fortezza ad essere in tutto pazienti e longanimi con letizia, ringraziando Dio Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, sottraendoci al potere delle tenebre; e trasportandoci nel regno del suo diletto Figliuolo, nel quale, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati”).
SAPERE.
San Paolo tocca mirabilmente tre verbi, che riassumono il fior fiore dell’attività veramente cristiana, con insistenza sul primo: sapere. Non è il caso di esagerare o piuttosto alterare l’azione che il Divin Maestro ha esercitato ed esercita sull’intelletto umano, e quella che l’intelletto umano deve esplicare docilmente, secondando gl’impulsi del Maestro. Ma non per nulla N. S. Gesù Cristo ha preso e conserva questo bel nome: Maestro. Rabbi. Non per nulla il Maestro è il Verbo di Dio, è la Sapienza incarnata di Lui. Verbo che illumina ogni uomo, quando specialmente, in carne mortale, viene a risiedere in mezzo a noi. – Il suo Vangelo è, inizialmente, radicalmente luce nuova. Ci ha strappato, dice San Paolo, parlando, si capisce, di preferenza ai convertiti, dal Gentilesimo, ci ha strappati dall’impero delle tenebre, trasportandoci nel regno della luce. Ed anche per questo il Cristianesimo è umano, cioè proporzionato, profondamente, perfettamente agli umani bisogni. L’uomo comincia di lì, dal sapere, dalla luce, dalla testa, la sua vita veramente umana. È un uomo perché pensa, uomo perché opera a ragione veduta. Il Cristianesimo ci prende di lì, comincia a prenderci di lì, dalla testa, colla sua rivelazione. Alla quale risponde la nostra fede, che è un sapere sovrannaturale, ma sapere. Sapere con una certezza nuova cose che erano oggetto di discussioni antiche; sapere cose nuove intravedute per « speculum in enigmate, » attendendo che venga di là, di lassù, la luce piena. E questo saper nuovo, scende sì, in noi, da Dio, ma dobbiamo noi pure accrescerlo col divino aiuto e la nostra operosità. Non tutti i Cristiani sono egualmente sapienti o veggenti. Paolo esorta i suoi lettori e discepoli a diventarlo sempre più. Augura loro e raccomanda che « siano riempiti della profonda conoscenza della volontà di Dio, in ogni sorta di spirituale sapienza e intelligenza spirituale ». Il che si consegue quando si studia e si medita il Vangelo, la rivelazione divina, il mondo della realtà cristiana. Si studia come fanno anche i più semplici Cristiani, leggendo il Catechismo, ascoltando la spiegazione evangelica dei Sacerdoti, e poi si medita come hanno fatto e fanno i grandi Cristiani, non solo sacerdoti e teologi, dirò così, di professione, S. Tommaso, S. Bonaventura, S. Bellarmino, ma anche i grandi laici, come Manzoni, Nicolò Tommaseo, Contardo Ferrini. Bisogna istruirsi per sapere; e bisogna sapere se si vuol essere degni del nome di uomini e di Cristiani. Ma, soprattutto, bisogna sapere cristianamente, per cristianamente lavorare e soffrire. Il sapere cristiano non è fine a se stesso; non è appagamento vano di vana curiosità. In ciò la sua profonda differenza dal sapere profano. S. Paolo segna subito quella finalità essenziale e doverosa del sapere cristiano, che è pratica. Augura a tutti i suoi lettori, a noi, che lo siamo dopo tanti secoli, di crescere in ogni maniera di sapienza spirituale perché — gli cedo la parola — « camminiate in modo degno di Dio in guisa da essergli in ogni cosa graditi, producendo frutti d’ogni opera buona ». – Del resto, è naturale, è logico. Alla luce si cammina meglio; più veloci, più alacri, nell’ordine fisico. Nell’ordine morale e religioso, è lo stesso. Quello che pareva problema di luce, si risolve in un problema di azione. Conoscendo meglio Dio, dobbiamo, — è quasi direi, una necessità, necessità logica, — amarlo di più. Conoscendo meglio noi stessi, dobbiamo lavorare di più alla nostra purificazione ed elevazione. Conoscendo meglio il prossimo, dobbiamo compatirlo di più e perdonargli più facilmente. C’è così, una vera termo-dinamica del mondo Spirituale. Siamo davvero immersi nella luce di Dio: questa ci circonda da ogni parte. Tutto è lucido attorno a noi. La via è nettamente tracciata. Si vedono molti ostacoli: avanti! «Ambulemus: » camminiamo. Lavoriamo: sapere per fare… Del qual fare è parte anche il soffrire, il sopportare. Il sacrificio è un Cristianesimo in forma di azione. Il soldato lavora e soffre, versa sudore e sangue. Noi dobbiamo essere i soldati di Gesù Cristo. – Sono cose buone, sempre a ricordarsi a noi; più utili ed opportune mentre si chiude un ciclo di vita ecclesiastica e se ne apre un altro. Un anno più dell’altro, il nostro programma deve essere: luce, lavoro, sacrificio.
P. G. Semeria: Le epistole delle Domeniche, Op. naz. Per il mezzogiorno d’Italia, Milano, 1939.
(Nihil obstat sac. P. De Ambroggi – Imprim. P. Castiglioni vic. Gen. Curia Arch, Mediolani, 1-3-1938)
Graduale
Ps XLIII:8-9
Liberásti nos, Dómine, ex affligéntibus nos: et eos, qui nos odérunt, confudísti.
[Ci liberasti da coloro che ci affliggevano, o Signore, e confondesti quelli che ci odiavano.]
V. In Deo laudábimur tota die, et in nómine tuo confitébimur in sæcula.
[In Dio ci glorieremo tutto il giorno e celebreremo il suo nome in eterno.]
Alleluja
Allelúia, allelúia.
Ps CXXIX:1-2
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam. Allelúia.
[Dal profondo Ti invoco, o Signore: o Signore, esaudisci la mia preghiera. Allelúia.]
Evangelium
Sequéntia ⊕ sancti Evangélii secúndum S. Matthǽum.
Matt XXIV: 15-35
“In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Cum vidéritis abominatiónem desolatiónis, quæ dicta est a Daniéle Prophéta, stantem in loco sancto: qui legit, intélligat: tunc qui in Iudǽa sunt, fúgiant ad montes: et qui in tecto, non descéndat tóllere áliquid de domo sua: et qui in agro, non revertátur tóllere túnicam suam. Væ autem prægnántibus et nutriéntibus in illis diébus. Oráte autem, ut non fiat fuga vestra in híeme vel sábbato. Erit enim tunc tribulátio magna, qualis non fuit ab inítio mundi usque modo, neque fiet. Et nisi breviáti fuíssent dies illi, non fíeret salva omnis caro: sed propter eléctos breviabúntur dies illi. Tunc si quis vobis díxerit: Ecce, hic est Christus, aut illic: nolíte crédere. Surgent enim pseudochrísti et pseudoprophétæ, et dabunt signa magna et prodígia, ita ut in errórem inducántur – si fíeri potest – étiam elécti. Ecce, prædíxi vobis. Si ergo díxerint vobis: Ecce, in desérto est, nolíte exíre: ecce, in penetrálibus, nolíte crédere. Sicut enim fulgur exit ab Oriénte et paret usque in Occidéntem: ita erit et advéntus Fílii hóminis. Ubicúmque fúerit corpus, illic congregabúntur et áquilæ. Statim autem post tribulatiónem diérum illórum sol obscurábitur, et luna non dabit lumen suum, et stellæ cadent de cælo, et virtútes cœlórum commovebúntur: et tunc parébit signum Fílii hóminis in cœlo: et tunc plangent omnes tribus terræ: et vidébunt Fílium hóminis veniéntem in núbibus cæli cum virtúte multa et maiestáte. Et mittet Angelos suos cum tuba et voce magna: et congregábunt eléctos eius a quátuor ventis, a summis cœlórum usque ad términos eórum. Ab árbore autem fici díscite parábolam: Cum iam ramus eius tener fúerit et fólia nata, scitis, quia prope est æstas: ita et vos cum vidéritis hæc ómnia, scitóte, quia prope est in iánuis. Amen, dico vobis, quia non præteríbit generátio hæc, donec ómnia hæc fiant. Cœlum et terra transíbunt, verba autem mea non præteríbunt.”
(“In quel tempo disse Gesù a’ suoi discepoli: Quando adunque vedrete l’abbominazione della desolazione, predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo (chi legge comprenda): allora coloro che si troveranno nella Giudea fuggano ai monti; e chi si troverà sopra il solaio, non scenda per prendere qualche cosa di casa sua; e chi sarà al campo, non ritorni a pigliar la sua veste. Ma guai alle donne gravide, o che avranno bambini al petto in que’ giorni. Pregate perciò, che non abbiate a fuggire di verno, o in giorno di sabato. Imperocché grande sarà allora la tribolazione, quale non fu dal principio del mondo sino a quest’oggi, ne mai sarà. E se non fossero accorciati quei giorni non sarebbe uomo restato salvo; ma saranno accorciati quei giorni in grazia degli eletti. Allora se alcuno vi dirà: Ecco qui, o ecco là il Cristo; non date retta. Imperocché usciranno fuori dei falsi cristi e dei falsi profeti, e faranno miracoli grandi, e prodigi, da fare che siano ingannati (se è possibile) gli stessi eletti. Ecco che io ve l’ho predetto. Se adunque vi diranno: Ecco che egli è nel deserto; non vogliate muovervi: eccolo in fondo della casa; non date retta. Imperocché siccome il lampo si parte dall’oriente, e si fa vedere fino all’occidente; così la venuta del Figliuolo dell’uomo. Dovunque sarà il corpo, quivi si raduneranno le aquile. Immediatamente poi dopo la tribolazione di quei giorni si oscurerà il sole, e la luna non darà più la sua luce, e cadranno odal cielo le stelle, e le potestà dei cieli saranno sommosse. Allora il segno del Figliuolo dell’uomo comparirà nel cielo; e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figliuol dell’uomo scendere sulle nubi del cielo con potestà e maestà grande. E manderà i suoi Angeli, i quali con tromba e voce sonora raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un’estremità de’ cieli all’altra. Dalla pianta del fico imparate questa similitudine. Quando il ramo di essa intenerisce, e spuntano le foglie, voi sapete che l’estate è vicina: così ancora quando voi vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino alla porta. In verità vi dico, non passerà questa generazione, che adempite non siano tutte queste cose. Il cielo e la terra passeranno; ma le mie parole non passeranno”).
OMELIA
(Discorsi del santo Curato d’Ars, vol. I, quarta edizione. Torino-Roma, C. Ed. Marietti, 1933)
DELLE VERITÁ ETERNE
Memorare novissima tua, et in æternum non peccabis
“Ricordati della tua fine e non peccherai in eterno”
(Eccli. VII, 40)
Fratelli miei bisogna che queste verità siano molto potenti e molto salutari, se lo Spirito Santo ci assicura che se le meditiamo seriamente non peccheremo mai. Ciò non è difficile da comprendere. In effetti, fratelli miei, chi è colui che potrebbe attaccarsi ai beni di questo mondo pensando che fra poco tempo non ci sarà più? Da Adamo fino al presente, nessuno si è portato via qualcosa da quaggiù, e anche per noi sarà lo stesso. Chi è colui che si occuperebbe tanto degli affari di questo mondo, se fosse veramente persuaso che il tempo che trascorre sulla terra non gli sia donato se non per impegnarsi a guadagnare il cielo? Chi è colui che, ben impresso nella mente, o meglio nel cuore, che la vita del Cristiano debba essere vissuta nelle lacrime e nella penitenza, potrebbe ancora dedicarsi ai piaceri e alle gioie folli del mondo? Chi è colui che, essendo ben convinto che potrebbe morire in ogni momento, non si terrebbe sempre pronto? Ma voi mi direte: perché queste verità che hanno convertito tanti peccatori ci impressionano così poco? Ahimè, fratelli miei, questo accade perché noi non le meditiamo seriamente; il nostro cuore è troppo occupato dagli oggetti sensibili, che possono soddisfare le sue cattive inclinazioni; inoltre essendo il nostro spirito ingombro di affari temporali, perdiamo di vista queste grandi verità che dovrebbero costituire la nostra unica occupazione in questo mondo. Se mi domandaste perché lo Spirito Santo ci raccomanda con tanta insistenza di non perdere mai di vista queste verità, eccovene la ragione: il motivo è che non c’è nulla che sia più capace di distaccarci dai beni di questo mondo, niente di più potente per farci sopportare le miserie della vita in spirito di penitenza, o per meglio dire, nulla, più di queste verità ci faccia distaccare da tutte le cose create per non legarci che a DIO solo. – Ah! Fratelli miei, non dimentichiamo mai queste grandi verità, e cioè: che la nostra vita non è che un sogno; che la morte ci segue molto da vicino, e che ben presto essa ci raggiungerà; che un giorno saremo giudicati molto severamente, e che dopo questo giudizio la nostra sorte sarà fissata per sempre. Vedete, fratelli miei, quanto Gesù Cristo desideri salvarci: a volte ci si presenta come un povero Bambino nella sua mangiatoia, adagiato su una manciata di paglia che egli bagna con le sue lacrime; altre volte come un criminale, legato, incatenato, coronato di spine, flagellato, cadente sotto il peso della sua croce, e, infine, morente tra i supplizi, per amore nostro. Anche se ciò non fosse capace di commuoverci, di attirarci a Lui, ci induce però ad annunciare che un giorno ritornerà, rivestito con tutto lo splendore della sua gloria e della maestà del Padre suo, per giudicarci senza più grazia né misericordia. Allora Egli svelerà, davanti al mondo intero, sia il bene che il male che noi abbiamo fatto in ogni istante della nostra vita. Ditemi, fratelli miei, se noi pensassimo bene a tutto ciò, ci sarebbe bisogno d’altro, per farci vivere e morire da santi? Ma Gesù Cristo, per farci comprendere bene cosa dobbiamo fare per andare in cielo, ci dice nel Vangelo, che le persone del mondo conducono una vita completamente opposta a quella di coloro che gli sono graditi, che appartengono interamente a Lui. I buoni Cristiani, Egli ci dice, fanno consistere la loro felicità nelle lacrime, nella penitenza e nel disprezzo; mentre le persone del mondo fanno consistere la loro felicità nei piaceri, nella gioia e negli onori della terra, rifuggendo da tutto il resto. Sicché, ci dice Gesù Cristo, la vita degli uni è del tutto opposta a quella degli altri, ed essi non andranno mai d’accordo, né nel modo di vivere né di pensare. E questo è molto facile da comprendere. Io dico che ci sono quattro cose che fanno la felicità di un buon Cristiano: la brevità della vita, il pensiero della morte, il giudizio e l’eternità. E noi vediamo che proprio queste quattro cose, costituiscono, invece, la disperazione di un cattivo Cristiano, cioè di una persona che dimentica il suo fine ultimo, per occuparsi solo delle cose presenti.
1. Dico che la brevità della vita è di conforto a un buon Cristiano, poiché egli vede che le sue pene, le sue disgrazie, le sue persecuzioni, le sue tentazioni, la sua separazione da DIO, non saranno lunghe. Quale gioia per noi, fratelli miei, quando pensiamo che tra poco tempo lasceremo questo mondo, dove siamo sempre in pericolo di offendere il buon DIO, che è un Salvatore così caritatevole, che ha tanto sofferto per noi. Ahimè! fratelli miei, con questo pensiero, potremmo forse noi mai attaccarci alla vita che è piena di tante miserie? “Che buona nuova! Esclamò san Girolamo. Quando si venne per annunziargli che stava per morire, felice nuova, che sta per unirmi al mio DIO, per sempre!”. Ed in effetti, fratelli miei, così è, dato che la morte è lo strumento di cui il buon DIO si serve per liberarci.
2° Io dico che il giudizio, ben lungi dal gettare il Cristiano nella disperazione, non fa invece che consolarlo, perché egli sta per trovarsi davanti non un giudice severo, ma suo Padre e il suo Salvatore. Sì, suo Padre, che lo attende per aprirgli le viscere della sua misericordia, al fine di riceverlo nel suo seno paterno; che sta, io dico, per manifestare al mondo intero tutte le sue lacrime, le sue penitenze, e tutte le buone opere che egli ha fatto durante tutti i giorni della sua vita.
3° Il pensiero dell’eternità, poi, porta al colmo la sua gioia. Se la sua beatitudine è infinita nelle sue dolcezze e nelle sue grandezze, l’eternità gli assicura che essa non finirà mai. Questo solo pensiero, fratelli miei, deve incoraggiarci a ben servire il buon DIO e per sopportare con pazienza tutte le miserie della vita, perché, una volta che saremo in cielo, non ne usciremo mai più! Ahimè! fratelli miei, tutte le miserie di questo mondo passano, tutto questo non dura che un momento, mentre la ricompensa durerà per sempre. Coraggio! ci dice san Paolo, siamo ormai vicini alla meta della nostra strada. Ma per un Cristiano, fratelli miei, che ha perso di vista il pensiero dei suoi fini ultimi, non è la stessa cosa; la brevità della vita è una sciagura e un’amarezza che lo turba e lo rode anche nel bel mezzo dei suoi piaceri; egli fa tutto ciò che può per allontanare questo pensiero della morte. Tutto ciò che gliene offre un ricordo, lo atterrisce; rimedi e medicine, tutto è invocato in suo soccorso, al minimo sentore che la morte si approssimi. Egli crede sempre di poter trovare la felicità quaggiù. Ma, purtroppo, egli si inganna. Questo povero derelitto, abbandonando il buon DIO, abbandona proprio ciò che poteva procurargliela; al momento della morte, sarà costretto a confessare di aver trascorso tutta la vita nel cercare un bene che non è mai riuscito a trovare. Ahimè! fuori di Dio, solo molte pene, molte sofferenze, nessuna consolazione, e nessuna ricompensa! Prima di partire da questo mondo, avrà il suo bel gridare, come quel re di cui ci parla la Scrittura, nell’Antico Testamento, il quale, vedendosi sul punto di dover lasciare la vita e tutti i suoi beni, diceva: “Ah!, devo dunque morire! Devo lasciare le mie aiuole e i miei bei giardini, per andare in un paese dove non conosco nessuno!”. Ahimè! la morte che è la consolazione del giusto, diviene la sua disperazione; bisogna morire, e non ci si è mai pensato! Ah! triste pensiero, bisogna andare a rendere conto a DIO di una vita che non è che una catena di peccati, e… senza buone opere che possano rassicurarlo. Al momento di partire da questa vita, egli vede chiaramente che il buon DIO lo aveva posto sulla terra soltanto per servirlo e per salvare la sua povera anima, mentre non ha fatto altro che oltraggiarlo e perdere così la sua bella anima. Egli vede, capisce benissimo, in questo momento, che il buon Dio non voleva affatto che si perdesse, ma voleva assolutamente salvarlo, e che sono i suoi peccati che Lo costringono a condannarlo. Quanto poi all’eternità, egli vede che fra qualche minuto sarà gettato nell’inferno. DIO mio, che disperazione! Se il pensiero dell’eternità consola tanto un Cristiano, nella certezza che la sua felicità non avrà mai fine, questo medesimo pensiero, completa la disperazione di questo povero infelice. Ah! povero disperato, deve iniziare il suo inferno per non finirlo mai più! Entrando nell’inferno, vede l’infelice Caino che brucia fin dall’inizio del mondo ed egli che ci sta entrando adesso, non ha meno tempo di lui da trascorrervi. Allora, i demoni stessi che lo hanno spinto a peccare, per rendere il suo supplizio ancora più violento, gli metteranno davanti tutte le grazie che il buon Dio aveva meritato per lui, con la sua morte e con la sua santa Passione. Egli vede come preoccupandosi della sua salvezza, sarebbe stato più felice. Egli vede quanto Gesù Cristo sia buono, per coloro che vogliono amarlo. – Ma, malgrado tutte queste riflessioni, che per lui saranno come altrettanti inferni, bisognerà rassegnarsi a bere, per tutta l’eternità, a piena bocca, il fiele del furore di Colui che doveva essere tutta la sua felicità, se egli si fosse deciso ad amarlo. Ah! triste meditazione che questo Cristiano farà per tutta l’eternità, dicendo a se stesso: ho perso il mio tempo, ho rovinato la mia anima, ho perduto DIO, ho rifiutato il cielo, ed ora mi aspetta una eternità di sofferenze! Ah! Cielo! che disgrazia! Ecco, fratelli miei, cosa succede a chi perde di vista i suoi fini ultimi. Ma! forse voi direte, voi dite bene che ci sia un’eternità infelice per i peccatori; ma occorre che lo dimostriate. Sarebbe molto facile, fratelli miei; ma questo significherebbe fare un affronto a dei Cristiani. Sarebbe molto meglio per voi, se potessi convincervi della necessità che avete di fare tutto il possibile per evitare quei tormenti. Se volete, ve ne dirò qualche parola, di passaggio, visto che siete così ignoranti e così ciechi, da nutrire qualche dubbio sull’argomento. Ascoltatemi bene. – Ecco cosa ci dice lo Spirito Santo per bocca del profeta Daniele: ci sono due sorta di uomini, ci sono coloro che sono giusti, vi sono quelli che sono peccatori; gli uni muoiono nella grazia di Dio, gli altri in odio a Lui. Tutti compariranno un giorno davanti al buon Dio, tutti si risveglieranno dal sonno della morte; tutti saranno giudicati e riceveranno una sentenza senza appello, dopo la quale, gli uni non avranno più nulla da temere, gli altri più nulla da sperare. Ma la differenza che sarà trovata tra gli uni e gli altri sarà molto grande, poiché gli uni si sveglieranno per andare a godere una gioia eterna, gli altri, per essere coperti di obbrobri, inabissati in ogni genere di pena, e questo, per tutta l’eternità. Lo Spirito Santo ci indica dappertutto quale sarà la sorte dei peccatori nell’altra vita; Egli ci dice: « Il Signore spargerà il fuoco sulla loro carne, affinché ardano e siano eternamente divorati ». Il santo re Davide dice che « il peccatore che durante la vita ha disprezzato il suo Dio, sarà gettato nell’inferno ». Se desiderate procedere oltre, san Giovanni Battista, predicando ai Giudei il battesimo di penitenza, per prepararli alla venuta del Messia, insegna loro, ancora, quale sarà la sorte del peccatore nell’altro mondo, dicendo loro che Gesù Cristo verrà un giorno e separerà il buon grano dal grano cattivo e dalla paglia: il buon grano, che sono i giusti, il Padre eterno li porrà nel suo granaio, che è il cielo; il grano cattivo e la paglia, che sono i peccatori, saranno legati in fasci e saranno gettati nel fuoco, che è l’inferno; là vi sarà pianto e stridore di denti. Gesù Cristo ci dice nel Vangelo, che il ricco epulone muore e che l’inferno è il suo sepolcro, dove soffre infiniti mali. Lazzaro, invece, è trasportato dagli Angeli nel seno di Abramo, cioè nel cielo. In un altro passo, parlando del peccatore ci dice: « Va’, maledetto, nel fuoco che è stato preparato per il demonio e per coloro che lo hanno imitato ». Sant’Agostino ci dice parlando del peccatore: « Va’ maledetto, tu hai disprezzato il tuo DIO e le sue grazie durante la vita; va’ maledetto, tu sarai precipitato in uno stagno di fuoco e di zolfo per tutta l’eternità. » Ma, fratelli miei, ciò che sto dicendo è inutile. Non c’è bisogno che vada a trovare così grandi prove, per mostrarvi che c’è una vita felice o infelice, a seconda che avremo vissuto bene o male. E’ sufficiente solo che apriate il vostro Catechismo, e lì troverete tutto quello che dovete credere, sapere e fare. Infatti, fratelli miei, quale è stata la prima domanda che vi è stata fatta, quando siete venuti in Chiesa per farvi istruire? Non è stata forse questa: chi vi ha creato e conservato fino al presente? E voi non avete forse risposto, molto semplicemente, che è stato DIO? Poi vi è stato chiesto: perché DIO vi ha creato? E voi avete risposto: per conoscerlo, amarlo, servirlo, e con questo mezzo guadagnare la vita eterna. Ecco, dunque, quale deve essere tutta l’occupazione di un buon Cristiano, e tutta la sua felicità. Deve imparare a conoscere DIO, cioè, a conoscere quali siano i mezzi più sicuri che debba usare, per piacere al buon DIO, evitando il male, e facendo il bene. Sto dicendo, fratelli miei, che noi dobbiamo amare il buon DIO. Ahimè! fratelli miei, non inganniamoci; se non ameremo il buon Dio in questo mondo, non avremo mai e poi mai la felicità di amarlo nell’altro. Non vi è stato detto forse, quando siete venuti al catechismo, che se non salvate la vostra anima, per voi tutto è perduto? Che avrete un bel piangere per tutta l’eternità, che non ne caverete un bel nulla! Non vi è stato forse assicurato, facendovi distinguere il bene dal male, che un solo peccato mortale possa portarvi alla idannazione eterna? E non vi è stato detto che il peccato sia l’unico male che dovete temere, perché non c’è che esso che abbia il potere di separarci da Dio per tutta l’eternità, gettandoci nell’inferno? Non vi è stato forse detto, che tutti noi un giorno moriremo, e che ogni giorno potrebbe essere l’ultimo per ognuno di noi? Non vi è stato forse ricordato che nell’istante in cui moriremo, saremo giudicati rigorosamente, e che tutto ciò che abbiamo fatto durante la nostra vita, sia in bene che in male, ci accompagnerà davanti al tribunale di Dio? Non avevo, dunque, ragione nel dirvi che se conoscessimo tutto quello che è scritto nel nostro Catechismo, avremmo tutta la scienza necessaria per salvarci? Allorché siete venuti qui, nella vostra infanzia, non vi è stato forse detto che, dopo questo tempo che finirà ben presto, ne verrà un altro che non finirà mai più, e che racchiuderà ogni sorta di bene o di male, a seconda che ci avremo fatto bene o male? Ditemi, fratelli miei, se tutte queste verità fossero incise nei nostri cuori, potremmo vivere senza amare il buon Dio, e senza fare tutto ciò che dipende da noi, per evitare tutti questi malanni? – Ahimè! fratelli miei, queste verità hanno fatto tremare i Santi, hanno fatto convertire grandi peccatori, e hanno spinto i penitenti a usare grande rigore nelle loro penitenze e nelle loro macerazioni! – Leggiamo nella storia che sant’Ambrogio, scrivendo all’imperatore Teodosio che aveva commesso un certo peccato, più per essere stato colto di sorpresa che per malizia, gli diceva: « Ho visto – dice Sant’Ambrogio – in una visione nella quale il buon DIO mi ha mostrato che, se ti avessi visto venire in chiesa, mi ha comandato di chiudervi la porta, poiché il vostro peccato vi aveva reso indegno di entrarvi ». Dopo la lettura di questa lettera, l’imperatore cominciò a spandere lacrime in abbondanza; tuttavia, come era suo costume, andò a presentarsi alla porta della chiesa, nella speranza che il Vescovo si sarebbe lasciato commuovere dalle sue lacrime e dal suo pentimento. Ma il Vescovo, ben lontano dal lasciarsi piegare, come i suoi ministri vili e compiacenti, vedendolo avvicinarsi alla chiesa, gli intimò di fermarsi, secondo l’ordine ricevuto da DIO, poiché non era degno di entrare nella casa di Colui che aveva osato oltraggiare, e gli ordinò di cominciare a espiare il suo peccato ». L’imperatore rispose: « E’ vero – gli dice – che sono un peccatore e indegno di entrare nel tempio del Signore, ma il buon DIO vede il mio pentimento. Anche Davide ha peccato, ed il Signore gli ha perdonato ». – « Ebbene! – gli rispose sant’Ambrogio – se avete imitato Davide nel suo peccato, imitatelo nella sua penitenza ». L’imperatore, senza nulla replicare a queste parole, si ritira; le lacrime colano dai suoi occhi; il suo cuore si lacera per il dolore; si strappa i suoi abiti regali e ne indossa di poveri e laceri, si getta con la faccia a terra, abbandonandosi a tutta l’amarezza del dolore e facendo risuonare per il palazzo le grida più laceranti. I suoi sudditi, vedendolo in una così grande desolazione, non hanno il coraggio né di guardarlo, né di rivolgergli la minima parola per consolarlo; si contentano di mescolare le loro lacrime a quelle del loro padrone; il suo palazzo si trasforma in un luogo di dolore, di lacrime e di penitenza. Egli non si contenta di confessare il suo peccato nel tribunale della penitenza, ma lo confessò pubblicamente, affinché una tale umiliazione attirasse su di lui la misericordia di DIO. Era inconsolabile nel vedere che i suoi sudditi potessero entrare in chiesa, mentre egli ne era escluso. Se gli si permetteva di partecipare ad una preghiera pubblica, vi prendeva parte nella maniera più umiliante: non stava né in piedi, né in ginocchio, come gli altri, ma prostrato con la faccia a terra, inondandola di lacrime. Si strappava i capelli per mostrare la grandezza del suo dolore, raccoglieva delle pietre con le quali si martoriava il petto e gridava: Misericordia! Per tutta la vita conservò il ricordo del suo peccato: i suoi occhi versavano continuamente lacrime. Ma se voi mi domandate: quale è stata la causa di tante lacrime, di un così grande dolore e di una penitenza così straordinaria? Ahimè! fratelli miei, vi risponderei: che fu il solo pensiero che un giorno Dio lo avrebbe citato in giudizio per il suo peccato, davanti a quel tribunale dove sarebbe stato giudicato senza più misericordia. Ahimè! fratelli miei, se queste grandi verità fossero ben impresse nei nostri cuori, potremmo noi vivere senza lavorare continuamente per placare la giustizia di Dio, che i nostri peccati hanno tanto esasperato? In effetti, fratelli miei, chi è colui che, pensando che non si trovi in questo mondo se non per salvarsi l’anima, potrebbe ancora cercare di ingannare o fare torto al proprio prossimo? Chi è colui che ben convinto che tutti questi beni che accumula a discapito della salvezza della sua anima, fra poco tempo li lascerà a degli eredi che forse sono ingrati, che li dissiperanno in dissolutezze, senza, forse, fare la minima preghiera in suffragio della sua anima? Ma, quand’anche essi li usassero per compiere opere buone, queste non potranno strapparvi all’inferno, se voi avete lasciato la vostra anima nel peccato. Chi potrebbe ancora abbandonarsi ai divertimenti del mondo, che sono tanto fugaci e sì funesti per la nostra salvezza, perdendo di vista l’affare più grande della nostra salvezza? Chi è colui che, essendo ben persuaso che un solo peccato mortale possa dannarlo, avrebbe il coraggio di commetterlo? Oppure, chi, avendo avuto la disgrazia di averlo commesso, potrebbe restare ancora in uno stato sì deplorevole, in cui la mano di DIO può colpirlo da un momento all’altro, e non si affretterebbe invece a far ricorso al Sacramento della Penitenza, unico rimedio che il buon DIO ci offre, nella sua misericordia? – Chi è colui, fratelli miei, che pensando che potrebbe morire in qualunque momento, non vivrebbe ogni giorno, tremante, sull’orlo dell’abisso? Chi è colui che si attaccherebbe tanto fortemente alla vita, al pensiero che forse domani non esisterà più? Chi, fratelli miei, pur essendo certo che nell’istante in cui andrà a comparire davanti a DIO, sarà giudicato con ogni rigore, non temerebbe continuamente di dover subire un giudizio, così temibile perfino per i più giusti? Chi è colui fratelli miei che, essendo certo che dopo questa vita mortale ne avremo un’altra felice o infelice, a seconda che avremo vissuto bene o male, non metterebbe ogni cura nel meritare i beni che il buon DIO ha preparato per coloro che lo hanno amato? Ah! fratelli miei, diciamo ancora meglio, chi è colui che, meditando a fondo queste grandi verità, non vivrebbe e non morirebbe da santo? Anima mia – gridava un santo penitente – ricordati dei tuoi peccati e di queste grandi verità; non dimenticare mai da dove vieni, dove vai, da chi hai ricevuto l’essere, a chi devi donare il tuo cuore, che cosa hai portato in questo mondo e che cosa porterai via, uscendo dal tuo esilio. Ahimè! fratelli miei, noi, fino ad ora, non abbiamo mai considerato tutto questo fino al presente; ahimè! noi aspettiamo, per pensarci, il momento in cui le nostre lacrime e le nostre penitenze resteranno senza frutto. Come saremmo felici, fratelli miei, se queste grandi verità potessero dissipare le tenebre che ci accecano, riguardo al grande affare della nostra salvezza; se noi avessimo la fortuna di essere fortemente convinti che noi non siamo stati che un puro nulla e un miserabile verme di terra: che siamo solo peccatori e pieni di colpe, che un giorno saremo eternamente felici, se evitiamo il peccato, ed eternamente infelici, se seguiamo le nostre cattive inclinazioni! Ahimè! fratelli miei, forse non abbiamo a nostra disposizione che pochi istanti ancora, per prepararci al terribile passaggio. Rientriamo nei nostri cuori, fratelli miei, per non occuparci che delle grandi verità, le sole degne della nostra attenzione, le sole capaci di convertirci. Fratelli miei, lasciamo passare ciò che passa e perisce insieme a noi; attacchiamoci a ciò che è eterno e permanente. Diciamo a tutte le cose di quaggiù, come facevano tutti i Santi: No! No! Voi per me non contate più nulla, dal momento che, forse domani, o voi o io, non esisteremo più; lasciatemi profittare del poco tempo che mi resta, per fare in modo che il buon Dio si degni di perdonarmi. Ah! no, no, io non voglio vivere che per Dio, disprezzando i beni che periscono. Ah! questi Santi hanno ben compreso queste grandi verità! E potremmo dire che ne hanno fatto l’unica loro occupazione! Leggiamo nella storia della Chiesa che un gran numero di Santi, tutti penetrati dal nulla di questo mondo e dalla grandezza delle verità, lo hanno disprezzato e abbandonato, per andare a chiudersi nei monasteri o ritirarsi nel fondo delle foreste, per poter meditare queste verità con maggiore agio. E là, nelle grotte spaventose e oscure, lontani dai rumori e dai tumulti del mondo, non si occupavano d’altro se non di queste verità immutabili. Penetrati da questi grandi sentimenti, esercitavano sui loro corpi tutti i rigori della penitenza, che il loro amore per DIO gli ispirava. La preghiera, il digiuno e la disciplina, riducevano i loro corpi in uno stato degno della più grande compassione. Una gran parte di loro non mangiava che qualche radice che trovava smuovendo la terra. Se mangiavano qualche pezzetto di pane, lo ammollivano con le loro lacrime, vedendosi costretti a dare un po’ di sollievo a quel corpo che era più morto che vivente. Così trascorrevano la loro vita, che non era altro che un continuo martirio. E allorché, dopo venti, trenta, quaranta o ottant’anni di penitenza, arrivavano alla fine della loro corsa, ancora tutti spaventati, si dicevano, gridando, gli uni gli altri: Pensate, amici miei, che Dio avrà finalmente pietà delle nostre anime e che si lascerà piegare? Che vorrà ancora accordarci il perdono dei nostri peccati? Pensate che potremo ancora trovare grazia davanti a questo Giudice che allora sarà senza misericordia? Ah! chi pregherà per noi, per addolcire la severità del nostro Giudice? Ah! potremo ancora sperare di aver parte un giorno alla felicità dei figli di DIO? – Sì, fratelli miei, noi vediamo che i Santi penitenti, dopo aver avuto la fortuna di conoscere che cosa sia veramente il peccato, e come il buon Dio lo punisca severamente nell’altra vita, non mettevano limiti alla loro penitenza. – San Girolamo ci racconta che una dama romana, avendo abbandonato il marito, a causa dei vizi a cui era dedito, credette che, essendosi separata secondo la legge, poteva, senza peccare, rimaritarsi legittimamente con un altro uomo. San Girolamo ci dice che un giorno la rese consapevole del suo peccato; ella allora fu colta da un tale dolore, coperta da una tale confusione, che abbandonò all’istante gli abiti mondani e si vestì di un sacco; … i capelli scompigliati, il volto coperto di fango, le mani tutte sporche, la testa coperta di cenere e di polvere, i vestiti tutti strappati, la bocca serrata. In questo misero stato, si va a gettare ai piedi del santo Padre (san Girolamo). Il santo Padre e tutti coloro che furono testimoni di questo spettacolo, non riuscivano a resistere vedendo il triste stato in cui questa signora romana era caduta, a causa della sua ignoranza. Roma, continua questo Padre, faceva echeggiare le sue mura delle grida più laceranti, e sembrava voler condividere il dolore di questa grande penitente. Ella confessava pubblicamente il suo peccato, sempre versando un torrente di lacrime. Portò per tutta la vita i vestiti della penitenza; il suo dolore e il suo pentimento la seguirono fino alla tomba. Non contenta di tutto ciò, vendette tutti i suoi beni, che erano immensi, per vivere e morire nella più grande povertà. A questo punto vi sarete chiesti: … ma quale è stata la causa di tutto questo? Ahimè! Il solo pensiero che un giorno le sarebbe stato intimato di andare a presentarsi davanti al tribunale di Gesù Cristo. Ella chiedeva a Dio la grazia di prolungarle di qualche giorno la vita, affinché avesse il tempo di fare penitenza. Ahimè! Gridava ad ogni istante, bisogna che io vada a comparire davanti al buon Dio; che ne sarà di me, se il mio peccato non sarà cancellato dalle lacrime e dalla penitenza? O felice penitenza! O lacrime salutari! Venite in mio aiuto: soltanto voi voglio come compagne per tutti i giorni della mia vita. Ahimè! Fratelli miei, ci dice il grande Santo Giovanni Climaco, se il pensiero dell’eternità ha portato tanti Santi a fare penitenze così straordinarie, quale sarà la nostra sorte, noi che non facciamo nessuna penitenza? DIO mio! Quanto sarà terribile la vostra giustizia per questi poveri peccatori che non avranno nulla su cui appoggiarsi! « Ah! Amici miei, egli ci dice, ho visto dei penitenti in un luogo che non si può nemmeno immaginare, senza versare lacrime; in un luogo, dico, sprovvisto di ogni aiuto umano, di ogni consolazione umana. Non c’era che oscurità, puzza e sporcizia; tutto era così spaventoso, che non lo si poteva vedere senza piangere di compassione. Questi nobili e santi penitenti non avevano in questo luogo né fuoco né vino, solo qualche radice e qualche pezzo di pane duro e nero che essi inzuppavano con le loro lacrime. Quando arrivai – ci dice san Giovanni Climaco, in quel luogo di penitenza, che molto giustamente è nominato « soggiorno del pianto e delle lacrime », vidi veramente, oserei dire, ciò che colui il quale trascura la sua salvezza, non ha mai visto, e ciò che colui che è pigro nei suoi doveri, non ha mai ascoltato, e ciò che il cuore di colui che cammina lentamente nella via della virtù, non ha mai potuto comprendere; poiché vi assicuro che ho visto delle azioni ed ho ascoltato delle parole, capaci di esprimerlo. Alcuni passavano le notti intere in piedi nel rigore dell’inverno e, quando il loro povero corpo cadeva per la debolezza e il rilassamento: Ah! maledetto, dicevano a se stessi, poiché hai avuto l’ardire di oltraggiare il buon DIO, bisogna che tu soffra in questo mondo o nell’altro. Scegli la parte che vuoi prendere; le sofferenze di questo mondo non sono che di un momento, invece quelle dell’altra vita sono eterne. Ne vidi altri che con gli occhi sempre levati al cielo, rivolgevano le grida più laceranti chiedendo misericordia. Altri che si facevano legare le mani, finanche le dita, durante la loro preghiera, come criminali, ritenendosi indegni di fissare il cielo. Essi erano talmente penetrati dalla loro miseria e del loro niente che non sapevano da dove cominciare la loro preghiera. Essi si offrivano a DIO come vittime pronte ad essere immolate. Si vedevano altri, vestiti da un sacco, coperti di cenere, distesi sul pavimento e battersi la fronte contro le pietre; altri che piangevano con tante lacrime, da formarne dei ruscelli. Ne vidi alcuni talmente pieni di ulcere, che ne usciva un’infezione capace di far morire coloro che erano loro vicini. Essi avevano sì poca cura di sé, che i loro corpi sembravano un ammasso di ossa coperto da una pelle. Ovunque ci si volgeva, non si ascoltavano che grida e singhiozzi che laceravano le viscere facendo versare lacrime. Le loro grida più frequenti erano: Ah! guai a noi che abbiam peccato! Gli uni portavano il loro rigore tanto lontano che non bevevano acqua se non per impedirsi di morire; altri, quando mettevano qualche boccone di pane in bocca, lo rigettavano subito dicendo che essi erano indegni di mangiare il pane dei figli di DIO dopo averlo oltraggiato. Essi avevano sempre presente al loro spirito e davanti ai loro occhi l’immagine della morte; essi si dicevano l’un l’altro: ahimè! Amici miei, cosa diventeremo? Pensate che avanziamo un poco nella strada della penitenza? Oh! Siano profonde le nostre lacrime! I nostri debiti sono troppo grandi! Come faremo per ripagarli? Facciamo, si dicevano, come i niniviti. Ahimè! Chissà se il buon DIO non avrà ancora pietà di noi? Facciamo tutto ciò che potremo per sperare che il Signore voglia ancora lasciarsi commuovere; corriamo nella corsia della penitenza senza risparmiare questo corpo di peccato che non è che abisso di corruzione: uccidiamo questo corpo maledetto come esso ha voluto uccidere le nostre povere anime. Era questo il loro linguaggio ordinario, esso era sufficiente – ci dice San Giovanni Climaco, a condurli a piangere amaramente: essi avevano gli occhi abbattuti, infossati nella testa, non avevano più ciglia alle palpebre: le loro gote erano talmente infossate che sembrava che il fuoco le avesse rose, tanto era per loro ordinario il piangere con lacrime calde; il loro viso era così sfigurato e pallido che sembravano dei morti che avevano dimorato due giorni nella tomba; ve n’erano di taluni che si martoriavano talmente il petto a colpi di pietre, che alla maggior parte di essi si vedeva il sangue uscire dalla bocca; diversi chiedevano al loro superiore di mettere loro dei ferri al collo ed alle mani e ceppi ai piedi: una parte li tenevano fino alla tomba. Essi erano così umili, amavano talmente il buon DIO, avevano tanto dolore dei propri peccati, e si vedevano sul punto di comparire davanti al loro Giudice, che essi pregavano in grazia del loro superiore, di non seppellirli; ma di gettarli in qualche fiume o in qualche foresta per servire da pasto ai lupi e alle bestie selvagge. Ecco – ci dice San Giovanni – la maniera in cui vivevano queste anime sante ed innocenti. Quando fui di ritorno – continua il Santo medesimo – ed il superiore vide che ero così distrutto e che appena poteva riconoscermi e sembravo di non poter più vivere: ebbene! Padre mio – mi dice – avete visto i travagli ed i combattimenti del nostro genere di soldati? Io non potei rispondergli se non con lacrime e singhiozzi, tanto questo genere di vita mi aveva colpito in dei corpi umani. » Ahimè! Fratelli miei, dove siamo? Qual sarà la nostra sorte e la nostra eternità se DIO domandasse a noi altrettanto? Ah! No, no, fratelli miei, mai per noi il cielo se ci volesse tanto! Ah! almeno senza fare così grandi e spaventose penitenze e cominciassimo ad amare il buon DIO, potremmo ancora sperare la stessa felicità! Oh DIO mio, quanto siamo ciechi circa la nostra eterna felicità! Ahimè!, fratelli miei, questi grandi Santi che ammiriamo senza avere il coraggio di imitarli, ditemi, avevano forse un altro Vangelo da seguire? Avevano un’altra Religione da praticare? Avevano un altro DIO da servire? Un’altra eternità da temere o da sperare? No, senza dubbio, fratelli miei, ma essi avevano la fede che noi non abbiamo, che noi abbiamo quasi spenta per la moltitudine dei nostri peccati: è che essi pensano seriamente alla salvezza della loro povera anima, mentre noi lasciamo da parte questa povera anima che è sì povera e che tanto è costata a Gesù-Cristo, e che torna indifferente salvare o dannare. È che essi meditavano incessantemente queste grandi e terribili verità dell’altra vita, la perdita di un DIO, la grandezza del peccato, una eternità felice o infelice, l’incertezza della morte, gli abissi spaventosi dei giudizi di DIO e le sequele di un avvenire felice o infelice, secondo che avremo vissuto bene o male, mentre noi non ci pensiamo mai. Non essendo occupati che da cose di questo mondo, lasciamo la nostra anima ed il cielo da parte. In una parola, c’è che essi vivono da penitenti e da Santi, mentre noi viviamo da mondani, nel peccato e nei piaceri del mondo, e non di penitenza. O cecità dell’uomo, quanto grande tu sei! Chi potrà mai comprenderlo? Non essere in questo mondo che per amare il buon DIO e salvare la nostra anima, e non vivere per offenderlo e rendere la nostra anima infelice per l’eternità! In effetti, fratelli miei, qual è la nostra vita al presente? A cosa abbiamo pensato da quando siamo sulla terra? A chi abbiamo dato il nostro cuore? Cosa abbiamo fatto per Dio, nostro primo ed ultimo fine? Qual zelo, quale ardore abbiamo avuto per la gloria di Dio e la salvezza della nostra povera anima che è costata tante sofferenze a Gesù-Cristo? Quanti rimproveri, al contrario, non abbiamo da farci? Ahimè! Ben lungi dall’avere impiegato tutta la nostra vita a procurare la gloria di DIO ed assicurarci la felicità eterna, forse noi non vi abbiamo mai pensato un solo giorno, come un Cristiano dovrebbe fare tutta la vita. Ah! ingrati! È forse per questo che il buon DIO ci ha creati e messo sulla terra? Non è al contrario che per occuparci di Lui e consacrargli tutto i movimenti del nostro cuore? Noi non dovremmo vivere che per LUI, e forse non abbiamo ancora vissuto un solo giorno del quale potremmo dire di essere tutto per Lui e solo per Lui. Ahimè! Fratelli miei, ben presto ci toccherà render conto di tutte le nostre azioni. Cosa abbiamo da presentargli? Cosa avremo da rispondere a tutte le sue interrogazioni quando ci mostrerà da un lato tutte le grazie che ci ha accordato durante tutta la nostra vita, e dall’altra il poco profitto o piuttosto il disprezzo che ne abbiamo fatto? È possibile mai che, avendo tra le mani, delle grazie così preziose, siamo ancora sì tiepidi, sì lassi e languidi nel servizio a DIO? Ah! fratelli miei, se i pagani e gli idolatri avessero ricevuto tante grazie come noi, non sarebbero divenuti gran Santi? Quanti, fratelli miei, grandi peccatori, se fossero stati ricolmi di tanti benefici come noi, non avrebbero fatto penitenza, come i niniviti, coperti da cenere e cilicio? Ricordiamoci, fratelli miei, tutto ciò che il buon DIO ha fatto per noi da quando siamo al mondo. Quanti tra voi sono morti senza avere avuto il beneficio di ricevere il santo Battesimo? Quanti altri che, dopo un peccato mortale sono stati colpiti subito e sono caduti nell’inferno! Oh! Quanti pericoli anche corporali da cui DIO, nella sua misericordia, ci ha preservato, preferendoci a tanti altri che sono periti in una maniera straordinaria. Ma a quanti di noi, dopo avere avuto la disgrazia di peccare, il buon DIO non ci ha perseguiti con rimorsi di coscienza, di buoni pensieri? Quante istruzioni, quanti buoni esempi che sembravano rimproverarci la nostra indifferenza per la nostra salvezza! Ditemi, fratelli miei, dopo tanti tratti di misericordia del buon DIO, cosa avremo da rispondergli quando ci domanderà conto del profitto che ne abbiamo fatto? O pensiero triste, fratelli miei, per un peccatore che ha disprezzato tutto, e che non ha saputo profittare di nulla. Eh ben ingrato, ci dirà Gesù-Cristo, le virtù che vi ho comandato erano troppo difficili? Non potevate praticarle come tanti altri? In quale stato comparirete davanti a me! Non sapevate che sarebbe arrivato un giorno in cui Io avrei domandato a voi conto di tutto ciò che la mia misericordia ha fatto per voi? Ebbene, miserabili, rendetemi conto di tutto ciò che la mia misericordia ha fatto per voi! Ahimè! Fratelli miei, cosa andremo a rispondere, o piuttosto qual confusione per noi! Preveniamo, fratelli miei, questo momento orribile per il peccatore, profittando finalmente delle grazie che la bontà di DIO vuole ancora ben accordarci oggi. Io dico oggi, perché forse domani, in cui il buon DIO ci avrà abbandonato, non saremo più in questo mondo. Sapete, fratelli miei, il linguaggio che dobbiamo tenere in questo momento? Eccolo: Ah! diremo. Io sapevo molto bene che non ero sulla terra che per poco tempo, e tuttavia non ho vissuto che per il mondo. E perdendo la vita eterna, io sapevo che in qualche anno avrei finito la mia corsa, e che mille anni non sarebbero stati tanto lunghi per prepararmi a questo triste passaggio da questo mondo all’eternità in cui potevo entrare in ogni istante; e questo poco tempo io non l’ho impiegato che per gli affari del tempo, per i divertimenti e per del niente. Ecco questo tempo prezioso che DIO non mi aveva dato che per assicurarmi una eterna felicità che va a sparire ai miei occhi, e l’eternità che sta per cominciare per non finire mai. Sarà essa felice o infelice? Ahimè! Cosa ho fatto per meritarla felice? O tempo perduto! Eternità obliata! Qual disprezzo! Tu che getti anime nell’inferno! O cecità dell’uomo che potrà comprendere, quattro giorni da passare in questo mondo ed una eternità intera nell’altra: e questi quattro giorni hanno fatto tutta la mia occupazione, ed io ho fatto tutto ciò che ho potuto per cancellarvi dalla mia memoria. DIO mio, dov’è dunque la nostra fede? Dove la nostra ragione? Per vivere come viviamo. – Cosa dobbiamo concludere da tutto questo, fratelli miei? È che, malgrado noi abbiamo tanto disprezzato delle grazie, se vogliamo profittare di quelle che il buon DIO vuole accordarci nella sua misericordia, non soltanto potremo riscattare il tempo passato, ma procurarci una felicità infinita nell’altra vita. Se il buon DIO ci ha conservato la vita, malgrado tanti peccati, non è che perché voleva effondere su di noi la grandezza delle sue misericordie; più siamo peccatori, più Egli desidera la nostra salvezza, affinché possiamo essere come tanti strumenti per manifestare per tutta l’eternità la grandezza delle sue misericordie per i peccatori. Sì, fratelli miei, Egli ci attende con le braccia aperte; Egli ci apre la piaga del suo Cuore divino per nasconderci alla severità della giustizia di suo Padre; Egli ci presenta tutti i meriti della sua morte e passione al fin di pagare per i nostri peccati. Se il nostro ritorno è sincero, Egli si incarica di rispondere per noi al tribunale di suo Padre, quando saremo interrogati per rendere conto della nostra vita. Felice colui che obbedisce alla voce del suo DIO che lo chiama! Felice, fratelli miei, colui che non avrà mai perso di vista che la sua vita è breve, che può morire in ogni istante, e non ha mai perso il pensiero che dopo questa vita sarà giudicato, per una eternità di felicità e di dannazione, per il cielo o per l’inferno. O DIO mio! Se noi pensassimo incessantemente ai nostri fini ultimi, potremo vivere nel peccato, potremmo dimenticare questo tempo avvenire che, una volta cominciato, non finirà mai? Ditemi, fratelli miei, credete a questa eternità, voi che dopo forse dieci o venti anni siete nell’odio di DIO? Credete all’eternità, fratelli miei, voi che avete i beni di altri? Ah! no, no, se voi vi credeste, voi non potreste vivere come vivete. Ditemi, voi miserabile, che dopo tanti anni di peccati celati nelle vostre Confessioni, colpevole di tanti sacrilegi fatti con le Comunioni; ahimè! Se voi lo credeste appena un poco, non morireste di orrore di voi stesso, pensando ad ogni momento in cui siete esposto ad andare a rendere conto di tutte queste turpitudini davanti ad un Giudice che sarà senza misericordia. Sì, fratelli miei, se avessimo la felicità di ben meditare su ciò che ci attende dopo questo mondo che è così breve, sarebbe impossibile non lavorare per tutta la vita tremando nel timore di non riuscire a salvare la nostra povera anima. Felice, fratelli miei, colui che si terrà sempre pronto! Ciò che io vi auguro…
Credo …
Offertorium
Orémus
Ps CXXIX: 1-2
De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam: de profúndis clamávi ad te, Dómine.
[Dal profondo Ti invoco, o Signore: o Signore, esaudisci la mia preghiera: dal profondo Ti invoco, o Signore.]
Secreta
Propítius esto, Dómine, supplicatiónibus nostris: et, pópuli tui oblatiónibus precibúsque suscéptis, ómnium nostrum ad te corda convérte; ut, a terrenis cupiditátibus liberáti, ad cœléstia desidéria transeámus.
[Sii propizio, o Signore, alle nostre suppliche e, ricevute le offerte e le preghiere del tuo popolo, converti a Te i cuori di noi tutti, affinché, liberati dalle brame terrene, ci rivolgiamo ai desideri celesti.]
Communio
Marc XI: 24
Amen, dico vobis, quidquid orántes pétitis, crédite, quia accipiétis, et fiet vobis.
[In verità vi dico: tutto quello che domandate, credete di ottenerlo e vi sarà dato].
Postcommunio
Orémus.
Concéde nobis, quǽsumus, Dómine: ut per hæc sacraménta quæ súmpsimus, quidquid in nostra mente vitiósum est, ipsorum medicatiónis dono curétur.
[Concedici, Te ne preghiamo, o Signore: che quanto di vizioso è nell’ànima nostra sia curato dalla virtú medicinale di questi sacramenti che abbiamo assunto.]
PREGHIERE LEONINE (dopo la Messa)