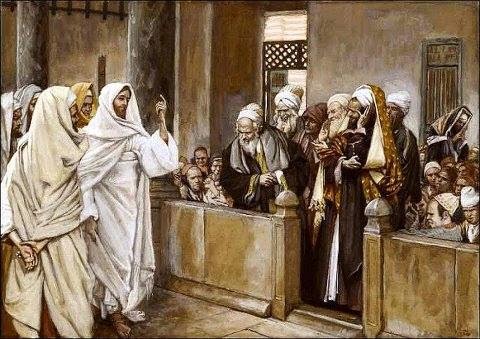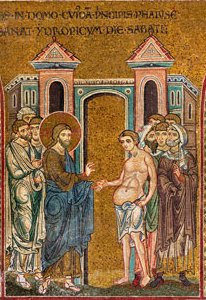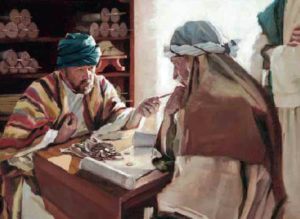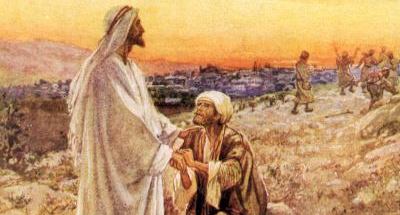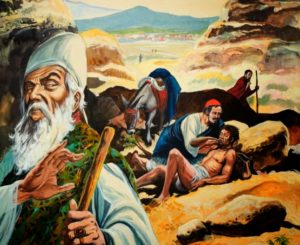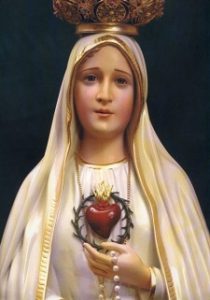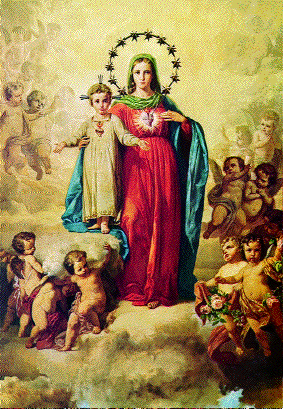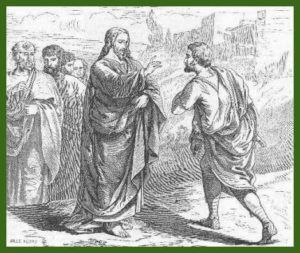
Incipit
In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
Introitus
Dan III:31; 31:29; 31:35
Omnia, quæ fecísti nobis, Dómine, in vero judício fecísti, quia peccávimus tibi et mandátis tuis non obœdívimus: sed da glóriam nómini tuo, et fac nobíscum secúndum multitúdinem misericórdiæ tuæ. [In tutto quello che ci hai fatto, o Signore, hai agito con vera giustizia, perché noi peccammo contro di Te e non obbedimmo ai tuoi comandamenti: ma Tu dà gloria al tuo nome e fai a noi secondo l’immensità della tua misericordia.]
Ps CXVIII:1
Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini. [Beati gli uomini di condotta íntegra: che procedono secondo la legge del Signore.]
Omnia, quæ fecísti nobis, Dómine, in vero judício fecísti, quia peccávimus tibi et mandátis tuis non oboedívimus: sed da glóriam nómini tuo, et fac nobíscum secúndum multitúdinem misericórdiæ tuæ. [In tutto quello che ci hai fatto, o Signore, hai agito con vera giustizia, perché noi peccammo contro di Te e non obbedimmo ai tuoi comandamenti: ma Tu dà gloria al tuo nome e fai a noi secondo l’immensità della tua misericordia.]
Oratio
Orémus.
Largíre, quǽsumus, Dómine, fidélibus tuis indulgéntiam placátus et pacem: ut páriter ab ómnibus mundéntur offénsis, et secúra tibi mente desérviant.
[Largisci placato, Te ne preghiamo, o Signore, il perdono e la pace ai tuoi fedeli: affinché siano mondati da tutti i peccati e Ti servano con tranquilla coscienza.]
Lectio
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Ephésios.
Ephes V:15-21
Fratres: Vidéte, quómodo caute ambulétis: non quasi insipiéntes, sed ut sapiéntes, rediméntes tempus, quóniam dies mali sunt. Proptérea nolíte fíeri imprudéntes, sed intellegéntes, quae sit volúntas Dei. Et nolíte inebriári vino, in quo est luxúria: sed implémini Spíritu Sancto, loquéntes vobismetípsis in psalmis et hymnis et cánticis spirituálibus, cantántes et psalléntes in córdibus vestris Dómino: grátias agéntes semper pro ómnibus, in nómine Dómini nostri Jesu Christi, Deo et Patri. Subjecti ínvicem in timóre Christi.
Omelia I
[Mons. Bonomelli: Nuovo saggio di Omelie; vol. IV – Omelia XV.– Torino 1899]
“Badate adunque, o fratelli, come procediate circospetti, non da stolti, ma come saggi, ricomperando il tempo, perché corrono giorni tristi. Il perché non siate imprudenti, ma studiatevi di conoscere qual sia la volontà del Signore. Non vi inebriate di vino, nel quale è dissolutezza, ma riempitevi di Spirito Santo, parlando a voi stessi con salmi ed inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nei vostri cuori al Signore; rendendo grazie del continuo, per ogni cosa al Dio e Padre, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo „ (Agli Efesini, V, 15-21).
La Chiesa in questa Domenica ci chiama nuovamente a meditare alcune sentenze della lettera di S. Paolo, scritta ai fedeli di Efeso. Io non so quante volte, lungo l’anno, ci si proponga a considerare qualche tratto di questa lettera, ma certo sono moltissime, benché la lettera sia tra le più brevi, e ciò a ragione. Nell’ultima parte di questa lettera l’Apostolo ha condensato tante e sì mirabili massime di morale evangelica, che nulla di meglio; è una miniera ricchissima di verità pratiche, che tornano acconce ad ogni stato e ad ogni classe di persone. Era dunque ben naturale che la Chiesa ci conducesse frequentemente in questa miniera, e ci invitasse a cavarne l’oro purissimo delle più sante verità. Io mi studierò di aprirvi questa miniera, di scavarvi l’oro delle verità che vi si nascondono, sceverarlo dalla terra e dalla scoria che lo copre, e voi studiatevi di riceverlo e custodirlo gelosamente. – Nei versetti precedenti, S. Paolo, sull’esempio di Cristo, ha caldamente esortato i fedeli a guardarsi da ogni cupidigia, a non lasciarsi sedurre, a separarsi, essi, figli della luce, dai figli delle tenebre e a rendere frutti a Cristo, ruggendo e riprendendo le male opere, ch’egli chiama opere di tenebre, e, continuando sempre il suo metodo, che è quello d’indicare il male da fuggire e poi suggerire il bene da praticare, per via di sentenze concise e chiarissime, dice: ” Badate, fratelli, come procediate circospetti. „ La nostra vita è un cammino, che comincia dalla culla e termina sull’orlo della tomba; è un cammino alcuna volta piano e netto, più spesso ripido, seminato di sterpi e di spine, infestato da ladroni e assassini, costeggiato da dirupi e precipizi; le insidie e i pericoli sono senza numero. Per correre questo cammino sì aspro e sì pieno di lacci, senza cadere, si richiede aver sempre l’occhio aperto, e badar bene dove mettiamo il piede, affine di non inciampare: “Videte quomodo caute ambuletis — Badate come procediate circospetti. „ Sicuramente i nemici interni ed esterni e la naturale nostra debolezza ci creano tante difficoltà e pericoli, che è assai difficile non cadere; ma che sarà poi se cammineremo senza cautela e quasi a caso? Se noi terremo sempre gli occhi sopra noi stessi, se veglieremo sui nostri pensieri e sui nostri affetti; se peseremo le nostre parole e porremo ben mente ad ogni nostro atto; se staremo in guardia quanto alle compagnie, alle amicizie, alle letture, insomma a tutto ciò che ne circonda, noi eviteremo moltissime colpe e acquisteremo la perfetta signoria sopra noi stessi, e opereremo non da stolti, ma sì da prudenti, come vuole l’Apostolo: Videte quomodo caute ambuletis, non quasi insipientes. – Allorché una cosa ci sta molto a cuore, noi la ripetiamo, e S. Paolo ripete qui la sua raccomandazione, cioè di camminare od operare circospetti, non da stolti, ma da saggi, sed ut sapiente», dove la parola saggi è il contrapposto di stolti, ed è la ripetizione di circospetti. Questa circospezione e saggezza, sì efficacemente inculcata dall’Apostolo, deve manifestarsi in particolar modo in una cosa, che tosto si accenna. Uditela: ” Redimentes tempus — Ricomperando il tempo. „ Il cielo è una mercede, che si dà soltanto a chi lavora: è la mietitura, che si fa soltanto da chi ha seminato. Ma dove si lavora? dove si semina? Qui sulla terra! Quando si lavora e quando si semina? In questa giornata della vita presente, nel tempo. Allorché cala la notte, e le tenebre coprono la faccia della terra, nessuno può lavorare, e allora comincia il riposo. Similmente allorché la morte stende sopra di noi il nero suo velo, si chiude lo stadio del tempo e comincia la eternità interminabile, non possiamo più lavorare, e cessa il periodo di vita, in cui possiamo meritare. Ora può accadere (e troppo frequentemente accade) che molti si trovino già presso alle porte della eternità, sul finire della vita, dopo avere malamente sciupato il loro tempo e con le mani quasi vuote di meriti. Costoro che devono fare se hanno senno? Ciò che fa il viaggiatore, il quale, avendo perduto gran parte del suo tempo in discorsi inutili e in sonno non necessario, studia il passo e procura di riguadagnare il tempo inutilmente speso. Gli Efesini, ai quali l’Apostolo scriveva, per la maggior parte dovevano essere stati Gentili, ed erano entrati nella Chiesa già molto innanzi negli anni. Il tempo per loro perduto nella idolatria e nelle brutture del paganesimo era molto: quello che rimaneva era breve. Qual cosa più naturale quanto l’esortarli ad affrettarsi, e con la frequenza e col fervore delle buone opere ricuperare il tempo perduto, e così in qualche modo mettersi a pari con quelli che avevano speso santamente tutta la loro vita? – Dilettissimi! Uno sguardo alla nostra vita. Ben è vero che noi abbiamo ricevuta la fede col santo Battesimo prima ancora che ne potessimo avere coscienza; ma (siamo sinceri) nella nostra vita qua e là non vi sono molti intervalli, e fors’anche lunghi, nei quali ci arrestammo sulla via e facemmo getto d’un tempo prezioso? Non è egli vero che vivemmo mesi e mesi (e a Dio non piaccia), anni e lustri in peccato? Quello, o cari, è tutto tempo miseramente perduto per il cielo, e Dio stesso nella sua onnipotenza non potrebbe fare che non sia perduto. Eppure possiamo ripararne la perdita, non già col far sì che ritorni il tempo perduto, ma col far uso migliore di quello che ci resta, simili all’operaio, che nelle due ultime ore del giorno può fornire il lavoro che altri fornisce appena in quattro. È questo il ricomperare il tempo, che S. Paolo predica agli Efesini. E perché avessero nuovo e più forte sprone a ricomprare ciò che per negligenza avevano perduto, l’Apostolo aggiunge una ragione speciale, dicendo: ” Perché ì tempi volgono tristi — Quoniam dies mali sunt. „ I tempi tutti sono cattivi, perché brevi per ciascun uomo, incerti, pieni di lotte, di pericoli, di tentazioni, di dolori, di mali d’ogni guisa; è vero, essi hanno anche la loro porzione di beni, che si alternano; ma la misura dei mali quasi sempre soverchia quella dei beni. I tempi poi, nei quali l’Apostolo scriveva la sua lettera, erano miserrimi sopra tutti: persecuzioni sanguinose, tirannie, delle quali non abbiamo nemmeno l’idea; basti sapere che imperava Nerone; corruzione spaventosa, schiavitù, ignoranza dei primi principi della morale, guerre atrocissime e continue. Aveva ben dunque ragione S. Paolo di esclamare: ” I tempi corrono tristi! „ Quale la conseguenza? L’ha detto sopra: quella di usare a bene di tempi sì cattivi. Come? Soffrendo con pazienza, con costanza e con rassegnazione tanti mali, e così volgendo in guadagno pel cielo le calamità della terra. — ” In questo, continua l’Apostolo, voi mostrerete il vostro senno — Propterea nolite fieri imprudente» — se farete di conoscere qual sia la volontà del Signore — Intelligentes quæ voluntas Dei. I mali che ci travagliano, così sembra ragionare il nostro Apostolo, sono grandi, e i tempi sono infelici; io vi dico di farne tesoro e con il soffrirli generosamente, riguadagnare quelli malamente perduti. Ma voi direte: Questi mali, che si aggravano sopra di noi, vengono dalla malizia degli uomini. No, risponde Paolo: se avrete la vera sapienza dei figli di Dio, comprenderete che è Dio quegli che così vuole. Come ciò? domanderete voi. Ve lo spiego. Tutto ciò che accade sulla terra è voluto da Dio o da Lui permesso: ciò che è bene è certamente voluto da Dio, che è la stessa bontà, e non è mestieri provarlo; ciò che non è bene, ma è male, e al male conduce, non è voluto da Dio, ma da Dio permesso e tollerato. E poiché è cosa manifesta che Dio potrebbe, nella sua onnipotenza, impedire il male, ne segue che se avviene, avviene perché lo permette, e lo permette perché anch’esso entra nei grandi disegni della sua sapienza e della sua misericordia. Lo permette per farci conoscere e sentire la nostra debolezza, per fiaccare il nostro orgoglio, per obbligarci a levare a Lui supplichevoli le nostre mani e invocare il suo aiuto, per staccarci dall’amore di questo mondo, per darci modo di esercitare la pazienza, la carità, la prudenza, la fortezza, per acquistare meriti, per renderci simili al Figliuol suo, fatto uomo, Gesù Cristo. Allorché dunque i mali della vita presente si addensano sopra di te, o fratel mio, e ti senti per poco schiacciato, non lagnarti, non far ingiuria a Dio e alla sua provvidenza, dicendo: Perché mi abbandonate, o Signore? Nei mali che ti opprimono, e in quelli che ne sono strumenti e ministri, vedi la mano paterna di Dio, che opera o che lascia fare, e sappi che tutto è volto a tuo bene. Non fermare l’occhio sulla mano del tristo che ti percuote, ma in Dio, che potendo arrestare questa mano, la lascia percuotere. L’infermo che geme e si dimena dolorosamente sotto il ferro del chirurgo, che recide il membro cancrenoso, non si sdegna col medico pietosamente crudele, ma lo ringrazia. Ecco ciò che voleva insegnare l’Apostolo allorché esclamava: “Sono giorni tristi, ma non vogliamo essere dissennati, anzi riconosciamo che anch’essi sono voluti da Dio, e volgiamoli a nostro vantaggio. „ – S. Paolo, continuando la sua esortazione morale, scrive: ” Non vi inebriate di vino, nel quale è dissolutezza — Nolite inebriavi vino, in quo est luxuria. „ Ubriachezza! Questa parola sì brutta e sì vergognosa per l’uomo ragionevole, e più brutta e più vergognosa assai per il Cristiano, come quella di lussuria, non si dovrebbe nemmeno pronunciare. Eppure più volte comparisce sotto la penna del grande Apostolo! “Non vi ubriacate. — Gli ubriachi non possederanno il regno dei cieli. — L’uno ha fame e l’altro è ubriaco. „ Sono sentenze dell’Apostolo, e provano come anche nei primi giorni della Chiesa, tra gli stessi discepoli degli Apostoli, il turpissimo vizio della ubriachezza non fosse ignoto. E ai nostri giorni, o carissimi? Che avviene sotto i nostri occhi? Qual vituperoso spettacolo vediamo noi quasi ogni giorno, e particolarmente nei giorni consacrati a Dio? Uomini, giovani, vecchi, e perfino talvolta donne, avvinazzati per le vie, barcollanti, schiamazzanti, presentare in se stessi il miserando spettacolo del più schifoso degradamento morale! Genitori ubriachi e i bambini senza pane, coperti di luridi cenci, piangenti per la fame e per il freddo! E sono uomini, e sono cristiani costoro? L’ubriachezza toglie all’uomo ciò che lo differenza dalla bestia: la ragione. Vedetelo, il miserabile, mal reggersi in piedi, barcollare e cadere! La lingua va articolando parole e accenti che nessuno intende; guarda e non vede; or ride stupidamente ed or minaccia; or prega ed ora insulta e bestemmia; attacca brighe con tutti, provoca risse e peggio, oggetto di compatimento e di orrore, di scherno e di disprezzo, disonore della famiglia, tormentatore di chi è costretto a vivere con lui, scialacquatore, distruggitore d’ogni cosa, finisce anzi tempo una vita di scandalo; eccovi l’ubriaco! – Ma l’Apostolo, in questo luogo, da conoscitore profondo della natura umana, col vizio detestabile dell’ubriachezza ne congiunge un altro come conseguenza naturale, ed è la dissolutezza: ” Non vi ubriacate di vino, nel quale è dissolutezza — In quo est luxuria. „ Dissolutezza e ubriachezza sono inseparabili; lo videro gli stessi pagani, e ne sono autorevolissimi testimoni Cicerone, Seneca ed altri. Ma noi non abbiamo bisogno dell’autorità di sapienti pagani; udite S. Girolamo: “Dove è intemperanza e ubriachezza, ivi signoreggia la libidine… Io non riputerò giammai casto l’ubriaco… Dica chiunque ciò che vuole, io parlo secondo la mia coscienza: io so che a me fece danno l’interrompere l’astinenza, e mi giovò il ripigliarla.” (Ep. Tit.) — L’ubriachezza è propria dei buffoni e dei mangiatori, ed un ventre pieno di vino ci lascia veder tosto la spuma della libidine. „ Bando adunque, o cari, all’intemperanza, bando all’ubriachezza che ci fa meno che uomini, che è il flagello della famiglia e della società: Nolite inebriari vino, in quo est luxuria. – Non è pago l’Apostolo di ciò che ha detto per tenere lontani i suoi cari dal vizio detestabile dell’ubriachezza: dopo il vizio da fuggire, suggerisce il bene da fare, come è suo costume: “Non inebriatevi di vino, ma siate ripieni di Spirito Santo — Sed implemini Spiritu Sancto. „ Cioè fate in modo che la grazia di Dio, che è il dono per eccellenza dello Spirito Santo, riempia le vostre menti e i vostri cuori e ridondi anche nei vostri corpi. Il vino riscalda i corpi, esalta gli spiriti, annebbia la ragione, porta l’uomo ai piaceri sensuali, lo fa simile ai bruti; la grazia divina riempie l’anima d’un fuoco puro e sacro, la eleva sopra se stessa, rischiara la sua mente, le fa gustare le caste delizie del cielo, la fa simile agli Angeli. Ecco il vino sacro, di cui potete inebriarvi: Implemini Spiritu Sancto. E quando sarete ripieni di questo vino sacro della grazia divina, le vostre anime gioiranno, i vostri cuori esulteranno, sarete inondati d’una santa letizia, e sentirete il bisogno di sfogarla tra voi stessi e nelle vostre radunanze, “cantando salmi ed inni e cantici spirituali, salmeggiando nei vostri cuori al Signore. „ – Allorché l’uomo è compreso da sublimi verità, da gagliardi sentimenti umani, e più ancora se divini, sente il bisogno irresistibile di sfogarli col canto e con la musica: il canto e la musica sono naturali all’uomo, come lo sono il pianto ed il riso (S. Girolamo distingue gli inni e i salmi e i cantici, e dice, che negli inni si celebrano la grandezza, la bontà e le perfezioni di Dio, e mette nel numero degli inni quei salmi, ai quali è premesso o aggiunto l’alleluja: i salmi, secondo lui, sono quelli che si riferiscono alla morale; i cantici poi celebrano le bellezze e le armonie dell’universo). Il canto è uno sfogo naturale degli affetti interni, e in pari tempo giova mirabilmente ad alimentarli ed a crescerli. S. Agostino narra, che allorquando, dopo la sua conversione, entrava in chiesa e udiva il popolo cantare a pieno coro i salmi, si sentiva tutto commuovere e versava copiose lacrime. E chi di noi non si sente fortemente commosso e intenerito allorché ode la gran voce del popolo, che canta le litanie della Vergine, il Miserere od il Pange lingua? S. Paolo esortava i suoi cari Efesini ad innalzare a Dio inni e salmi e cantici spirituali: e perché non faremo altrettanto noi pure? E qui un mesto pensiero, o carissimi, si affaccia alla mia mente. Alle nostre orecchie giungono, e spessissimo, i cantici degli operai nelle loro officine e lungo le vie, e dei contadini sparsi pei campi. Che canti son questi? Ah! certo non sono cantici spirituali, come li voleva S. Paolo: Canticis spiritualibus — ; non sono le lodi di Dio o della Vergine benedetta; sono cantici profani, forse liberi, fors’anche osceni che rivelano un cuore abbietto o corrotto, che accendono e dilatano una fiamma impura. Che le vostre labbra non si imbrattino mai di queste canzoni, che, come e forse più dei discorsi cattivi, corrompono i costumi: Corrumpunt bonos mores colloquia prava. Come starebbe bene che nelle nostre campagne ritornasse il costume, che S. Girolamo ricorda usato nella villetta, dov’egli viveva! “In questa villetta di Cristo, così il santo, tutto è semplicità, tutto è silenzio, fuorché il canto dei salmi. Dovunque ti volgi, il contadino che ara, tenendo l’aratro, canta alleluja (La parola Alleluia è composta di Allelu- e –ia, abbreviazione di Jehovah, e vuol dire Vìva Jehovah, viva Dio.); il mietitore che suda, si richiama coi salmi, e il vignaiuolo, che con la curva falce pota la vite, canta qualche strofa di Davide. Questi sono i canti nella campagna; queste, come suol dirsi, le canzoni d’amore, questo il fischio dei pastori, queste le armi dell’agricoltura (Epist. 17 ad Marcellam). „ Nè vi sfugga, o cari, quella espressione di S. Paolo riguardante il modo d’innalzare a Dio gli inni, i salmi ed i cantici: “Salmeggiando e cantando nei vostri cuori al Signore. „ Con queste parole egli ci ricorda che le nostre preghiere, le nostre lodi, i nostri ringraziamenti a Dio, non devono risuonare soltanto sulle nostre labbra, ma devono sgorgare dai nostri cuori, cosa che troppo facilmente per molti si dimentica. Gesù Cristo, ammaestrando la povera Samaritana, tra le altre cose, le disse: “I veri adoratori adoreranno in spirito e verità… Dio è spirito, e perciò conviene che quelli che l’adorano, l’adorino in spirito e verità, cioè spirito vero „ (S. Giov. IV, 23, 24). Come è l’anima tua, o cristiano, quella che fa vivere e muovere il tuo corpo, cosi dev’essere l’anima tua che fa cantare la lingua e lodare Iddio. Se la mente ed il cuore non accompagnano la tua lingua, che valore possono avere le tue preghiere e le tue lodi? Nessuno, perché manca ciò che le fa degne di Dio e di te, la mente e il cuore: sarebbero come le preghiere e le lodi di chi sogna o delira. Tu incontri un uomo che ti saluta ed inchina cortesemente, e ne va lieto. Se tu leggessi nel suo cuore e vedessi ch’egli ha ciò fatto senza saperlo, senza porvi mente, te ne terresti tu onorato? Non credo. Come vuoi tu dunque che torni accettevole a Dio la tua preghiera, la tua lode, se vede ch’essa si riduce ad un movimento di lingua, ad un suono materiale, e che il tuo cuore non vi ha parte alcuna? Il tuo canto non differisce da quello dell’augelletto che saluta il nuovo giorno. “Non è la voce, ti dice S. Agostino, quella che Iddio vuole, non è la corda della cetra, ma il tuo cuore. „ Allorché pertanto pregate e lodate Iddio, almeno a principio, con la voce levate a Lui il vostro cuore, secondoché vuole lo stesso Apostolo in altro luogo, scrivendo: ” Io salmeggerò con lo spirito, salmeggerò con la mente „ (I. Cor. XIV, vers. 15). “Rendendo grazie del continuo, per ogni cosa, a Dio e Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. „ La nostra vita, ad ogni istante è un continuo beneficio di Dio: ogni respiro, ogni battito del nostro cuore è suo dono; suo dono il cibo che ci nutre; suo dono la bevanda che ci disseta; suo dono il sole che ci illumina e ci riscalda; suo dono l’aria che respiriamo, tutto il nostro essere, tutto ciò che è in noi e fuori di noi, è suo dono, puro suo dono. È dunque dover nostro essere grati a tanto donatore, ringraziarlo di tanti benefici. Ma come farlo debitamente noi che siamo creature sì miserabili? Abbiamo Gesù Cristo; come Dio Egli è uguale al Padre e al Santo Spirito; come uomo è fratello nostro; Egli è il nostro capo, il nostro mediatore: il nostro ringraziamento presentato per le sue mani è degno di Dio: ringraziamolo adunque per suo mezzo: In nomine Domini nostri Jesu Christi. – La nostra Epistola si chiude con questa raccomandazione bellissima, che esprime a meraviglia l’indole della legge evangelica: “Siate soggetti tra voi nel timore di Cristo. „ Ogni società, sia grande, sia piccola, intanto può conservarsi e prosperare, in quanto è bene ordinata, ed è bene ordinata in quanto ogni membro rimane al suo posto, e rimane al suo posto osservando l’ubbidienza. Togliete l’ubbidienza ed ogni cosa è turbata: le famiglie si dividono, la società va in rovina. Ed è questa ubbidienza che S. Paolo raccomanda, dicendo: “Siate soggetti tra voi — Subditi invicem. „ L’ubbidienza, perché sia secondo verità e giustizia, deve prestarsi dagli inferiori ai superiori, e così senza dubbio ha da intendersi la sentenza apostolica. Ma perché dire: “Siate soggetti tra voi, ad invicem, „ come se il dovere dell’ubbidienza fosse imposto a vicenda, cioè in guisa che ciascuno debba ubbidire a ciascun altro, senza badare a chi tiene l’autorità? Certamente il comando dell’Apostolo: “Siate soggetti, „ importa che si debba ubbidire dagli inferiori ai superiori, ed è questa la vera ubbidienza; ma io penso che l’Apostolo volesse insinuare in bel modo ciò che forma una cotale appendice dell’ubbidienza, e ch’egli in altro luogo espresse felicemente in questa frase: “Reputandovi gli uni agli altri superiori nella umiltà. „ Ai superiori noi dobbiamo l’ubbidienza; agli eguali ed agli inferiori dobbiamo rispetto, piacevolezza, cortesia e condiscendenza, che sono alcunché di simile alla ubbidienza. E perché dobbiamo ubbidire ad altri, che infine sono uomini come noi, e, può essere, anche inferiori a noi? Perché così vuole Iddio, perché così comanda Gesù Cristo, e ubbidendo a quelli che tengono il suo luogo, ubbidiamo a Lui stesso: a disubbidendo loro, a Lui disubbidiamo. E come non temere di rifiutare l’ubbidienza a Gesù Cristo? Ecco perché S. Paolo, dopo aver detto: “Siate soggetti, „ soggiunge: “nel timore di Cristo. „ Così si eleva l’autorità che comanda, e con l’autorità si eleva e si nobilita l’ubbidienza, e tutto si riporta a Gesù Cristo, a Dio, al quale sia onore e gloria per tutti i secoli.
Graduale
Ps CXLIV:15-16
Oculi ómnium in te sperant, Dómine: et tu das illis escam in témpore opportúno.
Aperis tu manum tuam: et imples omne ánimal benedictióne. [Tutti rivolgono gli sguardi a Te, o Signore: dà loro il cibo al momento opportuno. V. Apri la tua mano e colmi di ogni benedizione ogni vivente.]
Allelúja.
Ps CVII:2
Allelúja, allelúja
Parátum cor meum, Deus, parátum cor meum: cantábo, et psallam tibi, glória mea. Allelúja. [Il mio cuore è pronto, o Dio, il mio cuore è pronto: canterò e inneggerò a Te, che sei la mia gloria. Allelúia.]
Evangelium
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Joánnem.
R. Gloria tibi, Domine!
Joannes IV:46-53
In illo témpore: Erat quidam régulus, cujus fílius infirmabátur Caphárnaum. Hic cum audísset, quia Jesus adveníret a Judaea in Galilæam, ábiit ad eum, et rogábat eum, ut descénderet et sanáret fílium ejus: incipiébat enim mori. Dixit ergo Jesus ad eum: Nisi signa et prodígia vidéritis, non créditis. Dicit ad eum régulus: Dómine, descénde, priúsquam moriátur fílius meus. Dicit ei Jesus: Vade, fílius tuus vivit. Crédidit homo sermóni, quem dixit ei Jesus, et ibat. Jam autem eo descendénte, servi occurrérunt ei et nuntiavérunt, dicéntes, quia fílius ejus víveret. Interrogábat ergo horam ab eis, in qua mélius habúerit. Et dixérunt ei: Quia heri hora séptima relíquit eum febris. Cognóvit ergo pater, quia illa hora erat, in qua dixit ei Jesus: Fílius tuus vivit: et crédidit ipse et domus ejus tota.
[In quel tempo: Vi era a Cafàrnao un certo regolo, il cui figlio era malato. Avendo udito che Gesú dalla Giudea veniva in Galilea, andò da lui e lo pregò perché andasse a sanare suo figlio, che stava per morire. Gesú gli disse: Se non vedete miracoli e prodigi non credete. Gli rispose il regolo: Vieni, Signore, prima che mio figlio muoia. Gesú gli disse: Va, tuo figlio vive. Quell’uomo prestò fede alle parole di Gesú e partí. E mentre era già per strada, gli corsero incontro i servi e gli annunziarono che suo figlio viveva. Allora domandò loro in che ora avesse incominciato a star meglio, e quelli risposero: Ieri, all’ora settima, lo lasciò la febbre. Il padre allora riconobbe che quella era l’ora stessa in cui Gesú gli aveva detto: Tuo figlio vive. E credette lui e tutta la sua casa.]
Omelia II
[Del canonico G. B. Musso – Seconda edizione napoletana, Vol. III -1851-]
(Vangelo sec. S. Giovanni IV, 46-53)
Mal esempio dei Genitori.
Quant’è mai grande la forza del buon esempio! Un padre, come ci narra l’odierna evangelica storia, col suo credere a Gesù Cristo, trae con l’ardore del suo esempio alla fede di Gesù Cristo medesimo tutta la sua famiglia. Era questo un piccolo Re, il cui figlio giaceva gravemente infermo a Cafarnao. Vedendo inutili tutti gli umani rimedi, ebbe ricorso al Consolator degli afflitti, partì da Cafarnao, e Lo raggiunse in Cana sui confini della Galilea, e prostèso a Lui dinanzi “Signore, disse, tengo un figliuolo in pericolosa infermità, compiacetevi venirlo a risanare, e a consolare il più addolorato di tutti i padri”.- “Se non vedete miracoli, Gesù rispose, voi non credete”. – “Ah Signore, soggiunse il padre, venite per pietà che ogni momento d’indugio può esser fatale al figlio moribondo”. – “Andate, disse allora il Salvatore, che il figlio vostro è vivo e sano e salvo”. Credette alle sue parole il genitor consolato, e nel tornarsene a casa ecco alla metà del cammino i suoi servitori spediti ad apportargli la lieta notizia, che il figlio aveva ricuperata in un istante la sanità. Interrogati dell’ora in cui la febbre l’aveva lasciato, e in udir che ieri all’ora settima cessata la febbre era uscito di pericolo, comprese essere precisamente quell’ora stessa, in cui il divin Redentore detto gli aveva che il suo figliuolo era vivo e risanato. In vista di questo prodigio abbracciò la fede di Gesù Cristo, e trasse col suo esempio alla stessa fede tutti di sua famiglia, numerosa di alti e bassi ufficiali, d’ordini diversi di servitori, essendo egli un piccolo Re da Erode Tetrarca costituito Principe e Governatore di tutta la Galilea. “Credidit ipse, et domus eius tota”. – Tant’è la forza del buon esempio! Ma ancor più grande è la forza dell’esempio cattivo. “Un poco d’assenzio, dice S. Gregorio Nisseno, basta a rendere amara una notabile quantità di miele, ma una notabile quantità di miele non può far dolce l’assenzio”. E più facile distruggere che edificare. Quanta rovina adunque recherà ai propri figli l’esempio malvagio dei genitori! Per impedirlo io prendo a dimostrarvi le perdite inconsolabili, che fanno i genitori col mal esempio. Pérdono l’autorità sopra dei figli, perdono i figli e perdono sé stessi. Tre perdite che abbracciano il temporale e l’eterno interesse, tre punti che meritano la vostra più seria applicazione.
I. L’autorità è in tutto il suo vigore, quando ne hanno il dovuto concetto i subalterni; ma ohimè quando decade, se nei soggetti autorevoli trovano gli inferiori di che adontarsi, e scoprono che riprendere! Veniamo al pratico. Entro col mio pensiero in una casa di questo mondo, e v’entro nell’ora in cui marito e moglie sono tra loro in aspra contesa. Vomita il primo le più infami e contumeliose parole, aguzza l’altra la lingua come un serpente; crescono le ingiurie, crescono gli insulti a vicenda. La tempesta non finisce in tuoni. Alle imprecazioni, alle bestemmie succedono colpi, percosse, duri e villani maltrattamenti. Oh Dio! e tutto ciò in presenza dei figli che piangono, che alzano stridi e clamori. Che casa è questa, ove abita il demonio della più arrabbiata discordia? Che scuola è questa in cui dai figliuoli s’apprende l’immodesto parlare, lo scostumata procedere, l’ira, la contumelia, lo spirito d’odio e di vendetta? E qual concetto può avere la povera famiglia di un padre bestiale, d’una madre viperina? Perduta la stima si perde necessariamente l’autorità tanto necessaria per la buona educazione. Lo scandalo che date, o incauti genitori, vi chiude la bocca: non potete più correggere la vostra prole di quei misfatti, dei quali voi siete più rei. – Allorché Caino stese a terra impiagato e morto Abele suo innocente fratello, Iddio acremente rimproverandolo, “il sangue del tuo germano, gli disse, dalla terra, su cui è sparso, alza voci e clamori che giungono al cielo”. – “Sanguis fratris tui clamat ad me de terra” (Ge. IV, 19). Così abbiamo dal sacro testo; ma il sacro testo non dice che Adamo aprisse bocca a correggere il crudel fratricida. E perché? Risponde Teodoreto, che Adamo, come uomo intelligente, ben prevedeva le amare risposte del figlio uccisore, se l’avesse rimproverato; e perciò il suo delitto, il mal esempio, l’obbligò a rigoroso silenzio. “Come! detto gli avrebbe probabilmente Caino, voi mi riprendete per l’uccisione d’un uomo, mentre voi avete uccisa tutta l’umana generazione! Mi rimproverate per la morte di mio fratello, voi che avete dati a morte più dannevole tutti i vostri figli che sono e che saranno sino alla fine del mondo? Io poi ho peccato per un movimento d’insidia, per un trasporto di collera, e voi solo per il gusto meschino di un vilissimo pomo”. Tutti questi acerbi rimbrotti si aspettava Adamo, perciò si tacque, vedendosi spogliato d’autorità per correggere. – Così avviene tutto dì. Quel padre ha un figliuol giocatore che nel giuoco perde il tempo, lo studio, il danaro, il buon nome. Vede la necessità di correggerlo, ma come può, s’egli giorno e notte ha le carte e i dadi alla mano? Con qual animo, dice S. Gregorio Magno, pretenderà medicar l’altrui piaga colui che porta in faccia la stessa medesima piaga? “Qua præsumptione mederi properat, qui in facie vulnus portat?” (Pur. 2 Past. C. 9). Quella madre sa ed osserva che la propria figlia è libera, nemica del ritiro, che tratta, che parla, che ride, che si trattiene con tutti; ma come impedire questi pericolosi disordini se essa tiene un’eguale condotta? Quell’altro padre vorrebbe i suoi figli dediti alla pietà, frequenti alla Chiesa, alla parola di Dio, ai santi Sacramenti; ma come avvisarli o punirli per la loro indevozione, se egli mai non si lascia vedere in Chiesa o in casa a piegar le ginocchia in qualche pubblica o privata preghiera? Ma diamo che dai genitori si correggono i viziosi figliuoli: che autorità e forza potrà avere la riprensione, se quel che si pronunzia con la parola si distrugge con l’opera?
II. Se non che il perdere col mal esempio l’autorità di correggere è il meno: quello che monta incomparabilmente di più, è la lacrimevole perdizione degli scandalizzati figliuoli. La prima scuola, solete voi dire, è quella dì casa. Gli esempi domestici fanno più d’impressione che gli stranieri. La tenera età è più disposta a copiare l’immagine del vizio che della virtù. La gioventù non ha bisogno di sprone per gettarsi alla strada della dissolutezza, e la corrotta natura pendente al male trova nei mali costumi dei genitori come una specie di guarentigia a impunemente seguirli. Di Abia, figlio di Roboamo, dice la divina Scrittura che camminò in tutti i peccati di suo padre, “ambulavit in omnibus peccatis patris sui” (III Re, XIII, 3). Notate la frase: le scelleratezze del proprio padre furono per lui come tante pedate impresse sulla polvere o sull’arena, sulle quali camminò come l’empio suo genitore, “ambulavit in omnibus peccatis patris sui”. – Se poi al mal esempio tacito s’aggiungesse l’espresso, poveri figli! Così non fosse, come odono sovente di bocca del padre o della madre certe massime affatto opposte a quelle del santo Vangelo. “Non ti far pecora, o figlio, ma come cane mostra e adopera i denti contro chi t’offende”, ché tanti riguardi! è un codardo che non sa vendicarsi e farsi portar rispetto”. – “Bisogna farsi ricchi per essere rispettati e temuti. Chi ha danaro ha tutto, e può far di tutto”. – “La coscienza è per chi la teme, e chi la teme sarà sempre povero”. Oh Dio! oh Dio! che diabolica scuola! Non vi credo capaci, uditori miei cari, di questo linguaggio pestifero, scandaloso, anticristiano, contentatevi invece ch’io vi metta sott’occhi un altro scandalo indiretto, a cui non si bada gran fatto. – Per meglio spiegarmi premetto quel che di Gerosolima diceva piangendo il Profeta Geremia. Paragona egli quell’infelice città ad uno struzzo nel deserto, “Filia populi mei crudelis quasi struthio in deserto” (Theren. IV, 3)). Osserva Plinio, e con esso altri indagatori della natura (checché ne dica qualche viaggiatore) che lo struzzo nei deserti dell’Africa e dell’America lascia cader le sue uova in sull’arena, e le abbandona. La provvidenza si cura delle medesime, e di giorno col calore del sole, e di notte col calor mantenuto nella sottoposta arena fa che le uova si schiudano e fuori saltellino i piccoli struzzoli che sull’arena stessa trovano l’opportuno alimento. La divina provvidenza non vuol fare altrettanto a riguardo dei figli vostri: a voi, alla vostra cura li ha commessi, or che sarà se voi li abbandonate? E appunto da questo abbandono nascono quegli scandali indiretti non conosciuti, e perciò più pericolosi e dannevoli. Torme di fanciulli si vedono a trastullar tutto il dì in mezzo alle piazze e alle contrade, abbandonati a sé stessi, come tanti struzzoli, e vanno intanto imparando sconce parole e maliose azioni, e il padre trascurato e la madre indifferente non badano che a levarsi il fastidio d’averli intorno. Fatti più adulti si lasciano in maggior libertà, vanno, vengono di giorno, di notte, praticano compagni malvagi, contraggono amicizie sospette: l’ozio che insegna ogni malizia, il giuoco che dissipa lo spirito, il libero conversare che corrompe il costume, formano la giornaliera occupazione. Tanti disordini, gli scandali che danno, gli scandali che ricevono, vanno tutti a carico dei genitori, che per una insensata trascuratezza hanno ad essi lasciata la briglia sul collo. Che dirò delle figlie anch’esse abbandonate come struzzoli nel deserto? Col pretesto di divozione si lasciano andare liberamente a certe novene, che cominciano avanti l’aurora, a certe feste di chiese rurali, a campagne, a passeggi, a festini …. Adagio, è vero, ma sono accompagnate da quel nostro parente uomo onesto, da quel nostro parente uomo dabbene. Peggio, io vi rispondo, e vel ripeto, peggio! Se quel tal uomo avesse nome, fama ed apparènza di libertino, non gli affidereste la vostra figlia, e non fidandovi, voi e la figlia vostra non correreste alcun rischio. Per lo contrario, col fidarvi non siete sicuri, potete esser traditi. Si fidò Giacobbe, e concesse a Dina sua figlia un’innocente curiosità, e Dina fu rapita, fu disonorata, ed egli ferito dal più acèrbo dolore. Il mal esempio dato, il mal esempio non impedito rovina i figliuoli, ed è finalmente causa lacrimevole dell’eterna perdita dei genitori.
III. Il Faraone, per politica di stato fece gettare nell’acque del Nilo tutti appena nati i maschi degli Ebrei. Erode per gelosia di regno, fece trucidare in Betlemme e nei suoi contorni tutti i bambini dai tre anni in giù per assicurarsi nella strage di tutti la morte di uno solo, il nato Re d’Israele. Or questi uccisi bambini furono veduti da S. Giovanni nel divino suo Apocalisse, sotto l’altare di Dio, e uditi alzar al cielo voci e clamori, gridando vendetta: “Usquequo Domine, … non vindicas sanguinem nostrum?” (cap. VI, 10). Fino a quando, o Signore, tarderete a vendicare il sangue innocente?- Ora io dico così: tanto i primi fanciulli sommersi nel Nilo, quanti i secondi trucidati da Erode son salvi: i primi come circoncisi e figli d’Abramo: i secondi non solo sono salvi, ma santi e martiri dalla Chiesa venerati sugli altari; e pure domandano a Dio vendetta. Or che sarà se i figliuoli scandalizzati dai genitori piomberanno all’inferno? Se invece di essere affogati in un fiume, saranno immersi in uno stagno di fuoco inestinguibile? Se invece di aver sofferto il taglio momentaneo della spada di Erode, si troveranno per sempre sotto la spada inesorabile della divina Giustizia? Vendetta, grideranno allora a più alta voce, vendetta contro i nostri padri, contro le nostre madri, che dopo averci data la vita temporale ci hanno tolta con gli esempi malvagi la vita spirituale ed eterna: vendetta contro coloro che non ci hanno dato la vita … se non per darci una doppia morte. – Padri e madri, volete dire che la giustizia di Dio sarà sorda a queste lamentevoli voci? E se le ascolta, come fuor di dubbio le ascolterà, che sarà di voi, che sarà dell’anime vostre? Voi siete perduti. Se foste causa della perdita dell’anima d’uno a voi straniero, dovreste temere la perdita della vostra; quanto più dovrà crescere il vostro timore e se per vostra disavventura foste cagione della perdita dei figli vostri? Miei dilettissimi, se la coscienza vi rimprovera il mal esempio dato, e le omissioni apportatrici di scandalo alla vostra prole, altro rimedio non trovo per liberarvi da tanto pericolo, che pentimento sincero riguardo al passato, e riparo nell’avvenire ai dati scandali col buon esempio.
Credo …
Offertorium
Orémus
Ps CXXXVI:1
Super flúmina Babylónis illic sédimus et flévimus: dum recordarémur tui, Sion. [Sulle rive dei fiumi di Babilonia ci siamo seduti e abbiamo pianto: ricordandoci di te, o Sion.]
Secreta
Cœléstem nobis præbeant hæc mystéria, quǽsumus, Dómine, medicínam: et vítia nostri cordis expúrgent. [O Signore, Te ne preghiamo, fa che questi misteri ci siano come rimedio celeste e purífichino il nostro cuore dai suoi vizii.]
Communio
Ps CXVIII:49-50
Meménto verbi tui servo tuo, Dómine, in quo mihi spem dedísti: hæc me consoláta est in humilitáte mea. [Ricordati della tua parola detta al servo tuo, o Signore, nella quale mi hai dato speranza: essa è stata il mio conforto nella umiliazione.]
Postcommunio
Orémus.
Ut sacris, Dómine, reddámur digni munéribus: fac nos, quǽsumus, tuis semper oboedíre mandátis. [O Signore, onde siamo degni dei sacri doni, fa’, Te ne preghiamo, che obbediamo sempre ai tuoi precetti.]