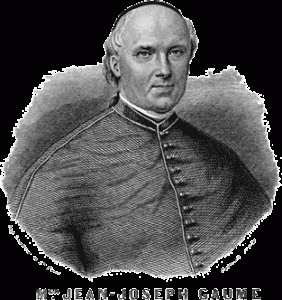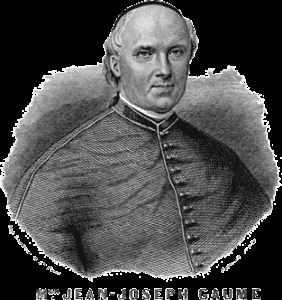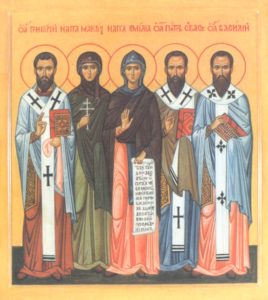[da: Attualità di Fatima; Città della Pieve, 1953, impr.]
Un profondo pensatore spagnolo, alludendo all’alto e ricco contenuto teologico del grande Messaggio di Fatima, argutamente scriveva : « La Vergine conosce molto bene la teologia del suo Rosario e del suo Cuore » (Llamera M., O. P., Fatima, Il Rosario e il Cuore di Maria, trad. dallo spagnolo del P. A. Andaloro, O. P., Catania 1949, p. 9) . M a è sommamente opportuno, per non dire necessario, che una tale teologia venga conosciuta anche dai figli di questa Madre celeste, poiché è soltanto alla luce della Teologia che si può scorgere, in tutta la sua ricchezza, il grandioso messaggio di Fatima, e, in modo tutto particolare, quella che si potrebbe chiamare l’anima di un tale messaggio: il suo preciso scopo e i mezzi per ottenerlo.
I – SCOPO DEL MESSAGGIO DI FATIMA
Il Messaggio di Fatima — come si rileva dalla storia delle apparizioni — è la più stupenda rivelazione del Cuore Immacolato di Maria, un Cuore tutto avvolto dalle fiamme d’amore della sua duplice maternità: naturale, verso Dio, spirituale, verso gli uomini. Abbiamo qui la Madonna nell’esercizio — reso visibile, direi quasi, palpabile — della sua Maternità universale, quella Maternità cioè che abbraccia tutti, Creatore e creature, e che costituisce il primo, il supremo principio di tutta la scienza Mariana, la ragione stessa di essere di così eccelsa creatura. Ha insistito infatti la Vergine, in tutte e sei le apparizioni, sopra un fatto dolorosissimo che interessa sia Dio, Figlio suo naturale, sia gli uomini, figli suoi spirituali: « le povere anime peccatrici ». La vita della grazia, questo ineffabile dono della munificenza divina, che unisce, nel modo più ineffabile, Dio agli uomini e gli uomini a Dio, tramite Maria Mediatrice di grazia, viene inesorabilmente soppressa dal peccato. Teologicamente considerato, il peccato è il più grande fra i mali, anzi, l’unico vero male, sorgente di tutti gli altri mali. Il peccato, infatti, mentre oltraggia Dio, di cui si trasgredisce la legge, danneggia indicibilmente l’uomo, poiché provoca la inesorabile giustizia divina con castighi sia temporali (la guerra) sia eterni (l’inferno). Per questo la Madonna di Fatima, dalla prima apparizione fino all’ultima, giustamente preoccupata sia dello oltraggio arrecato dal peccato al Figlio suo naturale — Dio —, e sia dei castighi che ne derivano ai figli suoi spirituali — agli uomini —, chiede, con materna insistenza, riparazione, ossia, « sacrifici » « in riparazione di tanti peccati », specie per i peccati impuri e per le offese arrecate all’Eucarestia e all’Immacolato suo Cuore. Di qui l’accorato grido del suo Cuore materno: « Non offendano più il Signore, che è già troppo offeso! ». L’intima essenza teologica del Messaggio di Fatima è perciò manifesta: la salvezza dell’umanità, compromessa seriamente dal peccato, sommo male sia di Dio, sia dell’uomo, entrambi figli suoi, e perciò entrambi sommamente cari al suo Cuore Immacolato. Per questo la Vergine SS.ma ha voluto rivelare, in modo così meraviglioso, il suo Cuore. – Ma il Cuore materno della Vergine non si è limitato, in questo messaggio di salvezza, a rivelarne lo scopo: si è anche degnato di indicare agli uomini, con sollecitudine squisitamente materna, i mezzi più efficaci per raggiungere la salvezza, ossia, per evitare i castighi sia temporali (la guerra con tutte le sue orribili conseguenze) sia, specialmente, eterni (l’inferno, che Ella si degnò mostrare ai tre fanciulli terrorizzati, onde eccitarli alla « riparazione ») . Questi mezzi si riducono a due: la preghiera ( specie il Rosario) unita al sacrificio, e la Devozione al Cuore Immacolato di Maria nella sua triplice forma: vene razione, riparazione e consacrazione. Considerati attentamente questi due mezzi alla luce della Teologia Cattolica, ci appariscono di una efficacia singolarissima, oggi specialmente, per la salvezza dell’umanità tribolata, e per allontanare da essa i castighi sia del tempo che dell’eternità. La Vergine non poteva scegliere mezzi più efficaci.
II – MEZZI PER L’ATTUAZIONE DEL MESSAGGIO
Preghiere e sacrifici
Nella quarta apparizione, la Vergine SS. Di Fatima, col volto velato da profonda mestizia, esortò vivamente i piccoli veggenti alla pratica della preghiera e del sacrificio, e concluse: « Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori » . Ed aggiunse: « Badate, che molte, molte anime vanno all’inferno, perché non vi è chi sacrifichi e preghi per loro ». I tre pastorelli diedero subito ascolto, in modo esemplare, eroico, a questo invito della Vergine, abbandonandosi ad una vita tutta intessuta di preghiere e di sacrifici. Quante anime saranno debitrici dell’eterna salvezza alle loro preghiere ed ai loro sacrifici! E’ indispensabile, per evitare la suprema iattura a tanti nostri fratelli, che i cristiani votati alla preghiera e ai sacrifici diventino legione. Per comprendere la salutare efficacia della preghiera e dei sacrifici fatti per gli altri, è necessario tener presente la dottrina teologica del mistico Corpo di Cristo, esposta con tanta chiarezza dall’Apostolo Paolo e dalla recente Enciclica « Mystici corporis Christi » del S. P. Pio XII (Cfr. Acta Ap. Sedes 35, 1943, p. 247 ss.). Esiste un’evidente analogia tra il corpo fisico e il corpo morale, ossia, la società, sia di ordine naturale (la società civile), sia di ordine soprannaturale (la società religiosa, ossia, la Chiesa). Come il corpo fisico ha vari membri, con vari uffici, dimodo che pur essendo molti, formiamo un sol corpo in Cristo, ed ognuno è membro dell’altro » (Rom. XII, 4-5). V’è perciò una vera, soprannaturale solidarietà fra i vari membri del mistico corpo di Cristo, ossia, fra i battezzati, di modo che tutti son tenuti ad amarsi e ad aiutarsi scambievolmente, come le membra di uno stesso corpo fisico: « Se un membro soffre — osserva S. Paolo — tutte le membra soffrono con lui; e se un membro è glorificato, tutte le membra godono con lui » (1 Cor. XII, 26). Questa è la ragione per cui tutti i cristiani sono veri fratelli, poiché sono uno solo in Cristo, membri tutti dello stesso mistico corpo di Cristo, figli tutti della stessa madre spirituale, Maria SS. Nessuno perciò può rimanere indifferente, inerte, dinanzi alla eterna dannazione di tanti fratelli. Ciò spiega come la Vergine SS., spinta dalla sua sollecitudine materna, si sia rivolta con tanta insistenza ai piccoli veggenti di Fatima, e per mezzo di loro, a tutti i suoi figli, chiedendo « preghiere e sacrifici per i peccatori », onde impedire che tanti precipitino nell’Inferno. « Preghiera » innanzitutto. « L’inferno! l’inferno!… — esclamava Giacinta — Che pena mi fanno le anime che vanno all’inferno! … E tremando si inginocchiava con le mani giunte e pregava: « — O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell’inferno, portate tutte le anime in cielo, specialmente le più bisognose della vostra misericordia —- Rimaneva così a lungo ripetendo la medesima preghiera. Tratto, tratto, come svegliandosi, chiamava gli altri: -— Lucia, Francesco, voi non pregate con me? … Bisogna pregare per liberare le anime dall’inferno. Ve ne cadono tante! … » (Cfr. L. G. da Fonseca, Le meraviglie di Fatima. Roma 1950, p. 125 s.) . L’accorato appello di Giacinta va raccolto da tutti i cristiani. Occorre pregare, pregare molto per la salvezza dei nostri fratelli. Tutti sanno quanto sia efficace questo « gran mezzo » di salvezza — come lo chiama S. Alfonso M. de’ Liguori — per ottenere, non solo per noi, ma anche per gli altri, le grazie necessarie per allontanarci dalla via del male, per perseverare nella via del bene e giungere così alla meta della eterna felicità: « Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto! » (Matth. VIII, 7). La preghiera — è stato detto arditamente — è la forza dell’uomo e la debolezza di Dio: Dio, Padre amoroso, non sa resistere all’umile supplica dei suoi figli pellegrini in questa valle di lacrime. Fra tutte le preghiere, poi, un vero, innegabile primato spetta al Rosario. Per questo la Madonna di Fatima lo preferì a tutte le altre preghiere, raccomandandone la recita quotidiana in ciascuna delle sei apparizioni. Ma della singolare eccellenza di questa forma di preghiera, vera « arma dei cristiani », scriverà un’altra penna, molto più autorizzata della mia. – Alla « preghiera, la Madonna di Fatima esorta di unire « i sacrifici » . Fin dalla prima apparizione, esortò i veggenti ad « offrire sacrifici per la salvezza dei peccatori » . La Vergine SS. spese tutta la sua vita per l’eterna salvezza dei suoi figli. Dietro l’esempio della Madre, anche i fratelli dovranno sentire l’urgenza del sacrificio per l’eterna salvezza dei loro fratelli. La vista dell’inferno, nel quale vanno a cadere tanti, perché non v’è nessuno che si sacrifichi per loro, aveva talmente terrorizzato i tre piccoli veggenti di Fatima, che tutte le penitenze, tutte le mortificazioni, tutti i sacrifici sembravano loro un bel nulla, pur di preservare con essi una sola anima da quella spaventosa prigione. Alludendo a questi sacrifici, Lucia osservava: « Se volessi raccontarli tutti, non finirei mai » . Giunse a tal punto questa sete di sacrifici per un sì nobile scopo, che la Vergine stessa dovette maternamente intervenire per moderarli. Trovata infatti per la strada, subito dopo la quarta apparizione, una corda ruvida e grossa, la divisero in tre parti, se ne cinsero strettamente i fianchi e la portarono, con indicibile strazio, sia di giorno che di notte, fino a lacrimare per il continuo, insopportabile tormento. Ma nella quinta apparizione, l a Vergine SS. moderò il loro ardore dicendo: « Nostro Signore è molto contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la corda. Portatela soltanto durante il giorno » (Da Fonseca, o. c., p. 127.). Mirabile esempio che dovrebbe trascinare innumerevoli altri sulla medesima via! – Il campo per cogliere questi profumati fiori del sacrificio da offrirsi al Signore per la salvezza degli altri è vastissimo: si estende infatti a tutto l’uomo, ai suoi sensi sia interni che esterni, alle sue facoltà sia intellettive che volitive. Nessun palmo di questo vasto terreno è incapace di offrire abbondanti fiori di sacrificio. Basta la buona volontà e la profonda convinzione del dovere, che tutti abbiamo di impedire che un nostro fratello, un membro dello stesso mistico corpo di Cristo, al quale tutti appartengono, sia vittima dell’eterna maledizione. – Preghiera e sacrifici! All’uscio di ogni anima cristiana bussa il lamento di Fatima: « Molte, molte anime vanno all’inferno, perché non vi è chi si sacrifichi e preghi per loro » . Sarà l’amore mariano, sostanziato di preghiera e sacrifici, che arresterà la corsa dei figli di perdizione.
III – LA DEVOZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Oltre al Rosario, la Madonna di Fatima ha indicato, come mezzo di salvezza, la devozione al suo Cuore Immacolato. In ciascuna delle tre prime apparizioni, la Madonna del Rosario ha parlato ai piccoli veggenti del Suo Cuore Immacolato. Nella seconda disse a Lucia che Ella sarebbe dovuta rimanere ancora sulla terra — a differenza di Giacinta e Francesco, che sarebbero andati presto in cielo — perché Gesù, per salvare i poveri peccatori, intendeva servirsi di lei: « Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al m i o Cuore Immacolato ». La Madonna di Fatima, inoltre, ha rivelato i tre atti fondamentali e, direi quasi, connaturali della devozione al suo Cuore Immacolato: la venerazione, l a riparazione e la Consacrazione, tre atti praticati poi in modo esemplare, eroico, dai tre piccoli veggenti di Fatima. – Consideriamo separatamente, alla luce della Teologia, questi tre atti fondamentali del culto al Cuore Immacolato di Maria.
1) La venerazione al Cuore Immacolato di Maria
– La venerazione, primo ed essenziale atto di qualsiasi culto, è anche il primo ed essenziale atto del culto o devozione al Cuore Immacolato di Maria. La legittimità teologica di una tale venerazione appare evidente dalla considerazione sia dell’oggetto che della ragione fondamentale di un simile culto. – Oggetto mediato del culto al Cuore Immacolato di Maria è, evidentemente, la persona stessa di Maria SS., alla quale il Cuore appartiene. Come allorché si bacia, per esempio, la mano un sacerdote, si compie, evidentemente, un atto di venerazione verso la persona di Lui, così allorché si venera il Cuore Immacolato di Maria, si compie un atto di venerazione verso sua persona. — Oggetto invece immediato di tale venerazione è il Cuore stesso fisico di Maria in quanto simbolo del Cuore simbolico o metaforico, ossia, dell’amore. Ciò risulta dalle rivelazioni e dagli scritti di S. Margherita Maria Alacoque, dai primi scrittori e postulatori di tale culto liturgico ( i PP. Croiset e Gallifet), nonché dai d ocumenti autentici dottrinali e liturgi quali la Messa e l’Ufficio (Cfr. Pujolras E., C.M.F. Cultus Purissimi Cordis B. M. Virginis, ed. Ancora, Milano 1942.) . Il fondamento biblico di tale venerazione possiamo riscontrarlo nel Vangelo, ossia, nelle due aperte allusioni « al Cuore » di Maria SS. (Luc. II, 18, 51.) e nelle sette parole pronunziate dalla Vergine, parole che ci rivelano, in modo meraviglioso, il suo Cuore (Cfr. Peinador M., O.M.F., El Corazon de Maria en los Evangelios, in «Estudios Marianos », 4 (1945) p. 11.58.). La ragione stessa, del resto, ci dimostra la ragionevolezza del culto tributato al Cuore Immacolato di Maria SS., a preferenza di altre parti del suo Corpo verginale, santissimo. Il Cuore, infatti, a differenza di qualsiasi altra parte del corpo, rivendica una particolare eccellenza per il fatto che costituisce il centro di tutta la vita affettiva, per cui il cuore è comunemente ritenuto come il simbolo naturale dell’amore, che è come centro motore della vita fisico-psichica. Ciò posto, l’amore, simboleggiato dal cuore, non solo è il primo e principale fra tutti gli affetti, ma anche il principio e la radice dei medesimi e insieme di tutte le azioni (S. Th. I . H , q. 28, a. 6.). L’amore, perciò riassume tutta la vita psicologica e morale dell’individuo. Che se poi, oltreché sotto l’aspetto naturale, ci spingiamo a considerare l’amore anche sotto l’aspetto soprannaturale, esso, oltreché di tutta la vita naturale, appare anche il centro e la sintesi di tutta la vita soprannaturale, esso oltreché di tutta la vita naturale, appare anche il centro e la sintesi di tutta la vita soprannaturale, secondo quella scultorea espressione dell’Angelico: « La carità è la vita dell’anima, come l’anima è la vita del corpo » ( S. Th., t. II, q. 23, a. 2, ad 2.). Il Cuore della Vergine quindi è la vera sorgente di tutta la sua vita e il compendio dei suoi misteri, fra i quali primeggiano q quelli espressi nel S. Rosario. Di qui la singolare e — direi — trascendente eccellenza di una tale devozione, comprovata anche dai mirabili effetti che essa produce nelle anime che la praticano, primo fra tutti quello di rendere il nostro cuore sempre più conforme a quello di Maria, e perciò anche a quello di Cristo, cuore del cuore di Maria. Il Cuore di Maria è come il luogo di convegno, il punto di incontro di Dio con l’uomo, del cuore di Cristo col cuore di tutti i cristiani, il mezzo più efficace per far palpitare tutti i cuori all’unisono. Non esagerava davvero P. Llamera quando scriveva che « l’oggetto formale principale della devozione al Cuore di Maria (l’amore simboleggiato dal Cuore) è ragione dell’oggetto di tutte le devozioni, che onorano l’eccellenza della perfezione o santità di Maria nelle sue diverse manifestazioni, dato che l’eccellenza del suo amore è causa e ragione della eccellenza della sua vita. In tal senso la devozione al Cuore di Maria è per se stessa la più eccellente, tutte le devozioni, in quanto venerano le virtù e i privilegi della Vergine, sono subordinate ad essa come a causa formale e come a fine » (O. c., p. 98.). Questa singolare eccellenza ci dice eloquentemente perché la Madonna di Fatima abbia voluto che la devozione al suo Cuore Immacolato fosse maggiormente statuita e propagata nel mondo d’oggi, così assetato d’amore, così tormentato dalla tempesta dell’odio.
2) La riparazione al Cuore Immacolato di Maria
Spontanea esigenza dell’amore e sua necessaria scaturigine è la riparazione per le offese arrecate al cuore della persona amata. Logicamente perciò la Madonna di Fatima, oltre a stabilire la devozione al suo Cuore Immacolato, della quale è frutto nativo l’amore, ha chiesto con insistenza la riparazione per gli oltraggi arrecati all’Immacolato suo Cuore. Per questo presentò in visione il suo Cuore Immacolato, circondato da una corona di spine che lo pungevano da ogni parte (Già precedentemente, ad un’altra anima privilegiata, Berta Petit, Terziaria Francescana (+ 1943), fu affidata in visione privata la missione di diffondere la consacrazione del mondo al Cuore Addolorato e Immacolato di Maria. Nella comunicazione celeste dell’8 sett. 1911 Gesù le disse : « Il cuore di mia Madre ha diritto al titolo di Addolorato e io lo voglio anteposto a quello di Immacolato, perché il primo se lo ha acquistato essa stessa ». Delicatezza filiale di Gesù per la Sua e nostra Mamma! Benedetto XV fece menzione del Cuore Addolorato e Immacolato di Maria in una lettera inviata al Cardinale Vannutelli, i l 31 maggio 1914. Il 28 Settembre 1915 lo stesso Sommo Pontefice indulgenziava la seguente giaculatoria: « O Cuore Addolorato e Immacolato di Maria, pregate per noi che ricorriamo a Voi ». – Eminenti diffusori del Culto al Cuore Addolorato e Immacolato di Maria sono stati i Cardinali Bourne, Mercier, Granito Di Belmonte. Il Card. Griffin, successore di Bourne nell’Archidiocesi di Westminster, ha annesso la indulgenza di 300 gg. o. v. alla sopraddetta giaculatoria – 21.VI-1947). Fin dalla prima apparizione, la « bella Signora » chiese sacrifici e penitenze « in riparazione delle bestemmie e di tutte le offese arrecate al Cuore Immacolato di Maria ». Anche nella terza apparizione la Vergine SS. esortò i piccoli veggenti a sacrificarsi « in riparazione delle ingiurie commesse contro il Cuore Immacolato di Maria»; e incominciò a parlare della « Comunione riparatrice nei primi sabati del mese ». Il 10 luglio 1925. la Vergine SS., insieme a Gesù Bambino, apparve a Lucia e, integrando ciò a cui aveva di già accennato nella terza apparizione, mostrava il suo Cuore avvolto dalle spine, e Gesù, additandolo, esortava la veggente « ad aver compassione di quel Cuore continuamente martoriato dall’umana ingratitudine, senza che vi sia chi lo consoli con atti di riparazione ». E la Vergine soggiunse: « Guarda, figlia mia, il mio Cuore circondato dalle spine con cui gli uomini ingrati ad ogni momento 1° trafiggono con le loro bestemmie ed ingratitudini. Tu almeno cerca di consolarmi, e da parte mia annuncia che io prometto di assistere, nell’ora della morte, con le grazie necessarie alla salvezza delle loro anime, tutti quelli che nel primo sabato di cinque mesi consecutivi si confesseranno, riceveranno la Santa Comunione, diranno una corona del Rosario e mi faranno compagnia durante quindici minuti, meditando i misteri del Rosario, col fine di offrirmi riparazione ». – La riparazione al Cuore Immacolato di Maria è del tutto analoga alla riparazione al S. Cuore di Gesù. Ne segue dunque che, sia L’una che l’altra, ha analoghi fondamenti teologici. Ha lumeggiato egregiamente i fondamenti teologici generali della riparazione il S. P. Pio X I nella Enciclica « Miserentissimus Redemptor » del 9 Maggio 1928. Dopo aver rilevato come la « riparazione » o « espiazione » è l’ovvia conseguenza dell’amore che si porta alla persona amata, allorché si vede oltraggiata, asserisce che « al debito particolarmente della riparazione», oltreché dall’amore, « siamo stretti da un più potente motivo di giustizia e di amore: di giustizia, per espiare l’offesa recata a Dio con le nostre colpe e ristabilire con la penitenza l’ordine violato; di amore, per patire insieme con Cristo paziente e saturato di obbrobri, e recargli, secondo la nostra pochezza, qualche conforto. » – Giustizia ed amore: ecco i due titoli generici della riparazione al Cuore Immacolato di Maria. Ho detto: titoli generici, poiché non mancano titoli specifici che reclamano, in particolare, una adeguata riparazione alle offese che pungono di continuo, come spine, il Cuore Immacolato di Maria. Questi titoli di riparazione sono tanti quanti sono quelli della sua grandezza e della sua gloria, ed i nostri doveri di figli, di sudditi, di beneficati. La nostra qualità di figli affettuosi ci vieta di rimanere indifferenti dinanzi agli oltraggi, dei quali è continuamente il bersaglio una Madre sì dolce; la nostra qualità di sudditi fedeli ci spinge a risarcire le offese rivolte ad una così amabile Regina; la nostra qualità di beneficati verso Colei che, quale Corredentrice del genere umano, ha cooperato col Redentore all’acquisto di tutte le grazie, e coopera di continuo alla distribuzione delle medesime, non può non stimolarci a risarcire tanti affronti ricevuti da tanti, in compenso di innumerevoli benefizi. Che se si riflette, inoltre, alla singolare, impareggiabile grandezza della persona offesa, — l’Augusta Madre di Dio — e alla sua esimia santità, sia negativa (la perfetta immunità da qualsiasi macchia di colpa sia originale che attuale), sia positiva (la pienezza di grazia e di tutte le virtù), è impossibile non sentire, in tutto il suo vigore, l’impellente invito della Madonna di Fatima al dovere della riparazione mariana.
3) La consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Il terzo, supremo atto della devozione al Cuore Immacolato di Maria, conseguenza anche esso dell’amore, è la consacrazione al medesimo Cuore. « Verrò a chiedere — così disse la Madonna di Fatima nella sua terza apparizione — la consacrazione del mondo al mio Cuore Immacolato », particolarmente della Russia. Il 31 Ottobre 1942, e poi, solennemente, nella Basilica Vaticana, l’8 Dicembre dello stesso anno, il S. P. Pio XII, nella pienezza del suo potere, consacrava la Chiesa e tutto il mondo al Cuore Immacolato di Maria. Recentissimamente poi, con la lettera Apostolica « Anno vergente Sacro » del 7 luglio 1952, consacrava in modo particolare i popoli della Russia allo stesso Cuore Immacolato. [In realtà la Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria, così come richiesto dalla Vergine a Fatima, cioè con la formulazione esatta e precisa, venne fatta da S. S. Gregorio XVIII, successore, canonicamente eletto, di Gregorio XVII G. Siri, il 13 maggio del 1991, come primo atto ufficiale del suo Pontificato “il esilio” – ndr.- ]. Il Vicario di Cristo — com’è noto — non regola mai la sua attività di Pastore supremo della Chiesa in base a rivelazioni particolari, ma è mosso sempre da soli motivi teologici, senza escludere con ciò che la prima idea o l’ultima spinta a compiere un atto, teologicamente giustificabile e praticamente opportuno, possa essere anche qualche rivelazione di carattere puramente privato, sufficientemente accertata. Questo, precisamente, ci sembra il caso del grandioso gesto della Consacrazione, sia del mondo, in genere, sia della Russia, in particolare, al Cuore Immacolato di Maria SS. Ho detto: gesto grandioso. Io stesso, infatti, durante un’indimenticabile udienza privata concessami qualche giorno dopo, mi permisi di dire all’Augusto Pontefice, che con tale sublime gesto Egli aveva raggiunto il vertice del culto mariano. La giustificazione teologica di questa mia modesta valutazione del grandioso gesto, compiuto dal S. P. Pio XII, va ricercata nella natura stessa della Consacrazione e nelle sue basi dogmatiche. Proietta molta luce su questo fondamentale argomento l’Enciclica « Annum sacrum » (De hominìbus Sacratìssimo Cordi Jecu devovendis.), di Leone XIII (25 Maggio 1899), e l a già citata Encìclica « Miserentissimus Redemptor », di Pio XI (8 Maggio 1927), in quella parte che riguarda la Consacrazione al Cuore Sacratissimo di Gesù, alla quale è perfettamente analoga la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Con la « Consacrazione » — rileva Pio XI — offriamo al Cuore di Gesù noi e tutte le cose nostre, riconoscendo le ricevute dalla eterna carità di Dio » . Questa dedizione totale (di noi e di tutte le cose nostre in forza della quale diventiamo « sacri a Dio » ) è anche perenne, a causa appunto di quella nota di stabilità che — come rileva lo stesso Pontefice — è propria, secondo lo Angelico (S. Th., t. II q. 81, a. 8. c.) della « Consacrazione » . Ha riunito felicemente questo duplice concetto proprio della « consacrazione » a Maria SS. (quello cioè di una dedizione totale e perenne) il S. P. Pio XII nel suo discorso ad un gruppo di partecipanti francesi al « Grand Retour » (23 Novembre 1946): « la Consacrazione è un dono intero di sé, per tutta l’eternità; è un dono non di pura forma o di puro sentimento, ma effettivo, compiuto nell’intensità della vita cristiana e mariana ». La Consacrazione, in breve, non è un chiedere, ma un dare; non è solo un dare in custodia, ma è un dare in proprietà; non è un dare in proprietà per qualche tempo, ma per sempre. Il fondamento dogmatico perciò della Consacrazione a Maria è — evidentemente — il dominio o regalità che Ella, insieme con Cristo, ha sopra di noi, dominio o regalità che noi, con l’atto di Consacrazione, liberamente riconosciamo. E’ quanto espone Leone XIII nell’Enciclica « Annum Sacrum ». Dopo aver rilevato « come tutto il genere umano è sotto il potere di Cristo », espone come per tre titoli (naturale, acquisito e di libera elezione) convenga a Cristo il dominio, ossia, la regalità universale. Cristo, infatti, « essendo Figlio del Re di tutti, è erede di tutto il suo potere (diritto naturale); avendo « dato se stesso per la redenzione di tutti », tutti « sono diventati il suo popolo d’acquisto » (diritto acquisito). Non basta: « Benignamente Cristo lascia che a questo duplice titolo ( naturale ed acquisito) di podestà e di regalità si aggiunga liberamente, da parte nostra, il titolo di una consacrazione volontaria » (« Imperator Christus non iure tantum nativo, quippe qui Dei Unigenitus, sed etiam quæsito… Ad istud potestatis dominationisque suæ fundamentum duplex, benigne ipse sinit ut accedat a nobis, si libet, devotio voluntaria ».). – Quello che ci ha insegnato Leone XIII, intorno al fondamento dogmatico della Consacrazione al Cuore Sacratissimo di Gesù, va ripetuto analogamente, del1a Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Se Cristo, infatti, è nostro Re, Maria SS. è nostra Regina. Se triplice è il titolo di Cristo alla Regalità, ossia, al dominio sopra di noi, e perciò al nostro pieno assoggettamento a Lui, triplice ancora è il titolo di Maria SS. alla Regalità e al nostro assoggettamento a Lei mediante la « Consacrazione », ossia: per diritto naturale (quale Madre del Re dei Re), per diritto di conquista (quale Corredentrice, ossia, quale cooperatrice, con Cristo, al nostro riscatto dalla schiavitù del demonio), e per libera nostra elezione, permettendoci anche Lei — come Cristo suo Figlio —, di offrire noi stessi al suo Cuore, come se appartenessimo a noi, umilmente supplicandola a volersi compiacere di ricevere da noi ciò che già (per un duplice titolo) le appartiene. Non occorre spendere molte parole per rilevare la singolare eccellenza della Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Leone XIII, nell’Enciclica « Annum Sacrum », parlando della Consacrazione al Cuore Sacratissimo di Gesù, non esita a qualificarla come « il più ampio e il più grande atto di ossequio e il coronamento e il perfezionamento di tutti gli onori soliti a tributarsi al Sacratissimo Cuore » (« Amplissimum… maximumque obsequii testimonium », « honorem omnium, quodquot Sacratissimo Cordi haberi consueverunt, velut absolutio perfectioque ».) . Anche il S. P. Pio XI asserisce che « fra tutte le pratiche riguardanti il culto del Sacratissimo Cuore, primeggia… la Consacrazione ». Altrettanto, parallelamente, si può e si deve dire della Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. E’ il più alto, il più ampio attestato di ossequio, poiché è la dedizione totale e perenne di noi stessi alla Vergine, fatta in uno slancio di amore. Con la Consacrazione alla Vergine, sintesi e coronamento di tutte le devozioni mariane, il culto mariano raggiunge il suo vertice. Effettivamente non si può andare più in là nell’onorare Maria. Con essa, debitamente compiuta e intensamente vissuta, è suonata sul mondo l’ora di Maria, ora di salvezza e di pace, preannunziata dal Messaggio di Fatima.
P. Gabriele M. Roschini, O. S. M.