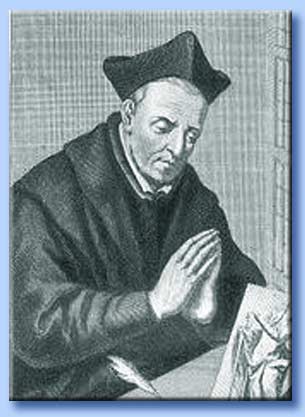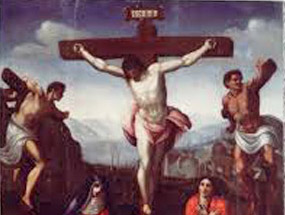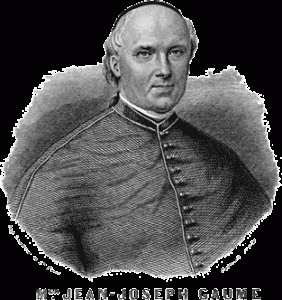CAPITOLO XXII.
IMITATORI DEL BUON LADRONE NELL’ORIENTE
E NELL’OCCIDENTE.
Storia di Moisè capo d i ladri. — Sua conversione. — Suo apostolato presso i ladri. — Ei ne arresta quattro. — Loro conversione. Loro santità. — Egli stesso gran santo e celebre solitario, — Storia del commediante Gelasino. — Convertito in Eliopoli, e subitamente, in presenza di tutto il popolo, e nell’atto che eseguiva una sacrilega parodia. — Storia simile di S. Genesio commediante. — Suo discorso a Diocleziano ed ai grandi dell’Impero. — La stessa prontezza ed efficacia della grazia sulle peccatrici. — Storia della famosa cortigiana di Antiochia.
Rapida come il lampo, efficace come l’acqua del Battesimo, la misericordia, venendo a un’anima indegna, la rende degna di Dio, e produce azioni meritevoli di premio là dove non aveva trovato che colpe da punire. In prova di questo consolante prodigio, poniamoci a considerare il ladro, del quale ci facciamo a narrare la storia. Nella Cronaca di Alessandria, sotto la data 28 Agosto, circa l’epoca di s. Antonio, si legge: « Nei deserti dell’Etiopia viveva un famoso masnadiere, chiamato Moisè. La grazia avendo fatto di questo novello Disma un cenobita di gran nome, ed uno dei santi più amabili tra tutti i santi della Tebaide, egli divenne Apostolo dei masnadieri, che infestavano quella regione. Egli ne ridusse a buona vita un gran numero che divennero monaci esemplari. Un giorno, quattro di quei malfattori si riunirono per saccheggiare il romitaggio di Moisè, ignorando che questi era stato una volta capo assassino. Àvevano forzata appena la porta, che Moisè si fa loro innanzi, e robusto come Sansone, li afferra, e quasi fossero un fastello di paglia, se li mette sulle spalle, li porta al monastero, ove giunto li getta a terra in mezzo ai suoi religiosi adunati intorno a lui. « I monaci gli domandano: Che volete voi fare di questi uomini che osarono aggredirvi? Certamente per espiare le ingiurie da esso lui fatte agli altri, Moisè si era proposto di non mai contristare chicchessia, e di non esigere la punizione di alcuno; perciò non rispose; e ritiratosi, i suoi monaci ebbero pietà di quegli sciagurati, e li posero in libertà. – « Venuti ben tosto a sapere che Moisè era stato un capo di ladri, e che era poi divenuto un santo anacoreta, furono a tal punto tocchi dalla grazia, che chiesero di esser ricevuti nel Monastero. Un tal favore venne loro accordato, e divennero cenobiti esemplari. Per incoraggiarsi, dicevano a se stessi: Se Moisè, ch’era sì gagliardo, e teneva il primo luogo tra i masnadieri, teme così Iddio, continueremmo noi più a lungo la nostra sciagurata condizione di vita, a rischio, se indugiamo ancora un istante a convertirci, di compromettere il grande affare della nostra salute? » [Vedi Pellade, Hist. Laus. Vita di S. Arsenio.] Quei ladroni ripetevano alla loro maniera la parola di Nostro Signore: « Che giova all’uomo guadagnar tutto il mondo, se poi perda l’anima sua? » Questa parola fece in essi quella salutare impressione che produrrà sempre in ogni uomo ragionevole. E se il nostro secolo volesse pur dirla a se stesso francamente e seriamente, di qual pace verrebbe a godere, e di qual miracoli non saremmo noi testimoni? Abbandoniamo ora le foreste e le montagne, ricoveri di assassini, per ritornarvi più innanzi, e seguiamo per poco la divina misericordia nelle città; e vediamola anche qui operare le stesse mirabili conversioni che nelle solitudini. La rapidità della sua azione ci apparirà, se è possibile, anche più miracolosa e più consolante. Nei deserti essa spiega la sua azione su nature brute e crudelmente malefiche; ma desse non hanno quella specie di malignità, che è il prodotto di una civiltà bastarda e corrotta, e che troppo spesso ai più stupendi tratti della grazia oppone una lorica di bronzo impenetrabile. Nelle città e sull’animo dei peccatori civilizzati ben altrimenti si passan le cose. L’antropofago dell’Oceania è men difficile a convertirsi di quello che sia il libertino e 1’empio dell’Europa. Cionondimeno la misericordia spira ove essa vuole, e nulla ad essa resiste. – I due commedianti Gelasino e Genesio ce ne offrono due memorabili esempi. Era il tempo della persecuzione di Valeriano, nella città di Eliopoli. Si davano degli spettacoli al popolo, e tutti i gradini dell’anfiteatro erano coperti di spettatori. Dopo le pugne degli uomini e delle fiere, venivano le rappresentazioni dei mimi, e dei pantomimi, lascivi ballerini, commedianti buffoni, destinati ad eccitare le grasse risa della moltitudine a vilipendio dei Cristiani. Vi ha nell’arena un ampio bacino ripieno di acqua tepida. Giunge la schiera che fa corteggio a Gelasino, uno degli attori, che coperto di lunga e candida veste, a derisione del battesimo cristiano, vien gittato nell’acqua. Appena immerso in essa, egli ben presto si leva gridando non per ischerno, ma sul serio: « Io son Cristiano. Io vidi nel bagno uno spettacolo di terribile maestà, e son Cristiano. » Il popolo montato in furore discende dai sedili nell’arena, trascina fuori dell’anfiteatro Gelasino e lo lapida sul momento. La sua bianca veste è imporporata del suo sangue, e l’anima vola al cielo adorna dei gigli dell’innocenza e della porpora del martirio. I Cristiani cui nessun pericolo intimidisce, accorrono a raccogliere le di lui reliquie, e le recano nel suo natio villaggio, ove gli edificano una chiesa. [Chronic. Alexandr., an. 369]. – Una conversione non meno subitanea, e forse più celebre a motivo della città nella quale avvenne, e degli spettatori che ne furono i testimoni, ebbe luogo sotto Diocleziano. (Parigi ha in questo momento la compagnia imperiale Giapponese dei comici del Taicun. Diocleziano, quest’altro Taicun di Roma, aveva pure la sua propria: poiché quasi tutti gl’imperatori si rassomigliano). In questa compagnia trovasi un istrione chiamato Genesio, e la storia dice che era famoso nelle parti buffe. Essendo un giorno al teatro Diocleziano stesso, Genesio che ben conosceva l’odio di lui contro i Cristiani pensò fargli cosa grata rappresentando sulla scena i misteri della loro religione. Egli comparve pertanto coricato su di un letto, e con voce quasi estinta diceva: « Amici miei, quanto è grave la mia infermità! Io sto per morire. Sento un peso enorme sullo stomaco. Non vi sarebbe modo di liberarmene e rendermi più leggiero? » Gli attori suoi compagni ch’erano intorno al suo letto, rispondevano: « Che vuoi tu che facciamo per alleviarti? Siamo noi forse segatori, o fabbri per ripassarti colla lima o con l’ascia ? » E queste insipide buffonate facevan ridere il popolo sovrano. Ma replicava Genesio: « Voi non intendete niente, non è questo quel ch’io domando. Siccome sento di esser vicino a finire, voglio morir Cristiano. E perché? replicano gli altri attori. Perché Iddio mi accolga nel suo paradiso, come un disertore dei vostri Dei. » Si fanno allora le viste di andare in cerca di un prete e di un esorcista. E i due attori che si avanzano a rappresentare quei sacri ministri, si seggono al capezzale del finto malato, e gli dicono: « Che vuoi tu da noi o figliuolo? e perché ci hai tu cercato? » Mutato tutto ad un tratto, come il Buon Ladrone, per un effetto miracoloso della grazia, Genesio risponde, non più per scherzo o per finzione, ma veramente sul serio e di tutto cuore: « Io vi ho fatto chiamare per ricevere, col mezzo del vostro ministero, la grazia di Gesù Cristo, perché rinascendo pel santo battesimo, venga mondato di tutti i miei peccati. » – Si procede allora a compiere le cerimonie del battesimo, e di una bianca veste si ricopre il neofita. Poi, alcuni soldati che fingonsi mandati dal prefetto di Roma, lo arrestano e fingono di maltrattarlo e percuoterlo, e lo conducono ai piedi dell’imperatore, il quale rideva all’eccesso per aver veduto in un modo sì naturale raffigurato tutto ciò che ordinariamente avveniva nelle cerimonie dei Cristiani, e nell’arresto dei martiri. E per continuare il giuoco, Diocleziano, fingendo di esser montato in furore, domanda a Genesio: « È egli vero che tu sei cristiano? » E Genesio risponde con queste precise parole: Augusto signore, e voi grandi dell’impero, ufficiali della casa di Cesare, cortigiani e cittadini tutti, ponete attenzione a quello ch’io son per dire. Io aveva in tale e tanto orrore i Cristiani, che il loro incontro era sempre per me di funesto presagio. Il loro nome stesso mi era odioso tanto, che fremeva al solo sentirlo ripetere, ed era per me un vero gaudio il poter insultare, anche in mezzo ai loro tormenti, quei che davano la lor vita per difesa e confessione di quel nome. I misteri dei Cristiani non mi parevano men degni di riso, che non lo fossero di disprezzo le persone. Ed è perciò che io volli appieno conoscere i loro riti per farne un soggetto di scherno, e divertire voi sul loro conto. Ma, cosa incredibile per voi e provata per me fino all’evidenza! – Al momento che l’acqua ha toccato il mio corpo, e che, alla rituale domanda se io credessi, ho risposto io credo: ho veduto discender dal cielo una schiera di Angeli sfolgoranti di luce che m’han circondato. Leggevano essi in un libro tutte le colpe che io ho commesse dalla mia infanzia in poi, quindi hanno immersa quel libro nell’acqua, nella quale io mi trovava ancora e ritiratolo, me ne hanno mostrato i fogli tutti bianchi al par della neve. Cesare, e voi Romani che qui mi ascoltate, voi che le tante volte avete applaudito alle profanazioni ch’io feci di questi misteri, voi dovete fin da questo momento venerarli meco e credere che Gesù Cristo è il vero Dio, la luce, la verità, la bontà per essenza, e pronto ad accogliervi e perdonarvi. » Diocleziano, vedendo che Genesio parlava sul serio, si accende di furore veramente imperiale, gli fa rompere addosso molti bastoni, e consegnollo a Plauziano, capitano della guardia pretoriana, il quale gli comandò di sacrificare agli Dei: al che Genesio rispose: Io non sacrifico. — Che gli siano lacerati i fianchi cogli unghioni di ferro, e sia bruciato con carboni ardenti. — Durante la crudele tortura, Genesio non cessa di ripetere: « Non v’ha altro Dio che il Dio dei Cristiani. Quando mi facessero morir mille volte per lui, io morrei mille volte con gioia. » – Terminava appena questa generosa e nobile professione di fede che Plauziano gli fece troncare il capo. Era il 25 Agosto dell’anno 286, alla presenza di tutto il popolo della gran Roma [D. Ruinart, Àct. des martyrs, t. I, 384]. – Io credo volentieri, diceva Pascal, a testimoni che si lasciano uccidere. Prova luminosa della nostra fede, la conversione di Genesio è soprattutto un attestato autentico di quella misericordia che scende fino al fondo dell’abisso per cercare il peccatore, e della rapidità colla quale lo trae da quel fondo. E poiché noi siamo sul teatro, non ne usciamo prima di aver contemplata un’altra meraviglia. Assistere a questi colpi di stato, pei quali il Dio d’ogni bontà strappa in un subito al demonio le più elette sue vittime nel luogo stesso ove questo le immola, vi ha nulla di più dolce al cuore? Se alcuna cosa fosse difficile a Dio, la conversione di cui andiamo a parlare, parrebbe offrire, nel gran numero delle iniquità, un ostacolo eccezionale all’azione della misericordia. Ascoltiamo l’eloquente espositore di questo avvenimento ch’ebbe per testimoni i cento mila abitanti di Antiochia. (Che nessuno, dice s. Giovanni Crisostomo, fosse egli pur caduto nel più profondo abisso del vizio, disperi mai della sua conversione; perocché è facile uscire dal baratro dell’iniquità. Che forse non avete voi mai udito parlare di quella meretrice che sorpassò tutte le altre per la sregolatezza della sua condotta, e che poi sorpassò tutti con 1’ardore della sua pietà? Io non parlo già di quella di cui si fa menzione nell’Evangelio, ma di Fenicia che ai nostri giorni portò lo scandalo all’estremo grado. – « Questa cortigiana era qui, ed occupava il primo luogo sulla scena. Il suo nome era su tutte le bocche, non solo in Antiochia, ma fin nella Cilicia e nella Cappadocia. Ella assorbì la fortuna d’un gran numero di persone, e spogliò molti giovani figli di famiglia. Corse voce ch’essa non solo servivasi della sua beltà, ma altresì di sortilegi e di pratiche diaboliche per sedurre le sue vittime, e stringerle nei suoi lacci: sedusse perfino il fratello dell’imperatrice, conciosiachè la potenza della sua seduzione era una vera tirannia. « Ma ecco che ad un tratto, io non so come, o meglio il so benissimo, ella ritrovasi del tutto cangiata. La grazia di Dio la visita, ed ella disprezza tutto, non cura le sue diaboliche attrattive, rinunzia ad ogni cosa mondana, e prende la via che mena al cielo. Benché nulla vi fosse di più impuro di lei quando compariva sulla scena, ora è modello incomparabile di castità, rivestita sempre di un cilizio che non lascia mai né la notte né il giorno. Dietro le premure di taluni, il prefetto volle richiamarla sulla scena, ed i soldati che inviò a cercarla, non mai poterono indurverla, né strapparla alle pie vergini che l’avevano accolta tra loro. – « Ammessa che fu ai santi misteri, ella di proposito si diede alla pratica di tutte le virtù, e morì dopo di aver purificata l’anima sua da ogni macchia dando tutti i segni di una gran santità. Giammai essa non volle rivedere neppur uno di quelli che da essa furono criminalmente amati e che venivano per visitarla. Si era chiusa in una cella, ove passò molti anni, come in un carcere. Così avviene che gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Abbiasi pure da noi un sì generoso coraggio, e nulla ci sarà di ostacolo a divenire grandi ed ammirabili cristiani. 1[In Matth. Homil. LXVII, Opp., t. VII, p. 750, n 3] – Possa questo esempio, se viene a conoscersi da qualcuna delle moderne Fenicie, parlare al loro cuore e farne venir fuori questa parola operante prodigi: Voglio pur io convertirmi; e perché non potrò io fare quel che han fatto altre mie pari? A me, come ad esse, la divina misericordia apre le braccia. Gettarmi in quelle, è salvarmi.
CAPITOLO XXIII.
IMITATORI DEL BUON LADRONE NELL’ORIENTE
E NELL’OCCIDENTE.
(Continuazione.)
Il mandriano della Tracia. — Suoi atti di brigantaggio. — Vani sforzi per arrestarlo. — Condotta ammirabile dell’Imperatore Maurizio. — Il brigante convertito. — Sua malattia, sua penitenza, sua morte, suo giudizio . — Racconto del medico. — Il giovane ladro di Cluny. — Audace brigante. — Suo incontro Con S. Odone. — Sua conversione. — Sua santità. — Eroismo della sua penitenza. — Sua morte preziosa.
Ritorniamo sulle montagne per veder la misericordia proseguire ad operare le subitanee sue meraviglie tra i privilegiati clienti del Buon Ladrone. S. Anastasio del monte Sinai, dopo di aver riportato la conversione del Ladrone di s. Giovanni, si esprime così: «Questo fatto è tanto più degno di fede, in quanto che non è il solo. Noi lo vedemmo prodursi ai Calvario, ove, di un famoso masnadiere, una sola parola di fede bastò a fare un gran santo. Noi 1’abbiamo di poi riscontrato in un gran numero d’insigni peccatori, e particolarmente nel famoso brigante dell’età nostra, sotto il regno dell’imperator Maurizio; ed eccone la storia. « Un capo di masnadieri aveva fissata la sua dimora sulle frontiere della Tracia. Animoso e forte come un leone, crudele come una tigre, egli aveva rese impraticabili quelle strade. Un gran numero di soldati e di arcieri non avevano potuto con tutti i loro strattagemmi riuscire ad arrestarlo. Il pio Imperatore, essendone stato informato, chiamò a se uno dei suoi giovani ufficiali, e togliendosi dal collo le sante Reliquie che vi portava appese: Va’ gli disse, a recar questo dono al capo dei briganti. « Il messaggero adempì la sua commissione: e il masnadiere non appena si ebbe in mano quelle Reliquie, che colpito come da una potenza divina si sentì in un subito mutato. Di lupo crudele diviene un mansueto agnello, e va a gettarsi ai piedi dell’Imperatore, cui fa la confessione di tutti i suoi delitti. Pochi giorni dopo è colto da febbre violenta, e trasportato all’Ospedale di s. Sansone. Là sul letto dei suoi patimenti volgevasi egli ai suoi pietosi infermieri, e loro confessava i suoi falli, non cessando mai di ripetere questa preghiera: Mio benigno Signore, io non vi domando nulla di nuovo. Siccome voi faceste risplendere la vostra misericordia su di un ladro che mi precedette, spandetela pure su di me che sono un ladro come lui. Accogliete le lacrime ch’io verso su questo letto di dolori ove tra poco morirò. Fate che esse valgano a cancellare la sentenza della mia condanna, e passate la spugna della vostra misericordia sulle mie colpe, che sono al di là d’ogni immaginazione. – « Per lunghe ore questo ladrone penitente continuò a ripetere le stesse parole, asciugandosi le lacrime fino all’ultimo respiro. Al momento ch’ei morì, il valente medico di quell’ospedale dormiva profondamente nella propria casa; ed appunto nell’ora della morte di quel ladro, vide in sogno una folta schiera di Etiopi che accerchiavano il letto del moribondo. Nelle loro mani avevano molte carte, ove erano scritte le iniquità del ladro. Ma bentosto sopravvennero due personaggi coperti di bianca veste; gettarono gli Etiopi in una bilancia tutti quei documenti della reità del moribondo, ed il piatto di quella discese fino al basso, mentre l’altro montò in alto. I due angeli di luce si dissero allora: Non abbiamo noi dunque nulla da mettere per contrappeso ? — Che potremmo aver mai, rispose un d’essi, se dieci giorni non son passati ancora da che cessò egli di commettere omicidi e furti, ed abbandonò la sua caverna? Qual buona opera possiamo noi chiedergli? – « Avendo parlato così fra loro, parve che colle mani cercassero nel letto del moribondo per vedere di trovare alcuna cosa di buono; e venne loro trovato il fazzoletto, del quale il ladro si era servito per asciugarsi le lacrime. Ecco il suo fazzoletto, disse l’uno degli Angeli: mettiamolo nell’altro piatto con la misericordia di Dio: questo sarà pur qualche cosa. Ma non appena vi fu posato quel cencio che il piatto discese al fondo, e le carte ch’erano nell’altro bacino disparvero. Allora gli Angeli d’una sola voce gridarono: Viva la misericordia di Dio! E presero e seco loro portarono l’anima del fortunato ladrone; mentre gli Etiopi confusi si ritirarono fuggendo. – « Intanto il medico di buon mattino si recò a fare la sua visita, e trovato il ladro ancor caldo, prese il suo fazzoletto bagnato di lacrime; ed informato dai malati vicini al suo letto delle preghiere e delle lacrime del defunto, corse all’Imperatore, e gli narrò quanto era avvenuto. Ascoltato con emozione il racconto dal pio Monarca, il medico soggiunse: Sire, rendiamo grazie a Dio. Noi conoscevamo già un Ladrone salvato sulla croce dal confessar che ei fece la divinità del Salvatore: or sotto il vostro impero abbiamo visto un altro ladrone salvato per la confessione dei suoi falli, e per le lacrime del suo pentimento. Simili fatti sono ben consolanti, quanto innegabili: ciò nondimeno, la prudenza esige che, pensando all’ora terribile della morte, noi la preveniamo con una vita penitente! » [Orat. in ps. VI, vers. fin.]. – Così per il Ladrone del Calvario quattro parole, e per costui alcune lacrime bastarono ad espiare una vita d’iniquità. E perché no? La misericordia di Dio non è meno pronta della tentazione. Se un solo istante basta per cadere nel peccato mortale e perder l’anima la più santa, perché mai un istante non deve bastare a convertire il più gran peccatore? – Rassicurati da questa consolante certezza, passiamo dall’Oriente all’Occidente, dai secoli antichi a quelli più prossimi al nostro, e vedremo che la divina misericordia non invecchia, e che la sua azione non conosce ostacoli, e non si arresta a qualsiasi impedimento. Uno de’più gloriosi e più amabili nostri compatrioti, s. Odone, abate di Cluny, essendo un giorno in viaggio, s’incontrò in una banda di masnadieri. Alla vista del suo volto esprimente la bontà e serenità dell’animo suo, ed al suono della sua voce dolce al pari del miele, uno di quei ladri intenerito e compunto cade ai suoi piedi, e a bassa voce lo scongiura ad aver pietà di lui. – « Che vuoi, figlio mio? gii domanda l’uomo di Dio. — Voglio ritirarmi nel vostro Monastero, risponde il giovine masnadiere. —Conosci tu qualcuno in questo paese? Io son conosciuto da tutti i nobili e da tutti gli sfaccendati e libertini. » Da ciò appare che lo sciagurato appartenesse ad una distinta famiglia. « Va’ dunque, replicò il santo, e domani verrai a trovarmi accompagnato da uno dei notabili abitanti della contrada. » Egli fece quanto gli era stato comandato, e il domani si presenta al Monastero con uno dei più nobili abitanti. Rivoltosi a quel gentiluomo, Odone gli disse: « Conoscete voi questo giovine? Qual fu il tenore della sua vita, e quali sono i suoi costumi? — Io lo conosco, rispose quel signore, per un insigne brigante: Latronem imprimis insignem. — Figlio mio, disse allora il santo all’assassino, cambia condotta, e poi vieni, e sarai accolto nel monastero. — Padre mio, rispose il giovine, se tu oggi mi respingi, domani sarò perduto, e Dio ti domanderà conto dell’anima mia. » – Mosso a compassione il santo abate, consentì alla sua entrata nel monastero; ed egli, dopo le usate prove del noviziato, professò e fu dato a compagno del Cellerario con ordine di essergli subordinato ed obbediente in ogni cosa. E poiché non sapeva leggere gli fu forza di sostenere un doppio carico, imparare cioè a leggere e lavorare. Egli però si mostrò tanto animoso nel compiere l’uno e l’altro dovere, che con una mano aiutava il Cellerario e con l’altra teneva il Salterio. Ben tosto il Signore fu contento del suo fervore e lo chiamò a sé. – Vicino a morte, fece pregare il santo abate Odone di venire a visitarlo, volendo parlargli a solo. Venne il santo e gli disse: « Figlio mio, hai tu forse commesso qualche peccato dopo la tua professione religiosa? Sì, padre mio, rispose l’infermo, ho commesso un fallo. Senza la vostra permissione, ho dato la mia tonaca ad un povero che era nudo, e nel guardaroba ho presa una corda di crini. — E che ne hai fatto? Me ne cinsi i lombi per reprimere la voracità del mio appetito. » — Sorpreso e intenerito l’uomo di Dio, volle toglierli un sì duro legame; ma sciogliendolo e ritirandolo, con la putredine sen venne appresso la carne alla quale aderiva quel cinto. – Senza punto commuoversi, né lamentarsi, il moribondo si fece a dire: « Nella scorsa notte, Padre mio, mi vidi trasportato in sogno nel cielo. Incontro a me venne una Signora, sfolgorante di luce e di un’ammirabile maestà, ed appressatasi mi disse: Mi conosci tu? No, io risposi. Io sono, Ella soggiunse, la Madre della misericordia. Ed io le dissi: o Signora che mi comandate Voi? Ed Ella riprese a dire: Fra tre giorni, alla tal ora tu verrai qui. » Giunse infatti il giorno e l’ora indicata, ed il religioso morì, a contestare con certezza la verità della sua visione. E fu da quel momento che il beato Odone prese l’abitudine di chiamare la Beatissima Vergine, Madre della misericordia: Mater Misericordiæ. Una anche questa delle affettuose invocazioni a Maria, della quale dai più s’ignora l’origine prodigiosa. [Vit, S. Odon ap. Sur., t. VI.]

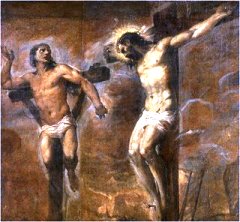




 Visione di S. Pio V
Visione di S. Pio V