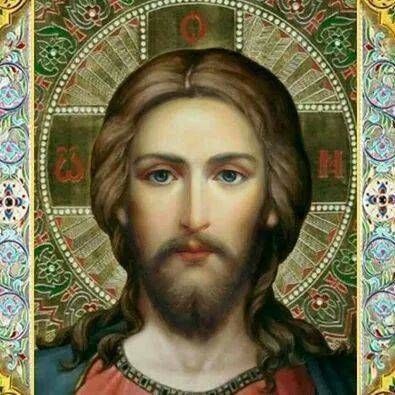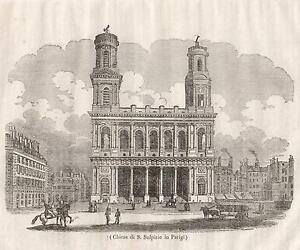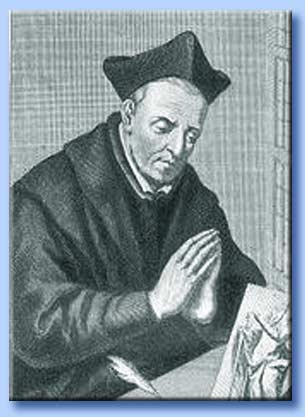LA GRAZIA
(Note di Teologia Dogmatica) (2)
[Ludovico Ott: Compendio di Teologia Dogmatica; Marietti Torino-Herder Roma – imprim. Can. Oddone, Vic. Gen. 7/VI/1955]
4. Necessità della grazia della
perseveranza.
Il giustificato non può
perseverare sino alla fine nella giustificazione ricevuta, senza un particolare
aiuto di aiuto. De fide.
Il II Concilio
di Orange insegna, contro i semipelagiani, che anche i rigenerati devono sempre
implorare l’aiuto di Dio, onde pervenire a una buona fine e poter perdurare nelle opere buone (D. 183). Il
Concilio di Trento chiama la perseveranza finale « un grande dono (magnum illud usque in finem perseverantiæ
donum (D. 826) e insegna che il giustificato senza un particolare aiuto di Dio non può perseverare nella
giustizia ricevuta: Si quis dixerit,
iustificatum vel sine speciali auxilio Dei in accepta iustitia perseverare
posse vel cum eo non posse, A. S. (D. 832). Il « particolare aiuto di
Dio » necessario alla perseveranza finale consiste in una somma di grazie
attuali.
Si distingue tra:
a) perseveranza temporaneao imperfetta
che dura per un certo tempo, per es. da una confessione all’altra, e perseveranza
finaleo perfetta, che
dura fino alla morte;
b) perseveranza
(finale) passiva,che
è il coincidere della morte o della chiamata di Dio con lo stato di grazia, e
perseveranza attiva,che
è la continua cooperazione del giustificato con la grazia. Quella dei bambini è
passiva, quella degli adulti è ordinariamente passiva e attiva. Nella tesi si
parla solo di quest’ultima;
c) possibilità di perseverare (posse
perseverare) e perseveranza effettiva o attuale (actu
perseverare). La possibilità di perseverare, dacché Dio vuole che tutti
si salvino, è data a tutti, la perseveranza effettiva è data solo agli eletti. La Scrittura attribuisce a Dio il compimento
dell’opera di Salvezza. Fil. 1, 6: « Colui che ha incominciato in voi l’opera
buona, la perfezionerà sino al giorno di Gesù Cristo ». Cfr. Fil. II, 13; 1
Piet. V, 10. Essa accentua la necessità della preghiera continua, per poter superare
gli ostacoli che si oppongono alla salvezza (Lc. XVIII, 1: « Si deve pregare
sempre senza stancarsi mai »; 1 Tess. V, 17: « Pregate senza interruzione »)
come pure la necessità di una fedele collaborazione
con la grazia divina (Mt. XXVI, 41: « Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione »; cfr. Lc. XXI,
36). . S. AGOSTINO, alla fine della sua vita, ha scritto una monografia dal
titolo De dono perseverantiæcontro i semipelagiani, nella quale si fonda particolarmente sulla prassi
della preghiera: « Perché dunque si chiede a Dio questa perseveranza, se non è
Lui che ce la dà? Non sarà la nostra una petizione irrisoria, se gli chiediamo
ciò che si sa che Egli non può dare, ma che è in potere nostro averlo, senza
che Egli ce lo conceda? » (2, 3).
– La perseveranza finale non può essere meritata (de condigno), ma si può
ottenere infallibilmente con la preghiera costante fatta in stato di grazia:
Hoc Dei donum suppliciter emereri potest (De
dono persev. 6, 10). L
a certezza di essere esauditi è fondata sulla promessa di Gesù (Gv. 16, 23). Siccome però l’uomo fino a
che non sia immutabilmente confermato nel bene, ha sempre la possibilità di
cadere, nessuno, senza una speciale rivelazione, può sapere se persevererà realmente
sino alla fine. Cfr. D. 826. F i
l . II, 12; 1 Cor. X, 12. – Il motivo intrinseco della
necessità della grazia della perseveranza, sta nel fatto che la volontà umana,
per la continua ribellione della carne contro lo spirito, non ha in se stessa la
forza di persistere immutabile nel bene (perseveranza attiva). – Cosi pure non
è in potere dell’uomo far coincidere l’istante della sua morte con lo stato di
grazia (perseveranza passiva). Cfr. S.
Th. I – II, 109, 10.
5. Necessità di una particolare
grazia per evitare durante tutta la vita ogni peccato veniale.
Il giustificato non è in grado,
senza una particolare grazia, di evitare durante tutta la vita ogni peccato,
anche veniale. De fide.
Il Concilio di
Trento dichiarò, contro la dottrina dei Pelagiani, secondo cui l’uomo con le
sue proprie forze può durante tutta la sua vita evitare ogni peccato, che a tal
fine è necessario uno speciale privilegio di Dio: Si quis hominem semel iustificatum dixerit… posse in tota vita
peccata omnia, etiam venialia, vitare, nisi ex speciali Dei privilegio,
quemadmodum de beata Virgine tenet Ecclesia, A. S. (D. 833). Cfr. D.
107-108; 84.
Per un’esatta comprensione del dogma occorre notar quanto segue: Per « peccata venialia » si devono intendere principalmente i peccati semideliberati; « omnia » va preso in senso collettivo, non distributivo, vale a dire che con l’aiuto della grazia ordinaria si possono evitare i singoli peccati veniali, ma non tutti insieme; « tota vita » significa uno spazio di tempo piuttosto lungo; il « non posse » designa una impossibilità morale; lo « speciale privilegium » in questione comprende una somma di grazie attuali, che rappresentano un’eccezione dell’ordine comune della grazia, ed una eccezione tutta particolare. – Secondo la Scrittura nessuno si mantiene immune da tutti i peccati. Giac. III, 2: « Tutti manchiamo in molte cose ». Il Signore esorta anche i giusti a pregare: « Rimetti a noi i nostri peccati » (Mt. VI, 12). Il Concilio di Cartagine (418) respinse l’interpretazione pelagiana secondo cui i giusti pregano per la remissione dei peccati altrui o, se pregano per sé, pregano secondo umiltà e non secondo verità (humiliter, non veraciter D. 107-108; cfr. 804). – S. AGOSTINO scrive contro i pelagiani:
Se si potessero radunare tutti i
giusti della terra e domandare loro se siano senza peccati, risponderebbero all’unisono con l’Apostolo Giovanni (1 Gv. 1, 8): « Se noi diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi »
(De nat. et grat. 36, 42). – Il
motivo intrinseco sta nella debolezza della volontà decaduta di fronte al complesso degli impulsi
disordinati, e nella saggia
disposizione della provvidenza che permette le piccole mancanze, per mantenere il giusto nell’umiltà e nella coscienza della sua totale dipendenza
da Dio. Cfr. S. Th. I – II, 109, 8.
§ 9. La capacità
e i limiti della natura umana senza la grazia.
La dottrina cattolica della grazia sta
di mezzo a due estremi. Di fronte al naturalismo dei pelagiani ed al
razionalismo moderno, essa difende la necessità assoluta della grazia elevante e
la necessità morale della grazia sanante. Di fronte all’esagerato
sopranaturalismo dei riformatori, dei seguaci di Bajo e di Giansenio essa
difende la capacità della natura umana da sola nel campo religioso e morale.
Opponendosi ai due estremi, la teologia cattolica fa una netta distinzione tra
l’ordine della natura e della sopranatura, tra religione e morale naturale e
religione e morale soprannaturale.
1. Capacità della natura da sola.
a)
L’uomo
anche nello stato decaduto può conoscere con la sola ragione naturale verità
religiose e morali. De fide.
Questa possibilità è fondata sul fatto che le forze naturali dell’uomo col peccato originale non furono distrutte (naturalia permanserunt integra), anche se indebolite dalla perdita dei doni soprannaturali. Cfr. D. 788, 793, 815. – Papa Clemente XI respinse la proposizione giansenistica secondo cui noi senza fede, senza Cristo, senza carità siamo soltanto tenebra, errore e peccato (D. 1398; cfr. 1391). Il Vaticano dichiarò dogma la conoscibilità naturale di Dio, chiaramente attestata in Sap. XIII, 1 ed in Rom. 1, 20 (D. 1785, 1806); cfr. D. 2145 (dimostrabilità dell’esistenza di Dio). La conoscibilità naturale della legge morale è attestata in Rom. II, 14-15; cfr. D. 3005. La stessa civiltà superiore dei popoli pagani depone in favore della capacità della ragione umana naturale. Vedi Trattato di Dio, §§ 1 e 2.
b)
Per
compiere azioni moralmente buone non è richiesta la grazia santificante. De
fide.
Quantunque sia
senza grazia santificante, il peccatore può tuttavia compiere opere moralmente buone e, con l’aiuto della grazia attuale, anche buone soprannaturalmente (benché non meritorie) e prepararsi così alla giustificazione. Perciò non tutte le opere dei peccatori sono peccati. Il Concilio di Trento dichiarò: Si quis dixerit, opera omnia, quæ ante iustificationem
fiunt, quacunque ratione fatta sint, vere esse peccata vel odium Dei
mereri… A.S. (D. 817; cfr. D. 1035, 1040, 1399).
La Scrittura
esorta i peccatori a prepararsi alla giustificazione mediante opere di
penitenza. Ez. XVIII, 30: « Convertitevi, fate penitenza di tutte le vostre
iniquità, e l’iniquità non sarà più a vostra rovina ». Cfr. Zac. 1, 3; Sal. L,
19; Mt. III, 2. Non si può pensare che azioni richieste da Dio e preparanti
alla giustificazione siano peccaminose. La prassi ecclesiastica della penitenza
e del catecumenato sarebbe incomprensibile, se tutte le opere compiute senza la
grazia santificante fossero peccati. La
frase di Mt. VII, 18: « Un albero cattivo non può produrre frutti buoni » non
esclude che il peccatore possa fare opere moralmente buone, così come non
esclude che il giusto possa fare dei peccati la frase parallela: « Un albero
buono non può produrre frutti cattivi ». – S. AGOSTINO insegna che anche la
vita dell’uomo più malvagio difficilmente sarà priva di qualche opera buona (De
spirito et litt. 28, 48). La sua sentenza cui s’appellano i giansenisti:
« Regnat carnalis cupiditas, ubi non
est Dei caritas » (Enchir. 117) non prova che ogni singola
azione del peccatore sia peccaminosa, ma vuol esprimere soltanto il concetto
che nella vita morale vi sono due tendenze, l’una dominata dall’impulso al bene
(amore divino in senso lato) e l’altra dalla concupiscenza disordinata (amore
del mondo e di sè). Cfr. Mt. VI, 24: «Nessuno può servire due padroni». Lc. XI, 23: « Chi non è con me è
contro di me ». Per il significato del concetto di carità in Agostino cfr. De
Triti. VIII, IO, 14: charitas =
amor boni; De gratia
Christi 21, 22: charitas = bona voluntas;
Contro duas. p. Pel. II, 9, 21: charitas = boni cupiditas.
c) Per compiere
azioni moralmente buone non è richiesta la grazia della fede. Sent. certa.
Anche l’infedele può compiere azioni moralmente buone. Di conseguenza non tutte le sue opere sono peccati. Pio V condannò la seguente proposizione di Baio: Omnia opera infidelium sunt peccata et philosophorum virtutes sunt vitia (D. 1025); cfr. D. 1298. – La Scrittura riconosce anche ai pagani la capacità di compiere opere moralmente buone. Cfr. Dan. IV, 24; Mt. V, 47. Secondo Rom. II, 14 i pagani sono per natura capaci di adempiere i precetti della legge morale: « Quando i Gentili che non hanno la legge (mosaica), per lume naturale fanno ciò che la Legge comanda, senza avere la Legge, sono legge a se stessi ». Paolo pensa ai veri pagani, non ai pagani-cristiani, come « spiegava erroneamente Bajo (D. 1022). Il passo Rom. XIV, 23: « omne autem, quod non est ex fide, peccatum est » si riferisce non alle fede cristiana come tale, ma alla coscienza (πίστις = ferma convinzione, giudizio della coscienza), e quindi si traduce: « Quanto non procede da convinzione (ossia non è secondo coscienza) è peccato ». – I Padri attribuiscono senza riserve agli infedeli la capacità di compiere azioni moralmente buone. S. AGOSTINO loda la sobrietà, l’altruismo e l’incorruttibilità del suo amico Alipio, non ancora Cristiano (Conf. V I , 7, 10) e le virtù civili degli antichi (Ep. 138, 3, 17). Se si trovano nei suoi scritti non poche espressioni che quasi coincidono verbalmente con le proposizioni di Bajo, in quanto sembrano affermare che le opere buone e le virtù dei pagani sono peccati e vizi (cfr. De spirito et litt. 3, 5), occorre interpretarle tenendo conto della sua polemica contro il naturalismo pelagiano, nella quale egli ammette come veramente buono e vera virtù solo ciò che ha relazione col fine soprannaturale dell’uomo. Cfr. Contra Iulianum IV, 3, 17, 21, 25.
d) Per compiere
opere moralmente buone non è richiesta la grazia attuale. Sent. certa.
L’uomo
decaduto può compiere con le sole forze naturali, senza l’aiuto della grazia divina,
opere moralmente buone. Perciò non tutte le opere fatte senza grazia attuale
sono peccati: Pio V condannò la seguente proposizione di Bajo: Liberum arbitrium, sine gratiæ Dei adiutorio,
nonnisi ad peccandum valet (D. 1027) cfr. D. 1037, 1389.
Né con la
scrittura né con l’antica tradizione si può provare la necessità di un aiuto della
grazia attuale per tutte le opere moralmente buone. A torto gli avversari si
appellano a S. AGOSTINO. Se egli dichiara ripetutamente che senza grazia di Dio non è
possibile alcuna opera esente da peccato, occorre osservare che chiama peccato in senso ampio tutto ciò che non ha relazione alcuna con il fine
soprannaturale. In tal senso dev’essere
inteso anche il can. 22 del II
Concilio di Orange: Nemo
habet de suo nisi mendacium et peccatum (D. 195 = AGOSTINO, In Ioan. tr. 5, 1).
2.
Limiti della capacità naturale.
a)
Nello
stato della natura decaduta è per l’uomo moralmente impossibile, senza
rivelazione soprannaturale, conoscere con facilità, con ferma certezza e senza
alcun errore tutte le verità naturali morali e religiose. De fide.
Il Concilio
Vaticano dichiarò in accordo con S. TOMMASO
(S. Th. I, 1, 1): «È merito di questa divina rivelazione se le verità divine, che
per sé non trascendono l’umana ragione, anche nello stato presente del genere umano,
da tutti si possono conoscere con facilità, con ferma certezza e senza alcun
errore » (D. 1786). Cfr. l’enciclica Humani
generis
(D. 3005), che conferma e spiega l’insegnamento del
Concilio Vaticano, parlando anche espressamente delle « verità morali », cioè «
della legge naturale ».
Il motivo per cui senza rivelazione soprannaturale soltanto pochi uomini
raggiunsero di fatto una completa conoscenza di Dio e della legge morale e naturale,
sta nell’indebolimento dell’intelletto, causato dal peccato originale (vulnus
ignorantiæ).
b)
Nello
stato della natura decaduta è moralmente impossibile all’uomo, senza grazia
medicinale (grazia sanans), adempiere per lungo
tempo l’intera legge e vincere tutte le tentazioni gravi. Sent. certa.
Se, come insegna il Concilio di Trento, lo stesso giustificato ha bisogno « di un particolare aiuto di Dio per evitare durevolmente tutti i peccati gravi e cosi perseverare nello stato di grazia » (D. 806, 832), con maggior ragione bisogna ammettere che chi non è giustificato non può evitare per lungo tempo tutti i peccati gravi, anche se, grazie alla sua libertà naturale, ha la capacità di evitare questo o quel peccato e di osservar questo o quel comandamento. – L’Apostolo Paolo descrive in Rom. VII, 14-25 la debolezza dell’uomo decaduto, fondata sulla concupiscenza disordinata, di fronte all’assalto delle tentazioni e accentua la necessità dell’aiuto divino per superarle.
CAPITOLO TERZO
La distribuzione della grazia attuale.
§ 10. La
gratuità della grazia.
1. La grazia non può essere
meritata in alcun modo (né de condigno né de congruo) con buone opere naturali.
De fide.
Il II Concilio
di Orange insegna contro i pelagiani ed i semipelagiani che la grazia non è preceduta
da alcun merito: nullis meritis
gratiam præveniri (D. 191). Il Concilio di Trento afferma che la
giustificazione negli adulti ha inizio con la grazia preveniente, in quanto
essi « sono da lui chiamati, senza alcun merito preesistente » (nullis eorum existentibus meritis;
D. 797). Nella Lettera ai Romani Paolo dimostra che la giustificazione non può
essere ottenuta né mediante le opere della Legge del Vecchio Testamento, né
mediante l’osservanza della legge naturale, ma è un libero dono dell’Amore
divino: « Tutti sono gratuitamente (δωρεάν (dorean)
= gratis) giustificati per la sua misericordiosa bontà » (III, 24). Cfr. Rom.
III, 9. 23; XI, 6: « Ma se ciò è stato fatto per grazia, dunque non per le
opere: altrimenti la grazia non sarebbe più grazia ». Cfr. Ef. II, 8 ss.; 2 Tim.
1, 9; Tit. III, 4-5; 1 Cor. IV, 7. Tra i Padri il più strenuo difensore
della gratuità della grazia
contro i pelagiani è S. AGOSTINO. Cfr. Enarr. in Ps. XXX, sermo 1, 6: « Perché grazia? Perché viene data gratuitamente. Perché vien data gratuitamente? Perché
non è preceduta dai tuoi meriti
». In Ioan. tr. 86, 2: «
Non vi sarebbe grazia se
precedessero i meriti. Ma la grazia c’è, essa dunque non trova i meriti, ma li opera ». – La ragione argomenta la gratuità della prima grazia dal fatto della mancanza di intrinseca
proporzione tra la natura e la
grazia (gratia excedit proportionem naturæ) e dalla impossibilità di meritare il principio (la grazia)
del merito stesso (principium
meriti non cadit sub eodem merito). Cfr. S. th. I – II, 114, 5.
2.
La grazia non può essere ottenuta con
suppliche naturali. Sent. certa.
Il II Concilio di Orange insegna contro i semipelagiani che la grazia non viene concessa perché invocata (naturalmente) dall’uomo, ma che è invece la grazia a far sì che noi invochiamo Dio (D. 176). Secondo la dottrina di S. Paolo la retta preghiera è un frutto della grazia dello Spirito Santo. Rom. VIII, 26: « Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza: poiché noi non sappiamo quello che convenientemente abbiamo da domandare; ma lo stesso Spirito intercede per noi con gemiti inesprimibili ». 1 Cor. XII, 3: « Nessuno dice: Gesù Signore, se non in Spirito Santo ». – S. AGOSTINO insegna che la preghiera salutare efficace è effetto della grazia di Dio. Commentando Rom. VIII, 15 («riceveste lo spirito di adozione filiale per cui gridiamo: Abba! Padre! ») egli dice: « Di qui comprendiamo che anche questa è dono di Dio il poter gridare a lui interiormente e con sincerità di cuore. Vedano dunque quanto errano coloro i quali pensano che abbiamo da noi stessi, non ricevuto da altri, il potere di chiedere, di cercare, di picchiare » (De dono persev. 23, 64). Poiché l’iniziativa dell’opera di salvezza parte da Dio, una preghiera salutare efficace è possibile soltanto con l’aiuto della grazia divina preveniente.
3. L’uomo non può acquistarsi
alcuna disposizione naturale positiva alla grazia. Sent. certa.
Per disposizione si intende la capacità
di un soggetto di ricevere una forma, cioè una determinazione. Mentre la disposizione
negativa rimuove unicamente gli ostacoli che si frappongono alla
recezione della forma, quella positiva prepara e adatta il soggetto a
ricevere la forma, dandogli una certa qual tendenza verso di essa, che appare
così come il suo naturale compimento. Questa disposizione positiva è del tutto
distinta dalla cosiddetta potenza obedienziale, che è pura capacità passiva,
fondata nella natura spirituale dell’anima umana (e dell’Angelo) di ricevere la
grazia. Una disposizione positiva naturale per la grazia non è possibile poiché
tra natura e grazia non vi è alcuna intrinseca proporzione.
Il II Concilio
di Orange afferma che il desiderio della purificazione dal peccato non proviene
dalla volontà naturale dell’uomo, ma dalla grazia preveniente dello Spirito
Santo (D. 177; cfr. 179). – La Scrittura attribuisce alla grazia di Dio il
principio e tutta quanta l’opera della salvezza. Cfr. Gv. VI, 44; XV, 5; 1 Cor.
IV, 7; Ef. II, 8-9.
S. AGOSTINO ha insegnato nei suoi primi
scritti una disposizione naturale positiva per la grazia (cfr. De div. quæst.
83, q. 68, n. 4: Præcedit ergo aliquid in peccatoribus, quo, quamvis
nondum sint iustificati, digni efficiantur iustificatione; prima parla
di « occultissima
merita »). Negli scritti posteriori, a cominciare dalla Questione a
Simpliciano I, 2, che è del 397, egli respinge recisamente la
possibilità di una siffatta disposizione e sostiene la gratuità assoluta della
grazia. Cfr. De dono persev. 21,
55. Come prova scritturale egli si serve con predilezione di Prov. VIII, 25 secondo la vecchia traduzione
latina dipendente dai Settanta: Preparatur voluntas a Domino (Volg.:
hauriet
salutem a Domino; Ebr.: « ottiene il favore di Dio »).
Anche in S. TOMMASO vi fu un’evoluzione della dottrina. Mentre nei primi scritti (Sent. II, d. 28, q. 1, a. 4 e Sent. IV, d. 17, q. 1, a. 2) egli insegna, d’accordo con i teologi più antichi, che l’uomo, senza grazia interna, può raggiungere con la sola libera volontà una disposizione positiva alla grazia santificante, in quelli posteriori esige, per la preparazione a ricevere tale grazia, un aiuto divino che muova internamente l’anima, cioè la grazia attuale. Cfr. S. th. I – II, 109, 6; 112, 2; Qlb. 1, 7.
4.
L’assioma scolastico: « Facienti quod in se est, Deus non denegat
gratiam ».
c) Spiegazioni possibili.
1) S. TOMMASO, negli ultimi suoi scritti che contengono l’espressione definitiva della sua dottrina, spiega l’assioma, comparso per la prima volta nella teologia del sec. XII e attribuito a Pietro Abelardo, nel senso della collaborazione con la grazia: a colui che con l’aiuto della grazia fa tutto ciò che è in suo potere, Dio non rifiuta un’ulteriore grazia. Cfr. S. th. I – II, 109, 6 ad 2; 112, 3 ad 1; In Rom. X, lect. 3. 2) L’assioma può anche interpretarsi, come fanno non pochi molinisti, nel senso della disposizione naturale negativa, che consiste nell’evitare il peccato. C’è però da osservare che la connessione tra la disposizione negativa e la comunicazione della grazia non è un rapporto di causa ad effetto, ma puramente contingente, fondato sulla universale volontà salvifica di Dio. In altre parole Dio dà la grazia non perché l’uomo evita il peccato, ma perché Egli vuole sinceramente la salvezza di tutti gli uomini.
b)
Spiegazioni inaccettabili.
1) Semipelagiana è la spiegazione secondo cui gli sforzi naturali dell’uomo, per il loro intrinseco valore, fondano un certo diritto (meritum de congruo) alla grazia. Siffatta spiegazione si avvicina a quella sostenuta dagli antichi scolastici e da S. TOMMASO nei suoi primi scritti (Sent. II, d. 2 q. I, a. 4).
2) Anche i nominalisti
riferiscono l’assioma agli sforzi morali dell’uomo dai quali deriverebbe un
certo diritto alla grazia (m. de congruo), ma non fanno dipendere la comunicazione
di questa dall’intrinseco valore di quelli, bensì da una accettazione
estrinseca da parte di Dio: a colui che fa ciò che è in suo potere, Dio dà
la grazia perché così ha promesso conforme a Mt. VII, 7: « Chiedete, e vi sarà dato; cercate, e troverete;
picchiate, e vi sarà aperto ». — Secondo l’insegnamento della rivelazione la
salvezza vien da Dio, non dall’uomo Pertanto anche il chiedere, il cercare, il
picchiare, di cui Mt. VII,7, non
son dovuti allo sforzo morale del solo uomo, ma alla cooperazione con la
grazia.
Lutero dapprima spiegò
l’assioma in senso nominalistico più tardi lo respinse come pelagiano.
§ 11. L’universalità
della grazia.
Benché la grazia sia un dono dell’Amore
e della misericordia di Dio, tuttavia per la volontà divina salvifica
universale, vien data a tutti gli uomini. Siccome però in realtà non tutti gli
uomini raggiungono la felicità eterna, ne consegue che c’è una duplice volontà
di Dio relativa alla loro salvezza:
a) l’una universale, per cui Dio,
indipendentemente dallo stato finale dei singoli, vuole la salvezza di tutti
gli uomini alla condizione che muoiano in grazia (voluntas antecedens et condicionata);
b) l’altra particolare, per cui Dio,
tenendo conto dello stato finale dei singoli, vuole assolutamente la salvezza
di coloro che lasciano la vita in grazia (voluntas consequens et absoluta).Tale volontà coincide con la predestinazione;
se invece esclude dalla beatitudine eterna si dice riprovazione. Cfr. GIOVANNI DAMASCENO,
De fide orth. II, 29.
1. La volontà salvifica
universale di Dio in sé. Anche con la caduta e il peccato originale, Dio vuole
veramente e sinceramente la salvezza di tutti gli uomini. Sent. fidei proxima.
Che Dio voglia
la salvezza non soltanto dei predestinati, ma almeno di tutti i credenti, è
dogma formale.
La Chiesa ha
condannata come eretica la tesi dei predestinazianisti, dei calvinisti e dei
giansenisti che limitava la volontà divina salvifica ai soli predestinati. Cfr.
D. 318, 827, 1096. Tale volontà abbraccia almeno tutti i credenti, come risulta
dalla professione di fede della Chiesa nella quale i fedeli dicono: Qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de cœlis. Che inoltre si estenda al di là dell’ambito
dei fedeli risulta dalla condanna da parte di Alessandro VIII di due proposizioni
contrarie (D. 1294-1295). Gesù mostra, con l’esempio della città di Gerusalemme,
che Egli vuole anche la salvezza di quelli che in realtà si perdono (Mt. XXIII,
37; Lc. XIX, 41). Da Gv. III, 16 risulta che Dio vuole la salvezza almeno di
tutti i credenti, perché ha dato il suo Figlio « affinché chiunque in Lui crede
non perisca, ma abbia la vita eterna ». Secondo 1 Tim. II, 4, la volontà divina
salvifica abbraccia senza eccezione tutti gli uomini: « Egli (Dio) vuole che tutti
si salvino e giungano alla conoscenza della verità ». I Padri
preagostiniani non pongono in dubbio l’universalità della volontà divina salvifica. L’Ambrosiastro così chiosa 1 Tim. 2, 4: « Egli non ha escluso nessuno dalla salvezza Anche S. AGOSTINO nei primi suoi
scritti aderisce a questi modo
di vedere (cfr. De spiritu et litt. 33, 58). In quelli posteriori però, conformemente alla sua rigida
teoria della predestinazione, limita la volontà divina salvifica ai
predestinati e spiega artificiosamente il passo di S. Paolo a Timoteo nei modi seguenti: a) Dio vuole che
uomini di tutte le classi si salvino
(Enchir. 103); b) tutti
quelli che si salveranno, si salveranno per la volontà di Dio (Contro
Iulianum IV, 8, Enchir. 103); c) Dio fa che noi vogliamo che
tutti si salvino (De corrept.
et grat. 15, 47). Non pochi
teologi riferiscono la
spiegazione limitativa di S . Agostino alla volontà salvifica conseguente, la quale non è
universale. Tuttavia dalla forzata spiegazione
agostiniana emerge come sia assai problematico se egli, negli ultimi anni della sua vita, abbia ancora sostenuto l’universalità della volontà salvifica
antecedente. La sua dottrina
della predestinazione, secondo cui Dio, per puro suo beneplacito, sceglie una parte degli uomini dalla « massa dei dannati », mentre non sceglie gli
altri, sembra che non dia più
adito ad una autentica e seria volontà salvifica universale.
2.
L a volontà salvifica universale nella
sua attuazione.
a)
Dio
dà a tutti i giusti la grazia sufficiente (proxime vel remote sufficiens) per
l’osservanza dei comandamenti divini. De
fide.
La grazia
sufficiente si distingue in prossima o immediata (gr. proxime
sufficiens), che dà immediatamente la capacità di compiere un
determinato atto salutare, e in remota o mediata (gr. remote sufficiens), che
dà la capacità di compier un atto col quale si ottengono ulteriori grazie.
Quest’ultima è soprattutto la grazia di pregare.
– Dopo il II Concilio di Orange, che aveva già espressa questa dottrina (D. 200), quello di Trento dichiarò che l’adempimento dei comandamenti di Dio non è impossibile all’uomo giustificato: Si quis dixerit Dei prœcepta nomini etiam iustificato et sub gratia constituto esse ad adservandum impossibilia A. S. (D. 828). – Lacontraria dottrina dei giansenisti fu condannata dallaChiesa come eretica (D. 1092). – Secondo la Scrittura Dio rivolge ai giusti le sue cureparticolari. Cfr. Sal. XXXII, 18-19; XXXVI, 25 ss.; XC; Mt. XII, 50;Gv. XIV, 21; Rom. V, 8-10. I precetti di Dio possono facilmente essere adempiuti dai giusti. Mt. XI, 30:« Il mio giogo è soave, e il mio peso è leggero ». 1 Gv.V, 3: « L’amore di Dio consiste nell’osservare i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi, perché tutto ciò che è nato da Dio trionfa nel mondo. 1 Cor. X, 13: « Dio è fedele, e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione provvederà anche il buon esito, dandovi il potere di sostenerla ». – S. AGOSTINO coniò la frase accolta dal Concilio di Trento:« Dio non abbandona i giusti, se non vien prima abbandonato da loro » (D. 804); cfr. AGOSTINO, De nat. et grat. 26, 29. La fedeltà di Dio vuole che egli dia ai giusti la grazia sufficiente, perché essi possano conservare il diritto, loro concesso,alla vita eterna.
b)
Dio
dà a tutti i peccatori credenti la grazia sufficiente (saltem remote
sufficiens) per la conversione. Sent. communis.
Egli non nega
completamente la sua grazia neppure ai peccatori accecati e induriti. – La
Chiesa insegna che « se qualcuno dopo il Battesimo è caduto in peccato, può sempre rialzarsi con una vera penitenza» (D. 430). Ciò presuppone che Dio conceda
la grazia sufficiente per la conversione. Cfr. D. 911, 321. – Le numerose
esortazioni che la Scrittura rivolge ai peccatori perché si convertano
presuppongono la possibilità della conversione con l’aiuto della grazia divina.
Ez. XXXIII, 11: «Io non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e
viva ». 2 Piet. III, 9: « Il Signore… usa pazienza per riguardo a voi, non
volendo che alcuno perisca, ma che tutti ritornino a penitenza ». Rom. II, 4: «
E non sai che la bontà di Dio ti spinge a penitenza? ». I passi della Scrittura
che attribuiscono a Dio l’indurimento dei peccatori (Es. VII, 3; 9, 12; Rom.
IX, 18) sono da intendere nel senso che Dio permette il male sottraendo al
peccatore, per punizione, la grazia efficace. La conversione viene così resa
più difficile, ma non tuttavia impossibile. Secondo l’insegnamento comune dei Padri
anche i più grandi peccatori non
sono esclusi dalla misericordia di Dio.
S. AGOSTINO dice: « Non si deve dubitare neanche del peccatore più grande, fintantoché vive qui
sulla terra » (Retract. I, 19, 7).
Il fondamento psicologico della possibilità della conversione anche dei peccatori induriti, sta nel
fatto che la loro ostinazione,
finché sono in vita (in statu viæ), non è definitiva come quella dei dannati.
c)
Dio
dà a tutti gli infedeli senza loro colpa (infideles negativi) la grazia
sufficiente per salvarsi. Sent. certa.
Alessandro VIII condannò nel 1690 le proposizioni giansenistiche secondo le quali Cristo era morto soltanto per i fedeli e che i pagani, i giudei e gli eretici non ricevono da lui alcun influsso di grazia (D. 1294-1295). Cfr. D. 1376. La Scrittura attesta la universalità della volontà divina di salvezza (1 Tim. II, 4; 2 Piet. III, 9) e l’universalità della redenzione di Cristo (1 Gv. II, 2; 2 Cor. V,15; 1 Tim. II,6; Rom. V,18). È pertanto inammissibile che a una grandissima parte dell’umanità rimanga preclusa la grazia necessaria e sufficiente alla salvezza. – I Padri spiegano Gv. 1, 9 (illuminat omnem hominem) nel senso di un’illuminazione di tutti gli uomini, anche degl’infedeli, mediante la grazia divina. Cfr. Giov. CRISOSTOMO, In Ioan. hom. 8, 1. Una monografìa patristica sull’universale distribuzione della grazia è lo scritto anonimo, ma probabilmente composto da Prospero d’Aquitania, dal titolo De vocatione omnium gentium (circa il 450), che cerca una via di mezzo tra i semipelagiani ed i seguaci della dottrina agostiniana e sostiene decisamente l’universalità della volontà divina salvifica e della concessione della grazia. – Siccome la fede è « l’inizio della salvezza, il fondamento e la radice di ogni giustificazione » (D. 801), essa è pure indispensabile per la giustificazione dei pagani. Ebr. XI, 6: « Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è ed è rimuneratore di quelli che lo ricercano ». Una semplice « fede razionale » non basta. Innocenzo XI riprovò la proposizione: « Fides late dicta ex testimonio creaturarum similive motivo ad iustificationem sufficit » ( D . 1173). È necessaria la fede teologale, cioè la fede soprannaturale nella rivelazione, fede questa che è un effetto della grazia (D. 1789: concetto della fede teologale; 1793: nemini unquam sine illa contigit iustificatio). Per ciò che riguarda il contenuto di questa fede, secondo la testimonianza della Lettera agli Ebrei XI, 6, è necessario di necessità di mezzo credere esplicitamente che Dio esiste e che premia i buoni e castiga i cattivi. Per la Trinità e l’Incarnazione è sufficiente la fede implicita. L’infedele giunge alla fede soprannaturale richiesta per la giustificazione per il fatto che Dio, con ammaestramento interno o esterno, gli fa conoscere la verità rivelata e con la grazia attuale gli conferisce la capacità di emettere l’atto di fede. Cfr. S. TOMMASO, De verit. 14, 11.
Obbiezione. Contro
l’universalità della volontà salvifica divina si obbietta che Dio non vuole
seriamente e sinceramente la salvezza dei bambini che muoiono senza battesimo.
Risposta: Dio, a motivo della sua volontà di salvezza, non è obbligato a
eliminare con un intervento miracoloso dall’ordine del mondo da lui creato,
tutti i singoli ostacoli derivanti dalla cooperazione di cause seconde con la
causa prima divina e che in molti casi rendono vana l’esecuzione della volontà divina.
Esiste anche la possibilità che Dio rimetta il peccato originale, per via
straordinaria, ai bambini che muoiono senza Battesimo e li faccia partecipi della
sua grazia; la sua potenza non è legata ai mezzi della grazia proprii della
Chiesa. Il fatto di questa comunicazione estrasacramentale della grazia non si
può tuttavia provare positivamente.