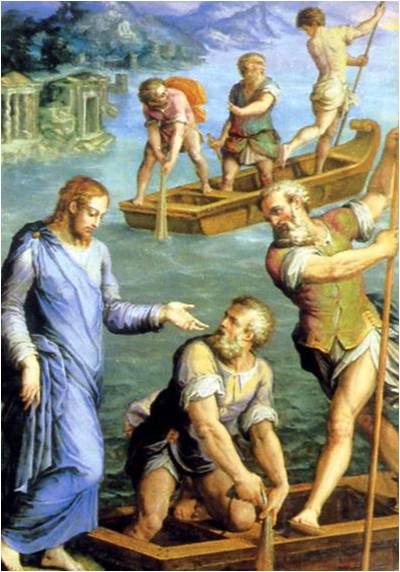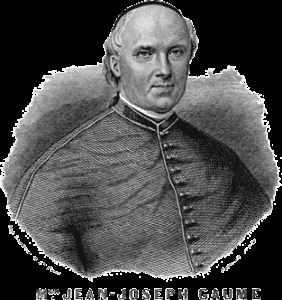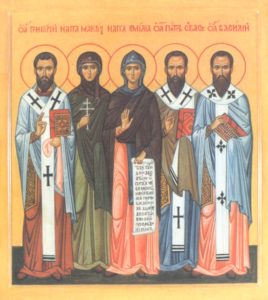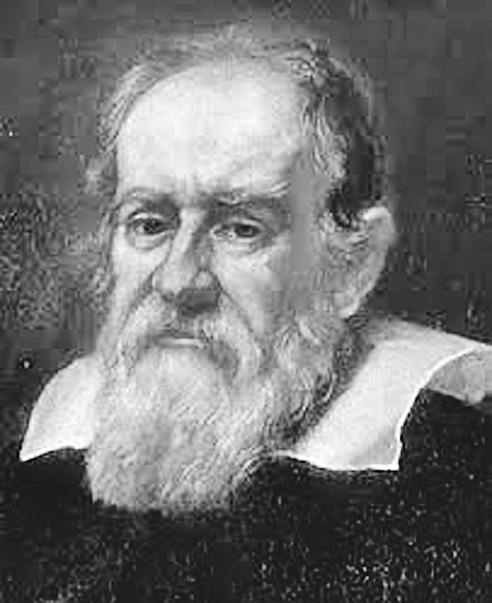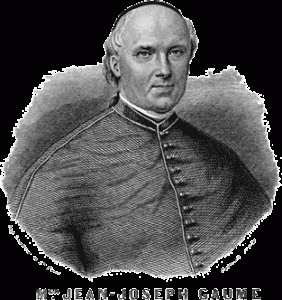
CAPITOLO VII
TERZA EPOCA.
Siffatto ordine, cosi perfettamente logico agli occhi della ragione e della fede, ebbe la disgrazia di spiacere alle persone, che, sapendolo o senza saperlo, ricondussero il paganesimo in Europa ed inaugurarono la terza epoca della nostra pubblica educazione. Ecco in brevi accenti la storia di sì inaudito rivolgimento, del quale noi proviamo anche ai dì nostri le conseguenze perniciose. Costantinopoli era caduta sotto i colpi di Maometto II: ciò fu nel 1453. Tristi reliquie d’una nazione dispersa ai quattro venti per aver tradito la fede dei suoi padri, i Greci fuggiaschi giungono in Occidente. Nel loro fardello gli esuli recan seco le opere dei filosofi, dei poeti, degli oratori, degli artisti pagani, di cui eglino sono ammiratori pazzi. Accolti dai Medici, i Greci pagano la gentile accoglienza ricevuta spiegando le opere dei loro antichi concittadini ed esaltando la gloria di quanto fu inspirato dal genio pagano. A sentirli, l’Europa non conobbe insino allora la letteratura, l’eloquenza, la filosofia, la poesia, le belle arti. « Barbaro, istruisciti: non cercar più i tuoi modelli né le tue ispirazioni nei tuoi pretesi grandi uomini, nei tuoi annali, nella tua religione. Roma pagana, la Grecia pagana soprattutto possono sole offerirli, in tutti i generi, capi d’opera degni delle tue meditazioni. Colà fuvvi il monopolio dell’ingegno, del sapere e dell’eloquenza; colà vissero gli uomini che tu devi imitare, ma che tu non eguaglierai mai. Fia tua gloria l’appressarti loro; non ti lusingare di andare più lungi: essi posero le colonne d’Ercole dell’umano sapere ». Ecco quanto si disse su tutti i tuoni dai nuovi maestri. Occultamente rosa dallo spirito di ribellione, triste frutto del grande scisma d’Occidente, l’Europa presta attento orecchio a questi discorsi: essa vi ravvisa un biasimo, un’ingiuria per il Cattolicesimo. Con tutto l’ardore d’un astio a lungo compresso, essa afferra l’occasione d’infrangere l’autorità letteraria di quello, aspettando di poter infrangere apertamente la sua autorità religiosa. Un eco immenso risponde alla seducente voce dei novelli dottori. Non si hanno più innanzi gli occhi se non i pagani di Roma e d’Atene; si divorano le loro opere, si esaltano alle nubi; non si conoscono più per l’umanità se non due secoli di luce, quello d’Augusto e quello di Pericle: tutti gli altri sono ascosi dal Carlo Dupin di allora sotto larghe zone di nero inchiostro. Nulla è bello, nulla è tollerabile nelle diverse forme dell’umano pensiero, nel linguaggio, nella poesia, nell’eloquenza, nella pittura, nella scultura, nell’architettura, tranne quanto reca il suggello del paganesimo. Gli uomini arrossano di non lo avere saputo più presto: se ne fa ammenda onorevole ingegnandosi di modellarsi sull’antichità. – Tanto per risparmiare all’infanzia una tale fatica quanto per assicurare il buon esito del felice Rinascimento, si prepara frettolosamente uno stampo perfettamente pagano, e vi si gettano le giovani generazioni. – Via i classici cristiani, via gli Atti dei martiri, le Scritture, i Padri della Chiesa che avevano formato i loro avi! La storia degli Dei dell’Olimpo, le favole di Fedro e di Esopo, Quinto Curzio, Ovidio, Virgilio, Orazio, Omero, Senofonte, Demostene, Cicerone, Aristofane; ecco oramai i soli modelli della gioventù cristiana, dei figliuoli dei cavalieri e dei martiri: « Stupiranno gli avvenire, dice un grave protestante dei nostri giorni, di sapere che una società la quale si diceva cristiana dedicò i sette od otto più begli anni della gioventù dei suoi figliuoli all’esclusivo studio dei pagani « Eppure è così. Sì, egli è un fatto che nell’età di cui parliamo vi fu una totale rottura della tradizionale catena dell’insegnamento, una esorbitante deviazione nel processo dello spirito umano; in una parola, un radicale cambiamento nella educazione della gioventù. Si ebbe un altro libro più classico ancora, e, se possibile è, più popolare delle opere stampate o manoscritte: voglio dire dell’arie in generale. Esclusivamente consacrata alla religione, l’Arte spiegava agli occhi dei dotti e degli ignoranti gli Atti dei martiri, i fatti della Scrittura e le storie de’santi: le pagine sì variate, sì intelligibili di questo nuovo libro si trovavano dovunque, nelle chiese e perfino nel focolare della capanna la più umile. Tale era il secondo libro classico, il secondo stampo cristiano delle giovani generazioni. – Ora, quanto si era fatto per la letteratura, si affrettarono a fare per le arti. Al tipo cristiano succede un tipo perfettamente pagano, e vi si riconduce la gioventù. Via tutte le glorie artistiche delle età di fede! Via i magnifici monumenti d’architettura, di pittura, di oreficeria, di cui l’Europa è coperta. I templi mutilati della Grecia e dell’Italia, le statue, i vasi, i resti di colonna, gli archi di trionfo, gli edifici per metà rovinati del paganesimo, gli affreschi dei suoi palazzi, le nudità delle sue ville e delle sue terme: ecco pel pittore, per lo scultore, per l’architetto, pel disegnatore, per l’orefice i veri libri classici ed il tipo esclusivo del bello. Qui, come per la letteratura, l’entusiasmo fu spinto sino al delirio: esso diventò una epidemia che invase l’intera Europa. – Voi avete veduto in qual modo fu rotto lo stampo in cui l’Europa era stata raffazzonata durante quindici secoli, e donde era uscita sì eroica, sì cavalleresca, sì forte, sì grande in ogni modo, in una parola, sì cristiana. Io vi rammemoro ora la vostra prima obbiezione e vi chiedo: Vi sembro io ancora troppo assoluto? Il cambiamento di stampo è egli stato meno assoluto di quanto io avevo detto? Raccogliete la vostra memoria e paragonate. Durante le due prime età, i classici, cioè i libri e le arti insieme, presentate come modelli all’infanzia, sono esclusivamente cristiane. Durante la terza età, sono esclusivamente pagane. Durante le due prime età, i classici propriamente detti sono: gli Atti dei martiri, la Sacra Scrittura, i Padri della Chiesa; gli autori pagani non sono studiati se non di seconda mano, e solo nell’adolescenza. Durante la terza età, i libri classici propriamente detti, sono: le Storie degli Dei del paganesimo, le favole del paganesimo, i libri dei grandi uomini del paganesimo; essi sono studiati principalmente, esclusivamente, e questo sin dalla prima infanzia. – Durante le due prime epoche, i giovinetti rimangono a lungo in seno alla loro famiglia, in cui sono potentemente nutriti del puro latte delle verità cristiane; ei non entrano nelle scuole se non per ricevere un alimento più sostanzioso, ma non meno cristiano. Durante la terza epoca, i fanciulli abbandonano di buon’ora il focolare domestico, in cui hanno già ricevuto un nutrimento metà cristiano, metà pagano: poscia entrano nelle pubbliche scuole, ove non trovano più se non un cibo esclusivamente pagano. Nelle due prime epoche i pagani non sono studiati se non con un’intenzione religiosa, e non già quali modelli di pensare, di sentire e di parlare. Nella terza epoca i pagani non sono per nulla studiati con religiosa intenzione, ma sì come modelli esclusivi della perfezione nell’arte di pensare, di sentire e di parlare. La mutazione di sistema, di forma, di stampo, può ella essere più compiuta?
CAPITOLO VIII
RISPOSTA ALLA SECONDA OBBIEZIONE
TESTIMONIANZA DEGLI UOMINI.
Voi non vi considerate per sconfitto, ed aggiungete: « Ammettendo la mutazione totale da voi indicata, io trovo che voi attribuite una esagerata influenza ad una semplice forma. Ora, il Rinascimento non è insomma altro che una nuova forma, data al pensiero ». Io non disputerò con voi per sapere se il Rinascimento fu una semplice forma o qualche cosa di più. Io parto dal fatto che voi non negate punto, cioè che il Rinascimento si fu l’introduzione del paganesimo nella educazione, Ora, io sostengo che, se ciò non è guari che una semplice forma, la forma reca seco il fondo, e che non esagero per nulla l’influenza da me attribuitale. Per sostenere il mio asserto, ho due sorta di testimonianze: gli uomini ed i fatti. – Gli uomini. Accusandomi di esagerare l’influenza disastrosa del paganesimo nella educazione, sapete voi chi è che accusate? Voi accusate uomini la cui autorità non è discutibile;uomini che dalla loro probità sono esclusi da ogni sospetto; uomini che dalla loro celebrità sono resi rispettabili ed ai loro amici ed ai nemici loro; uomini, cui la loro condizione pose più che altri mai in caso di portare una testimonianza irrecusabile su fatti ch’essi osservarono a lungo,ch’essi toccarono con mano, ch’essi videro con i loro occhi, e di cui parecchi furono vittime. Ho nominato i Padri della Chiesa, i Padri dell’Europa cristiana, le guide le più illuminate delle nazioni, i principi della virtù e della sapienza. Forse che Origene non ravvisava nel paganesimo classico se non una nuova forma data al pensiero, un modo d’istruzione senza pericolo pei giovinetti cristiani? Origene, il quale, parlando degli scrittori e soprattutto dei poeti profani, non teme dire che le opere loro, anche le più celebrate, sono tazze i cui orli sono dorati e il cui fondo è pieno d’un veleno mortifero? (Homil. 2, in Hier). Felice lui stesso, se, tenendosi sempre in guardia contro le opere di cui indicava con tanta eloquenza il pericolo, saputo avesse schivare il veleno dei filosofi pagani con tanta cura con quanta quello dei poeti! Ma no; il grande Origene, ingannato dalla filosofia di Platone, si lasciò trascinare da una folla di errori che scandalizzarono la Chiesa, ed i quali lasciano ancora dubbio a molti circa la sua eterna salvezza. – Il suo commilitone nella lotta in favore del Cristianesimo nascente, l’immortale Tertulliano, avrebbe forse considerato come cosa innocente lo studio dei pagani per parte dei giovinetti cristiani, egli che con tanta verità chiama i filosofi pagani « Patriarchi degli eretici, corruttori della dottrina della Chiesa? (Apud S. Hier; ad Clesiphont.) ». – Sant’Ireneo, il sapiente apologista della religione, da lui segnata col proprio sangue, è più formale ancora. È noto il celebre motto, con cui condannando tutta quanta la filosofia pagana nella persona del suo rappresentante il più accreditato, definisce Platone « artigiano di tutte le eresie (“Doleo Platonem fuisse omnium hæsereseon condimentarium”. De hæres.) ». Ecco qui un testimonio non meno irrecusabile. Lattanzio, che aveva studiato a lungo le belle lettere, ed il quale meglio che altri conosceva il segreto influsso dei libri classici, afferma, come cosa conosciuta ai suoi dì, che la fede in nessun uomo era tanto debole quanto in coloro che erano dediti alla letteratura pagana (“homines litterali minus credunt”.). Confermando il pensiero di Lattanzio, Sant’Ambrogio sorge con energia contro coloro i quali, per darsi allo studio degli autori pagani, negligono le Sacre Scritture. « Non vi è pericolo mediocre nel tralasciare la parola di Dio per quella del secolo (“Non est mediocre periculum, cum habeas tanta eloquia Dei, illis prætermissis, loqui quæ sæculi sunt”. Sermo. XXII, in Ps. CXVIII) ». Se tale era siffatto pericolo per uomini maturi d’anni, quanto grande ei non sarebbe agli occhi di sì grande Dottore per giovinetti la cui tenera anima, e senza difesa, tutte le impressioni riceve con una facilità eguale alla fedeltà con cui essa le conserva? Vi citerò io San Giovanni Grisostomo, il quale così si esprime : « Non voglio che si diano ai giovinetti, per prime lezioni, le favole della mitologia…. Cominciate con l’imprimere nell’anima loro i principi della vera sapienza: voi non guadagnerete mai tanto ad insegnar loro le scienze profane che li condurranno alla fortuna, quanto ad insegnar loro la scienza che farà ad essi disprezzar la fortuna (Homil. xxi, in epist. ad Ephes.) ». – Alcune famiglie, allontanandosi da tali regole fortunatamente rispettate dal gran numero, il Santo Dottore le avverte in questi termini: « La prima età, voi dite, è quella dell’ignoranza; sì, e non vedete voi che ciò che la rende più profonda e più pericolosa, si è l’uso che avete di darle per suoi primi libri le storie di quegli eroi antichi che le si insegna ad ammirare, sebbene fossero ingolfati in tutte le passioni? Noi raccogliamo il frutto di simile educazione, la quale tende a popolare la società d’uomini sbrigliati; senza freno e senza costumi, avvezzi a trascinarsi nel fango del vizio (In epist. ad Eph. Homil. xxi, a. 1 et 2 opp,, t. xi, p. 183.)». San Basilio è ancor più formale di San Crisostomo. Egli vuole che i giovani prendano per punto di partenza i principi cristiani, onde giudicare sanamente delle parole, degli atti e delle massime dei pagani; il che suppone evidentemente una grande cognizione della religione, anteriormente acquistata. Soggiunge che la lettura degli autori profani è supremamente pericolosa, perché essa predica il sensualismo ed insegna ad ammirare uomini virtuosi soltanto in parole. – Ma la testimonianza di San Gerolamo è più esplicita e più grave di tutte quelle che avete sentite. Insieme con Sant’Agostino egli è forse il Padre della Chiesa che ha maggiormente studiato, che ha meglio conosciuto e più giustamente apprezzato le opere pagane, nonché il pernicioso influsso che esse possono esercitare. Scrivendo al Papa San Damaso, esso pure molto versato nelle lettere latine, gli cita il testo di San Paolo: Non abitate nel tempio degli idoli; poi grida: « E non sentite voi il gran Paolo che vi dice in altri termini: « Non leggete né i filosofi, né gli oratori, né i poeti pagani; non vi riposate in su lo studio delle loro opere. Non ci rassicuriamo pel motivo che non crediamo punto alle cose che leggiamo. Egli è un delitto il bere ad un tempo al calice di Gesù Cristo ed al calice dei demoni (Epist. ad Damas. De duobus filiis.) ». In altri termini, il paganesimo ed il Cristianesimo sono inconciliabili: l’uno si è il sensualismo, l’altro lo spiritualismo; l’uno predica tutto quello che l’altro condanna. Nulla esser vi può di comune tra Gesù Cristo e Belial (Id. ad Eustoch. Oc custodiend. virginit., opp. t. IV, Ep. xvm, p. 12.). – « Io stesso ho voluto fare, dice altrove, questa pericolosa prova, ed ecco gli amari frutti che ne raccolsi. Da vari anni avevo lascialo la paterna casa, mi era privato della società dei miei parenti, di mia sorella e dei miei amici; e, ciò che è più difficile, avevo rinunciato all’uso dei cibi delicati; tutto questo per guadagnarmi il Cielo. Avendo l’intenzione di recarmi a Gerusalemme per combattere le battaglie del Signore, non potevo far senza la biblioteca che mi avevo composto in Roma con estrema cura e con pena infinita. Perciò, disgraziato ch’io sono! mi privavo di tutto, digiunavo per leggere Cicerone. Dopo le frequenti veglie delle mie notti, dopo abbondanti lacrime versate in ricordanza dei miei passati errori, prendevo Plauto tra mani. Se talvolta, ritornando in me, provavo a leggere i Profeti, il loro stile incolto mi faceva orrore: e siccome i miei occhi infermi non scorgevano la luce, io credeva che la colpa non fosse dei miei occhi, ma sì del sole. « Mentre ero per tal guisa lo zimbello dell’antico serpente, fui di repente rapito in spirito e trascinato al tribunale del Supremo Giudice. Tale era la purezza della luce che usciva dalla sua Persona, nonché dagli Angeli dai quali Egli era circondato, che io rimasi prostrato contro terra senza osare di alzare gli occhi. Interrogato sulla mia condizione, risposi che ero cristiano. « Tu mentisci, replicò il Giudice; tu sei ciceroniano, e non cristiano; poscia ché colà dove è il tuo tesoro, ivi pure è il tuo cuore. » A queste parole, io mi tacqui, e il Giudice ordinò fossi percosso, ed i colpi che riceveva mi erano meno crudeli dei rimorsi dai quali era la mia coscienza lacerata. Mi rammentai di questa parola del profeta: Chi potrà lodarvi nell’inferno? Tuttavia co- minciai a gridare e a dire singhiozzando: « Signore, abbiate pietà di me! » Finalmente coloro che attorniavano il tribunale gittaronsi ai piedi del Giudice e Gli chiesero grazia per la mia giovinezza, e tempo per fare penitenza del mio errore, dicendogli che mi sottometteva al supplizio se mai ritornassi alla lettura degli autori pagani. Io stesso, in quella estremità, faceva promesse ancora più grandi; giurai, invocando il nome di Dio, che se mai m’accadesse di conservare libri pagani, volevo esser tenuto quale un apostata. – « Appena pronunciato questo giuramento sono rilasciato, e ritorno in me stesso. Con grande stupore di quei che mi attorniavano apro gli occhi talmente molli di pianto, che ciò solo bastava a provare agli increduli la violenza del dolore che avevo sofferto. Non fu già quello un sogno od un vano parossismo, come quelli che talvolta si provano. Ne prendo a testimonio quel tribunale innanzi cui ero prostrato, ne prendo a testimonio la formidabile sentenza che mi agghiacciò di spavento. Perciò non mi accadrà mai più di espormi a subire una simile tortura, in cui mi ebbi le spalle afflitte da colpi dei quali provai a lungo il dolore, e dopo la quale studiai le Sacre Scritture con altrettanto ardore quanto n’avevo impiegato a studiare prima le opere profane (“Nec vero sopor il le fuerat, aut vana somnia, quibus sæpe deludimur. Testis est tribunal illud, ante, quod jacui; testis iudicium triste, quod limui: ita mihi uunquam contingat in lalem incidere quaestionem , liventes habuisse scapulas, plagas sensisse post somnum, et tarilo dehinc studio divina legisse, quanto non ante mortalia legeram”. Ad Eustoch., De custod. virginit., cp. XVIII, opp. IV, p. 43. Prolegom, in Daniel., et ad Pammach.) ». – Il santo Dottore fu fedele al suo giuramento. Non solo non gli accadde più di leggere alcun autore pagano, ma ei temette eziandio di citarne i passi che gli ritornavano naturalmente alla memoria. A coloro che gli dicevano ciò che oggidì si ripete, cioè che senza la cognizione di quegli autori, non si potrebbe ben parlare né ben scrivere, ei rispondeva: « Quanto voi ammirate, ed io lo disprezzo; e lo disprezzo poiché gustai la follia di Gesù Cristo: e la follia di Gesù Cristo, sappiatelo bene, è più sapiente di tutta quanta l’umana sapienza ».
CAPITOLO IX
SEGUITO DEL PRECEDENTE .
Sentiamo ora Sant’Agostino. Verun Padre della Chiesa adoprò mai tanìa forza e perseveranza a combattere il deplorando uso dei classici pagani quanto codesto ammirabile Dottore, il cui cuore così bello come l’ingegno voleva ad ogni costo preservare i giovanetti da un pericolo in cui ei medesimo aveva trovato miseramente la propria perdita. Ei comincia con indicare il motivo pel quale i suoi parenti gli facevano studiare i pagani autori; è esattamente lo stesso motivo che è allegato oggidì. « Mi si diceva, ei scrive, è colà che s’impara il bel parlare; è colà che si attinge l’eloquenza sì necessaria per persuadere e per esporre vittoriosamente i l proprio pensiero (1Conf., lib V) ». Ora ci dimostra con un esempio non solo la frivolezza, ma eziandio il pericolo di simile motivo. « E che! dice, non conosceremmo noi queste parole pioggia d’oro, girone, belletto, se Terenzio non ci parlasse d’un giovine dissoluto che si proponeva lo stesso Giove per modello di un’infamia? No, non è coll’imparare siffatta turpitudine che noi impariamo tali parole, ma con tali parole s’impara a commettere con maggiore coraggio simile infamia ». – Quindi, pieno di dolore e di indignazione, grida: « Guai a te, torrente del costume! Chi arresterà i i tuoi guasti? Quando sarai tu disseccato? E sino a quando trascinerai tu i figliuoli di Eva in quel mare immenso, formidabile, che appena traversano i meglio armati? Non è forse questa bella scienza della fàvola quella che ci mostra un Giove tuonante e adultero? È una finzione! gridano tutti i maestri. Finzione sinché vi piacerà; ma questa finzione fa che i delitti non sono più delitti, e che commettendo simili infamie si ha aria d’imitare non già uomini perversi, ma gli Dei immortali. « Eppure, oh fiume infernale! Si è coll’esca delle ricompense che s’imbarcano i figliuoli degli uomini sulla corrente dei tuoi fiotti per fare imparar loro di tali cose! lo non accuso le parole che sono vasi preziosi ed innocenti, ma sibbene il vino dell’errore e del vizio che ivi ci era presentato da maestri ubriachi; e se noi non bevevamo, eravamo percossi senza che ci fosse stato permesso di richiamarcene ad un giudice sobrio…. e poiché io imparava di tali cose con piacere, chiamavanmi giovinetto di grandi speranze (Conf. Lib. I c. 16) ». – Virgilio stesso, il più casto dei poeti latini, fece profonde ferite alla sua anima. « Io imparai, dice, studiandolo, molte utili parole che avrei altrettanto bene imparato leggendo cose men vane; ma inoltre imparai le avventure di non so quale Enea, e dimenticai i miei propri errori. Imparai a compiangere Didone, che s’era uccisa per aver troppo amato; ed io stesso, trovando la morte nel leggere quelle colpevoli follie, non avevo per me alcuna lacrima negli occhi. Quale deplorabile induramento! Se si voleva privarmi di cosiffatta lettura, piangevo di non aver nulla a piangere; ed una tale demenza chiamavasi le belle lettere! (“Talis dementia honestiores et uberiores littere putantur. Ibid. ib. c. 13.) ». – E voi, o maestri, professori, reggenti, i quali, anche ai dì nostri fate un caso capitale dello studio di ciò che voi chiamate la bella latinità; i quali non temete punto di proporre qual modelli Orazio, Catullo, Terenzio, ben più pericolosi che Virgilio non è; i quali date nota di barbaro a quanto non reca il suggello del loro linguaggio, sentite come Sant’Agostino giudica la vostra condotta: « Mi si faceva tenere quale una cosa capitale, a cui ero forzato applicarmi colla speranza delle ricompense o col timore dei castighi, l’imparare le parole piene di dolore e di collera di Giunone, impossente ad impedire Enea di approdare in Italia. Eravamo obbligati a dire in prosa alcune delle cose che il poeta aveva detto in verso: ed il più applaudito era colui che meglio avesse finto la collera ed il dolore di quella Dea immaginaria. Guardate, o Signore, mio Dio, guardate quale importanza i figliuoli degli uomini danno a sillabe e a lettere, ed ei dimenticano i vostri precetti! Di tal che biasimano più volentieri colui che avrà mancato di emettere un’aspirazione nel pronunciare una parola, che non colui che non avrà temuto di infrangere la vostra legge. Ve egli a stupirsi che tutte queste vanità mi abbiano allontanalo da voi, o mio Dio? Poiché non si cessava di proporre alla mia imitazione uomini che non si tralasciava di coprire di ridicolo, se, nel riferire le azioni loro, d’altra parte irreprensibili, essi avevano la disgrazia di commettere un barbarismo od un solecismo; mentre essi erano colmati di lodi allorché avevano l’ingegno di raccontare le infamie loro in un idioma corretto ed elegante? (Ibid. c. XVIII) ». – Quali furono pel giovine Agostino i frutti di questa educazione, così perfettamente simile alla nostra? Quelli che esser dovevano, quelli che saranno sempre: il predominio del sensualismo, l’indebolimento dello spiritualismo; in altri termini, l’immoralità precoce e il disgusto delle cose di Dio. « Quando io fui più innanzi negli anni, dice ei medesimo, mi proponeva di leggere le Scritture affin di sapere che si fossero. Ma io non era capace di penetrarne il senso; il mio orgoglio non si voleva sottomettere alle loro lezioni. Lo stile, i pensieri, tutto mi sembrava indegno d’essere paragonato alla maestà di Cicerone. La gonfiezza del mio spirito non poteva affarsi al loro linguaggio; il mio occhio non penetrava la profondità dei loro pensieri. La sapienza che vi si fa sentire è quella che si compiace coi pusilli; ed io non voleva essere pusillo: ed ebbro di me stesso, mi credeva qualche cosa ben grande (lib. III, c. 5). – Non dimentichiamo, la Storia d’Agostino è più o meno la storia di tutti i giovani; la storia del suo cuore è la storia del cuore umano. Dovremo dunque stupirci se sentiamo un sì grand’uomo alzare la sua voce possente e gridare a tutti i secoli: « Istruire i giovinetti con libri pagani non è solamente un insegnar cose inutili, ma eziandio un toglierli al Cielo e sacrificarli al demonio. Che sono mai tutte queste cose, se non vento e fumo? Non v’ha dunque altro modo di coltivare lo spirito e di formarlo all’eloquenza? Le vostre lodi, o Signore, con tanta eloquenza cantate nelle Scritture, avrebbero innalzato, raffermato il mio debole cuore, e l’avrebbero trattenuto dal diventare preda degli augelli impuri. Ah! vi è più di un modo di sacrificare l’uomo ai demoni. È dunque così che ei conviene educare i giovani? Sono eglino questi i modelli che loro si debbono presentare? Così operando, voi non offrite già né augelli, né animali, e nemmeno sangue umano; ma, ciò che è ben più abominevole, si è l’innocenza della gioventù che voi immolate sugli altari di Satana (Ib., et Epist. Ad Nectarium.) ». – Poi, ad un tratto, vedendo la triste condizione dei giovinetti, che sì crudelmente vengono rapiti a Dio, prende a piangere, e grida: « Voi vedete ciò, o Signore, e Voi vi tacete, Voi che siete pieno di longanimità, di misericordia e di verità. Ma tacerete voi sempre? Non ritrarrete voi da questi pozzi dello abisso anime che sono fatte per voi e che han sete del vostro amore? ». Aggiungiamo che uno dei più amari rimorsi di sì gran Santo quello si fu d’avere ei medesimo insegnato retorica conforme al metodo pagano, e d’aver corrotto così, materializzandolo, il cuore dei suoi discepoli. – Per evitare le ripetizioni, io non ritornerò sul proposito delle autorità del medio-evo. Noi abbiamo veduto che durante cotale età la solenne proscrizione dei classici pagani era una legge generale e fedelmente osservata. Citerò solo la lettera di San Gregorio il Grande a Desiderio, vescovo di Vienna nel Delfinato. Dimenticando la proibizione fatta dall’immortale pontefice a tutti i vescovi d’insegnare ai giovani la pagana letteratura, Desiderio aveva infranto quell’ordine che a ragione riguardavasi come importantissimo. Gregorio, avendolo saputo, gli scrisse nei termini seguenti: « Ci fu fatto sapere (il che non possiam rammentarci senza arrossire) che Vostra Fraternità insegna la grammatica a taluno. Simile cosa ci cagionò tanto dolore ed eccitò nell’anima nostra un così profondo disgusto, che le buone notizie che avevam ricevuto di voi si sono mutate in gemito e in dolore; poiché le lodi di Giove non potrebbero trovarsi nella bocca stessa colle lodi di Gesù Cristo. Considerate quale delitto, quale mostruosità non è mai il rinvenire in vescovi ciò che non si addice nemmeno ad un laico religioso. Ora, sebbene il nostro carissimo figliuolo, il sacerdote Candido, sia qui venuto dopo che ci fu annunziata tale nuova, e quantunque essendo egli stato accuratamente interrogato, abbia negato il fatto, e cercato di scusarvi eziandio, noi continuiamo tuttavia ad essere inquieti; e quanto più ella è cosa orribile il narrare tali cose di un sacerdote, tanto più noi amiamo sapere di certa scienza se elleno sono vere o no. Se dunque ci sarà dimostrato che quanto ci fu riferito è falso, e che voi non sciupate il tempo nell’occuparvi di bagattelle e di lettere profane, noi renderemo grazie a Dio il quale non ha permesso che il cuor vostro fosse macchiato dalle lodi blasfematorie d’uomini indegni di questo nome (Epist., lib. XI, cp. 54, opp. t. III, p. 1171, edit. novis.) ». In questa sì energica lettera, è l’insegnamento degli autori pagani ai giovani, quale è dai Padri della Chiesa indicato, che è condannato? No, poiché San Gregorio stesso lo approva altrove e poiché esso era praticato, come vedemmo, nelle scuole del medio-evo. Ciò che è condannato si è l’insegnamento della letteratura pagana, dato da un vescovo e dato ai fanciulli; il che è inescusabile, soggiunge il Pontefice, anche in un laico sinceramente religioso, cioè che capisce e la santità del cristiano e l’influsso fatale degli studi pagani sovra anime senza esperienza. – A questa lunga catena tradizionale aggiungiamo un ultimo e brillante anello. Verso la metà del sedicesimo secolo, nel momento in cui il paganesimo risuscitato nella educazione invadeva Europa, uno di quegli uomini sapienti, quali l’illustre Società di Gesù non cessò mai dal produrre, il Padre Possevino, tremante per lo avvenire, faceva sentire queste energiche parole: « Un antico ha détto: « l’educazione non è poca cosa, essa è tutto; essa è l’uomo, la società, la religione ». E questo ha detto in un libro in cui egli rivela alle nazioni il segreto di loro grandezza e di loro rovina (Non parum sed totum est, qua quisque disciplina imbiutar a puero. Arist. Politic.). Infatti, noi vediamo che gli Ebrei, sebbene abitanti in mezzo di Roma, sebbene per la loro stessa dispersione siano vivente prova dello adempimento delle profezie e delle minacce di Nostro Signore contro Gerusalemme e contro la Sinagoga; sebbene abbiano tutto dì sotto gli occhi gli archi di trionfo di Tito e di Vespasiano, monumenti eterni di loro rovina; sebbene siano convinti da ogni sorta di prova dell’abolizione della legge loro, non si convertono. E perché? Perché sino dalla fanciullezza essi hanno ricevuto col latte il veleno dell’errore. Lo stesso vediamo nei Turchi, quali tutti rimangonsi ostinati nella loro superstizione e nelle loro insostenibili credenze. Ancora, perché? Perché l’educazione ha, per dir così, ribadito loro nel capo le false opinioni dei padri loro. « Quale pensate voi dunque essere la cagion formidabile che oggi precipita gli uomini nello abisso del sensualismo, della ingiustizia, della bestemmia, dell’empietà, dell’ateismo? Si è, nonne dubitate, che sin dalla fanciullezza si insegnò loro di tutto, eccetto la religione; si è che nei collegi, semenzaio degli Stati, loro si fece leggere e studiare di tutto, eccetto gli autori cristiani. Se vi si parla di religione, codesto insegnamento va unito coll’insegnamento impuro del paganesimo, vera perdita dell’ anima. A che mai può servire, io vi chiedo, il versare in una vasta botte un bicchiere di vino puro, delizioso, ben fatto, ed il versarvi in egual tempo torrenti di aceto e di vino guasto? In altri termini, che significa egli un po’ di catechismo per settimana coll’insegnamento giornaliero delle impurità e delle empietà pagane? Ecco però quanto si fa nel secolo nostro da un capo d’Europa all’altro! « Volete voi salvare la vostra repubblica? Mettete senza ritardo la scure alla radice del male; esiliate dalle scuole vostre gli autori pagani, i quali, col vano pretesto di insegnare ai figliuoli vostri la bella lingua latina, insegnano loro la lingua dell’inferno. Li vedete! Appena usciti di fanciullezza essi si danno allo studio della medicina o delle leggi, od al commercio, e ben presto dimenticano il po’ di latino che hanno imparato. Ma non dimenticano già i fatti, le massime impure da loro lette nei profani autori e da essi imparate egregiamente. Così fatte rimembranze rimangono loro talmente scolpite nella memoria, che per tutta la loro vita amano meglio leggere, dire, sentire cose vane e disoneste che non cose utili ed oneste: somiglianti a stomachi infermi, essi tosto rigettano i salutiferi insegnamenti della parola di Dio ed i sermoni e le religiose esortazioni che più tardi loro sono indirizzate (Ragionamento del modo di conservare lo Stato e la libertà ai Lucchesi.) ». L’eloquente scrittore chiede indi che cosa bisogni sostituire agli autori pagani, e risponde che fa d’uopo ritornare all’antico uso dei classici cristiani, uso praticato nelle università e nelle scuole del medioevo; uso approvato, comandato da Dio stesso, dai Padri, dai Concili e da mille altre ragioni; uso che consiste nel porre tra mano ai giovinetti gli Atti dei martiri, le Vite dei santi, la Scrittura e i Padri; dopo di che, sotto la direzione di maestri illuminati e cristiani, potrà la gioventù non solo senza pericolo, ma ancora con profitto studiare gli autori profani e giudicar sanamente delle loro dottrine, paragonandole alle dottrine cristiane delle quali sarà stata nutrita. Per rendere pratici questi salutari consigli e per opporre un argine qualsiasi al torrente del male, un confratello del Padre Possevino, il venerabile Canisio, fece stampare le lettere di San Gerolamo, ad uso delle scuole. Bisogna dirlo; questa raccolta, adottata in un grandissimo numero di ginnasi e di collegi sì in Alemagna sì nel resto d’Europa, ritardò l’invasione del paganesimo. – Che dirò ancora? La Chiesa stessa fece sentire la sua gran voce e vietò espressamente di porre tra mano a giovanetti i libri pagani. A questo nuvolo di testimonianze, facil cosa sarebbe aggiungerne altre molte. Quelle che hanno deposto sembra che bastino per darmi diritto di chiedere se v’ha nella storia un fatto meglio provato della riprovazione quindici volte secolare del paganesimo nella educazione; se non v’ha presunzione né imprudenza nel non far caso alcuno degli avvertimenti solenni della sapienza, del senno, dell’ esperienza e della virtù; se agli occhi dei Padri della Chiesa e dei Pontefici il paganesimo classico non è se non una semplice forma, una forma innocente, una forma la quale non ha alcun sinistro influsso sulla gioventù, e dalla gioventù sulla letteratura, sulle arti, sulla filosofia, sulle scienze, sulla religione, sulla famiglia, sulla società; in una parola, sull’universo procedere delle cose umane?

 Rus Cassiciacum
Rus Cassiciacum