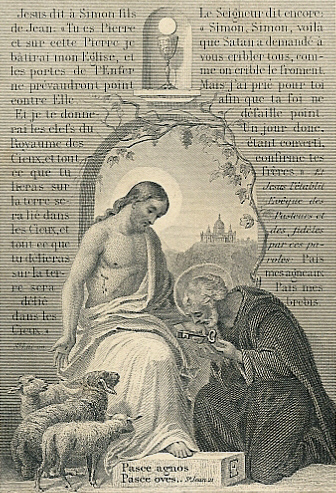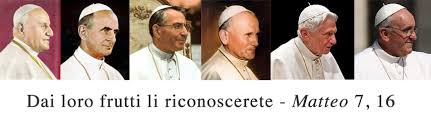DOMENICA VIII dopo PENTECOSTE (2018)
Incipit
In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
Introitus Ps XLVII: 10-11.
Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam in médio templi tui: secúndum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terræ: justítia plena est déxtera tua. [Abbiamo ricevuto, o Dio, la tua misericordia nel tuo tempio; la tua lode, come si conviene al tuo nome, si stende fino alle estremità della terra: la tua destra è piena di giustizia.]
Ps XLVII: 2. Magnus Dóminus, et laudábilis nimis: in civitate Dei nostri, in monte sancto ejus. [Grande è il Signore, e degnissimo di lode nella sua città e nel suo santo monte.]
Ps XLVII: 10-11 Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam in médio templi tui: secúndum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terræ: justítia plena est déxtera tua. [Abbiamo ricevuto, o Dio, la tua misericordia nel tuo tempio; la tua lode, come si conviene al tuo nome, si stende fino alle estremità della terra: la tua destra è piena di giustizia.]
Oratio
Orémus.
Largíre nobis, quǽsumus, Dómine, semper spíritum cogitándi quæ recta sunt, propítius et agéndi: ut, qui sine te esse non póssumus, secúndum te vívere valeámus. [Concedici propizio, Te ne preghiamo, o Signore, di pensare ed agire sempre rettamente; cosí che noi, che senza di Te non possiamo esistere, secondo Te possiamo vivere.]
Lectio
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános.
Rom VIII:12-17
Fratres: Debitóres sumus non carni, ut secúndum carnem vivámus. Si enim secúndum carnem vixéritis, moriémini: si autem spíritu facta carnis mortificavéritis, vivétis. Quicúmque enim spíritu Dei aguntur, ii sunt fílii Dei. Non enim accepístis spíritum servitútis íterum in timóre, sed accepístis spíritum adoptiónis filiórum, in quo clamámus: Abba – Pater. – Ipse enim Spíritus testimónium reddit spirítui nostro, quod sumus fíli Dei. Si autem fílii, et herédes: herédes quidem Dei, coherédes autem Christi.
“Fratelli, noi non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne; perché se vivrete secondo la carne, voi morrete: ma se con lo spirito avrete mortificato la carne, vivrete. Perché, quanti sono guidati dallo Spirito di Dio, sono figliuoli di Dio. E’ vero, voi non avete ricevuto di nuovo lo spirito di servaggio a timore; ma avete ricevuto lo spirito di adozione, nel quale diciamo: Abba! Padre! Poiché lo stesso Spirito rende testimonianza allo spirito nostro, che noi siamo figliuoli di Dio. Se poi siamo figliuoli, siamo altresì eredi: eredi cioè di Dio, ma coeredi di Cristo „.
La dottrina contenuta in questi sei versetti, l’altezza delle idee, la forma del dire ed il contorno dei periodi vi dicono senz’altro, che questo tratto dell’Epistola appartiene all’Apostolo Paolo; e veramente si legge nel capo ottavo della sua lettera ai Romani. Questa lettera tra le quattordici lasciateci dall’Apostolo è la principale per la copia e profondità della dottrina dogmatica e morale ed anche per l’ampiezza dello svolgimento, e fra i sedici capi, onde consta la lettera, questo, a mio giudizio, tocca la massima altezza per ciò che spetta la natura e gli effetti della rigenerazione operata da Cristo. – Dopo aver toccata la felice condizione dei rigenerati in Cristo, raffrontati a quelli che vivono nella carne, afferma che in essi abita lo Spirito Santo, e che esso un giorno li risusciterà come già risuscitò Gesù Cristo. Qui o cari, comincia il testo, che devo interpretare e che domanda tutta la vostra attenzione. – “ Fratelli, noi non siamo debitori alla carne, per vivere secondo la carne. „ L’Apostolo, lo sapete, con la parola carne indica l’uomo vecchio, l’uomo del peccato, l’uomo corrotto, l’uomo schiavo delle passioni, le quali hanno la loro radice principalmente nella carne, e perciò lo chiama semplicemente carne: con la spirito significa l’uomo nuovo, l’uomo della grazia, l’uomo rigenerato nel Battesimo, l’uomo che segue lo spirito di Cristo, e perciò lo chiama spirito. Il Battesimo mette in noi la grazia, che cancella il peccato, depone in noi un germe nuovo, una forza, una vita nuova, che è la partecipazione della vita stessa di Cristo, ma non distrugge le conseguenze o pene del peccato, e lascia sussistere accanto al nuovo uomo il vecchio, accanto alla grazia la concupiscenza, accanto allo spirito di Cristo, la carne con le sue passioni, e ciò ad esercizio della virtù. Vedeste mai, o dilettissimi, spuntare una pianta gentile, una vaga rosa, un candido giglio in mezzo ad un terreno pantanoso? È un’immagine del Cristiano, esso ha in sé la grazia di Gesù Cristo, pianta gentile che germoglierà la rosa ed il giglio; ma la terra, in cui sorge e tiene le radici, è un pantano, che spesso esala miasmi pestilenziali, è il nostro corpo, la nostra natura corrotta, nella quale si annidano le più sozze passioni. Che dobbiamo far noi? Ciò che fa l’industre giardiniere: egli non guarda al pantano, non l’ama, non vi mette il piede, che vi s’imbratterebbe, non se ne cura, anzi ne torce lo sguardo, rimira e vagheggia con occhio di compiacenza la rosa ed il giglio e circonda la pianta di tutte le sue cure amorose. – Similmente noi pure, o dilettissimi. Gesù Cristo ha posto in noi, come dicevo, la sua grazia: col santo Battesimo a Lui ci siamo dati e gli abbiamo fatta solenne promessa di vivere come Lui, di seguire il suo spirito e di combattere il mondo, il demonio e la carne. Che cosa dobbiamo noi alla carne? Quali benefici ci ha essa fatti? Quali benefici possiamo aspettarci? Nessun beneficio ci ha fatto, né ci può fare, ed ogni male passiamo da essa temere. Dunque “non viviamo secondo la carne: „ – “Debitores sumus non carni, ut secundum carnem vìvamus.” La carne ci invita, ci trae a seguire la vanità, ad accumulare ricchezze, a mangiare e bere senza misura, a poltrire nell’ozio, ad odiare chi ci ha offesi, a vendicarci, a sfogare le basse voglie del senso e andate dicendo; no, non seguitiamo la carne per questa mala via; essa non ha diritto alcuno che noi la seguitiamo, e mal per noi se lo facessimo. E perché? – Perché esclama S. Paolo, “se vivrete secondo la carne, morrete: „ “Si enim secundum carnem vixiritis, morìemini”. Termine ultimo ed infallibile delle malnate vostre passioni soddisfatte, sappiatelo bene, sarà la morte. Qual morte? La morte dell’anima e con quella dell’anima, la morte altresì del corpo nell’eterna perdizione. Chi di voi non ha orrore della morte? Chi di voi non la fugge a tutto potere? Che non fareste voi per sottrarvi al suo braccio di ferro? Ebbene: non vivete secondo la carne, combattete virilmente le sue malvagie passioni e non sarete preda della morte. – No, noi non vivremo secondo la carne, come ci intimate voi, o grande Apostolo: come dunque vivremo? secondo qual legge? Udite: ” Se con lo Spirito avrete mortificate le opere della carne, vivrete: „ Si autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis. Comprendeste, o cari? Armati dalla grazia divina, come d’una spada a due tagli, avvalorati dalla forza dello spirito in noi infuso mercé del Battesimo e degli altri Sacramenti, dobbiamo rintuzzare le opere della carne, cioè le male cupidigie, che pullulano nella carne, ed allora vivremo, cioè avremo la vita eterna dell’anima e a suo tempo quella del corpo. Lo so, che il raffrenare e il castigare le perverse voglie della carne, cagiona assai volte dolori acutissimi, e la natura nostra fieramente si rivolta, né sa rassegnarsi a certi tagli crudeli; ma se vogliamo vivere è forza sottomettersi: Si spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis. – Un infelice è minacciato di gangrena in un braccio, in un piede o in altra parte del corpo: si chiamano i più valenti chirurghi: esaminano, si consultano tra loro e dichiarano unanimi, essere necessario il taglio. L’infermo impallidisce e domanda ansioso se non v’è altro rimedio. No, rispondono gli uomini della scienza: o il taglio e prontamente, o la vita. – Il misero s’arrende e lascia che il ferro penetri profondamente nelle carni, e recida senza pietà le parti cancrenose, vi dica Dio con quale atroce spasimo. – Quello sventurato trova, nella sua volontà e nel timore della morte e nel desiderio della vita temporale, la forza bastevole per sottomettersi al ferro ed al fuoco, e soffrire strazi indicibili e talora inutilmente; e noi nella nostra volontà sostenuta e rinvigorita dalla grazia divina, nel timore della morte e nel desiderio della vita eterna, non troveremo la forza necessaria per isvellere quella triste abitudine, per sbarbicare quel turpe amore, per recidere quella scellerata passione, che quasi cancro rode e va spegnendo la vita della misera anima? Che il timore della morte eterna e l’amore della vita eterna siano meno efficaci sul nostro cuore, del timore della morte temporale e dell’amore della vita temporale? Se così fosse, noi saremmo pessimi ragionatori. – Se voi seguirete, così l’Apostolo, se voi seguirete non gli appetiti della carne, ma lo spirito, ossia la grazia di Gesù Cristo, non solo non morrete, non solo avrete la vita, ma quella vita che è propria dei figli di Dio. Perché quanti sono guidati dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio: „ “Quicumque enim Spiritu Dei aguntur, ii sunt filli Dei”. Questa espressione dell’Apostolo è molto forte e in alcuno può far sorgere il timore, che corra pericolo la nostra libertà; se siamo mossi dallo Spirito di Dio, si dirà, è tolta la libertà nostra, e se questa è tolta, è tolta la ragione del merito e della pena, e tra noi ed i bruti non corre differenza alcuna. Non temete, o cari, che lo Spirito di Dio tolga o scemi la nostra libertà; Esso non solo la rispetta, ma la sorregge e l’aiuta, perché sta scritto, che dove è lo Spirito di Dio, ivi è la libertà. – Il vento agita e muove l’albero; il sole muove intorno sé la terra ed i pianeti; il pilota guida dove e come vuole la sua nave, il cocchiere i suoi cavalli: è forse così che Dio con il suo Spirito muove le nostre volontà? No, per fermo; se così le muovesse, la libertà nostra sarebbe annientata: l’albero non può non muoversi sotto il soffio del vento, la terra ed i pianeti non sono liberi di seguire il sole, la nave non può resistere al pilota, ed i cavalli sono costretti ad ubbidire al freno. Come, dunque le nostre volontà sono mosse dalla grazia, eppure rimangono libere? Come! Un giorno vostro padre e vostra madre vi dissero: Figliuoli! voi non andrete nel tal luogo dove correreste pericolo; voi attenderete allo studio ed andrete alla scuola; voi non piglierete il tal cibo e la tal bevanda, ma quello che vi sarà dato ed all’ora per voi stabilita, e tutto ciò per il vostro bene. Se non lo farete, mal per voi; se lo farete, noi, vostri genitori ne gioiremo e ne avrete la giusta mercede. E voi che faceste? Per il timore del castigo, per l’amore dei vostri genitori, seguiste il consiglio, faceste il loro volere, vi lasciaste guidare dal loro spirito. Perdeste voi la vostra libertà? No, sicuramente. Potevate fare il contrario di ciò che vi era da essi consigliato o comandato? Chi ne dubita? E forse in parte lo faceste ed ora ne provate rimorso. Il somigliante avviene rispetto a Dio, Padre nostro. Ci fa conoscere ciò che dobbiamo sfuggire e ciò che dobbiamo fare: ci mostra la via del male e ci dice: “Non camminate per questa”; ci mostra la via del bene e ci dice: “Ti metti per questa”. Poi infonde nell’anima nostra la forza necessaria perché facciamo ciò che ci comanda, ma non ci costringe e ci lascia, come dice la Scrittura santa, in mano del nostro libero arbitrio. Dio dunque si muove, come si può muovere una volontà libera; ci muove come voi potete muovere la libertà d’un amico, dei vostri figli mostrando loro la verità, eccitandoli, esortandoli, minacciandoli, pregandoli, allettandoli ed in cento altri modo studiandovi di far sì che le loro volontà seguano la vostra (corre una gran differenza tra la nostra azione e quella di Dio: noi non possiamo agire sugli altri che in modo esterno, doveché Dio agisce esternamente ed internamente; esternamente illumina la mente ed internamente muove la volontà e la avvalora secondo i bisogni). Forse che voi costringete e fate violenza alla loro volontà? E ciò che fa Dio con noi con la sua grazia e voi potete comprendere, che essa non nuoce, ma giova alla libertà, come il vostro consiglio ed il vostro comando e i vostri eccitamenti giovano al bene de’ vostri figliuoli. – In quanto siamo mossi e guidati dallo Spirito di Dio, “siamo figli di Dio, „ scrive san Paolo: Quicumque Spiritu Dei aguntur, ii sunt fillii Dei”. È questa una dottrina altissima, che ha bisogno d’essere ben compresa, e a ben rischiararla, userò d’una similitudine. Un padre, modello d’ogni virtù, ha due figli: l’uno è la copia fedele del padre, come lui pio e virtuoso; l’altro è il rovescio, superbo, iracondo, invidioso, dissoluto, senza fede, viziosissimo. Sono entrambi figli dello stesso padre? Indubbiamente, perché entrambi da lui hanno ricevuta la vita e secondo l’ordine naturale, rispetto alla vita umana, sono fratelli e fratelli, li dice il popolo. Ma secondo la vita morale sono essi fratelli e figli dello stesso padre? Certamente, no, e il padre nel suo dolore più volte va esclamando: Ah! tu non sei mio figlio; e il popolo lo conferma, ripetendo: Questo non è figlio di quell’ottimo padre. Che differenza passa tra i due figli? Il primo ha in sé non solo la vita naturale del padre, ma anche la parte migliore di lui, la vita morale: ha in sé lo spirito del padre, è mosso e guidato dallo stesso spirito, si dice ed è perfettamente suo figlio. Il secondo ha dal padre la vita naturale, come il fratello, ma non ha la parte migliore, la vita morale, non ha lo spirito del padre, non è mosso, né guidato dallo stesso spirito, e perciò si dice che per questo rispetto non è figlio del padre. Così noi tutti siamo opera di Dio creatore, tutti riscalda un Dio redentore, e come tali tutti egualmente siamo figli di Dio; ma se la nostra condotta non è quale si conviene ai figli di Dio, se lo Spirito di Dio non ci muove e non ci guida, a ragione si deve dire che non siamo figli di Dio. Guardando alle opere nostre, ai pensieri, agli affetti, onde si informa il nostro spirito, troviamo noi d’essere simili a Dio e figli di Dio, perché mossi ed informati del suo Spirito? Se, si, rallegriamoci e ringraziamone il buon Dio; se, no, facciamo del nostro meglio per essere tali almeno in avvenire. – “E veramente, voi non avete ricevuto di nuovo lo spirito di servaggio a timore”; è questa la sentenza che segue la spiegata e la rincalza. Noi siamo figli di Dio, guidati dal suo Spirito; e come potrebbe essere altrimenti? dice l’Apostolo. Noi, uomini della nuova legge, discepoli di Gesù Cristo, non abbiamo ricevuto lo spirito della legge antica, lo spirito di quella legge e quello spirito era proprio, non di figli, ma di servi, non di figli che amano il padre, ma di servi che temono il padrone. Che vuol dir ciò, o carissimi? L’indole e lo spirito della legge mosaica era quello di incutere timore con le pene gravissime temporali e con esse frenare le passioni e metterle in orrore il peccato, onde quella legge riguardava soltanto le opere esterne e non poteva, se non indirettamente, esercitare l’azione sua sull’interno e formare il cuore. Gli Ebrei servivano a Dio più per timore che per amore, erano più servi che figli; ma noi, dice S. Paolo, siamo informati ad un’altra scuola: lo spirito che abbiamo ricevuto, quello di figli adottivi di Dio; è tale spirito che ci diritto di chiamare Iddio col dolce nome di Padre: “In quo clamamus: Abba, Pater”. Dio Padre, per opera dello Spirito Santo congiunse la Persona del Figliuol suo con la natura umana assunta, e lo congiunse per modo che l’Uomo-Cristo è vero Dio; Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo, con la grazia, con la carità e soprattutto con la S. Eucaristia, congiunge gli omini a se stesso, per guisa che formano con Lui una cosa sola, vivono della sua vita, partecipano della sua stessa natura e diventano anch’essi figli, non naturali, che è impossibile, ma adottivi, e come tali possono chiamare Dio loro padre. Che cosa importi questa eccelsa dignità di figliuoli adottivi di Dio, lo spiegai in altra omelia, e perciò qui me ne passo. – E possiamo noi sapere se abbiamo veramente in noi lo Spirito di Dio e se siamo suoi figli? Sì, risponde S. Paolo: “Per lo stesso Spirito rende testimonianza allo spirito nostro, che noi siamo figli di Dio. „ – Noi possiamo avere una certezza di fede come quella che abbiamo p. es. della presenza reale di Gesù Cristo nella S. Eucaristia, e questa è la massima ed esclude qualunque ombra, ancorché lievissima, di dubbio; perché il nostro assenso si appoggia all’autorità stesso di Dio, che non può né ingannare, né ingannarsi: e possiamo avere una certezza umana, che esclude pur questa ogni dubbio e che appoggia alla nostra ragione od alla testimonianza altrui; così io sono certo che ogni effetto suppone la sua causa e che esiste il Giappone, benché io non l’abbia veduto. Chi mai, che sia sano di mente, potrà dubitare di queste due verità? Ebbene: noi siamo certi, dice S. Paolo, d’essere figli di Dio. E d’onde questa certezza? A qual prova si appoggia? Alla testimonianza che lo Spirito di Dio ci rende internamente. E questa una certezza di fede (Il Concilio di Trento insegnò, che l’uomo giustificato non è tenuto a credere per fede di essere nel numero dei predestinati, e che nessuno sa con assoluta ed infallibile certezza di essere predestinato, se non lo conosce per via di speciale rivelazione. -Sess. VI, Can. 15, 16.-) se non vi è una speciale rivelazione di Dio, della quale qui l’Apostolo non fa cenno e che è fuori di questione, perché parla in generale di tutti i fedeli, dicendo: “Perché lo stesso Spirito rende testimonianza allo spirito nostro, che siamo figli, di Dio. „ È questa dunque una certezza umana, maggiore o minore, secondo le persone e secondo le circostanze, che tiene, a così dire, il mezzo tra la certezza assoluta e la congettura. Ma in qual maniera poi lo Spirito Santo ci accerta che siamo figli di Dio e perciò adorni della sua grazia? Lo Spirito di Dio nella Scrittura santa e nell’insegnamento ordinario della Chiesa ci dice chiaramente, che chi crede le verità della fede, ed osserva la legge divina ed adempie come meglio può i propri doveri tutti, costui si santifica e si salva: ora, se interrogando schiettamente la nostra coscienza, essa ci dice che tutto questo noi abbiamo fatto e facciamo, noi abbiamo l’umana certezza d’essere nella sua grazia e di salvarci. Come siamo noi certi di godere l’amicizia di questa o quella persona? Come siamo noi certi che i genitori ci amino? Guardando alle opere loro e nostre, considerando il complesso delle cose tutte, noi teniamo con maggior o minore certezza di poter riposare sulla fedeltà degli amici e sull’amore dei nostri genitori, tantoché assai volte non ci si affaccia un’ombra sola di dubbio. Similmente, ragguagliata ogni cosa, possiamo dire dell’amicizia e dell’amore di Dio. – Alcuni provano angustie penose e grandi timori perché ignorano se sono in grazia di Dio od in peccato, se si salveranno o perderanno, e si sentono stringere il cuore. Nessuno sa con assoluta certezza se è degno d’odio o di amore, come insegna la S. Scrittura: il nostro cuore è un abisso e solamente l’occhio di Dio vi legge con tutta chiarezza; con tutto ciò a noi pure è dato leggervi alcun poco e tanto, da poterne avere una cotale certezza, che ci procuri quella pace che quaggiù è possibile . – Carissimi! volete voi sapere se siete veramente in grazia di Dio e per conseguenza suoi figliuoli? Sì, mi rispondete voi ad una voce e mi domandate: “Come ottenere questa certezza sì desiderata e sì consolante?” Raccoglietevi in voi stessi, nel santuario della vostra coscienza, e mettendovi faccia a faccia con essa, indirizzatele queste domande semplicissime: Credo io tutto ciò che insegna la Chiesa, madre mia? Se conoscessi d’aver commesso un peccato grave, me ne pentirei di cuore e sinceramente me ne confesserei? Se Dio, ora, in questo punto, mi comandasse un sacrificio grande, doloroso, sarei io pronto a farlo, sostenuto dalla sua grazia? Se in questo istante mi si offrisse un grande onore, un tesoro a patto di offendere Dio con un peccato mortale, avrei io il coraggio di respingere quell’onore e quel tesoro? Se la vostra coscienza vi risponde: Sì, consolatevi, la grazie di Dio è in voi e voi siete suoi figli. È una prova che ciascuno può fare in se stesso ogni qual volta gli piaccia (sono questi i segni che siamo in grazia di Dio indicati da S. Francesco di Sales. Iddio poi vuole che la nostra certezza sia sempre accompagnata da un po’ di timore per scuotere la nostra pigrizia. “Perpende, dulcissima filia, così S. Gregorio M. ad una pia dama di corte, quia mater negligentiæ solet esse securitas. Habere ergo in hac vita non debes securitatem, per quam negligens reddaris”). – Se siamo figli, siamo altresì eredi, eredi di Dio, ma coeredi di Cristo. „ Con questa sentenza si chiude la lezione della nostra Epistola. Se siamo figli di Dio e perciò nell’anima nostra simili a Lui, quale ne sarà la conseguenza? quale il frutto? “Saremo eredi di Dio. „ il Figlio di Dio, il figlio docile ed amorevole, che adempie tutti i suoi doveri, ha diritto alla eredità del padre: così noi, se adempiremo fedelmente i doveri nostri verso Dio che ci ha adottati per sola sua bontà, saremo eredi suoi. Di quali beni saremo noi eredi? Di tutti i beni, onde risulta la eterna felicità, fonte dei quali è il possesso di Dio medesimo. – Direte: i figli,- siano essi naturali od adottivi, non ricevono la eredità che alla morte del padre; ora Dio, Padre nostro, non muore mai, né può morire: perché dunque i beni, che un giorno ci darà su in cielo, si chiamano eredità? Si chiamano eredità, per indicare i rapporti che passano tra Dio rimuneratore e gli uomini rimunerati, che sono appunto i rapporti tra padre adottante e i figli adottati. Oltreché, noi siamo fratelli di Gesù Cristo secondo la sua natura umana: Gesù Cristo, in quanto uomo, ricevette dal Padre tutti i beni, come Figliuol suo naturale, e questi beni si chiamano la sua eredità; il perché, per ragione di analogia, pure i nostri beni futuri si dicono eredità. Nell’ordine naturale i figli qui sulla terra ricevono l’eredità dopo la morte dei genitori; nell’ordine sovrannaturale i figli devono morire prima di riceverla dal Padre immortale; ad ogni modo, per avere questi beni, deve sempre precedere la morte, e perciò si chiama eredità. Eredi di Dio! “Hæredes Dei!” Quale dignità! Quale grandezza è la nostra! Quei beni sono certamente un dono gratuito di Dio, se consideriamo la loro radice, che è la grazia, ma ci sono anche dovuti, se poniamo mente alla nostra prerogativa di figli di Dio e alle opere nostre, frutto della grazia. La eredità è dovuta ai figli per giustizia: poteva Iddio non adottarci; ma dopo l’adozione non può negarcela; Egli stesso ce ne ha dato il diritto. Eredi di Dio! Queste parole svegliano nella mente dell’Apostolo un’altra idea nobilissima e subito la nota, dicendo: “E coeredi di Cristo. „ Sì, siamo figli di Dio, e quindi eredi suoi; figli ed eredi di Dio, perché il Figlio di Dio si fece uomo e fratello nostro, e per Lui ed in Lui, Figlio naturale ed erede necessario della eredità paterna, noi pure siamo figli per adozione di Dio e suoi eredi. Tutto dunque abbiamo per Gesù Cristo e perciò a Lui si devono tutte le grazie e la gloria di tanta grandezza. a cui siamo sollevati. – O poveri che mi ascoltate; che bagnate di sudore il vostro pane quotidiano, che non possedete un palmo di terra, che soffrite tutti i mali ed i dolori, che sono inseparabili compagni della povertà e della miseria, rallegratevi, gioite: levate i vostri occhi al cielo, esso è vostro. Iddio il Padrone d’ogni cosa, ha un Figliuolo, unico Figliuolo: Egli ha diritto al possesso di tutti i beni del Padre suo; per eccesso di bontà Egli ha voluto associare voi tutti ai suoi diritti sulla eredità paterna; voi sarete suoi coeredi, a quest’unica condizione, che vi riuniate a Lui con la fede, con la speranza e con la carità, e dietro a Lui portiate quella croce ch’Egli per primo portò dinanzi a voi.
Graduale Ps XXX:3
Esto mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias. [Sii per me, o Dio, protezione e luogo di rifugio: affinché mi salvi.]
Ps LXX:1 V. Deus, in te sperávi: Dómine, non confúndar in ætérnum. Allelúja, allelúja. [V. O Dio, in Te ho sperato: ch’io non sia confuso in eterno, o Signore. Allelúia, allelúia]
Alleluja Ps XLVII:2
Alleluja, Alleluja.
Magnus Dóminus, et laudábilis valde, in civitáte Dei nostri, in monte sancto ejus. Allelúja. [Grande è il Signore, degnissimo di lode nella sua città e sul suo santo monte. Allelúia].
Evangelium
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Lucam. Luc XVI: 1-9
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis parábolam hanc: Homo quidam erat dives, qui habébat víllicum: et hic diffamátus est apud illum, quasi dissipásset bona ipsíus. Et vocávit illum et ait illi: Quid hoc audio de te? redde ratiónem villicatiónis tuæ: jam enim non póteris villicáre. Ait autem víllicus intra se: Quid fáciam, quia dóminus meus aufert a me villicatiónem? fódere non váleo, mendicáre erubésco. Scio, quid fáciam, ut, cum amótus fúero a villicatióne, recípiant me in domos suas. Convocátis itaque síngulis debitóribus dómini sui, dicébat primo: Quantum debes dómino meo? At ille dixit: Centum cados ólei. Dixítque illi: Accipe cautiónem tuam: et sede cito, scribe quinquagínta. Deínde álii dixit: Tu vero quantum debes? Qui ait: Centum coros trítici. Ait illi: Accipe lítteras tuas, et scribe octogínta. Et laudávit dóminus víllicum iniquitátis, quia prudénter fecísset: quia fílii hujus saeculi prudentióres fíliis lucis in generatióne sua sunt. Et ego vobis dico: fácite vobis amicos de mammóna iniquitátis: ut, cum defecéritis, recípiant vos in ætérna tabernácula.
Omelia II
[Mons. G. Bonomelli, ut supra, om. XVIII]
“Gesù disse ai suoi discepoli: Vi era un certo ricco, che aveva un amministratore: questo fu accusato presso il padrone di avere sperperati i beni di lui. Ed egli, chiamatolo, gli disse: Che è ciò ch’io odo di te? Rendi conto del fatto tuo, perché non potrai più oltre ritenere l’amministrazione. Allora colui disse tra sé: Che farò io ora che il padrone mi toglie l’amministrazione? Non posso vangare, ho rossore a cercare la limosina. So bene quel che farò, affinché, rimosso dalla amministrazione, alcuni mi abbiano ad accogliere in casa loro. Chiamati dunque a sé ad uno ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo: Che debito hai tu col mio padrone? E quegli disse: Cento barili di olio: ed egli a lui: Prendi la tua quietanza e siedi presto e scrivi cinquanta. Poi disse ad un altro: E tu quanto devi? Cento staia di grano. E l’altro a lui: Prendi la tua quietanza e scrivi ottanta. E il Signore lodò l’amministratore fraudolento, perché aveva operato con avvedutezza; con ciò sia che i figliuoli di questo secolo, nel genere loro, siano più avveduti che i figliuoli della luce. Ed io dico a voi: Con le ingiuste ricchezze fatevi degli amici, affinché quando verrete meno, quelli vi accolgano negli eterni tabernacoli „ (S. Luca, c. XVI . 1-9).
Gli scribi ed i farisei come erano duri e crudeli con i peccatori, così si mostravano stretti ed avari coi poverelli. Gesù per guarirli dalla prima infermità, recitò loro le tre parabole del buon pastore, che va in cerca della pecorella smarrita, poi della donna che ha perduta una delle dieci dramme, e finalmente del padre, che accoglie il figliuol prodigo: queste tre parabole leggiamo nel c. xv di S. Luca. Per guarire poi quegli scribi e farisei dell’altra infermità non meno grave dell’avarizia, Gesù, nel capo seguente, propone la parabola, che avete udito e insegna a loro e a tutti qual uso dobbiamo fare delle ricchezze malamente acquistate. La parabola ci presenta un lato che di primo tratto può sembrare uno scandalo e la sanzione d’una truffa: ma se voi porgerete attento l’orecchio alla spiegazione, vedrete dileguarsi ogni ombra di ingiustizia e comprenderete in tutta la sua semplicità e verità l’insegnamento del divino Maestro. – Gesù disse a’ suoi discepoli. „ Come ho avvertito, le tre parabole che precedono, e questa che le segue immediatamente, come apparisce dal contesto del Vangelo, sono rivolte in modo particolare agli scribi ed ai farisei, ma ciò non toglie che siano utili a tutti. Ben è vero che gli Apostoli e i discepoli di Gesàù, erano quasi tutti poveri e che perciò l’applicazione della parabola non li poteva gran fatto interessare: ma se non a loro direttamente, ai futuri discepoli poteva e doveva tornare utile e necessaria, e perciò quelle parole: “Gesù disse ai suoi discepoli, „ si vogliono intendere in senso largo, e si ha da riferire a tutti i credenti di tutti i tempi. Segue la parabola, che vi ho recitata. In essa abbiamo il padrone, il suo fattore o amministratore e i debitori verso del padrone. Amministratore o fattore è colui, che non è padrone dei beni, ma ne tiene il governo a nome del padrone e li deve curare ed amministrare nell’interesse del padrone, al quale deve renderne conto e dal quale deve poi ricevere la sua mercede. – Noi tutti, quanti siamo uomini e Cristiani, e noi specialmente Sacerdoti, non siamo che amministratori dei beni della terra, non padroni, come osserva S. Ambrogio (1). Dio solo è padrone assoluto d’ogni cosa, perché Egli ne è il creatore e conservatore e può i disporre a talento; noi non ne abbiamo che l’uso temporaneo, ne siamo soltanto dispensatori, e nell’uso e nella distribuzione dobbiamo attenerci alla volontà del padrone, legge sovrana, alla quale dobbiamo conformarci. O padrone, o signore, o ricco, che mi ascolti, non dir mai: Queste cose son mie, posso farne ciò che mi piace: posso spendere in passatempi, in pranzi, in vesti, in lusso, in piaceri i miei denari e le mie sostanze e nessuno ha diritto di chiedermene ragione. No, gli uomini non potranno domandartene conto legalmente, perché la legge riconosce nel padrone il diritto di fare delle cose sue ciò che gli piace, appunto perché padrone, ma te lo comanderà bene Iddio, del quale sei amministratore. Che risponderai allorché ti dirà: Rendimi conto della tua amministrazione? „ A Lui non potrai sottrarre nulla, né sfuggire all’infallibile suo giudizio. Quello che sprecasti in lusso, in gozzoviglie, in bagordi, in piaceri forse colpevoli, potevi usarlo a vestire il fratello coperto di cenci e soffrente la fame: il tuo superfluo poteva fornire il necessario al penurioso. Ah! miei cari, se ci considerassimo tutti come amministratori e dispensatori dei beni del Signore e rammentassimo il conto che dovremo renderne, non si farebbe tanto scialacquo da una parte e tanta penuria dall’altra. E qui lasciate che tocchi una differenza notabile tra la legge umana e la legge divina. La legge umana, generalmente parlando, ammette nel padrone il potere anche di distruggere ciò che è suo, anche quando lo fa per capriccio. Uno per capriccio potrebbe bruciare la casa sua e il granaio, mentre i poveri sono affamati; tutti biasimeranno il capriccioso padrone, lo malediranno, se volete, ma la legge non lo può punire, perché non offende rigorosamente il diritto altrui; ma la legge naturale e divina lo riprova e non sfuggirà il giudizio di Dio. Voi vedete pertanto come la legge divina, di cui è depositaria e interprete la Chiesa, spinga la sua azione oltre i confini della legge umana, e giovi a questa e ne avvalori la efficacia. – Ritorniamo alla nostra parabola. “L’amministratore fu accusato di avere sperperato i beni del padrone. „ La cosa era manifesta: l’amministratore viveva splendidamente, banchettava, largheggiava, sfoggiava come un gran signore e conveniva non aver occhi per non vedere, che doveva cacciare liberamente le mani negli averi del suo padrone; se ne sussurrava dovunque e, come suole accadere, qualcuno fu dal padrone e per sentimento di giustizia o per invidia e malanimo o per altra causa qualunque, gli riferì le voci sinistre che correvano sull’amministratore: Et hìc diffamatus est apud illum, quasi dissipasset bona sua. Il padrone, udite quelle voci, fece ciò che avrebbe fatto qualunque altro padrone, per non vedere sciupato il suo patrimonio; chiamato tostamente a sé il fattore infedele, e, avutolo innanzi, con piglio severo gli disse: “Che ciò ch’io odo di te? Rendimi conto del fatto tuo, perché non potrai più ritenere l’amministrazione. „ – Ecco, o cari, il primo e più naturale castigo, che Dio può e suole infliggere a chi usa male dei doni ricevuti, il castigo di levargli i beni stessi. E chi può muoverne lamento? Dov’è il padrone che lasci l’amministrazione de’ suoi beni in mano d’un fattore infedele ed anche solo caduto in sospetto di essere infedele? Anzi non è raro il caso che questi beni se li toglie egli stesso colui che ne abusa, e Dio lo punisce con le opere delle sue mani. Questi era ricco sfondato: si gettò al mal vivere, al lusso, a tutte le intemperanze del mangiare del bere: vedetelo sopra un letto di dolori, percosso da infermità insanabile; quegli godeva d’un’alta reputazione, e la sua condotta l’ha mortalmente ferita; quell’altro aveva la felicità della pace domestica; ora l’ha perduta e perché? Perché non seppe vincere se stesso e la mala educazione dei figli ha portato in casa la discordia. Ditemi, o cari: non è egli vero che troppe volte sono gli uomini che puniscono se stessi, che si privano di quei beni della perdita dei quali si lagnano? L’esperienza quotidiana lo dimostra e l’amministratore del Vangelo ne è una prova. La perdita del suo ufficio non la dovette alla durezza del padrone, ma sì alla sua condotta disonesta. – L’amministratore, udita l’intimazione del padrone, comprese tutta la gravità ed il pericolo del suo stato; la perdita dell’ufficio, con cui campava la vita, era inevitabile. Che fare? Raccolse i suoi pensieri e, chinata la testa fra le palme delle mani, prese a ragionare fra stesso, e disse: ” Che farò io, ora che il padrone mi toglie l’amministrazione? Come potrò vivere? Andrò a lavorare la terra come codesti contadini, che sudano sotto la sferza del sole e svolgono la gleba? Sono innanzi negli anni, non ho l’abitudine e non lo potrei fare. Stenderò la mano, chiedendo la limosina? Io che sin qui sono vissuto onorato ed agiato? Sarebbe per me vergogna intollerabile. Né l’una, né l’altra cosa: Fòdere non valeo, mendicare erubesco. Eppure è forza trovare un modo per uscire dal mal passo e provvedere a me stesso. Una cosa è degna di considerazione in questo amministratore, ed è che seco stesso riconosce il suo fallo, né pensa tampoco a coprire, o negare audacemente la sua colpa. – Dopo avere seco stesso considerato a lungo ciò che in tanta distretta gli conveniva, gli balenò alla mente un pensiero, lo colse, deliberò, e disse: ” Ora so bene ciò che farò, affinché, quando mi sarà tolta l’amministrazione, alcuni mi abbiano a ricevere in casa loro. „ – Osservate, o cari, come quest’uomo riconosce la sua infedeltà, confessa dinanzi alla propria coscienza il furto commesso, non cerca nemmeno di mascherarlo; ma egli non mostra pentimento alcuno, non fa la risoluzione generosa del figliuol prodigo, che disse: muoio di fame, andrò dal padre mio e gli dirò: Ho peccato contro Dio e contro di te”. Egli poteva gettarsi ai piedi del padrone, confessare il suo fallo, appellare alla sua carità e domandargli perdono e di metterlo nel numero dei suoi servi; nulla di tutto ciò, nessun pentimento, nessun indizio di ravvedimento, di emenda, non pensa che allo stato miserabile in cui tra breve si troverà. – Senza dubbio non è male pensare al proprio stato ed al modo di provvedere onestamente a se medesimo ed ai bisogni futuri del corpo; ma oltre i bisogni del corpo vi sono quelli dell’anima, e questi sono senza confronto più importanti che quelli del corpo, onde a questi anzi tutto è da provvedere. Ma così non fece l’amministratore del Vangelo, e pur troppo in ciò lo imitano tanti Cristiani. In conseguenza delle loro malfrenate passioni e dei loro peccati trovansi ridotti in tristi condizioni, rovinati nelle sostanze, nell’onore, nella salute stessa del corpo; gemono sotto il peso dei danni materiali, fanno ogni opera per cessarli, ma non si danno pensiero di rimuovere le cause che sono i peccati, di detestarli e riconciliarsi con Dio. Cecità incredibile! Non vogliono gli effetti, ma ne vogliono le cause; si studiano di sfuggire al castigo che Dio infligge per il peccato, ma vivono nel peccato e lo amano! E qual fu il partito, al quale si attenne l’amministratore infedele? Eccolo: “Chiamati ad uno ad uno i debitori del suo padrone disse al primo: Quanto devi tu al mio padrone? E quegli disse: Cento barili di olio; e lui: Prendi la tua quietanza e siedi e scrivi: Cinquanta. Quindi disse ad un altro: E tu quanto devi? E quegli: Cento staia di grano. E l’altro a lui: Prendi la tua quietanza e scrivi: Ottanta. „ – Questo amministratore, alle truffe già commesse a danno del padrone, ne aggiunge un’altra e forse più grave di tutte, dando ai debitori le obbligazioni per iscritto e lasciandole loro alterare, anzi esortandoli egli stesso ad alterarle, tantoché amministratore e debitore si fanno complici della falsificazione e del latrocinio, ciascuno con l’intento del proprio vantaggio: i debitori per diminuire il loro debito, l’amministratore per farseli amici e benevoli, e perché lo ricevano in casa, allorché sarà cacciato dal padrone. Noi, udendo questa truffa ordita di comune accordo tra l’amministratore e i debitori a danno del padrone, ci sentiamo indignati e la nostra coscienza si rivolta a questa ribalderia con tanta facilità disinvoltura consumata, e sta bene. Ma, siamo schietti, o cari fratelli: in mezzo alle nostre proteste di onestà, in mezzo alle lodi ed ai panegirici, che oggi a voce ed in iscritto si fanno della giustizia e della lealtà, in onta agli articoli del codice penale, le frodi, gli inganni, le falsificazioni ed i conseguenti latrocini di questo genere sono forse sì rari, come si potrebbe credere? Ohimè! me ne appello a voi stessi. Troppo spesso siamo spettatori di contratti fraudolenti, di usure enormi, di promesse violate, di obblighi calpestati, di alterazioni di firme e di fallimenti, che non sono sempre effetti di sventure fortuite, perché i falliti talora arricchiscono; e tutto questo perché? Per accumulare ricchezze, per vivere più lautamente, per grandeggiare in lusso, in conviti, in passatempi, e via dicendo. L’amministratore iniquo del Vangelo e i debitori non meno iniqui di lui, trovano troppi imitatori nella nostra società cristiana e la esecrabile fame del danaro, figlia della esecrabile fame de’ piaceri, continua l’opera sua demolitrice della pubblica morale. – Ma ritorniamo alla nostra parabola. Il padrone dovette ben presto conoscere la nuova truffa compiuta con tanta destrezza dal suo amministratore; lo cacciò via, come si rileva dal contesto del Vangelo, ma “il Signore, cioè Gesù Cristo, dice S. Matteo, lodò l’amministratore fraudolento, perché aveva operato con avvedutezza. „ Come? voi mi domanderete attoniti; come? Gesù Cristo lodò l’amministratore infedele e artefice della frode dei debitori? Come? Gesù Cristo adunque consacra l’inganno ed il furto? Ma questa è bestemmia: Laudavit Dominus vìllicum iniquitatis! Non turbatevi, o cari; Gesù Cristo, l’Uomo-Dio non può certamente approvare l’ingiustizia; sarebbe una bestemmia pure il pensarlo. Come dunque si vuole intendere quella sentenza dell’Evangelista: “Il Signore lodò l’amministratore fraudolento? „ Molto facilmente si intende e si spiega; Gesù non lodò, nè poteva lodare l’inganno, la frode ed il furto, ma la prudenza, la prontezza, l’industria, l’ingegno, col quale l’amministratore provvide a se stesso: Laudavit Dominus … quìa prudenter fecisset. Quando noi pure, udendo le scaltrezze con le quali taluno ha frodato il prossimo ed ha condotto a termine felice un inganno, un delitto anche atrocissimo, diciamo: Bravo! è un uomo d’ingegno! e lo ammiriamo. Nessuno di noi per fermo approva od ammira l’inganno e il delitto commesso, anzi lo detestiamo ad una voce, ma lodiamo e ammiriamo l’astuzia e l’ingegno, con cui fu compiuto, perché questo si considera separatamente dall’uso fattone, e per se stesso è buono e può essere degno di ammirazione, ed è unicamente in questo senso che Gesù Cristo lodò l’ingiusto amministratore. – Dalla parabola il divino Maestro discende a due applicazioni, che è prezzo dell’opera considerare particolarmente. “Conciossiaché i figliuoli di questo secolo, nel genere loro, ossia nel loro modo di operare, sono più avveduti, che non i figliuoli della luce. „ Chi sono i figliuoli di questo secolo? Indubbiamente gli uomini mondani, i tristi, i malvagi schiavi delle passioni. Chi sono i figli della luce? Evidentemente, per ragione dell’opposizione e secondo il linguaggio biblico, sono gli uomini spirituali, i credenti, quelli che hanno la luce della fede. L’amministratore disonesto, i debitori falsari e ladri, per sentenza di Gesù Cristo, sono messi tra i figli di questo secolo, e ciò conferma la spiegazione data or ora, allorché vi dicevo che Gesù non lodò l’opera dell’amministratore e dei debitori, ma sì la loro avvedutezza; e ciò è sì vero che l’Evangelista chiama l’amministratore: Villicum iniquìtatis, uomo ingiusto e fraudolento, benché gli dia lode di prudente, in quantochè provvide a se stesso. Gesù disse che i tristi sono più avveduti, s’intende alcuna dei buoni, nel loro modo di operare, ed è verità provata dall’esperienza direi quasi quotidiana. Noi vediamo molti uomini di mondo non ad altro intesi, che ad accumulare ricchezze, a salire in alto, a godere, in una parola, a raggiungere il loro fine affatto mondano. Quanti sottili artifizi per riuscire! quante fatiche! Quanti sforzi! quanti sacrifici! Non si danno pace né giorno, né notte, e tutto ciò per servire alle loro passioni, per l’acquisto di beni fugaci, se pure meritano il nome di beni. – Vedete d’altra parte i figli della luce, i credenti, i buoni! Essi attendono ai beni imperituri del cielo, alla santificazione di se stessi, al servizio di Dio: non è egli vero, o cari che assai volte, a nostra vergogna, i figli del secolo fanno più assai per servire al mondo, loro padrone, che non i figli della luce per servire a Dio? Non è egli vero che lo zelo, il coraggio, l’attività di questi è vinta al paragone di quelli? Non è egli vero che il troppo spesso è servito meglio dai suoi seguaci, che non lo sia Gesù Cristo da’ suoi discepoli? Ecco il lamento che fa Gesù Cristo nel luogo citato. Miei cari! se noi esamineremo sinceramente noi stessi, facilmente troveremo d’aver fatto per il mondo, per le nostre passioni, molto più di quello che abbiamo fatto per Iddio, benché a quello non dobbiamo nulla e tutto a questo! E un fatto, che ci deve umiliare in faccia alla nostra coscienza! Il divino Maestro conchiude la parabola con una sentenza, che ne è il frutto principale, dicendo: “Ed io vi dico: Fatevi amici con le ricchezze ingiuste, affinché quando verrete meno, ossia sloggerete dalla terra, quelli vi ricevano negli eterni tabernacoli. ,, – L’amministratore infedele usò dei beni che aveva, facendosi degli amici, che a tempo opportuno l’avrebbero aiutato; il somigliante fate voi, ci dice il Salvatore. Avete dei beni materiali? abbondanti ricchezze? Questi beni, queste ricchezze sono talora ingiuste, perché acquistate malamente, con usure, con inganni, con contratti illeciti; sono dette ingiuste anche, perché, quantunque acquistate onestamente, sono sempre incentivi al male, considerata la debolezza umana; ebbene, dice Cristo, volgete queste ricchezze all’acquisto del cielo, deponetele nelle mani dei poveri, ed essi vi riceveranno un giorno negli eterni tabernacoli, perché il fatto a loro, Dio lo reputa fatto a se stesso.- Direte: Ma se le ricchezze, che abbiamo, sono frutto di ingiustizie, queste dobbiamo riparare, e restituire il maltolto a chi si deve, e non convertirlo in limosine ai poverelli. Dite il vero, e così senza dubbio si deve fare; ma allorché non è possibile rendere il mal tolto a chi si dovrebbe, come non di rado accade, allora vada ai poveri, lenisca i loro dolori, e noi li avremo nostri avvocati dinanzi Dio. La sostanza è questa: non solo, vivendo sulla terra, dobbiamo acquistare il cielo, ma egli è con la terra che noi dobbiamo acquistare il cielo, vale a dire è col buon uso dei beni della terra che ci procureremo i beni del cielo.
Credo …
Offertorium
Orémus Ps XVII:28; XVII:32
Pópulum húmilem salvum fácies, Dómine, et óculos superbórum humiliábis: quóniam quis Deus præter te, Dómine? [Tu, o Signore, salverai l’umile popolo e umilierai gli occhi dei superbi, poiché chi è Dio all’infuori di Te, o Signore?]
Secreta
Súscipe, quǽsumus, Dómine, múnera, quæ tibi de tua largitáte deférimus: ut hæc sacrosáncta mystéria, grátiæ tuæ operánte virtúte, et præséntis vitæ nos conversatióne sanctíficent, et ad gáudia sempitérna perdúcant. [Gradisci, Te ne preghiamo, o Signore, i doni che noi, partecipi dell’abbondanza dei tuoi beni, Ti offriamo, affinché questi sacrosanti misteri, per opera della tua grazia, ci santífichino nella pratica della vita presente e ci conducano ai gaudii sempiterni.]
Communio Ps XXXIII:9 Gustáte et vidéte, quóniam suávis est Dóminus: beátus vir, qui sperat in eo. [Gustate e vedete quanto soave è il Signore: beato l’uomo che spera in Lui.]
Postcommunio
Orémus.
Sit nobis, Dómine, reparátio mentis et córporis cæléste mystérium: ut, cujus exséquimur cultum, sentiámus efféctum. [O Signore, che questo celeste mistero giovi al rinnovamento dello spirito e del corpo, affinché di ciò che celebriamo sentiamo l’effetto.]