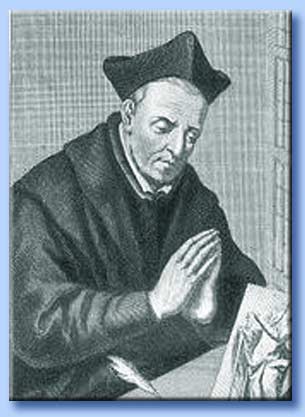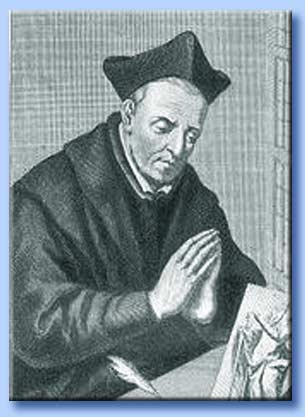
LA GRAZIA (2)
[E. Barbier: I Tesori di Cornelio Alapide, vol. II; S. E. I. ed. Torino – 1930]
9. ABBONDANZA DI GRAZIE. — « In Gesù Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e noi ne siamo in Lui riempiti » — In ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter; et estis initio repleti (Coloss. II, 9-10). Ora, se siamo riempiti della divinità, è chiaro che abbondano in noi tutte le grazie, poiché abbiamo in noi l’autore di tutte, il quale, come ci dice S. Giacomo, le dispensa largamente a tutti, senza muoverne rimprovero: — Dat omnibus affluenter, et non improperat (I, 5). Quindi gli Atti Apostolici notano che la grazia si manifestava abbondante nei Cristiani: — Et gratia magna erat cum omnibus illis (Act. IV, 33), e S. Bernardo confessa che Gesù Cristo gli si era comunicato tutto intero, e si era messo tutto quanto ai suoi servizi (Totus mihi datus, et totus in meos usus expensus – Serm., in Cantic.). – S. Tommaso insegna, che Dio dà con liberalità e generosità, non a prezzo; dà universalmente, non a uno solo ma a tutti … ; dà a profusione…, con bontà, senza rinfacciare il dono (3 p. q. art. 9). S. Ambrogio ci assicura che Dio ricompensa le nostre buone opere molto più abbondantemente di quello che esse non si meritino. Iddio, dicono d’accordo i teologi, punisce meno di quel che l’uomo meriti, ma premia oltre ogni merito. Questa dottrina concorda con quelle parole dell’apostolo Pietro: « Studiatevi sempre meglio, o fratelli, di assicurare per mezzo delle buone opere la vostra elezione e vocazione; perché facendo questo, voi non cadrete. E così vi sarà aperta una larga entrata nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo (II PETR. I, 10-11) ». Ah sì! ogni uomo può dire col Salmista, che Dio lo ha prevenuto con le benedizioni della sua clemenza: — Prævenisti eum in benedictionibus dulcedinis (Psalm. XX, 3), e che l’anima sua si è impinguata dei divini favori: — Sicut adipe et pinguedine repleatur anima mea (Psalm. LXII, 5). Chi non è ingrato ai benefizi di Dio, deve invitare quanti conosce e incontra a udire il racconto delle ammirabili grazie di cui lo ha colmato il Signore: — Venite, audite, et narrabo quanta fecit animæ meæ (Psalm. LXV, 15), ed esclamare: « Che renderò io mai al Signore, in ricambio di tanti beni di cui mi ha arricchito?— Quid retribuam Domino, prò omnibus quae retribuit mihi? (Psalm.CXV, 3). Dio può dire veramente che « ha inebriato le anime languide e saziato le affamate » — Inebriavi animam lassam, et omnem animam esurientem saturavi (JER. XXXI, 25); e in tutti coloro che vogliono, si avvera quel detto d’Isaia: «Non sentiranno più né la fame né la sete, perché Iddio misericordioso li disseterà ai fonti delle acque » — Non esurient, neque sitient, quia miserator ad fontes aquarum potabit eos (XLIX, 10); di quelle acque di cui diceva la Sposa dei Cantici: « La fontana dei vostri giardini è una polla di acqua viva che si precipita (su di me) dal Libano (dell’eternità) »— Fons hortorum, puteus aquarum viventium quæ fluunt impetu de Libano – (Cant. IV, 15). Dio nutrisce i Cristiani col suo Vangelo, con la sua dottrina, con i suoi favori, con la santa Eucaristia; li protegge nelle tentazioni; se si affidano a Lui e lo seguono, se vogliono cooperare alla sua grazia; escono vincitori di tutte le tentazioni, non patiscono più né fame, né sete… Chi può contare le grazie che Dio concede all’uomo? Grazie temporali…, grazie spirituali …; grazie interiori …, grazie esteriori…; grazie di creazione…, di redenzione.., di provvidenza…, di Sacramenti…; grazie per il corpo, per l’anima, per la mente, per il cuore, per la memoria, per la volontà; grazie nel tempo…, grazie nell’eternità…, grazie universali …, grazie particolari …, grazie ad ogni istante, tanto che Dio può dire a ciascuno di noi quello che disse al popolo ebreo: « Che altro c’era da fare alla mia vigna, che io non l’abbia fatto? » — Quid est quod debui ultra tacere vineæ meæ, et non feci? (Is. V, 4).
10. LA GRAZIA È UN INNESTO DIVINO. — La comunicazione della grazia ha molta rassomiglianza con l’innesto delle piante; perché 1° come si fa l’innesto di un albero di buona specie in un ramo di albero selvatico e sterile, affinché produca frutti saporiti e deliziosi, così la grazia comunicata dal cielo a noi, polloni selvatici e sterili, ci fa produrre abbondanti ed eccellenti frutti di buone opere. 2° Si prende il ramo da un albero di buona specie per innestarlo in uno di cattiva; così la grazia viene da Dio, virtù e santità per essenza, nel cuore dell’uomo di corrotta natura … 3° Alla pianta selvatica si recide un ramo che è surrogato da un altro produttivo; così la grazia taglia via da noi la parte del vecchio Adamo e vi pone invece il nuovo, cioè Gesù Cristo… 4° La gemma che s’inserisce sull’albero, prende il medesimo succo e gli si riunisce perfettamente; così con la grazia noi veniamo incorporati a Gesù Cristo, uniti, trasformati in Lui, divinizzati … 5° Il ramo s’innesta su l’albero affinché ne partecipi il succo; la grazia ci è data perché assorbisca in noi tutto quello che è della natura … 6° L’innesto si deve fare nella primavera, mentre gli alberi sono in succhio; nessun tempo della vita è più propizio per l’innesto della grazia nel cuore dell’uomo, che quello della giovinezza … 7° La pianta si deve fendere fino al midollo, se si vuole che l’albero profitti dell’innesto; così l’anima deve aprirsi fino al cuore, per mezzo dell’amore di Gesù Cristo, affinché possa unirsi a Lui e formare un solo cuore. Come il midollo si confonde col midollo, così il nostro cuore si unisce al cuore di Gesù Cristo per mezzo della grazia… 8° Come s’incide l’albero per l’innesto, così bisogna tagliare, recidere, schiantare le passioni dal nostro cuore, se vogliamo che vi alligni l’innesto di Gesù Cristo… 9°. L’innesto è diligentemente avviluppato e difeso dal freddo, dal caldo, dai venti, dagli insetti nocivi e si copre perfino di fango; così l’anima deve abbracciarsi a Gesù Cristo ed essere difesa contro tutte le tentazioni di accidia, di gola, di orgoglio, di lussuria, ecc., per mezzo della meditazione del proprio niente, del fango di cui siamo composti, delle miserie umane, della morte, dei peccati commessi… 10° L’innesto si fa nell’alto della pianta; la grazia deve dominare tutti i pensieri e i fatti nostri … 11° L’albero selvatico e sterile che poco o nulla produceva, e quel poco di sapore amaro e di nessun valore, produce in forza del legittimo innesto frutti belli a vedersi e dolci al gusto; così la grazia deve produrre in noi frutti di buoni esempi… 12° La pianta adotta l’innesto; per mezzo della grazia, Dio ci adotta in figli… 13° L’innesto si unisce indissolubilmente all’albero, il cuore deve vincolarsi inseparabilmente alla grazia…
11. LA GRAZIA È PARAGONATA ALLA PUPILLA DELL’OCCHIO. — «Avrà cura della grazia come della pupilla degli occhi suoi », leggiamo nell’Ecclesiastico — Gratiam quasi pupillam conservabit (XVII, 18). Bello e vero è questo paragone della grazia alla pupilla dell’occhio! Difatti, in primo luogo, nella pupilla si riflette al vivo l’immagine della bellezza e della bontà dell’occhio; e la grazia è il più splendido riverbero della bellezza e della bontà di Dio, poiché essa è la più pura partecipazione della divinità… In secondo luogo la pupilla forma l’ornamento e il brio del volto; la grazia è l’ornamento e la dignità dell’anima; se si toglie o si offende la pupilla, si acceca l’uomo; se si toglie la grazia si acceca, anzi si uccide l’anima. Spegnete il sole nel firmamento lungo il giorno, spegnete la luna e le stelle lungo la notte, e il cielo diventa oscurità e tenebre; togliete la grazia da un’anima, e voi distruggete il sole e le stelle dello spirito, non vi restano che folte tenebre nell’intelligenza e nella ragione, una tetra ed eterna notte pesa su l’anima priva della grazia, perché questa è per lei quello che è il sole per la terra e per il mondo…
12. ECCELLENZA DELLA GRAZIA. — La grazia è la sorgente della gloria dalla quale esce e alla quale conduce… «L’acqua che io vi darò, dice Gesù Cristo, è fonte di acqua che sale alla vita eterna » — Aqua, quam ego dabo eis fiet in eos fons aquae salientis in vitam aeternam – IOANN. IV, 14). Il Redentore chiama acqua viva la sua grazia, perché viene dal cielo che è la vita e conduce al cielo. La grazia è un fiume che mette foce nell’oceano della beatitudine eterna: « Chi beverà di quest’acqua, è parola di Gesù, non patirà più sete in eterno » — Qui biberit ex hac aqua, non siti et in æternum (IOANN. IV, 13). – Benché le nostre opere non abbiano nessuna proporzione con la gloria celeste, in quanto sono opere dell’uomo, l’hanno tuttavia in certo qual modo, in quanto sono le opere della grazia di Gesù Cristo; poiché la grazia è, sia di natura sua, sia per la promessa di Dio, la semenza della gloria. « Per mezzo della grazia, dice S. Gerolamo, l’uomo cessa di essere debole e vano e diventa, diremo quasi, un Dio (Per gratiam homo fit quasi Deus, et desinet esse homo et mendax (Lib. sup. Ioann.) ». Perciò S. Paolo afferma: « Quello che era per me guadagno, l’ho giudicato perdita, per Cristo. Del resto, pieno della scienza sovreminente di Gesù Cristo nostro Signore, per suo amore mi sono spogliato di ogni cosa; io reputo sterco e stimo perdita tutte le cose, per guadagnare il Cristo » — Quæ mihi fuerunt lucra, hæc arbitratus sum, propter Christum detrimenta. Verumtamen existimo omnia detrimentum esse, propter eminentem scientiam Iesu Christi Domini mei, propter quem omnia detrimentum feci, et arbitror ut stercora ut Christum lucrifaciam – Philipp. III, 7-8). S. Pietro augurava ai fedeli, che si aumentasse in loro la grazia e la pace nella conoscenza di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo, affinché sapessero come tutto ciò che spetta alla potenza divina per riguardo alla vita e alla pietà, tutto ci è stato dato per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati per la propria sua virtù e gloria e che ha adempito con le sue grazie le magnifiche e preziose promesse a noi fatte, acciocché divenissimo partecipi della natura divina … : — Per quem maxima et pretiosa nobis promissa donavit; ut per hæc erficiamini divinæ consortes naturæ (IIPIETR. I, 4). Dio ci si comunica per mezzo della sua grazia e dà se stesso al giusto, e per questa comunicazione innalza l’anima fino a sé, la trasforma, la divinizza. Dio solo ha essenzialmente la natura divina. I fedeli e i giusti ne partecipano, per mezzo della grazia, non essenzialmente, né personalmente, ma in parte accidentalmente ed in parte sostanzialmente.
1° Accidentalmente, col dono della grazia santificante che è accidentale nel giusto, cioè che vi è, ma che potrebbe non esservi, senza che la sua natura ne rimanga annientata. In forza di questa grazia, noi partecipiamo alla natura divina in modo strettissimo e quasi infinito. Infatti la grazia è cosa tanto nobile ed eccellente, che sta infinitamente al di sopra della natura degli uomini, e non si può trovare, secondo l’unanime sentenza dei teologi, sostanza creata che sia della stessa natura della grazia, poiché la grazia partecipa della divinità al più alto grado, ad un grado così sublime, a cui non arriva cosa o natura creata. – Per mezzo della grazia, l’uomo viene dunque innalzato all’ordine, non angelico, ma divino; egli diviene alleato e partecipe della natura divina. Non si può dare per l’uomo partecipazione più grande alla divinità, che quella che avviene per mezzo della grazia, eccetto la partecipazione di Dio per mezzo della gloria; la quale però allora soltanto si avvera, quando ebbe luogo la partecipazione alla divinità per la grazia. – I peccatori meditino queste sublimi cose, affinché vedano quello che hanno perduto perdendo la grazia per un vile piacere, per un misero interesse, e si sforzino senz’indugio a procurarsela; le meditino i giusti per non trascurare nulla di ciò che è necessario per conservarla, confermarla, accrescerla e compirla in se stessi.
2° I giusti partecipano alla natura divina non solo accidentalmente in virtù della grazia santificante, ma anche sostanzialmente, in virtù della natura divina in se stessa che loro è comunicata e con la quale vengono adottati da Dio come suoi figli, come eredi e come deificati. Per intendere questa cosa, notate in primo luogo, che la nostra giustificazione formale e la nostra adozione consistono interamente nella virtù e nella grazia che ci è data e che con noi s’identifica, la quale in sé contiene e con sé apporta lo Spirito Santo che è l’Autore della carità e della grazia. Infatti la grazia che adotta, non può andare separata dallo Spirito Santo, né l’adozione dello Spirito Santo può essere separata dalla grazia; a quel modo che non si possono separare né il sole da’ suoi raggi, né i raggi dal sole. Infatti, lo Spirito Santo, per la carità e la grazia, ci giustifica formalmente e abita in noi, ci vivifica e ci adotta. Infatti, la giustizia inerente, o la grazia santificante, non è una semplice qualità, ma comprende parecchie cose inestimabili, come per es. la remissione dei peccati, la fede, la speranza, la carità e, in una parola, lo Spirito Santo, autore di tutti i doni. Nella giustificazione infusa l’uomo riceve tutte queste grandi cose, dice il Concilio di Trento, sess. VI, cap. VIII. – Notate, in secondo luogo, che nella giustificazione e nell’adozione, non solamente la carità, la grazia e i doni dello Spirito Santo sono dati all’uomo, ma egli riceve inoltre la propria Persona dello Spirito Santo e per conseguenza tutta la divinità, ossia tutta intera la Santissima Trinità; di modo che la divinità si trova realmente e personalmente presente nell’anima del giusto con i suoi doni e per i suoi doni, ed abita in quell’anima sostanzialmente come in suo proprio tempio, e se la unisce, la indìa, e questo è un favore, una dignità ed una sorgente di felicità in certo qual modo infinita … Da questa comunicazione della propria Persona dello Spirito Santo e della Trinità intera, ne segue la suprema elevazione, o diremo la deificazione dell’anima, e quindi un’adozione perfettissima e divina, non solamente per la grazia, ma ancora per la sostanza divina. Perciò S. Basilio disse che i Santi sono dèi a cagione della dimora che tiene in loro lo Spirito Santo (Homil.). – La grazia è un’immensa partecipazione della santità e della bellezza di Dio… « Arido tronco tu eri divenuto in Adamo, dice S. Ambrogio all’uomo; ma ora, per la grazia di Cristo, sei cambiato in un albero fecondo di eccellenti frutti (Lignum aridum factus eras in Adam; sed nunc per gratiam Christi, pomifera arbor pullulasti (Serm.) ». – Udite gli elogi che fa della grazia il Savio: « Io l’ho anteposta ai regni e ai troni e le ricchezze ho stimate meno che polvere al suo paragone; non l’ho fatta uguale alla pietra preziosa, perché l’oro al suo confronto vale un granello di arena e l’argento al suo paragone è fango » — Et præposui illam regnis et sedibus, et divitias nihil esse duxi in comparatione illius. Nec comparavi illi lapidem pretiosum; quoniam omne aurum, in comparatione illius, arena est exigua, et tamquam lutum æstimabitur argentum in conspectu illius – Sap. VII, 8 – 9). « Essa è più preziosa di tutti i diamanti; tutti i tesori e le ricchezze del mondo non ne uguagliano il valore » — Pretiosior est cunctis opibus, et omnia quæ desideratur, huic non valent comparari (Prov. III, 15). La grazia è dunque il tesoro dei tesori; è la partecipazione della natura divina al più alto grado, cioè per quanto può parteciparne la creatura, non solo naturalmente, ma soprannaturalmente…
13. POTENZA E MERAVIGLIE DELLA GRAZIA. — Gesù Cristo cammina su le acque e vi sostiene anche Pietro; calma la burrasca e porta in un batter d’occhio la barca a terra. Per mezzo della sua grazia, i medesimi prodigi opera in noi Gesù Cristo: ci fa calpestare il secolo, calma le tempeste delle tentazioni, della concupiscenza, delle passioni e ci accoglie nel porto dell’eterna salute. Ah! se la grazia di Gesù Cristo abita nel nostro cuore, noi ci troveremo ben presto là dove vogliamo andare, cioè al cielo… Di che potenza, di che efficacia non dev’essere la grazia di quel Gesù Cristo, che su la croce fece d’un malfattore un santo, e cambiò in un istante Saulo di persecutore fierissimo in un Apostolo zelante ed operosissimo? L’acqua risale fino al livello della sua sorgente; e così pure l’acqua della grazia, che discende dal cielo nell’anima giusta, spinge con tale impeto ed efficacia l’anima, che l’innalza fino al suo divino Creatore; poiché la grazia è la sorgente della gloria, prende l’uomo e lo trasporta con sé nella gloria. La grazia è un fiume di acqua viva e chi naviga in esso deve arrivare al porto della vita eterna. « Affinché lo splendore delle rivelazioni non mi levi in orgoglio, dice il grande Apostolo, fu dato alla mia carne un pungolo, l’angelo di satana che mi schiaffeggi. Perciò supplicai il Signore che mi fosse tolto; ed Egli mi rispose: Ti basta la mia grazia — Sufficit tibi gratia mea — perché nella debolezza si manifesta la forza. Dunque volentieri mi glorierò nella mia infermità, affinché in me si spieghi la forza del Cristo … Soffriamo angustie in ogni cosa, ma non cadiamo d’animo; siamo battuti, ma non prostrati; perseguitati, ma non abbondonati; feriti, ma non morti » (II Cor. XII, 7 – 9; IV, 8 – 9); e a Timoteo: « Il Signore mi accompagnò passo passo e mi sostenne con la sua forza, affinché si compia per mezzo mio la predicazione fra le genti: Egli mi ha strappato alle fauci del leone » (Tim. IX, 17). Le anime pie, sostenute dalla grazia, portano le afflizioni ed avversità loro con più facilità e coraggio, che non i cattivi la loro pretesa felicità… Parlando S. Giovanni Crisostomo della grazia dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste, dice: « La grazia spoglia della malignità e veste della mansuetudine, toglie la schiavitù e dà la libertà; perciò la terra fu cambiata in cielo, poiché quali stelle si possono paragonare agli Apostoli? » (Serm. I de Pentec). Ed in altro luogo afferma: « Ricetto sicurissimo e torre inespugnabile è la grazia di Dio (Maxima securitas et inexpugnabilis murus est gratia Dei – Homil. XLVI in Gen.) » .« Al primo risplendere della grazia in un’anima, scrive S. Gregorio, subito se ne sente radicalmente mutata, cosicché lascia su l’istante di essere quella che era e diventa quello che non era (Humanum subito, ut illustrai, immutat affectum; abnegat hoc repente quod erat, exhibet repente quod non erat – Moral.) ». Ed a confermare la sua osservazione, dice altrove, avrebbe gli esempi di Davide, di Amos, di Daniele, di Pietro, di Paolo, di Matteo, ma non gli basta a ciò la parola, tanto è sorprendente il vedere la grazia dello Spirito Santo investire un giovane che si trastulla sull’arpa e farne un salmista; posarsi su di un semplice pastorello e cambiarlo in un profeta; discendere in un giovanetto e crearlo giudice dei vegliardi; chiamare un pescatore e costituirlo sublime predicatore; abbattere un persecutore e rialzarlo dottore delle genti; scegliere un pubblicano e convertirlo in un evangelista (Homil. in Erang.). «Quali prodigi opera la grazia! esclama S. Agostino. Quell’uomo che ieri vedevate rotto alla gozzoviglia, oggi lo vedete sobrio e mortificato; ieri impudico, oggi modesto e continente; ieri bestemmiatore, oggi lodatore di Dio; ieri schiavo perduto della creatura, oggi servo zelante e fervoroso del Creatore. Da che cosa deriva un cambiamento così inaspettato, una diversità così prodigiosa? Dalla grazia» (In Psalm. LXXXVIII). Pietro, senza la grazia, è vinto dalla voce di una fantesca; con la grazia, esce trionfante dei re, dei principi, degli imperi… Quello che è impossibile per la natura, diventa non solo possibile ma facile, per la grazia… Essa chiama, esorta, eccita, inspira, spinge, anima, conforta, consola, rassoda… Di un uomo carnale, terreno, scandaloso, forma un angelo di purezza, un modello di santità. Eccovi la Maddalena…, S. Maria Egiziaca …, S. Agostino …, e cento altri. « Ah! è proprio vero che se il Signore innaffia della sua grazia un’anima, come dice S. Gerolamo, essa prontamente germina e fiorisce come il giglio; getta profonde radici come il cedro del Libano, il quale quanto più s’innalza, tanto più spinge nel suolo le radici, per sfidare la potenza dell’impetuoso aquilone» (Epist.). – Non appena la grazia si mostra in un’anima, ecco questa fondersi come cera al fuoco, piangere i suoi traviamenti, abbandonarsi rassegnata in Dio, diventare dolce e mansueta, ardere di amore celeste. Allora i monti dell’orgoglio si squagliano, i fiumi della vanità, dell’ambizione scompaiono, le fiamme dell’impurità diventano ghiaccio, le anguste gole della pusillanimità, del timore, dell’accidia, si chiudono e restano colme… La grazia muta un leone, una tigre in un agnello; la grazia cambia uno sparviero in una tortorella …; di un reprobo fa un eletto; di un demonio, un angelo; di un mostro d’iniquità, una splendida immagine di Dio… È la grazia che popola la terra di santi e il cielo di beati… Dolce, mirabile e confortante cosa è osservare le meraviglie operate dalla grazia nei martiri, nelle vergini, nei giusti di tutti i secoli.
14. UTILITÀ DELLA GRAZIA. — Diceva Gesù alla Samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio, lo cercheresti e lo domanderesti! (IOANN. IV, 10). Ah, se noi conoscessimo la grazia, i suoi vantaggi, oh! come ardentemente la brameremmo, quanto sollecitamente la cercheremmo, come studieremmo di procurarcela, di conservarla, di accrescerla! oh! come ci sembrerebbe vile e spregevole ogni altra cosa! La grazia rende indifferenti a quanto il mondo ha di più lusinghiero, attraente e seducente. Quando si bagnano le labbra nell’acqua sacra della divina grazia, non si ha più. sete del mondo, non si brama che il cielo… La grazia dà la vita e l’immortalità…; produce la pace…; la grandezza dell’anima …; la gioia nelle traversie …; la speranza della gloria… « Fare le cose eroiche, patire da forte avversità gravissime, è proprio non dei romani, ma dei Cristiani », diceva un autore alludendo al fatto di Scevola (Et facere, et pati fortia, non romanorum sed christianorum est – Anton. in Meliss.). Per la grazia noi diveniamo gli amici di Dio, siamo adottati in suoi figli e ci vantiamo di avere Dio per padre… Per la grazia, noi siamo in comunione con la SS. Trinità, con la Santa Vergine, con gli Angeli, coi beati tutti. Per la grazia, noi partecipiamo a tutti i meriti di Gesù Cristo, a tutti i favori annessi al santo Sacrifizio che si offre senza interruzione nel mondo intero; ai meriti di tutti i santi … Per la grazia, noi ci assicuriamo la ricompensa della vita eterna. Grandi, inestimabili vantaggi porta all’uomo la grazia: 1° Caccia e distrugge il peccato mortale che è la somma sua disgrazia… 2° Rende la persona accetta a Dio … 3° Fa l’uomo retto, santo, innocente, giusto, somigliante a Dio al quale tiene sottomessa l’intelligenza, la volontà e tutte le altre sue facoltà… 4° Ci fa figli di Dio, suoi eredi, coeredi di Gesù Cristo, templi dello Spirito Santo, membra di Cristo … 5° Porta con sé le virtù tutte e i doni dello Spirito Santo… 6° Rende l’anima più splendida del sole, più bella della luna, pura come gli Angeli, terribile a tutti i suoi nemici… 7° È la semenza della gloria; come dal seme nascono le piante, i fiori, i frutti, così dalla grazia nasce la felicità e la gloria eterna… 8° La grazia chiude l’inferno, apre il cielo, dispone di Dio come le piace. Si può dire della grazia quello che Salomone scrive della sapienza: « che conduce il giusto per vie diritte, gli addita il regno di Dio, gli dà la scienza dei santi, ne prospera il lavoro, ne benedice le imprese » — Iustum deduxit Dominus per vias rectas, et ostendit illi regnum Dei; dedit illi scientiam sanctorum, honestavit illum in laboribus et complevit labores illius (Sap. X, 10). « E insieme con lei vengono tutti i beni » — Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa (Ib. VII, 11). « Dio visita la terra dei nostri cuori, dice il Salmista, la feconda e la inebria di beni. La pioggia benefica delle sue grazie fa germogliare tutte le virtù nell’anima e la colma di gioia »— Visitasti terram, et inebriasti eam… In stillicidiis eius lætabitur germinans (Psalm. LX1V, 9-11). « Il latte delle vostre grazie, o Signore, possiamo dire con la Sposa dei Cantici, è più delizioso di ogni prelibato vino » — Meliora sunt tubera tua vino (Cant. I, 1). Ah sì! le mammelle spirituali della grazia nutriscono l’anima e la riempiono di consolazioni; come i bambini trovano tutto il loro nutrimento e la loro felicità al seno delle loro mamme, di modo che non cercano né vogliono altro, così è della grazia, della quale si può dire: « Chi di me si nutre, di me avrà sempre fame; chi di me beve, sempre sarà di me assetato » — Qui edunt me, adhuc esurient; et qui bibunt me, adhuc sitient (Eccli. XXIV, 29). – Infatti, quanto più le anime fedeli assaporano le dolcezze, le soavità della grazia, tanto più sentono in loro aumentarsene la voglia. È proprio delle delizie spirituali accrescere l’avidità in chi le assaggia; le grazie accrescono il desiderio saziandolo. – La grazia lenisce i patimenti. « Quelli, dice S. Bernardo, che aborriscono e fuggono la croce, vedono la croce, ma non l’unzione della croce. Voi che amate la croce, sapete per prova che stillante dolcezza e miele è la croce, perché unita delle grazie dello Spirito Santo che vi aiuta » (Serm. in Cant.). S. Paolo diceva: « In mezzo a tutte le mie tribolazioni, io mi sento ridondare il cuore di gioia e di allegrezza » — Repletus sum consolatione, superabundo gaudio in omni tribulatione (II Cor. VII, 4). La grazia, infatti, cambia il fiele in dolcezza, mentre le dolcezze del mondo cambiano il miele in amarezza. Basta una stilla di grazia a cambiare in miele un mare di fiele; basta una goccia di voluttà carnale a fare della vita intera un calice di amarezza.
15. CONTO CHE SI DEVE RENDERE DELLE GRAZIE. — Contro coloro che non si curano delle grazie di Dio, Gesù Cristo pronunziò una terribile sentenza: « A chi fu dato molto, si domanderà molto; a chi s’è fatto più largo prestito, più larga usura sarà richiesta » — Omni… cui multum datum est, multum quæretur ab eo; et cui commendaverunt multum, plus petent ab eo (Luc. XII, 48). Ricordate la parabola del servo infingardo e quelle parole: « Rendimi ragione della tua gestione » — Redde rationem villicationis tuæ (Luc. XVI, 2), le quali c’insegnano che se nulla mette tanto conto quanto il profittare delle grazie, niente per altra parte tanto nuoce quanto l’abusarne. « A misura che s’aumentano i doni, dice S. Gregorio, cresce anche la materia di cui s’avrà da rendere conto (Dum augentur dona, rationes etiam crescunt donorum – Homil. IX in Evang.) ». Stiano scritte a caratteri indelebili nel cuore nostro quelle parole di San Paolo agli Ebrei: « È cosa difficilissima, per non dire impossibile, che coloro i quali già furono una volta illuminati e ottennero il dono perfetto e furono partecipi dello Spirito Santo e gustarono le dolcezze della parola di Dio e le virtù del secolo venturo e sono poi precipitati, ritornino un’altra volta a penitenza, crocifiggendo nuovamente in loro stessi il Figliuolo di Dio ed esponendolo all’ignominia, poiché la terra che beve la pioggia che frequentemente cade in grembo, e produce erbe utili a chi la coltiva, riceve benedizione da Dio; ma se produce spine e triboli, essa è riprovata e prossima a maledizione; e la sua fine è nel fuoco » (VI, 4-8).
16. BISOGNA PROFITTARE DELLE GRAZIE. — « Colui che ci ha creati senza di noi, non ci salva senza noi (Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te -Confess.) », dice S. Agostino e con ragione; perché nessuno si salva se non per mezzo della grazia, ma la grazia non salva se non in quanto le si corrisponde e se ne trae profitto. Perciò S. Paolo scriveva a Timoteo: « Bada di non trascurare la grazia che è in te e questo avvertimento non ti cada mai dalla memoria, ma metti in esso tutto l’animo ed ogni tua cura, affinché il tuo profitto sia manifesto a tutti » — Noli negligere gratiam quæ in te est. Hæc meditare, in his esto, ut profectus tuus manifestus sit omnibus (l Tim. IV, 14-15). E agli Ebrei raccomandava che nessuno non venisse meno alla grazia: — Ne quis desit giatiæ Dei (Hebr. XII, 15). Questo era il saluto di S. Giovanni, l’augurio di S. Pietro ai primi fedeli: « Sia con voi, scriveva quegli alla casa di Eletta, la grazia e la misericordia e la pace » — Sit vobiscum gratia, misericordia et pax (77, 3); e questi chiudeva la sua seconda epistola dicendo: « Crescete nella grazia e nella cognizionedel Signor nostro e Salvatore Gesù Cristo » — Crescite in gratiæ cognitione Domini nostri et Salvatoris Iesu Christi (II PETR. III, 18). Infatti chi non profitta, scapita; diceva S. Leone (Serm. de Pass.), e chi non acquista niente, perde qualche cosa. Non imitiamo la cieca Gerusalemme nel fare poco profitto delle grazie, perché non avvenga che Gesù Cristo abbia anche da piangere su la nostra perdita e rivolgerci quelle parole, rimprovero e sentenza a un tempo: « Ah, se tu conoscessi almeno in questo giorno che ancora ti è concesso, quello che formerebbe la tua pace! ma ora tutto è celato agli occhi tuoi» (Luc. XIX, 41- 42). – « Beato chi mi ascolta, dice la grazia, e chi sta origliando alle mie porte per udire le mie parole! Chi trova me, trova la vita e avrà la salvezza dal Signore. Ma chi mi offende, nuoce all’anima sua; e chi non mi ama, va incontro alla morte » — Beatus homo qui audit me, et qui vigilat ad fores meas quotidie. Qui me invenerit, inveniet vitam, et hauri et salutem a Domino. Qui aut emin me peccaverit, lædet animam suam. Omnes qui me oderunt, diligunt mortem (Prov. VIII, 34-36). E chi non approfitterà della grazia, se dà retta ai caldi inviti che gliene fa Dio per mezzo dei suoi profeti? Udite, per esempio, quello che dice Isaia:« Chi ha sete venga al fonte; chi è nell’indigenza si affretti, compri e si sazi; venite e comprate, senza sborsare prezzo, vino e latte. Ascoltate me, nutritevi del bene, della grazia, e l’anima vostra sarà inebriata di dolcezze. Ascoltatemi e venite a me, ascoltatemi e vivrà l’anima vostra, ed io stabilirò con voi un patto sempiterno » (ISAI. LV, 1-3).
17. MEZZI PER OTTENERE E CONSERVARE LA GRAZIA. — 1° Bisogna averne grande desiderio: « La grazia, come ci assicura il Savio, previene coloro che la desiderano, per mostrarsi ad essi la prima. Chi sorgerà di buon mattino a cercarla, non avrà da stancarsi per trovarla, perché la incontrerà già seduta su la soglia della sua casa » — Præoccupat qui se concupiscimi, ut illis se prius ostendat. Qui de luce vigilaverit ad illam, non laborabit: assidentem enim illam foribus suis inveniet (Sap. VI, 14 – 15). S. Paolo l’augurava larga ed abbondante su tutti i Cristiani, dicendo: « La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi » — Gratia Domini nostri Iesu Christi cum omnibus vobis. Amen (II Tkess. III, 18); e con ciò ha dato a noi esempio di desiderarla per noi medesimi; perché, al dire della Sapienza, quanti ebbero sete ed invocarono il Signore, trovarono sempre l’acqua che li ha dissetati: — Sitierunt et invocaverunt te, et data est illis aqua (Sap. XI, 4 ).
2° Bisogna pregare per ottenerla, conservarla, aumentarla. « La chieda a Dio, suggerisce S. Giacomo, il quale gliela dà in abbondanza » — Postulet a Deo, qui dat omnibus affluenter (IACOB. I, 5 ). Così fece la Samaritana, la quale prontamente soggiunse a Cristo: « Dammi, o Signore, di quest’acqua, affinché non patisca mai più sete » — Domine, da mihi hanc aquam, ut non sitiam (IOANN. IV, 15). Così fecero coloro dei quali racconta il Salmista che « domandarono ed ebbero dal cielo di che nutrirsi; avendo sete pregarono, ed il Signore fece zampillare per loro una fonte nel deserto » — Petierunt, et pane cœli saturavit eos. Dirupit petram, et fluxerunt aquæ (Psalm. CIV, 9-40).
3° Bisogna vegliare; perché la grazia, dice il Crisostomo, è data solo ai vigilanti (Non datur gratia, nisi vigilanti – Homil. ad pop.). Perciò S. Paolo dice agli Efesini: « Scuotetevi, voi che dormite, levatevi di mezzo ai morti e Cristo v’illuminerà con la sua grazia. Badate adunque, o fratelli, di camminare cautamente, non da stolti, ma da savi » — Surge qui dormis, et exsurge a mortuis, et illuminabit te Christus. Videte, fratres, quomodo caute ambuletis, non quasi insipientes, sed quasi sapientes (Eph. V, 14-16).
4° Bisogna schivare il peccato od uscirne perché il peccato è il solo ostacolo alla grazia. La grazia non può stare col peccato, come la notte col giorno, la vita con la morte.
5° Bisogna cercare la grazia alla propria sorgente della grazia, cioè nei Sacramenti.