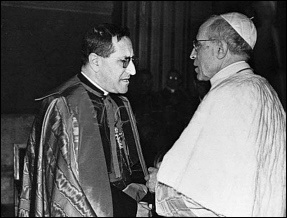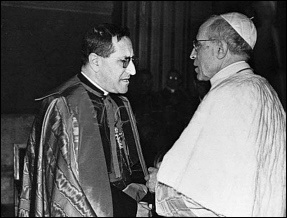DOMENICA fra L’OTTAVA DELL’EPIFANIA.
Semidoppio – Paramenti bianchi.
Dall’età di dodici anni, i Giudei dovevano celebrare ogni anno, a Gerusalemme, le tre feste: di Pasqua, della Pentecoste, e dei Tabernacoli. La liturgia del tempo di Natale, che ci ripete tutta la fanciullezza di Gesù, ce lo mostra oggi al Tempio. Per la prima volta Egli dichiara ai Giudei che Dio è «Suo Padre « (Vang). Non è senza un motivo – dice S. Ambrogio – che, dimenticando i suoi genitori secondo la carne, questo Fanciullo il quale, anche secondo la carne era pieno di sapienza e di grazia, volle esser ritrovato nei Tempio dopo tre giorni: egli significava con ciò che, tre giorni dopo il trionfo della Passione, Colui che si credeva morto sarebbe risuscitato e sarebbe stato allora l’oggetto della nostra fede, seduto sopra un trono celeste nella gloria celeste. In Lui infatti, ci sono due nascite: l’una per la quale è generato dal Padre e l’altra per la quale nasce da una madre. La prima è del tutto divina, con la seconda Egli si abbassa fino a prendere la nostra natura » (3° Nott.).
L’Ufficio di questa Domenica è ridotto alla semplice commemorazione nella festa della Sacra Famiglia. La Messa può essere tuttavia celebrata al primo giorno libero della settimana che segue.
Incipit
In nómine Patris, ✝ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
Introitus
In excelso throno vidi sedere virum quem adorat multitude Angelorum, psallentes in unum: ecce cujus imperii nomen est in æternum.
[Sopra un eccelso trono vidi sedere un uomo che una moltitudine di Angeli, cantando inni e salmi, adorava: ecco colui il cui nome è da tutta l’eternità]
Ps XCIX, 1 Jubilate Deo, omnis terra; servite Domino in lætitia. Introite in conspectu ejus in exsultatione. [Acclamate con gioiaa Dio da tutta la terra: servite al Signore con allegrezza]
Oratio
Orémus.
Vota, quæsumus, Domine, supplicantis populi cœlestis pietate prosequere: ut et quæ agenda sunt, videant, et ad implenda quæ viderint, convalescant. Per Dominum …
[Ascolta, Signore, con divina bontà, i voti del tuo popolo supplicante affinché e veda il suo dovere e di compierlo abbia la forza. Per nostro ….]
Lectio
Obsecro itaque vos fratres per misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem, rationabile obsequium vestrum. Et nolite conformari huic saeculo, sed reformamini in novitate sensus vestri : ut probetis quae sit voluntas Dei bona, et beneplacens, et perfecta. Dico enim per gratiam quae data est mihi, omnibus qui sunt inter vos, non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem: et unicuique sicut Deus divisit mensuram fidei. Sicut enim in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eumdem actum habent: ita multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra.
OMELIA I
[A. Castellazzi: La scuola degli Apostoli –
Sc. Tip. Vesc. Artigianelli, Pavia, 1921]
IL CULTO SPIRITUALE
“Fratelli: Vi scongiuro per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come ostia viva, santa, accetta a Dio, quale vostro culto razionale. E non vogliate conformarvi a questo secolo, ma trasformatevi col rinnovamento del vostro spirito, affinché possiate discernere quale sia la volontà di Dio buona, gradevole e perfetta. In virtù della grazia che mi è stata data dico, dunque, a ciascuno di voi di non voler stimar se stesso più di quanto convenga, ma di stimarsi con moderazione, secondo la misura della fede distribuita da Dio a ciascuno. Infatti, come nel corpo abbiamo molte membra, e non tutte le membra hanno la stessa funzione; così tutti insieme siamo un sol corpo in Cristo; individualmente siamo membra gli uni degli altri in Gesù Cristo nostro Signore.” (Rom. XII, 1-5).
S. Paolo, nella sua lettera ai Romani, dopo aver dimostrato che l’uomo ottiene la salute mediante la fede in Gesù Cristo, passa a dire quale dev’essere il tenore di vita d’un Cristiano. L’Epistola di quest’oggi è il principio di questa seconda parte della lettera. L’uomo che è entrato a far parte della Chiesa di Gesù Cristo deve offrire a Dio un culto spirituale, servendolo col corpo e con l’anima; rinunciando allo spirito del secolo, e seguendo la volontà di Dio. Deve inoltre aver sentimento di modestia nell’adempimento dei doveri reciproci tra i Cristiani. Parliamo del culto spirituale, col quale:
1 Offriamo noi stessi a Dio,
2 All’opposto di quel che fa il mondo;
3 Prendendo a norma la volontà divina.
1.
Fratelli, vi scongiuro per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come ostia viva, santa, accetta a Dio.
I Cristiani, chiamati dalla misericordia di Dio alla grazia del Vangelo, devono dimostrargli la loro riconoscenza con rendergli un omaggio degno di lui. Gli Ebrei gli offrivano ostie mute, corpi morti, incapaci di dare a Dio la dovuta lode. I Cristiani, al contrario, offriranno a Dio un’ostia a Dio viva e santa, che gli riesca gradita. Noi offriamo a Dio un’ostia viva, e quindi un culto ragionevole e spirituale, quando il nostro corpo non sarà schiavo del peccato; quando, con la mortificazione, gli impediremo di servire alle passioni. Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. «Non sapete voi — dice l’Apostolo — che siete tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi?» (I Cor. VI, 19) Il nostro corpo non va pertanto, riguardato come cosa nostra, ma come proprietà di Dio a cui è consacrato e, per conseguenza, non deve servire che per usi santi e degni di Dio, in modo da renderlo come sua gradita dimora. Tutte le nostre azioni esterne devono rendere omaggio a Dio. «Presentate voi stessi come risorti da morte a vita, e le vostre membra qual arma di giustizia a Dio», ci dice ancora l’Apostolo (Rom. VI, 13). Noi siamo liberi di scegliere tra il bene e il male: tra il servir Dio e il servir le passioni; tra il militare per la giustizia e il militare per l’iniquità. – Quando ci serviamo del corpo per compiere azioni conformi agli insegnamenti divini, noi militiamo per la giustizia, facendo a Dio l’offerta di noi stessi. – È poi necessario che questa immolazione mistica del nostro corpo con tutte le sue azioni sia vivificata dallo spirito interno. Allora solamente sarà un culto ragionevole e spirituale. Nel Levitico era prescritto che sull’altare dell’olocausto il fuoco dovesse ardere sempre. «Questo è il fuoco perpetuo che non mancherà mai sull’altare» (Lev. VI, 13). La carità è precisamente il fuoco che consuma il sacrificio delle nostre azioni. Ove questa, fiamma interna venisse a mancare, le nostre azioni, fossero anche eroiche, perderebbero del loro pregio in merito al sacrificio spirituale che noi dobbiamo compiere. Per i sacrifici, che si offrivano a Dio nel tempio di Gerusalemme, c’erano determinati giorni e ore. Noi invece, dobbiamo offrire il nostro sacrificio spirituale, il sacrificio di noi stessi, in qualunque luogo e in qualunque ora del giorno. E sempre dobbiamo compiere questo sacrificio con prontezza d’animo, poiché è troppo giusto « che noi dobbiamo rendere a Dio ciò che è suo: il corpo, l’anima, la volontà, avendo avuti da Lui questi doni » (S. Ilario, Comm., in Matth, cap. XXIII, 2). –
2.
E non vogliate conformarvi a questo secolo.
Il secolo è il mondo che non segue gli insegnamenti di Gesù Cristo. Esso tiene, naturalmente, un contegno tutto opposto a quello raccomandato dall’Apostolo. Invece di fare del proprio corpo una vittima accettevole a Dio, ne fa un idolo a cui tutto deve sacrificarsi. I sacrifici per il cielo sono cose prive di senso per i seguaci del secolo. I loro pensieri, le cure, le azioni sono per il godimento di questo mondo: piaceri sensuali, accumulamento e abuso delle ricchezze, mania di voler comparire a ogni costo. Si schiveranno, magari, certi vizi più gravi, che troppo esporrebbero al disonore o ad altre non piacevoli conseguenze; ma, quanto al resto, nessun ostacolo lo trattiene. Si capisce che non possono essere diversi dalla pratica gli insegnamenti. Chi pone lo spirito di sacrificio a norma della propria condotta, è un illuso. Chi mortifica le passioni, è uno squilibrato. Chi fugge i pericoli, è un uomo senza spirito. «Il timor di Dio vien chiamato semplicità, per non dir sciocchezza» (S. Bernardo. De Cons. L. 4. c. 2). – Quindi, certe ingiustizie non sono che questione di interesse. Tanti individui e tante famiglie spogliate non sono che la conseguenza degli affari. Se uno resta vittima, peggio per lui. Gli atti di prepotenza e di vendetta, pel mondo, sono un nobile puntiglio. Certi soprusi sono un diritto per salire in alto, e via di questo passo. Contro il secolo corrotto e corruttore ammoniva S. Agostino con quelle accorate parole: «Guai a te, o fiumana dell’umano costume. Chi ti potrà resistere? Fino a quando non ti seccherai? Fino a quando travolgerai i figliuoli d’Eva nel mare grande e pauroso che appena può solcarsi da coloro che sono saliti sulla nave?» (Conf. L. 1, c. 16). La Venerabile Teresa Eustochio Verzieri aveva appena cinque anni, quando, un giorno di festa, caduta in terra e infangatasi tutta la veste nuova che indossava, si dice che uscisse in queste gravissime parole: — Ecco che sono le vanità del mondo — (Decreto sulla causa di Beat, e Canoni, ecc. 2 Aprile 1922). Non mancano, come si vede, i privilegiati che, fin dagli anni più teneri, sanno giudicare che cosa sia il mondo, e, con l’aiuto della grazia, non si lasciano trascinare dalla sua corrente. Ma i più, ma il gran numero, o presto o tardi, ne sono miseramente travolti. E tu resisti al corso travolgente del secolo? Se ami ciò che il mondo ama e stima: se approvi ciò che il mondo approva; se ti dai ai piaceri terreni, invece di attendere all’acquisto della virtù: se ti occupi dei tuoi affari in modo da dimenticare il cielo: se odi la povertà, le umiliazioni; se ti rifiuti di portare la croce che ogni Cristiano deve portare in questa vita: tu ti conformi, più o meno a questo secolo, anche se non arrivi a certi eccessi, che nel secolo si commettono. Compirai. mettiamo pure, delle buone opere; ma. forse, è il caso del proverbio: Non è oro tutto quel che luce. Per quanto esternamente lodevoli, se sono basate sulla vanità, sull’amor proprio, non sono diverse dalle opere dei Farisei, tante volte condannate da Gesù Cristo; non sono diverse da tante opere del mondo, compiute, non per render omaggio a Dio, ma per appagare il proprio egoismo.
3.
Il Cristiano, mediante il Battesimo, è diventato una nuova creatura. Nuove devono essere ora le massime su cui regolare la propria condotta. Se per il passato aveva seguito le massime del mondo ora deve seguire le massime del Vangelo. Prima faceva la volontà del secolo, ora faccia la volontà di Dio. S’inganna gravemente il Cristiano che crede di attingere le norme della propria condotta da altra sorgente che dalla volontà di Lui. Egli solo può direi quello che è meglio per noi, quello che è gradito a Lui. Ed è chiaro che chi vuol conoscere la volontà di Dio deve prima liberar se stesso dalle passioni, e rinnovare in questo modo il suo spirito, affinché possa distinguere chiaramente ciò che Dio vuole da lui. Quando un’ondata di vento ci porta fumo e polvere negli occhi, non si possono scorger bene le cose che ci stanno attorno. Quando dall’anima non si è tolta la polvere del peccato, e vi si lascia innalzare il fumo delle passioni, quando, insomma, rimane l’uomo vecchio, non si è capaci e disposti al ascoltare ciò che Dio vuole da noi. – Non è pure il caso di osservare che la volontà di Dio va conosciuta per essere praticata. Una cognizione sterile della volontà di Dio, non seguita dalle opere, non completa il nostro rinnovamento. La nostra cognizione della volontà di Dio dev’essere così esattamente seguita dalle opere da poter essere una scuola efficace per i seguaci del mondo. I seguaci del mondo non si curano di conoscere la volontà di Dio direttamente, meditandola con spirito di umiltà. Ebbene, la conoscano indirettamente. Le nostre opere, così diverse dalle loro, volere o no, sono un richiamo. Quest’opere, che sono la conseguenza dell’esecuzione della volontà di Dio, insegnano, con linguaggio muto, ma eloquente, ciò che secondo la volontà di Dio è buono, lodevole, perfetto. – L’Apostolo esorta i Romani a stimarsi con moderazione, secondo la misura della fede distribuita da Dio a ciascuno. L’abbondanza dei doni, onde erano stati arricchiti, poteva esser loro cagione d’orgoglio. Non cedano a questa tentazione; ma ciascuno si stimi per quello che è in realtà; non si attribuisca doni e poteri che a lui non furono concessi: si accontenti, invece, di compire quell’ufficio che da Dio gli fu affidato. Si dice che il contentarsi del poco, è un boccone mal conosciuto. Pure, per far la volontà di Dio ed andare in Paradiso, non è scritto che dobbiamo essere in una condizione privilegiata, che dobbiamo sovrastare gli altri per potere e ricchezze, che dobbiamo emergere per coltura e per ingegno. Basta che ci accontentiamo di fare la via crucis giornaliera del nostro stato. E quanto più la faremo senza lamenti, senza rincrescimenti, tanto più daremo la dimostrazione pratica di fare la volontà di Dio. Dio vuole che ciascuno si dimostri fedele nel compire l’ufficio affidatogli; sia esso un ufficio di grande importanza, sia mi ufficio stimato da poco. Tanto al servo che, avendo ricevuto cinque talenti, ne consegna dieci, quanto a quello che, ricevuti due, ne consegna quattro, viene detto: «Bene, o servo fedele, entra alla festa dei tuo padrone» (Matth. XXV, 21-23). Ognuno ha da fare nel grado suo. L’importante è di fare la volontà di Dio contenti, sereni, perché «Dio ama chi dà con gioia » (2 Cor. IX, 7). Questo è anche l’invito che ci fa la Chiesa quest’oggi, ammonendoci ripetutamente col Salmista: « Servite il Signore con gioia » (Ps. IC, 1).
Graduale
Ps LXXI: 1-8 et 3
Benedictus Dominus, Deus Israel, qui facit mirabilia magna solus a sæcula. Suscipiant montes pacem populo tuo et colles justitiam. [Sia benedetto il Signore Dio di Israele, il solo che fa cose mirabili. Recheranno i monti pace al popolo tuo e i colli la giustizia.]
Alleluja
Ps XCIX, 1 Jubilate Deo, omnis terra; servite Domino in lætitia. Introite in conspectu ejus in exsultatione: [Acclamate con gioiaa Dio da tutta la terra: servite al Signore con allegrezza: entrate alla sua presenza con esultanza:]
Evangelium
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum S. Luca
S. Luc II: 42-52
Cum factus esset Jesus annórum duódecim, ascendéntibus illis Jerosólymam secúndum consuetúdinem diéi festi, consummatísque diébus, cum redírent, remánsit puer Jesus in Jerúsalem, et non cognovérunt paréntes ejus. Existimántes autem illum esse in comitátu, venérunt iter diéi, et requirébant eum inter cognátos et notos. Et non inveniéntes, regréssi sunt in Jerúsalem, requiréntes eum. Et factum est, post tríduum invenérunt illum in templo sedéntem in médio doctórum, audiéntem illos et interrogántem eos. Stupébant autem omnes, qui eum audiébant, super prudéntia et respónsis ejus. Et vidéntes admiráti sunt. Et dixit Mater ejus ad illum: Fili, quid fecísti nobis sic? Ecce, pater tuus et ego doléntes quærebámus te. Et ait ad illos: Quid est, quod me quærebátis? Nesciebátis, quia in his, quæ Patris mei sunt, opórtet me esse? Et ipsi non intellexérunt verbum, quod locútus est ad eos. Et descéndit cum eis, et venit Názareth: et erat súbditus illis. Et Mater ejus conservábat ómnia verba hæc in corde suo. Et Jesus proficiébat sapiéntia et ætáte et grátia apud Deum et hómines.
[Quando Gesù raggiunse i dodici anni, essendo essi saliti a Gerusalemme, secondo l’usanza di quella solennità, e, passati quei giorni, se ne ritornarono, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, né i suoi genitori se ne avvidero. Ora, pensando che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di cammino, dopo di che lo cercarono tra i parenti e i conoscenti. Ma non avendolo trovato, tornarono a cercarlo a Gerusalemme. E avvenne che dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, mentre sedeva in mezzo ai Dottori, e li ascoltava e li interrogava, e tutti gli astanti stupivano della sua sapienza e delle sue risposte. E, vistolo, ne fecero le meraviglie. E sua madre gli disse: Figlio perché ci ha fatto questo? Ecco che tuo padre ed io, addolorati, ti cercavamo. E rispose loro: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi di quel che spetta al Padre mio? Ed essi non compresero ciò che aveva loro detto. E se ne andò con loro e ritornò a Nazareth, e stava soggetto ad essi. Però sua madre serbava in cuor suo tutte queste cose. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia innanzi a Dio e agli uomini].
OMELIA II
[A. Carmignola, Spiegazione dei Vangeli domenicali, S. E. I. Ed. Torino, 1921]
SPIEGAZIONE VI.
“E quando Egli (Gesù) fu arrivato all’età di dodici anni, essendo essi andati a Gerusalemme, secondo il solito di quella solennità, allorché, passati quei giorni, so ne ritornavano, rimase il fanciullo Gesù in Gerusalemme; e non se ne accorsero i suoi genitori. E pensandosi ch’Egli fosse coi compagni, camminarono una giornata, e lo andavano cercando tra i parenti e conoscenti. Né avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme a ricercarlo. E avvenne, che dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, che sedeva in mezzo ai dottori, e li ascoltava, e li interrogava. E tutti quei, che l’udivano, restavano attoniti della sua’ sapienza e delle sue risposte. E vedutolo (i genitori) ne fecer le meraviglie. E la Madre sua gli disse: Figlio, perché ci hai tu fatto questo? Ecco che tuo padre e io addolorati andavamo di te in cerca. Ed Egli disse loro: Perché mi cercavate voi? Non sapevate come nelle cose spettanti al Padre mio debbo occuparmi? Ed eglino non compresero quel che aveva lor detto. E se n’andò con essi, e fe’ ritorno a Nazareth, ed era ad essi soggetto. E la madre sua di tutte queste cose faceva conserva in cuor suo. E Gesù avanzava in sapienza, in età, in grazia appresso a Dio e appresso agli uomini” (S. Luc. II, 42-52).
Dopo che nostro Signor Gesù Cristo per scampare ai furori di Erode era stato portato in Egitto ed ivi aveva dimorato alquanto tempo, cessato il pericolo per la morte di quel barbaro re, fu ricondotto nella Palestina, e con Maria e Giuseppe andò in Galilea ad abitare nella città di Nazareth. E fu in questa piccola città, dagli Ebrei tenuta in nessun conto, che Gesù passò d’allora fino ai trent’anni la sua vita privata. Ma come il Vangelo circondò di misterioso silenzio gli anni, che Gesù passò esule in Egitto, così di silenzio anche più misterioso circondò gli anni da Lui passati nella vita privata a Nazareth. Un solo fatto di questa vita ci narra, il quale è come uno splendido raggio di luce in mezzo ad una completa oscurità. Ed è questo fatto, che ci invita a considerare la Chiesa nel Vangelo di oggi. In esso noi potremo prendere varie lezioni, e tutte di grandissima importanza.
1. Gesù era arrivato all’età di dodici anni, ed essendo giunta la festa di Pasqua, Maria e Giuseppe recandosi secondo il solito a Gerusalemme per celebrarla, condussero con loro Gesù. E quando furono passati i giorni di quella solennità, ripresero a fare il viaggio di ritorno. Ma senza che Maria e Giuseppe se ne avvedessero, Gesù rimase in Gerusalemme. Camminarono adunque i Santi Sposi per tutta una giornata, pensandosi die fosse coi compagni di viaggio. – Il che non ci deve recar meraviglia, giacché era costume fra gli Ebrei, che, sia nell’andare, come nel ritornare da Gerusalemme, formassero tanti gruppi separati di uomini e di donne, andando i fanciulli indifferentemente con gli uni o con le altre. È dunque verisimilissimo, che Maria credesse Gesù essere con Giuseppe, e dal canto suo Giuseppe immaginasse, che Gesù fosse con Maria. Ma come giunsero ad un punto del viaggio, in cui forse si faceva una fermata e gli uomini si riunivano alle loro donne per prendere insieme qualche po’ di ristoro, ecco che Maria e Giuseppe riscontratisi, si avvedono che Gesù non era con loro. Lo cercano subito tra i parenti e gli amici, ma non lo trovano. Chi può dire allora il dolore che venne a colpire il cuor di Maria e quello di S. Giuseppe? Perdere Gesù!… e poteva loro capitare una disgrazia più grande? Con la loro immaginazione così viva e fatta più accesa dalla sventura andavano congetturando mille cose diverse di Lui, e tutte tristi. Sapevano che Gesù prendendo l’umana natura, ne aveva accettato altresì tutti i bisogni, tutte le prove, tutta la miseria. Epperò non poteva essere, che essendosi smarrito, ora si trovasse a patire la fame, la sete, il freddo, i disagi della vita? Pertanto, prontamente ritornarono indietro a Gerusalemme a ricercarlo. E chi sa dire le sollecitudini, che a tal fine adoperarono? È certo che ad ogni persona che incontravano, andavano domandando: Avete visto Gesù? un giovane di dodici anni, bello come il Paradiso? È certo, che di tanto in tanto, massime nei luoghi boscosi, facevano ripetutamente risuonare la voce gridando: Gesù! Gesù! È certo, che passando vicino a qualche luogo dirupato gettavano ansiosamente lo sguardo giù nei burroni, se caso mai vi fosse caduto. E quando poi rientrarono in Gerusalemme non vi furono strade, non vi furono piazze, che essi non percorressero da capo a fondo, in largo e in lungo; e non vedendolo in nessun luogo cominciarono a battere alle porte di quelle case, dove potevano supporre, che Gesù fosse stato raccolto. E ciò per tre giorni senza darsi pace mai, sempre con le lagrime agli occhi. Che desolante contrasto tra il dolore di Maria e di Giuseppe nell’avere perduto Gesù, la loro sollecitudine per ritrovarlo e il niun affanno, che provano certi Cristiani, i quali pure lo hanno perduto. Le Sacre Scritture ci insegnano, che noi per la grazia di Dio possediamo Gesù dentro i nostri cuori. Ma quando si commette il peccato mortale, questo caro Gesù si perde. E sapete che vuol dire perdere Gesù! Vuol dire perdere Iddio, che pur siamo destinati a possedere eternamente, vuol dire perdere la sua grazia e la sua amicizia, vuol dire perdere il merito di tutte le opere buone compiute pel passato, vuol dire chiudersi le porte del Paradiso e spalancarsi quelle dell’inferno, vuol dire diventare con l’anima brutta, nera, schifosa, vuol dire cadere nella schiavitù e sotto il potere del demonio, vuol dire infine rendersi inabile ad operare qualsiasi cosa, che giovi per la vita eterna; vuol dire tutto questo. Eppure vi hanno degli insensati, i quali vanno burbanzosi ripetendo: Peccavi et quid mihi accidit triste? (Eccl. V, 4). Ho peccato, e che cosa miè accaduto di triste? Ah se quando si commette il peccato mortale si perdesse la sanità, l’onore degli uomini, una gran somma di danaro, che dico una gran somma? si perdesse anche solo uno scudo, lo si riterrebbe per una gran disgrazia e gli si piangerebbe sopra e si farebbe di tutto per ritrovarlo; ma perché col peccato mortale si è perduto Gesù, non solo non si piange, non lo si ricerca, ma talvolta si continua forsennatamente a ridere e a stare allegri. Quale stoltezza e quale audacia! Eppure come concepire anche solo un Cristiano, che s’addormenta la sera senza pensar neppure a fare un atto di contrizione, sapendo che nel giorno ha offeso Iddio mortalmente ed ha perduto la sua grazia? Come comprendere coloro, che, pur credendo all’esistenza di un Sacramento istituito da Dio per ridonare la sua grazia a chi l’ha perduta, amano meglio rimanere e sprofondarsi nell’abisso della colpa per i giorni, per le settimane, per i mesi, e talvolta anche per gli anni? Ah, miei cari! non vogliate mai mettervi nel numero di questi sventurati. E se per disgrazia vi è accaduto di perdere Gesù e la sua grazia, ricercatela tosto col pentirvi del vostro peccato e col fare una santa confessione.
2. Infine Giuseppe e Maria, dopo di avere inutilmente cercato Gesù per tre giorni e tre notti intere nelle vie e nelle case di Gerusalemme, si recarono a ricercarlo nel tempio. E là propriamente lo ritrovarono, che sedeva in mezzo ai dottori della legge, udendo ed interrogando i medesimi e tutti facendo stupire per la sapienza delle sue risposte. Al vederlo restarono presi da meraviglia. E Maria subito gli disse: « Figlio, perché ci hai fatto tu questo? Ecco che tuo padre ed io addolorati andavamo in cerca di te ». Con le quali parole Maria non intendeva già di muovere a Gesù un rimprovero, ma bensì di fare nient’altro che un lamento di tenerezza e nel tempo stesso manifestare la gioia immensa, che essa e Giuseppe, a cui essa dà qui l’onorifico nome di padre di Gesù, provavano nell’averlo ritrovato. Ora qual èla risposta che diede Gesù al tenero lamento di Maria? Uditela: Egli disse: Perché mi cercavate voi? Non sapevate che io debbo occuparmi in ciò che spetta al Padre mio? In questa risposta era racchiuso un ammaestramento così grande che lì per lì, come osserva il Vangelo, Maria e Giuseppe non compresero ciò che Gesù aveva lor detto. Difatti con tali parole nostro Signor Gesù Cristo volle dettarci la gran legge, che noi dobbiamo seguire nelle nostre relazioni con gli uomini, di fronte a Dio. Molte sono le relazioni, che noi possiamo avere quaggiù con gli altri uomini: relazioni di superiorità coi nostri inferiori, di sudditanza coi nostri superiori, di parentela col nostro padre, con la nostra madre, coi nostri fratelli, con gli altri parenti, di amicizia con gli amici, di benevolenza con tutto il prossimo, ed altre simili. In tutte queste relazioni Iddio stesso con la sua santa legge ci impone dei rispettivi doveri, quelli cioè di governare saviamente gl’inferiori, di stare sottomessi ai superiori, di obbedire e rispettare i genitori, di far volentieri qualche sacrifizio per gli amici, di non negare al nostro prossimo quei piaceri, che gli possiamo fare, ed altri ancora di questo genere. Ma sebbene sia vero, che lo stesso Dio ci imponga questi doveri, di modo che non li possiamo trasgredire senza colpa, è pur verissimo, che anzitutto dobbiamo obbedire a Dio ed occuparci di quelle cose, che riguardano Lui, e che per obbedire a Dio ed occuparci delle cose sue dobbiamo, in caso che ciò sia richiesto, lasciare di contentare gli uomini e ben anche opporsi alle loro esigenze. Or ecco la gran legge che Gesù volle farci conoscere con quelle parole rivolte a Maria e Giuseppe: Perché mi cercavate voi? Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose spettanti al Padre mio?E quanto sia importante questa legge è facile a capirsi da ciò, che è la prima legge, che Gesù Cristo nel Santo Vangelo con la sua parola divina promulga. Perché sebbene dovessero essere grandi le cose, che Gesù aveva dette ai dottori, tuttavia il Vangelo non le nota; e invece nota con precisione e narra per disteso ciò, che Egli disse a Maria, precisamente perché si trattava d’una cosa di massima importanza. Ecco dunque ciò, che dobbiamo imprimere nella nostra mente secondo l’insegnamento, che ci dà Gesù in quest’oggi: che Iddio deve andare innanzi a tutti, innanzi alle autorità della terra, innanzi ai padroni e superiori, innanzi agli amici e conoscenti, innanzi agli stessi autori dei nostri giorni. Quando perciò accadesse che le autorità della terra, i padroni, i superiori, gli amici, e ben anche il nostro padre e la nostra madre volessero impedirci di adempiere i nostri doveri verso Dio e non permetterci, ad esempio, di essere veri Cristiani Cattolici, ossequenti al Papa ed ai Vescovi, di andare alla domenica ad ascoltare la S. Messa e di accostarci di tratto in tratto ai SS. Sacramenti, di seguire la vocazione, con la quale il Signore ci ha chiamati a servirlo da vicino nel Santuario o nello stato religioso, noi dobbiamo essere pronti a somiglianza di Gesù a rispondere con le parole e più ancora coi fatti: Prima devo occuparmi delle cose che riguardano a Dio: più che agli uomini devo studiarmi piacere a Lui. Non cercatemi adunque, vale a dire non tentatemi, non distoglietemi dal mio primo dovere. È così appunto, che hanno risposto gli Apostoli a coloro, che volevano loro impedire di predicare Gesù Cristo; è così, che hanno risposto i martiri a quelli, che li volevano costringere a rinnegare la fede; è così, che hanno risposto i Vescovi e i Papi ai potenti della terra, che volevano da loro concessioni dannose alla causa di Dio; è così, che hanno risposto tanti uomini grandi, come un Tommaso Moro, a coloro, che pretendevano di essere accontentati nelle loro ingiuste voglie; è così ancora, che hanno risposto tanti giovani e tante donzelle, quali un S. Luigi Gonzaga, un S. Stanislao Kostka, un S. Francesco di Sales, una S. Teresa, una S. Francesca Chantal e cento e mille altri, a quei parenti, che loro volevano impedire di seguire la loro vocazione e di farsi religiosi. Sappiamo pertanto, nel caso che fosse necessario, seguire anche noi questi sì nobili esempi, e dire anche noi a chicchessia le parole di Gesù: In his quæ Patris mei sunt oportet me esse!
3. Ma ecco che dopo averci dato questo grande ammaestramento con la sua parola, Gesù, secondochè si chiude il Vangelo d’oggi, ce ne dà ancora un altro con l’esempio. E ciò, che più dobbiamo notare si è, che trattasi di un ammaestramento qui al tutto impensato. Giacché il Vangelo dopo averci riferita la risposta di Gesù a Maria e Giuseppe, con la quale Egli dice, che non dovevano cercarlo, dovendo occuparsi delle cose di Dio, soggiunge poi, che tornò con essi a Nazaret, e stava a loro soggetto: Descendit cum eis et venit Nazareth; et erat subditus illis. Ora questo non è undirci chiaramente, che dopo la sudditanza, chedobbiamo a Dio, la prima, che le tien dietro, èquella, che dobbiamo ai nostri genitori? Sì, senzaalcun dubbio. Perciocché bisogna riflettere benea che cosa significa questa semplice espressione et erat subditus illis, che tutta compendia la vitadi Gesù Cristo dai dodici ai trent’anni. Benchéin apparenza dica una cosa di poco momento,in realtà tuttavia ne dice cose grandi assai. Edinvero: Ed era loro soggetto vuol dire, come osservano S. Agostino e S. Bernardo, che Egli, Gesù Cristo, il quale con tutta verità si dichiarò uguale a Dio, ed è Dio Egli stesso, Colui, che fabbricò il cielo e la terra, era soggetto ai parenti, agli uomini, alle creature della terra con quella sudditanza, che si immedesima con la più pronta, più umile e più affettuosa obbedienza. Immaginatelo adunque quel caro Gesù sempre intento a fare la volontà di Maria e di Giuseppe, a prevenirla anzi, ed aiutarli in tutte le loro faccende con una grazia e un’allegrezza mirabile. Epperò eccolo talvolta, per obbedire a Maria ed aiutarla nelle fatiche più pesanti della casa, ora accendere il fuoco, ora lavare con le sue mani divine le povere stoviglie, ora prendere con dolce violenza la scopa di mano a Maria e mettersi Egli a pulire la casa, ora correre sollecito al pozzo, che ancora presentemente si fa vedere presso di Nazaret, per attingere l’acqua. Eccolo, per obbedire a Giuseppe ed aiutarlo ne’ suoi lavori, ora segar qualche trave, ora piallar qualche tavola, ora verniciare quel mobile, ora uscire a far delle compere, ora a prendere delle misure, ed ora attendere ad altre cose somiglianti. – Ma, perché mai in Gesù Cristo una sì umile sudditanza? La ragione è manifesta. Se Gesù, dice Origene, volle onorare Maria e Giuseppe con quell’onore di star loro soggetto, si fu propriamente per dare a tutti i figliuoli l’esempio, affinché stiano sottomessi ai loro genitori e ricordino bene, che questo, dopo i comandamenti che riguardano Dio, è il primo che riguarda gli nomini. Importa adunque, che tutti i figliuoli prendano da Gesù questa importante lezione. E notate bene, o carissimi, che ho detto tutti i figliuoli a bello studio, perché non si pensi che questa lezione si convenga solamente ai bambini, ai fanciulli ed a coloro, che vivono in famiglia, ma perché si ritenga che essa conviene, e assai assai, anche agli adulti, anche a quelli che per ragione della loro educazione si trovano in qualche istituto, perché anzi tutto devono compiere in esso verso dei loro maestri e superiori i doveri, che hanno coi genitori, poscia perché la loro condotta riferita ai genitori può esser loro causa di consolazione e di dolore, da ultimo perché i doveri, che hanno coi genitori, continueranno in tutta la loro forza, anche allora che saranno usciti dall’istituto. Guai a coloro, i quali perché sono giunti ad una certa età e si sentono pieni di vigoria e di vita, non vogliono più sottostare al padre ed alla madre, ne sdegnano gli avvisi, le raccomandazioni ed i comandi, vivono come loro piace, vogliono insomma farla essi da padroni! La mano del Signore non tarderà a farsi pesante sopra il loro capo per castigarli terribilmente anche in questa vita. Nella Sacra Scrittura (Eccl. III, 18) è chiamato infame colui, che abbandona suo padre ed è dichiarato maledetto da Dio colui, che esaspera la sua madre. E nell’antica legge dettata da Dio a Mosè era ordinata la punizione di morte non solo contro di quel figlio snaturato, che alzasse la mano a percuotere i genitori, ma eziandio verso di chi mancava loro di rispetto col proferire ingiurie e maledizioni contro di essi: Qui maledixerit patri suo, vel matri, morte moriatur (Esod. XXI, 19). E con quali terribili esempi ha dimostrato Iddio quanto lo irriti la mancanza di rispetto verso i genitori! Cam mancò di rispetto al suo vecchio padre Noè, e Dio maledisse alla sua discendenza: maledictus Chanaan(Gen. IX, 25), e il segno di quella tremenda maledizione sta tuttora scolpito sopra di essa. Ofni e Finees sprezzarono gli avvisi del loro padre Eli, e tutti e due morirono nello stesso giorno uccisi in battaglia. Assalonne si ribellò al suo padre Davide, e finì di mala morte, appeso ad una quercia e trapassato il cuore dalla lancia di Gioabbo. E quanti altri fatti somiglianti si potrebbero citare! – Io so bene, che taluni vorrebbero esimersi dal dovere di rispettosa sudditanza verso dei loro genitori e superiori col dire, che sono troppo esigenti e noiosi! Ma a costoro io vorrei chiedere: È possibile ricordare le esigenze e le noie della nostra prima educazione e poi non sopportare in pace qualche po’ di esigenza e di noia da parte dei nostri genitori e superiori? O figlio, che mi ascolti, riduciti un po’ alla mente quando eri debole, impotente, senza forza, senza l’uso della ragione, senza parola. Che sarebbe stato di te, se allora la tua madre col pretesto, che le davi noia e fastidio, ti avesse abbandonato? Povera madre! Tutt’altro che abbandonarti! Essa dopo di averti ricevuto dalle mani di Dio nei più acerbi dolori, ti ha dato il suo latte, ti ha nutrito, ti ha cullato, ti ha vegliato di giorno, di notte, rompendo tante volte i suoi sonni, ha guidato i tuoi primi passi, ti ha insegnato le prime parole, ha sopportato i tuoi capricci e quando poi ti ha incolto una grave malattia, si è piantata lì al tuo letticciuolo e non ti ha più abbandonato un istante; ed a questa madre tu ora ardisci pretendi mancar di rispetto? Va là, sciagurato, che non hai cuore. E tuo padre? Sai tu, figliuolo, quel che gli hai costato? Seduto da mane a sera intisichiva nell’ufficio, nei campi bagnava di sudore i solchi, tra il fumo di un’officina logorava la vita sempre tra le ansietà, tra le sollecitudini e persino tra gli stenti e le privazioni, e tutto, tutto per te, per tirarti su, per metterti all’onor del mondo, per procacciarti anche un po’ di fortuna. E dopo tutto ciò, perché ora tu sei in forze e puoi fare da te, non vuoi più riconoscere per superiore tuo padre e vuoi comandargli tu? E i tuoi superiori? i tuoi maestri? Per educarti alle scienze, alle arti e alla virtù, consacrano il loro tempo, sacrificano la loro libertà, si riducono quasi in ischiavitù, pazientemente tollerano il disgusto e la noia di spesso ripetere le stesse cose, gli stessi insegnamenti e le stesse raccomandazioni; e tu non vorresti farne caso, e fors’anche mancar loro di gratitudine e di rispetto, deriderli, disprezzarli? Ahimè! temi e trema! Eadem mensura qua mensi fueritis, remetietur et vóbis (S. Luc. VI, 34). Quella misura, che adoperi adesso verso di tuo padre e di tua madre, e de’ tuoi superiori, Dio permetterà che altri un giorno l’usino verso di te. Ah! carissimi miei, a somiglianza di Gesù, rispettiamo, obbediamo, amiamo i nostri genitori equelli che ne tengono le veci. Se noi compiremo esattamente questo dovere, potremo anche noi meritare il bell’elogio, che, terminando, fa di Gesù il Vangelo di questa mattina: E Gesù avanzava in sapienza, in età, in grazia appresso a Dio e appresso agli uomini.Sì, lo star soggetti ai genitori e superiori, tutt’altro che avvilirci e farci comparire da poco, ci mostrerà veri sapienti e ci farà crescere nella stima sia presso a Dio, come presso agli uomini.
Altra OMELIA
[Mons. J. Billot; Discorsi Parrocchiali – Cioffi ed. Napoli, 1840]
PER LA I DOM. DOPO L’EPIFANIA
– Sopra i doveri dei figliuoli verso i loro Genitori –
“Erat subditus illis”. Luc. II.
Eccovi tutto ciò che il Vangelo ci fa apprende della vita di Gesù Cristo dall’età di anni dodici sino a quella di trenta, che egli passò a Nazaret in casa dei suoi genitori: erat subditus illis, era sottomesso ad essi. Quanti misteri ed istruzioni racchiudono, fratelli miei, queste poche parole! Quanto l’amore che ci dimostra il Salvatore avere per la vita privata degno è della nostra ammirazione! Non vi pare che avrebbe fatto un gran bene, se addirittura si fosse consacrato al pubblico ministero? Qual bene non avrebbe fatto in una vita pubblica? Qual gloria non avrebbe procurata al suo celeste Padre? Quanti peccatori convertiti non avrebbe con le sue prediche e con i suoi miracoli? Perché dunque ha Egli menata sì lungo tempo una vita privata e sconosciuta agli occhi degli uomini? Aveva forse bisogno di tutto quel tempo per prepararsi alla predicazione del suo Vangelo, dove non impiegò che tre anni della sua vita? No, senza dubbio; poteva subito annunziare questo Vangelo, perché aveva la scienza tutta e la capacità che necessaria gli era per adempiere la sua missione. Ma questo adorabile Salvatore ha voluto prima praticare ciò che doveva in appresso insegnare: Cœpit Jesus facere et docere (Act. 1). Ha voluto osservar il silenzio prima di parlare, ubbidire prima di comandare. Dato ci ha l’esempio dell’umiltà e dell’ubbidienza che voleva insegnarci colle sue parole. Esempio ammirabile, fratelli miei, che deve persuaderci in un modo molto eloquente la sommissione e l’ubbidienza che dobbiamo a coloro che hanno da Dio ricevuta l’autorità per condurci e comandarci. Un Dio di una maestà suprema si sottomette a creature, e la creatura ricuserà di sottomettersi a Dio, obbedendo a quelli che tengono le sue veci? A voi, o figliuoli, indirizzo io quest’oggi particolarmente la parola: venite alla scuola di Gesù sottomesso ai suoi genitori, ad apprendere il rispetto, l’ubbidienza che voi dovete ai vostri. Quali siano i doveri dei figliuoli a riguardo dei loro genitori, sarà il soggetto del mio discorso. Noi non possiamo, fratelli miei, apprendere da un miglior fonte i doveri dei figliuoli verso i loro genitori che dallo Spirito Santo medesimo, il quale ce li ha spiegati con quelle parole dell’Ecclesiaste. Onorate, dice egli ai figliuoli, vostro padre, e dimostrategli il vostro rispetto con le opere, con le parole e con la pazienza: In opere et sermone et patientia honora patrem tuum (Eccl. III). Questi doveri suppongono un amore tenero e filiale che esser deve nel cuore dei figliuoli, ma amore che deve farsi conoscere con il rispetto, con l’ubbidienza e coi servigi ch’essi debbono rendere ai loro genitori. Ecco, o figliuoli, quali sono le vostre obbligazioni. Amate i vostri genitori con un amor tenero e rispettoso: primo punto. Amateli con un amor efficace e compassionevole; secondo punto. Vi chiedo su di ciò tutta la vostra attenzione.
I. Punto. Che i figliuoli obbligati siano ad amare i loro genitori, egli è un dovere che la natura di concerto con la Religione ispira a ciascheduno di noi. Imperciocché se noi siamo obbligati di amare il nostro prossimo non solamente perché Dio ce lo comanda, ma ancora pei legami e per la conformità di natura che abbiamo gli uni con gli altri, qual deve essere il nostro amore pei genitori, con cui siamo sì strettamente congiunti? Mentre, se noi godiamo della vita, ad essi ne siamo, dopo Dio, debitori: l’esistenza che data ci hanno non dà loro diritto di dire che noi siamo una parte di essi medesimi, la carne della lor carne, il sangue del loro sangue, le ossa delle loro ossa? Hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea (Gen. II). Quale amore non dobbiamo noi avere pei genitori che si son presa tanta cura per conservarci la vita, che han tollerato tante fatiche e travagli, che esposti si sono a tanti pericoli, e privati di ciò che poteva loro far piacere ed anche del loro necessario per sovvenire ai nostri bisogni? Quante attenzioni, quante pene, quante inquietudini non ha avuto quella tenera madre, allorché portava quel figliuolo nel suo seno? Quanti dolori non ha ella sofferti, mettendolo al mondo? E dopo averlovi messo, qual vigilanza per provvedere ai suoi bisogni? Quante veglie non ha sopportate? Quali carezzi usati non ha per acchetare le lagrime di lui? Quante precauzioni per difenderlo dagli incomodi delle stagioni, per preservarlo dai rischi della morte? Quanti spaventi al minimo segno di dolore e di malattia, che pativa quel figliuolo? Quanti affanni, quante pene di spirito, quanti travagli di corpo non ha tollerati quel padre per trovar ai suoi figliuoli di che provvedere al loro mantenimento, alla loro sussistenza? Quanti passi per procurar loro qualche stabilimento? Non sono questi tanti motivi di amar un padre ed una madre, e di usare verso di essi una giusta gratitudine? Queste sono anche le ragioni per cui Dio nel comandamento che ci fa di amare il nostro prossimo, propone i nostri genitori per primo oggetto del nostro amore, perché ci toccano più da vicino e noi siamo loro debitori più che ad alcun’altra persona. Sappiate, o figliuoli, che, qualunque cosa voi facciate per dimostrare il vostro amore e la vostra gratitudine ai vostri padri e madri, voi non adempirete giammai perfettamente all’obbligo che ve ne corre; saranno essi sempre vostri creditori, e voi sempre sarete i loro debitori. Di qual durezza, di qual ingratitudine non si rendono dunque colpevoli quei figliuoli disumani, che ben lungi d’avere per i loro padri e loro madri l’amore e la riconoscenza che gli devono, li odiano, li disprezzano, non possono vederli né soffrirli? che giungono a tal seguo di crudeltà di far loro cattivi trattamenti, allorché quei poveri genitori non hanno forza bastante o per punirli, o per loro resistere? che sono sì barbari di desiderare la morte a quelli che hanno dato loro la vita, per possedere i loro beni e vivere a seconda delle loro passioni senza soggezione e senza contrasto? – Figli ingrati, che non meritate di vedere il giorno, voi siete parricidi, voi meritate che la terra apra i suoi abissi sotto i vostri piedi per ingoiarvi, che le bestie feroci vi divorino e che i corvi, per servirmi dell’espressione della Scrittura, vi strappino gli occhi, vi squarcino il cuore e vi rodano le viscere. Ma tosto o tardi voi sentirete la maledizione del Signore: le minacce che ve ne fa nelle sue divine scritture, i castighi terribili che ha praticati sopra figliuoli del vostro carattere, ne sono prove convincenti. Ne abbiamo esempio molto sensibile nella persona del perfido Assalonne, cui l’odio e l’ambizione prender fecero l’armi contro suo padre Davide per torgli ad uno stesso tempo e la corona e la vita. Ma qual fu la sua trista sorte? Il Signore rovesciò i suoi ambiziosi disegni: la sua armata fu sconfitta da quella del re Davide, e nel mentre che Assalonne prese la fuga per evitare la morte che meritava; restò sospeso per li capelli ad un albero sotto cui passava; ricevette in quello stato il colpo della morte dal generale dell’armata di Davide, che lo trafisse con tre colpi di lancia; ed invece del sepolcro magnifico che aveva fatto costruire per porvi il suo corpo dopo sua morte, fu posto in una fossa, che si ritrovò nella foresta, dove si gettò una quantità di pietre: il che continuarono a fare in appresso i viandanti, in esecrazione della sua perfidia, dicendo: Ecco il figlio ribelle che ha perseguitato suo padre e che ha voluto levargli la vita. Esempio terribile, fratelli miei, che deve far tremare i figliuoli del carattere di Assalonne, i quali odiano i loro padri e madri, e loro desiderano la morte! Essi temer devono che Dio morir non li faccia prima di essi di una morte tragica: felici ancora, se puniti non fossero che in questa vita; ma i castighi che sono loro riserbati nell’altra sono molto più terribili, e lo sono tanto più, quanto che l’odio e l’avversione dei figliuoli pei loro genitori è un più gran male di quello che essi avrebbero contro altre persone. – Amate dunque, o figli, i vostri padri e le madri vostre; egli è questo un dovere da cui dispensar non vi potete. Ma come conoscerete voi di avere per essi questo amore, che Dio da voi richiede? Ciò sarà allorché voi vorrete loro tanto bene quanto a voi medesimi: loro desidererete una sanità così perfetta, una vita così lunga, una fortuna così favorevole, come a voi medesimi; ciò sarà allorché voi amerete la loro compagnia, poiché si sta volentieri con le persone che si amano; e quando si fuggono, come fanno un gran numero di figliuoli, i quali non credono giammai di star più male che quando sono coi propri genitori, è segno che non li amano troppo. Finalmente voi conoscerete se avete questo amore pei vostri genitori, quando loro dimostriate il rispetto che ad essi dovete. E ancora il Signore che ve lo comanda. Onorate, vi dice, vostro padre e vostra madre: Honora patrem tuum et matrem tnam (Exod. 20). Non vi contentate di avere in cuore per essi sentimenti di tenereza e di benevolenza, ma date ancora prove esteriori del rispetto che loro portate. Per indurvi a ciò, riflettete che il padre, e la madre tengono a vostro riguardo le veci di Dio, che ne sono le immagini, e che dopo Dio sono i primi oggetti del vostro amore e del vostro rispetto. Voi dovete tutto a Dio, come alla causa prima, che vi ha dato l’essere, voi dovete tutto ai vostri genitori, come a cause seconde, a cui Dio ha data la fecondità per generarvi. Onorare i vostri genitori si è onorare Dio medesimo, di cui rappresentano la paternità, all’opposto disprezzarli è disprezzar Dio medesimo che ha comunicato loro il suo potere: e mancare di rispetto a Dio il mancarne verso i vostri genitori: Qui timet Dominum honorat parentes (Eccl. III). Chi teme il Signore, onora i suoi genitori, dice lo Spirito Santo, chi dunque manca a questo dovere non ha questo timor di Dio, che è il principio della sapienza. Per impegnarvi ancora ad usar questo rispetto; riflettete ai premi che il Signore promette ai figliuoli che adempiono questo dovere. Ne promette anche in questa vita: perocché dovete notare una prerogativa annessa a questo comandamento che non lo è agli altri. Infatti, tra tutti i comandamenti che Dio ci ha lasciati nel decalogo non avvenne alcuno alla cui osservanza destinato abbia un premio temporale, come a quello di onorar i nostri genitori: Onorate vostro padre evostra madre affine di vivere lunga vita sulla terra: ut sis longaevus super terram; cioè una vita ripiena di benedizioni del Signore, spirituali e temporali, una vita i cui dolori ed affanni verranno da grazie interiori raddolciti: l’bbidienza e il rispetto che userete verso i vostri genitori vi meriteranno la consolazione di essere voi medesimi obbediti erispettati dai vostri figliuoli. Ora in che consiste quest’onore, e questo rispetto che i figliuoli debbono mostrare ai loro genitori? Manifestare lo debbono nelle loro parole e con la loro ubbidienza. Debbono i figliuoli parlare ai loro genitori sempre con modestia ed umiltà dar loro, in tutte le occasioni che si presentano, segni della profonda venerazione di cui sono per essi penetrati, sia salutandoli, alzandoci in piedi per onore quando entrano in casa oppure n’escono, cedendo loro il passo, tutto l’onore che da un servo esigere può un padrone. Questo rispetto consiste ancora nel sopportare i loro difetti, nell’ascoltare con sommissione i loro rimproveri, le loro riprensioni, nel chiedere e nel seguire i loro buoni avvertimenti. – Che diremo noi dunque di quei figliuoli insolenti che prendono cert’aria d’arroganza col padre e la madre loro, che li contristano con parole ingiuriose e sprezzanti, che li trattano con disdegno, che li sbeffano a cagione dei loro difetti, li insultano, fan loro amari rimproveri sulle loro debolezze ed imperfezioni, che hanno talvolta meno di condiscendenza per loro che per un servo od uno straniero? Ah! di quali delitti non si rendono colpevoli quei figliuoli che in tal modo trattano i loro genitori, e qual diluvio di disgrazie non si tirano addosso! Imperciocché, se Dio minaccia severi castighi a chi tratterà suo fratello con parole ingiuriose, con qual rigore punirà poi i figliuoli che parlano al padre alla madre in una maniera aspra e orgogliosa, che li caricano d’ingiurie e di villanie e che giungono alcune volte (dirollo?) a tal segno di petulanza, di vomitar contro di essi maledizioni ed imprecazioni? Maledizioni però che ricadranno su di voi, figli inumani, non solo nel gran giorno delle vendette del Signore, ma in questa vita ancora; mentre maledetto è quel figliuolo, dice lo Spirito Santo, il quale non onora suo padre e sua madre: maledetto in sé stesso per le miserie che l’opprimeranno: maledetto nei suoi beni, che periranno: maledetto nei suoi figliuoli, che lo faran gemere e farangli passare i giorni nell’afflizione e nella tristezza. – La Santa Scrittura ce ne fornisce un memorabil esempio in un figliuolo di Noè, il quale per essersi beffato di suo padre, ne fu maledetto con tutta la sua posterità: Maledictus Canaan (Gen. IX). Canaan nipote di Noè provò questa maledizione, che il Signore confermò, condannando lui e i suoi figliuoli ad una vergognosa e lunga servitù: maledizione che vediamo ancora verificata in un gran numero di padri e di madri che sono stati figli ribelli ed indocili, e che nei propri figliuoli soffrono la pena delle loro ribellioni. Imparate dunque, o figliuoli, ad onorare il padre e la madre in qualunque stato voi siate, poveri o ricchi; se voi vi trovate in più alta fortuna che essi non dovete perciò dispregiarli, come certi figliuoli che sembrano non conoscere i poveri genitori e che si crederebbero disonorati a dar loro segni pubblici del loro rispetto, e che paiono vergognarsi di loro appartenere. In qualsivoglia stato siano i vostri genitori, poveri o ricchi, sani o infermi, sono sempre le immagini di Dio, sempre degni in conseguenza del vostro rispetto, vi sien utili o no, voglio anche che vi siano a carico per le loro malattie, la loro vecchiaia, la loro fiacchezza, voglio ancora che siano fastidiosi, di cattivo umore, che si mettano in collera per cose da nulla, che trovino da biasimare in tutto, che necessaria sia una grande pazienza per sopportarli: non importa, ritorno sempre al mio principio, tengono essi sempre le veci di Dio, voi dovete sempre onorarli. Se voi li mettete in collera e in cattivo umore per i vostri difetti, correggetevi, se vi si mettono essi senza ragione, niun diritto voi avete di resister loro; convien sopportare i loro difetti con pazienza, dice lo Spirito Santo: Honora in omni patientia (Eccl. III). – Questa pazienza sarà per voi di un gran merito innanzi a Dio, perché essa è una prova del rispetto che avete pei vostri genitori; dimostrate loro ancora questo rispetto con la vostra ubbidienza alla loro volontà. Vuole il buon ordine e la giustizia che ogni inferiore sia sottomesso al suo superiore: ora i genitori, per l’autorità che hanno ricevuta da Dio, sono i superiori dei figliuoli; questi conseguentemente loro debbono una pronta ed intera ubbidienza. Ubbidienza sì necessaria ai figliuoli che ne fa il carattere essenziale; di modo che siccome un raggio separato dal sole più non risplende, un ruscello separato dal fonte divien secco, un ramo tagliato dall’albero diventa arido; così, dice s. Pier Crisologo un figlio cessa di esser figlio, da che manca di ubbidienza ai suoi genitori; è un mostro nella natura, indegno di occuparvi un posto. Per la qual cosa l’Apostolo S. Paolo raccomandava sì caldamente quest’ubbidienza ai figliuoli come un dovere essenziale al suo stato: Filli, obedite parentibus per omnia (Col. V). Qual dunque esser dee quest’ubbidienza? Ella deve essere pronta ed universale, pronta per allontanare tutte quelle dilazioni che i più dei figliuoli apportano ad eseguire gli ordini dei loro genitori, cui non ubbidiscono, se non dopo molti comandi reiterati, brontolando, a forza di rigore e di castighi, il che fa loro perdere il merito dell’ubbidienza. L’ubbidienza forzata rassomiglia a quella dei demoni, che eseguiscono, malgrado loro, gli ordini di Dio. Bisogna dunque per esser grata ed accetta a Dio, che sia volontaria, pronta, senza doglianza e senza dilazione. L’ubbidienza deve ancora essere universale nei figliuoli per ubbidire in tutto ciò che vien loro comandato, sia pel temporale, sia per lo spirituale; pel temporale, lavorando, rendendo ai genitori tutti i servigi che domandano pel buon ordine ed il bene della famiglia. Per lo spirituale, sia fuggendo le cattive compagnie, i giuochi, le persone, la cui società è pericolosa per la salute, sia adempiendo i doveri di Cristiano: tali sono l’orazione, la frequenza dei sacramenti, l’assiduità alla santa Messa, ai divini uffizi, alle istruzioni ed altre buone opere. Ma è forse così che ubbidisce la maggior parte dei figliuoli, che far non vogliono se non ciò che loro piace; che dimostrano con certi segni di far poco caso di quanto loro si dice; che capaci si credono di condursi da se stessi, che a dispetto dei loro genitori mantengono relazioni pericolose, vanno nelle veglie, nei balli, nelle osterie, nelle case sospette; che, malgrado gli avvisi caritatevoli del padre e della madre, non frequentano i Sacramenti, vengono alla chiesa quando loro piace, vivono in una parola, come se non avessero né fede né Religione? Non è questo il ritratto di un gran numero di giovani che con la loro condotta sregolata danno mille motivi di affanno ai loro genitori, accorciano i loro giorni e fanno anch’essi una fine infelice? Perché tosto o tardi il Signore, di cui dispregiano l’autorità in quella dei loro genitori, fa loro sentire i rigori della sua giustizia. Ubbidite dunque, o figliuoli, ai vostri genitori, in tutto ciò che vi comandano secondo il Signore, come dice l’Apostolo, in Domino; poiché se vi comandano cosa contro la sua santa legge, come l’ingiustizia, la vendetta od altra qualsiasi azione proibita, allora, dovete loro rispondere, con piacevolezza per altro che voi dovete a Dio ubbidire e non agli uomini. Tralasciare qui non devo un articolo essenziale, su cui dovete consultare i vostri genitori ed anche loro ubbidire: cioè nella scelta che far dovete di uno stato. Io so benissimo che essi non debbono vincolare la vostra libertà; ma Dio ve li ha dati per guida e per maestri; essi hanno maggiori lumi e più di esperienza che voi; conoscono meglio quel che vi conviene. Voi dovete dunque seguir piuttosto i loro avvisi che una passione cieca che vi farà fare dei passi falsi. Ricompenserà Iddio la vostra ubbidienza con le benedizioni che spargerà sopra un matrimonio che fatto avrete di loro consenso. Né vi diate già a credere che, quando siete in questo stato, voi più non dobbiate loro né rispetto, né ubbidienza, come s’immaginano certuni che si credono padroni di se stessi; voi dovete sempre rispettarli, loro ubbidire, consultarli e seguire i loro avvertimenti. L’edificazione che voi dovete alla vostra famiglia nascente ve ne fa ancora un obbligo stretto; e che cosa pensar potrebbero i vostri propri figliuoli, se vi vedessero disubbidire e mancar di rispetto ai vostri padri e alle vostre madri?
II. Punto. Finiamo, fratelli miei, di spiegare i doveri dei figliuoli riguardo ai loro padri e madri, che consistono a render loro nel bisogno tutti i servigi di cui sono capaci. No, non basta per voi, o figliuoli che mi ascoltate, amare i vostri padri e le vostre madri con amor tenero e filiale, non basta portar loro rispetto; voi dovete ancora assisterli in tutti i loro bisogni del Corpo e dall’anima; i medesimi motivi che vi obbligano d’amarli vi obbligano altresì a soccorrerli. Richiamate per un momento i motivi che vi ho di già proposti al principio di questo discorso. I benefizi di cui siete debitori ai vostri genitori, vi faranno comprendere che, soccorrendoli, voi non fate che render loro quanto vi hanno prestato; e tuttavia non farete giammai quanto essi hanno fatto per voi; i vostri servigi saranno sempre minori di quel che loro dovete. Cessate dunque di dire che questi genitori non vi sono al presente di alcun vantaggio, che vi sono anche a carico per la loro età avanzata, per la vecchiezza, per le malattie: voglio accordare che sia così; ma non è ancor vero che non sono sempre stati tali? Senza le loro attenzioni e fatiche, voi non avreste quel che possedete, voi non sareste ciò che siete. Né stiate pure a dire che voi nulla loro dovete di quanto possedete, che è il frutto delle vostre fatiche e della vostra industria. Ve l’accordo ancora: ma non dovete voi loro la vita, la forza, la sanità, di cui godete? Nutriti non vi hanno e mantenuti nel tempo in cui non eravate in istato di procurarvi da voi medesimi quanto vi era necessario? Non è egli giusto che voi al presente facciate lo stesso a loro riguardo? Gli incomodi che han sofferto, le malattie che hanno contratte, sono gli effetti delle inquietudini, dei travagli che hanno sopportati per allevarvi; potete voi dunque senza ingratitudine ricusar loro i soccorsi di cui hanno bisogno? Nulla vi avanza, mi direte, che necessario non sia per voi e pei vostri figliuoli. Ma quante volte i vostri genitori privati si sono del necessario per darlo a voi? Se voi aveste più figliuoli, lo lascereste loro mancare? La vostra industria troverebbe i mezzi di provveder alla loro sussistenza: mettete i vostri padri e madri nel numero dei vostri figliuoli: fate per essi quel che fareste per li vostri figliuoli; Dio spargerà le sue benedizioni sopra le vostre fatiche, e la sua provvidenza supplirà a tutti i vostri bisogni. Se vitrovate nella miseria, non è questo un castigo della durezza che avete per li vostri genitori, cui non solamente ricusate ciò che loro è necessario, ma forse ancora con barbara crudeltà lo rapite? Siate più pietosi a loro riguardo, e Dio sarà pietoso verso di voi altrimenti mancherebbe alla promessa che vi ha fatto di ricompensare anche in questa vita l’amore ai vostri genitori; il che pensare non si può di un Dio sì buono e sì fedele alla sua parola come il Dio cui noi serviamo. – Ma in che i figliuoli sono obbligati di soccorrere i loro genitori? Dissi, fratelli miei, nei bisogni del corpo ed in quelli dell’anima. Nei bisogni del corpo assistendoli nella povertà, dividendo con loro il vostro pane, somministrando loro quanto è necessario per mantenerli e nutrirli. Se hanno bisogno dei vostri servizi, voi render glieli dovete a preferenza di qualunque altro; o se voi servite qualche altro padrone, impiegar bisogna per soccorrerli quel che guadagnate. Se sono infermi, allora è che raddoppiar dovete tutte le vostre attenzioni per procurar loro ì rimedi necessari ed un buon nutrimento. Oimè! se qualche bestia da carico che vi appartiene è assalita da malattia, voi nulla risparmiate per guarirla; e sovente morire si lascia un padre, una madre per mancanza di qualche soccorso che si potrebbe e si dovrebbe loro dare; e piaccia al cielo che loro anche non si ricusino questi soccorsi per accelerarne la morte! – Finalmente provveder voi dovete ai bisogni spirituali dei vostri genitori, sia consolandoli nelle loro afflizioni, sia facendo loro amministrare i Sacramenti quando sono infermi, più presto che è possibile; mentre basta una malattia di qualche giorno ed anche di alcune ore per mandare alla sepoltura corpi infermi cui la morte ha già portato i suoi colpi col peso degli anni che li opprime. Bisogna altresì in quei critici momenti pregar molto e far pregare per essi. Questo è dar loro il segno più certo di un amore veramente filiale, l’indirizzarsi al cielo per chiedere con istanza quanto è necessario per la loro salute. Figliuoli ben nati, amate i vostri genitori e a misura che il rischio della malattia aumenta, raddoppiate le vostre cure: domandate per essi una morte preziosa agli occhi del Signore, se ottener loro non potete una più lunga vita: vi lasciano quanto posseduto hanno sulla terra, ottenete loro il cielo; mentre il vostro amore dee stendersi ancora più in là del sepolcro, pregando pel riposo delle loro anime, eseguendo al più presto le pie intenzioni che significate vi hanno nei loro testamenti, adempiendo le restituzioni di cui vi hanno incaricati. Ma oimè! quanti pochi figliuoli si vedono al giorno d’oggi fedeli ad adempiere questi doveri a riguardo dei loro genitori defunti! Avidi, premurosi d’impadronirsi dei beni che hanno loro lasciato, non pensano che a dividerne le spoglie, a profittare della successione, senza mettersi in pena del tristo stato a cui ridotti sono questi padri e madri, forse pel troppo grande affetto che hanno avuto per essi: simili in ciò ai barbari fratelli di Giuseppe, i quali, dopo averlo messo in una cisterna, si divertivano sul luogo medesimo che serviva di teatro alla loro crudeltà. – Quanti anche si vedono figliuoli ingrati che perdono sino la memoria dei loro padri e madri, e fanno della conseguita eredità materia di dispute, divisioni e liti che suscitano gli uni contro gli altri? Divisioni, liti che si perpetuano di generazione in generazione, senza che si possano estinguere. Quanti altri che fanno di queste eredità materia delle loro dissolutezze, o non se ne servono che per contentare passioni peccaminose, senza riserbare una sola porzione dei beni che hanno ricevuto per soccorrere i genitori che soffrono crudeli pene nel fuoco del purgatorio? Ecco, poveri genitori, qual è il frutto del vostro faticare e soffrire. Ah figli ingrati, voi sarete misurati con la stessa misura che misurati avrete i vostri genitori; vi tratteranno col medesimo rigore con cui trattati avrete loro; e se continuate a fare un cattivo uso dei beni che avete acquistati, voi morrete nel peccato, e diverrete vittima non delle fiamme del purgatorio. ma di quelle dell’inferno.
Pratiche. Procurate di evitare questa disgrazia; istruiti come ora siete dei vostri doveri a riguardo dei vostri padri e madri, siate fedeli nell’adempierli: amateli, rispettateli, rispondete e non parlate loro che con rispetto; amatela loro compagnia, né fate cosa alcuna senza consultarli; ubbidite loro, come a Dio, quando vi comandano; pregate per essi, rendete loro tutti i servigi di cui siete capaci, e Dio vi ricompenserà non solo con una lunga vita sulla terra ma ancora con una vita eterna nel cielo. Così sia.
Credo.
https://www.exsurgatdeus.org/2019/10/12/il-credo/
Offertorium
Orémus
Ps XCIX, 1 Jubilate Deo, omnis terra; servite Domino in lætitia. Introite in conspectu ejus in exsultatione: quia Dominus ipse est Deus.
[Acclamate con gioia a Dio da tutta la terra: servite al Signore con allegrezza: entrate alla sua presenza con esultanza: sappiate che il Signore è Dio. ]
Secreta
Oblatum tibi, Domine, sacrificium vivificet nos semper, et muniat. Per Dominum … [L’offerto sacrificio o Signore, sempre ci vivifichi e custodisca. Per … ]
Comunione spirituale …
https://www.exsurgatdeus.org/2019/10/20/comunione-spirituale/
Communio
S. Luc. II: 48 et 49
Fili, quid fecisti nobis sic? ecce pater tuus et ego dolentes quaerebamus te. Quid est quod me quærebatis? nesciebatis quia in his quæ Patris mei sunt, oportet me esse? [Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco tuo padre ed io, addolorati, ti cercavamo – E perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi di quel che spetta al Padre mio?]
Postcommunio
Orémus.
Suèplices te rogamus, omnipotens Deus: ut quos tuis reficis sacramentis, tibi etiam placitis moribus dignanter deservire concedes. Per Dominum nostrum J. C. [Ti supplichiamo, Dio onnipotente, affinché quelli che nutria con I tuoi sacramenti, ti servano degnamente con una condotta a te gradita. Per nostro Signore …]
Preghiere leonine https://www.exsurgatdeus.org/2019/10/20/preghiere-leonine-dopo-la-messa/
Ordinario della Messa https://www.exsurgatdeus.org/2019/05/20/ordinario-della-messa/