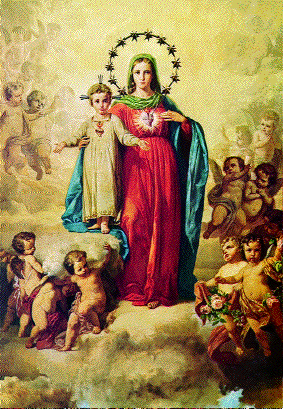Questa lettera enciclica mette in rilievo la cura che il Santo Padre voleva fosse posta sia nella decorosa decenza dei luoghi santi, in particolare ove si celebravano i Santi Misteri, sia nella devozione della recita del Santo Ufficio da parte dei chierici. Ma la parte più straordinaria si rileva nella accurata analisi della musica sacra e del canto sacro, analisi compiuta con somma perizia e maestria degna di un colto maestro di cappella. Infatti questo documento resta poi la base di tutti i riferimenti magisteriali successivi inerenti l’argomento della musica sacra, come ad esempio la “Musicæ sacræ” del 1955 di S. S. Pio XII. I modernisti attuali della setta del “novus ordo” dovrebbero impallidire e vergognarsi del neopaganesimo musicale introdotto nei sacri luoghi [sacri … un tempo, in verità], al ritmo di rockettari chiassosi e strampalati, che suonano [si fa per dire, naturalmente …] di strumenti elettrici, percussioni sciamaniche e tribali, dei più sofisticati karaoke ed elucubrazioni vocali degne di messe nere o consimili [ma tanto la messa del baphomet lucifero è proprio tale, e quindi essi giustamente non si meravigliano … anzi vi partecipano sull’onda di danze suadenti e lascive … il trionfo del kitch oltretutto!]. Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio sulla satanità del “novus ordo”, lo fugherebbe immediatamente entrando in queste moderne “discoteche-sale da ballo” costruite da avveniristici architetti, approvati con entusiasmo dalle finte autorità religiose, ove al ritmo frenetico di chitarroni elettrici [il più delle volte male accordati da approssimativi Jimmy Hendrix in erba], o di batteristi alla Tony Esposito [mi perdoni il percussionista partenopeo se lo tiro in ballo, ma è giusto per far comprendere meglio l’andazzo del novus ordo!] si accompagnano, nelle sfacciataggine più macabra dei finti chierici, dei riti che di sacro non hanno più nemmeno le candele, adulterate anch’esse, non più di cera d’api ma di sintetica paraffina! – Leggere la lettera di S. S. Benedetto XIV serve a farsi un’idea di cosa era e di cosa dovrà essere nuovamente la musica sacra, sconosciuta alla stragrande maggioranza non solo dei giovani, ma anche di quelli che si avvicinano oramai all’età vetusta, quando la falsa chiesa dell’uomo, parodia della Chiesa Cattolica e tragica anticamera del noachismo talmudico, sarà dal Nostro Signore Gesù Cristo distrutta con il soffio della sua bocca, secondo la profezia di San Paolo ai Cristiani di Tessalonica. Cominciamo allora a ripulire i condotti uditivi dalle orribili immondezze vocali e sonore accumulate nelle pseudo-celebrazioni sacrileghe e blasfeme del novus ordo con la lettura delle parole di Papa Lambertini, augurandoci quanto prima di innalzare a Dio il nostro spirito con canti liturgici gregoriani e con il suono maestoso dell’organo a canne suonato da un maestro vero dell’arte musicale sacra, magari un redivivo C. Frank o un novello Camille Saint Saens, o un emulo di Max Reger! Chissà?! … nel Vangelo il divin Maestro ci ha promesso: chiedete e vi sarà concesso …. E torneremo ai tempi felici del: “Confitemini Domino in cithara; in psalterio decem chordarum psallite illi. Cantate ei canticum novum; bene psallite ei in vociferazione…” [Ps XXXII].

Benedetto XIV
Costituzione Apostolica
Annus qui hunc
vertentem annum insequitur, ut Fræternitas Tua cognitum …
Terminato l’anno in corso, quello che verrà – come Ella ben sa – sarà l’anno del Giubileo, detto Anno Santo. Essendo – per somma misericordia di Dio – terminata la guerra e fatta la pace fra i Principi belligeranti, si può sperare che sarà grande il concorso dei forestieri e dei pellegrini di tutte le nazioni, anche delle più lontane, a questa nostra Città di Roma. Noi di vero cuore preghiamo e facciamo pregare Iddio, affinché tutti coloro che verranno conseguano il frutto spirituale delle sante Indulgenze, e Noi faremo tutto ciò che è in Nostro potere perché ciò si verifichi. Desideriamo inoltre che tutti coloro che vengono a Roma, ne ripartano non scandalizzati, ma pieni di edificazione per quanto avranno veduto non solo in Roma, ma anche in tutte le Città dello Stato Pontificio attraverso le quali sarà loro convenuto passare, sia nel venire come nel ritornare alle loro patrie. – Per quanto si riferisce a Roma, Noi abbiamo già preso alcune misure, né si tralascerà di prenderne altre. Abbiamo bisogno del Suo zelo e della Sua sperimentata attenzione per ciò che appartiene alla Città e Diocesi da Lei lodevolmente governate. Se Ella Ci darà, come speriamo, l’aiuto necessario, non solo si conseguirà il fine da Noi desiderato, cioè che i forestieri partano edificati e non scandalizzati di Noi, ma ne deriverà un altro buon effetto, cioè che le cose da Noi ordinate e da Lei eseguite, determineranno una buona disciplina non solo nell’Anno Santo, ma per molto tempo avvenire. Si ripeterà ciò che appunto accade nelle Sue Visite Pastorali; l’esperienza dimostra che i visitati, essendo imminente la Visita, fanno alcune cose, correggono alcuni difetti per non essere ripresi da Lei, e per non restare esposti alle dovute pene; il bene fatto in occasione della visita dura anche nel tempo successivo.
1. Ma venendo al particolare, la prima cosa che Le raccomandiamo è che le Chiese si presentino in buono stato, pulite, monde e provviste di sacri arredi; ci vuole poco a capire che se i forestieri vedessero le Chiese delle Città e Diocesi dello Stato Ecclesiastico in cattive condizioni, sporche o sprovviste di sacri arredi, o provviste di arredi laceri e degni d’essere sospesi, ritornerebbero ai loro paesi pieni di orrore e indignati. Teniamo a sottolineare che non parliamo della sontuosità e della magnificenza dei sacri Templi, né della preziosità delle sacre suppellettili, sapendo anche Noi che non si possono avere dappertutto. Abbiamo parlato della decenza e della pulizia che a nessuno è lecito trascurare, essendo la decenza e la pulizia compatibili con la povertà. Tra gli altri mali da cui è afflitta la Chiesa di Dio, anche di questo si doleva il Venerabile Cardinale Bellarmino, quando diceva: “Passo sotto silenzio ciò che si vede in certi luoghi: i vasi sacri ed i paramenti che si adoperano nella celebrazione dei Misteri sono spregevoli e sporchi, e del tutto indegni di essere adoperati nei tremendi Misteri. Può darsi che coloro che adoperano questi oggetti siano poveri; ciò è possibile, ma se non è possibile avere arredi preziosi, si abbia almeno cura che tali arredi siano puliti e decorosi“. Benedetto XIII, di santa memoria e Nostro benefattore, che tanto ha travagliato nel corso della sua vita per la retta disciplina e per la decenza nelle Chiese, era solito portare come esempio le Chiese dei Padri Cappuccini, povere di somma povertà e pulite di grandissima pulizia. Il Dresselio al tomo 17 delle sue opere stampate a Monaco, nel trattato intitolato Gazophylacium Christi (§ 2, cap. 2, p. 153), così scrive: “La prima e più importante cosa che si deve curare nelle Chiese è la pulizia. Non solo vi debbono essere gli arredi necessari al culto, ma bisogna anche che essi, per quanto è possibile, siano estremamente puliti“. Con tutta ragione egli inveisce contro coloro che hanno le loro case ben fornite e lasciano le Chiese e gli Altari nello stato miserabile in cui si vedono: “Vi sono alcuni che hanno case assolutamente infruttuose e adorne di tutto, ma nelle loro Chiese e nelle loro Cappelle tutto è squallido; gli Altari sono disadorni e ricoperti da tovaglie cenciose e luride; in tutto il resto regnano confusione e squallore” (Dresselio, Gazophylacium Christi, § 2, cap. 2). – Il grande dottore della Chiesa San Girolamo, nella sua lettera a Demetriade si mostrò assai indifferente sul fatto che le Chiese fossero povere o ricche: “Che altri edifichino Chiese, ne rivestano le pareti con lastre di marmo, vi elevino delle colonne maestose, indorino i loro capitelli, non sentenzio su tali preziosi ornamenti; che ornino le porte con avorio ed argento e rivestano di pietre preziose gli Altari dorati io non biasimo e non impedisco. Ciascuno abbondi nel proprio sentimento: è meglio fare così che custodire con avarizia le ricchezze accumulate“. Invece dichiarò apertamente di stimare la pulizia delle Chiese quando con somme lodi celebrò Nepoziano che era sempre stato attento a tener pulite le Chiese e gli Altari, come si legge nell’epitaffio dello stesso Nepoziano che il Santo scrisse ad Eliodoro: “Egli si adoperava con grande sollecitudine affinché l’Altare fosse nitido, le pareti non fossero ricoperte di fuliggine, i pavimenti fossero tersi, il portinaio fosse sempre presente all’ingresso; le porte fossero sempre provviste di tende, la sagrestia fosse pulita, i vasi sacri lucenti e in tutte le cerimonie non mancasse nulla. Non trascurava nessun dovere, né piccolo né grande“. Certamente si deve provvedere con grande cura e diligenza che non succeda, con disonore dell’Ordine Ecclesiastico, ciò che il suddetto cardinale Bellarmino racconta essere accaduto a lui: “Io – dice – trovandomi una volta in viaggio fui ospitato presso un nobile Vescovo assai ricco; vidi il suo palazzo risplendente di vasi d’argento e la mensa ricoperta dei cibi più squisiti. Anche tutto il resto era nitido e le tovaglie erano soavemente profumate. Ma il giorno dopo, essendo disceso di buon mattino nella Chiesa attigua al palazzo per celebrare le sacre funzioni, trovai un assoluto contrasto: tutto era spregevole e ripugnante, tanto che dovetti farmi violenza per arrischiarmi a celebrare i divini Misteri in un simile luogo e con simile apparato“.
2. La seconda cosa sulla quale richiamiamo la Sua attenzione riguarda le Ore Canoniche, siano esse cantate o recitate nel Coro secondo la pratica di ciascuna Chiesa, con la dovuta diligenza, da parte di coloro che ad esse sono obbligati. Infatti non c’è niente di più avvilente e pernicioso per la disciplina Ecclesiastica che entrare nelle Chiese e vedere e sentire le Ore Canoniche cantate o recitate nel Coro con strapazzo. Ella ben conosce l’obbligo che hanno i Canonici e gli addetti al servizio delle Chiese Metropolitane, Cattedrali o Collegiate, di cantare ogni giorno le Ore Canoniche nel Coro, e che a quest’obbligo non si soddisfa se non si adempie al tutto con assoluta devozione. – Il Sommo Pontefice Innocenzo III nel Concilio Lateranense (riferito nel capitolo Dolentes, de celebratione Missarum) parla del suddetto obbligo nei seguenti termini: “Noi ordiniamo rigorosamente, in virtù di obbedienza, di celebrare l’Ufficio Divino, tanto di notte quanto di giorno, per quanto sarà possibile, con diligenza e devozione. (La Chiesa, spiegando la parola studiose – con diligenza – soggiunge che essa si riferisce alla esatta e completa pronuncia delle parole; e quanto al termine devote – con devozione – annota che esso si riferisce al fervore dell’animo). – Il Nostro Predecessore Clemente V durante il Concilio Viennese, nella sua Costituzione che si trova tra le Clementine e che comincia con la parola Gravi, sotto il titolo De celebratione Missarum parla con lo stesso linguaggio: “Nelle Chiese Cattedrali, Regolari e Collegiate si tenga la salmodia alle ore stabilite, e con devozione“. – Il Concilio di Trento, trattando degli obblighi dei Canonici Secolari, dice: “Si faccia a tutti obbligo d’intervenire agli Uffici, di persona e non per mezzo di sostituti; di assistere e di servire il Vescovo quando celebra o compie qualche altra funzione pontificale; e infine di lodare il nome di Dio con inni e cantici, con riverenza, chiarezza e devozione, e ciò nel Coro istituito per la salmodia” (Conc. Trid., sess. 24, cap. 12, De reformatione). Dal che deriva che si deve vigilare con molta attenzione affinché il canto non sia precipitoso: o più affrettato del conveniente; le pause siano fatte nei punti indicati; una parte del Coro non incominci il versetto del Salmo se l’altra parte non ha terminato il proprio. Ecco le precise parole del Concilio di Saumur dell’anno 1253: “Nec prius Psalmi una pars Chori versiculum incipiat, quam ex altera praecedentes Psalmi, et versiculi finiantur“. – Infine, il canto deve essere eseguito con voci unisone ed il Coro deve essere diretto da persona esperta nel canto Ecclesiastico (chiamato canto piano o fermo). Questo è quel canto per regolare il quale e disporlo secondo i canoni dell’arte musicale tanto faticò San Gregorio il Grande, Nostro Predecessore, come attesta Giovanni Diacono nella Vita di lui (libro 2, cap. 7). Al che non sarebbe difficile aggiungere molte belle notizie ricavate dalla erudizione Ecclesiastica sull’origine del canto Ecclesiastico, sulla Scuola dei Cantori e sul Primicerio che ad essa presiedeva; ma lasciando da parte ciò che sembra meno utile, ritorniamo al punto da cui Ci siamo un poco allontanati, per proseguire l’argomento iniziato. Questo canto è quello che eccita le anime dei fedeli alla devozione e alla pietà; è pure quello che, se eseguito nelle Chiese di Dio secondo le regole ed il decoro, è ascoltato più volentieri dagli uomini devoti e, a ragione, è preferito al canto detto figurato. I Monaci appresero questo canto dai Preti Secolari come ben riferisce Giacomo Eveillon: “Il virtuosismo di ogni armonia musicale diventa ridicolo alle devote orecchie, se paragonato al canto piano e della semplice salmodia, qualora questa sia bene eseguita. Perciò oggi il popolo fedele diserta le Chiese Collegiate e Parrocchiali e corre volentieri e avidamente alle Chiese dei Monaci, i quali, avendo la pietà come maestra del culto divino, salmodiano santamente con moderazione e – come già disse il Principe dei Salmisti – con sapienza; servono al loro Signore, come a Signore e come a Dio, con somma riverenza. Ciò deve certamente tornare a vergogna delle Chiese più importanti e maggiori, dalle quali i Monaci hanno appreso l’arte e la regola di cantare e di salmodiare” (G. Eveillon, De recta ratione psallendi, cap. 9, art. 9). È per questo che il sacro Concilio di Trento, che non trascurò nulla di quanto poteva contribuire alla riforma del Clero, dove tratta della fondazione dei seminari, fra le altre cose che si devono insegnare ai seminaristi include anche il canto: “Perché siano meglio formati nella disciplina Ecclesiastica, portino sempre la tonsura e l’abito Ecclesiastico appena li abbiano ricevuti; studino le regole della grammatica, del canto, del computo Ecclesiastico e delle altre buone arti” (Conc. Trid., sess. 23, ca. 18, De Reformatione).
3. La terza cosa di cui Noi dobbiamo avvertire Lei, è che il canto musicale, che oggi si è introdotto nelle chiese e che, comunemente, è accompagnato dall’armonia dell’organo e di altri strumenti, sia eseguito in modo tale da non apparire profano, mondano o teatrale. L’uso dell’organo e degli altri strumenti musicali, non è ancora accolto in tutto il mondo cristiano. Infatti (senza parlare dei Ruteni di Rito Greco, che, secondo la testimonianza del Padre Le Brun, in Explication Miss. (tomo 2, p. 215 pubblicato nel 1749), non hanno nelle loro chiese né l’organo, né altri strumenti musicali), la Nostra Cappella Pontificia, come tutti sanno, pur ammettendo il canto musicale, a condizione che sia grave, decente e devoto, non ha mai ammesso però l’organo, come fa notare anche il Padre Mabillon, dicendo: “Nella domenica della Trinità abbiamo assistito alla Cappella Pontificia, come è chiamata, ecc. In queste cerimonie non si fa uso alcuno di organi musicali, ma soltanto la musica vocale, di ritmo grave, è ammessa col canto piano” (Mabillon, Museo Italico, tomo 1, p. 47, § 17). – Il Grancolas riferisce che anche ai nostri giorni vi sono in Francia delle Chiese insigni che non adoperano nelle funzioni sacre né l’organo, né il canto figurato: “Vi sono tuttavia anche oggi insigni Chiese della Gallia che ignorano l’uso degli organi e della musica” (Grancolas, Commentario storico del Breviario Romano, cap. 17). – L’illustre Chiesa di Lione, sempre contraria alle novità, seguendo fino ai nostri giorni l’esempio della Cappella Pontificia, non ha mai voluto introdurre l’uso dell’organo: “Da ciò che si è detto, consta che gli strumenti musicali non furono ammessi né fin dal principio né in tutti i luoghi. Infatti, anche ora, a Roma, nella Cappella del Sommo Pontefice, gli Uffici solenni si celebrano sempre senza strumenti, e la Chiesa di Lione, che ignora le innovazioni, ha sempre rifiutato l’organo, ed al presente ancora non lo ha accolto“. Queste sono parole del Cardinale Bona nel suo trattato De Divina Psalmodia (cap. 17, § 2, n. 5). – Stando così le cose, ciascuno può facilmente immaginare quale opinione si faranno di noi i pellegrini appartenenti a regioni dove non si adoperano gli strumenti musicali, e che, venendo da noi e nelle nostre città, ne udranno nelle chiese il suono, come si fa nei teatri ed in altri luoghi profani. Certamente vi verranno anche degli stranieri appartenenti a regioni ove, nelle chiese, si usano il canto e gli strumenti musicali, come avviene in alcune nostre regioni; ma, se questi uomini sono persone sagge ed animate da vera pietà, certamente si sentiranno delusi di non trovare nel canto e nella musica delle nostre Chiese il rimedio che desideravano applicare per guarire il male che imperversa a casa loro. Infatti, lasciando da parte la disputa che vede gli avversari divisi in due campi (quelli che condannano e detestano nelle Chiese l’uso del canto e degli strumenti musicali, e, dall’altra parte, quelli che lo approvano e lo lodano), non vi è certamente nessuno che non desideri una certa differenziazione tra il canto Ecclesiastico e le teatrali melodie, e che non riconosca che l’uso del canto teatrale e profano non deve tollerarsi nelle Chiese.
4. Abbiamo detto che vi sono alcuni che hanno riprovato ed altri che riprovano l’uso nelle Chiese del canto armonico con strumenti musicali. Il principe di costoro può in qualche modo essere considerato l’Abate Elredo, coetaneo e discepolo di San Bernardo, che nel libro 2 della sua opera intitolata Speculum Charitatis, così scrive: “Da dove provengono, malgrado siano cessati i tipi e le figure, donde vengono nelle Chiese tanti organi, tanti cembali? A che, di grazia, quel soffio terribile che esce dai mantici e che esprime piuttosto il fragore del tuono che non la soavità del canto? A che quella contrazione e spezzettamento della voce? Questi canta con accompagnamento, quell’altro canta da solo, un terzo canta in tono più alto, un quarto infine divide qualche nota media e la tronca” (cap. 23, tomo 23, della Biblioteca dei Padri, a p. 118). – Noi non Ci impegneremo ad affermare che, al tempo di S. Tommaso d’Aquino, non vi fosse in qualche Chiesa l’uso del canto musicale accompagnato dai musicali strumenti. Si può però affermare che tale usanza non esisteva nelle Chiese conosciute dal Santo Dottore; e perciò sembra che egli non fosse favorevole a questo genere di canto. Trattando infatti la questione nella Somma teologica (2, 2, quest. 91, art. 2) “se nelle lodi divine si debba usare il canto“, risponde di sì. Ma alla quarta obiezione, da lui formulata, che la Chiesa non suole usare nelle lodi divine strumenti musicali, come la cetra e l’arpa, per non sembrare voler giudaizzare – in base a quanto si legge nel Salmo: “Confitemini Domino in cythara, in psalterio decem chordarum psallite illi; Celebrate il Signore sulla cetra, a lui salmeggiate con arpa da dieci corde” – egli risponde: “Questi strumenti musicali eccitano il piacere piuttosto che disporre interiormente alla pietà; nell’Antico Testamento sono stati adoperati perché il popolo era più grossolano e carnale, ed occorreva allettarlo per mezzo di questi strumenti, come con promesse terrene“. Aggiunge inoltre che gli strumenti, nell’Antico Testamento, avevano valore di tipi o prefigurazioni di certe realtà: “Anche perché questi strumenti materiali raffiguravano altre cose“. – Del Sommo Pontefice Marcello II, ci è stato tramandato dalla storia che aveva deciso di abolire la musica nelle Chiese, riducendo il canto Ecclesiastico al canto fermo. Questo si può vedere leggendo la Vita di detto Pontefice, scritta da Pietro Polidori, testé defunto, e già Beneficiato della Basilica di San Pietro, e uomo noto fra i letterati. – Ai nostri giorni, abbiamo veduto che il Cardinale Tomasi, uomo di grande virtù, insigne liturgista, non volle il suono musicale, nella sua Chiesa titolare di San Martino ai Monti, il giorno della festa di questo Santo, in onore del quale quella Chiesa è dedicata. Non volle musica né alla Messa né ai Vespri, ma ordinò che nelle funzioni sacre si usasse il canto piano, come si costuma fare dai Religiosi.
5. Abbiamo detto che vi sono alcuni che approvano l’impiego del canto musicale ed il suono degli strumenti negli Uffici Divini. Infatti nello stesso secolo in cui visse il lodato Abate Elredo, fu celebre anche Giovanni Sariberiense, Vescovo di Chartres, il quale nel suo Policratius (libro 1, cap. 6) fa l’elogio della musica strumentale, e del canto vocale accompagnato da strumenti: “Per elevare i costumi e trascinare gli animi verso il culto del Signore, in una sana giocondità, i Santi Padri stimarono bene doversi ricorrere non soltanto al concento di uomini, ma anche all’armonia degli strumenti: purché ciò si facesse in modo che servisse ad unire di più al Signore e ad accrescere il rispetto per la Chiesa“. Sant’Antonino nella sua Somma non rigetta l’impiego del canto figurato nei Divini Uffici: “Il canto fermo, nei Divini Uffici, è stato stabilito dai Santi Dottori, da Gregorio il Grande, da Ambrogio, e da altri. Chi abbia introdotto il canto a più voci negli Uffici Ecclesiastici, io lo ignoro. Questo canto sembra piuttosto fatto per solleticare le orecchie che per alimentare la devozione, ancorché una mente devota possa ricavare frutto anche ascoltando questo canto” (parte 3, tit. 8, cap. 4, par. 12). Ed un poco più avanti, ammette nei Divini Uffici non solamente l’organo, ma anche altri strumenti musicali: “Il suono degli organi e degli altri strumenti cominciò ad essere usato con frutto, nella lode di Dio, dal Profeta Davide“. – Il Pontefice Marcello II aveva certamente deciso di bandire dalle Chiese il canto in musica e gli strumenti musicali, ma Giovanni Pier Luigi da Palestrina, Maestro di Cappella della Basilica Vaticana, compose un canto musicale, da usarsi nelle sante Messe solenni, con un’arte così eccellente da muovere gli uomini alla devozione ed al raccoglimento. Il Sommo Pontefice udì questo canto ad una Messa, alla quale presenziava, e mutò parere, recedendo da quanto aveva già divisato di fare. Ne fanno fede antichi documenti citati da Andrea Adami nella Prefazione storica delle Osservazioni sulla Cappella Pontificia (p. 11). – Nel Concilio di Trento si era stabilito di eliminare la musica dalle Chiese, ma l’imperatore Ferdinando avendo, per mezzo dei suoi legati, annunziato che il canto musicale, o figurato, serviva di incitamento alla devozione per i fedeli e favoriva la pietà, si mitigò il Decreto già preparato; ed ora questo decreto si trova nella sessione 22, al titolo: De observandis et evitandis in celebratione Missae. Con esso sono state escluse dai sacri Templi solo quelle musiche in cui, “sia nel suono sia nel canto, si mescola alcunché di lascivo o di impuro“. – Il fatto è riferito da Grancolas nel suo lodato Commentario (p. 56), e dal Cardinale Pallavicino nella Storia del Concilio (libro 22, cap. 5, n. 14). – Certamente Scrittori Ecclesiastici di gran nome seguono di buon grado la stessa sentenza. Il venerabile Cardinale Bellarmino nel tomo 4 delle sue Controversie, al libro 1 De bonis operibus in particulari, 17, in fine, insegna che deve essere mantenuto nelle Chiese l’uso degli organi, ma che non devono essere facilmente ammessi altri strumenti musicali: “Da ciò ne viene che, come l’organo si deve conservare nelle Chiese per riguardo ai deboli, così non devono essere introdotti alla leggera altri strumenti“. – Anche il Cardinale Gaetano è di questo parere, e nella sua Somma, alla voce organum, così scrive: “L’uso dell’organo, sebbene per la Chiesa costituisca una novità – perciò la Chiesa Romana fino ad ora non ne fa uso alla presenza del Pontefice –, è però lecito avuto riguardo ai fedeli ancora carnali ed imperfetti“. – Il venerabile Cardinale Baronio, all’anno 60 di Cristo [dei suoi Annali], così scrive: ” In verità nessuno potrà con ragione disapprovare che dopo molti secoli si sia introdotto l’uso nella Chiesa degli organi, strumenti formati da canne di diversa grandezza assieme unite“.- Cardinale Bona, nel De Divina Psalmodia, cap. 17, trattando degli organi suonati nelle Chiese, dice: “Non bisogna condannare un uso moderato di essi, ecc. Il suono dell’organo reca letizia agli animi tristi degli uomini, e richiama alla giocondità della celeste Città, scuote i pigri, ricrea i diligenti, provoca i giusti all’amore, richiama i peccatori a penitenza“. – Il Suarez (tomo 2 De Religione, al libro 4 De Horis Canonicis, cap. 8, n. 5) fa rilevare che la parola organo non indica soltanto quel particolare strumento musicale che oggi si suole ordinariamente chiamare organo – il che prima di lui fu avvertito da Sant’Isidoro nel libro 2 Originum, cap. 20: “La parola organo indica in generale tutti gli strumenti musicali” –; dicendo che l’organo può essere usato nelle Chiese, s’intende che possono essere usati altri strumenti musicali. – Silvio (tomo 3 delle sue Opere sulla 2, 2 di San Tommaso, quest. 91, art. 2) non rigetta dalle Chiese il canto armonico o figurato: “Perciò deve essere grandemente curato il canto Ecclesiastico, sia quello detto piano, o gregoriano, che è propriamente canto Ecclesiastico, sia quello introdotto dopo nella Chiesa, e che si chiama canto figurato o armonico“. E poco più avanti dice ancora: “Tuttavia, essendosi, dopo molti secoli, accolto l’uso di accompagnare gli Uffici Ecclesiastici con strumenti musicali, ciò non deve essere disapprovato“. – Il Bellotte, nel libro De Ritibus Ecclesiae Laudunensis (p. 209, n. 8), dopo aver a lungo e minuziosamente parlato degli strumenti musicali, che si suonano alle volte nei Divini Offici; e, dopo aver dimostrato che anticamente questi strumenti non si usavano nelle Chiese, ritiene che la cagione di tale antica usanza e diversa consuetudine, debba riporsi nella necessità che spingeva allora i Cristiani a stare lontani, il più possibile, dai riti profani dei pagani, i quali, nei teatri, nei festini, nei sacrifizi, usavano strumenti musicali. – “Perciò, dice il Bellotte, non si deve vedere una sconvenienza negli strumenti musicali stessi, se la Chiesa ha fatto uso di cantori in musica e di musicali strumenti soltanto negli ultimi secoli. Il motivo sta solo nel fatto che i pagani usavano simili strumenti musicali per scopi turpi e immorali, appunto nei teatri, nei conviti e nei sacrifizi“. – Il Persico, nel suo trattato De Divino et Ecclesiastico Officio (al dubbio 5, n. 7) così scrive del canto figurato nelle Chiese: “In secondo luogo dico: ancorché nel canto organico, o figurato, possano introdursi molti abusi – come suole d’altronde avvenire in tutte le altre cerimonie Ecclesiastiche – , esso tuttavia è di per sé lecito, e per nessun motivo vietato, quando viene eseguito in maniera regolata, devota e decente“. – Al dubbio 6, numero 3, sostiene che “l’uso ormai universale di suonare l’organo e altri strumenti musicali, durante i Divini Uffici, è un uso lodevole, e molto utile per elevare alla contemplazione di Dio gli animi delle persone imperfette“. – L’uso del canto armonico, o figurato, e degli strumenti musicali, sia nelle Messe, come nei Vespri e in altre funzioni di Chiesa, è ora talmente esteso, da essere giunto anche nel Paraguay. – Essendo quei novelli fedeli americani dotati di straordinaria propensione ed abilità al canto musicale ed al suono dei musicali strumenti, tanto da imparare con tutta facilità ciò che riguarda l’arte musicale, i Missionari si servono di questa tendenza per avvicinarli alla Fede Cristiana, mediante pie e devote canzoni. Così che, al presente, non vi è più quasi nessun divario, sia nel canto come nel suono, tra le Messe ed i Vespri di casa nostra con quelle delle suddette regioni. Ciò riferisce l’Abate Muratori, riportando relazioni degne di fede, nella sua opera: Descrizione delle Missioni del Paraguay (cap. 12).
6. Abbiamo pure detto che non c’è alcuno che non condanni il canto teatrale nelle Chiese, e che non desideri una differenziazione tra il canto sacro della Chiesa e il canto profano delle scene. Celebre è il testo di S. Girolamo, riferito nel Canone Cantantes: “Cantando e salmeggiando nei vostri cuori al Signore. Ascoltino questo gli adolescenti; lo ascoltino coloro che hanno nella Chiesa il dovere di salmeggiare. Non basta cantare ad onore di Dio con il suono della voce, ma bensì è necessario unirvi il cuore. Né alla moda degli attori teatrali occorre spalmare la gola e le labbra di soave unguento affinché nella Chiesa si sentano melodie e canti teatrali” (distinzione 92). – L’autorità di S. Girolamo fu abusivamente invocata da coloro che, con troppa audacia, volevano rimuovere dalle Chiese ogni sorta di canto. Ma S. Tommaso, nel luogo già citato, così risponde, alla seconda obiezione ricavata dal detto testo di S. Girolamo: “Riguardo alla seconda obiezione, occorre notare che S. Girolamo non condanna il canto, ma riprende coloro che nelle Chiese cantano come canterebbero in un teatro“. – San Nicezio, nel libro De Psalmodiae bono (cap. 3, nel tomo 1 dello Spicilegio), così descrive il canto che deve adoperarsi nelle Chiese: “Si usi un suono ed un canto di salmodia che siano conformi alla santità della Religione, e non piuttosto espressioni del canto tragico; che vi faccia apparire veri cristiani, e non piuttosto riecheggi suoni teatrali; che vi induca alla compunzione dei peccati“. – I Padri del Concilio di Toledo (riuniti nell’anno 1566, nell’azione 3, al cap. 11 del tomo 10 della Collezione dei Concilii dell’Arduino), dopo aver molto parlato della qualità del canto da usarsi nelle Chiese, così concludono: “ Bisogna assolutamente evitare che il suono musicale porti nel canto delle divine lodi qualche cosa di teatrale; o che evochi profani amori, e gesta guerresche, come suole fare la musica classica“.– Non mancano numerosi e dotti scrittori, che severamente condannano la paziente tolleranza, nelle Chiese, del suono e del canto teatrali, e domandano che simile abuso venga tolto dalle Chiese. – Si consultino il Casadio (De veteribus sacris Christianorum ritibus, cap. 34) e l’Abate Lodovico Antonio Muratori (Antiqua Romana Liturgia tomo I; dissertazione De rebus liturgicis, cap. 22, in fine). – E per terminare il Nostro dire su questo argomento, ossia dell’abuso dei teatrali concerti nelle Chiese (che è cosa per sé evidente e che non richiede parole per dimostrarla), basterà accennare che tutti quelli che Noi abbiamo sopra citati, come favorevoli al canto figurato ed all’uso degli strumenti musicali nelle Chiese, chiaramente dicono ed attestano di aver sempre nei loro scritti inteso e voluto escludere quel canto e quel suono propri i dei palcoscenici e dei teatri. Canto e suono che essi, come gli altri, condannano e deprecano. Quando si professavano favorevoli al canto ed al suono, sempre intesero un canto ed un suono adatto alle Chiese, e che eccita il popolo a devozione. Questa loro intenzione ognuno può conoscere leggendo i loro scritti.
7. Stabilito che, essendo già introdotta la consuetudine del canto armonico o figurato e degli strumenti musicali negli Uffici Ecclesiastici, se ne condanna soltanto l’abuso; il Bingamo (Delle Origini Ecclesiastiche, tomo 6, libro 14, par. 16), benché sia autore eterodosso, concorda; ne consegue che bisogna diligentemente studiare quale sia il retto uso e quale l’abuso. – Riconosciamo che per fare Noi bene quanto Ci siamo proposto, avremmo bisogno della perizia musicale di cui erano adorni alcuni dei Nostri santi e illustri Predecessori, quali Gregorio il Grande, Leone II, Leone IX e Vittore III. Noi però non abbiamo avuto né il tempo e né l’occasione di imparare la musica. Tuttavia Ci accontenteremo di dire alcune cose ricavate dalle Costituzioni dei Nostri Predecessori, e dagli scritti di uomini virtuosi e dotti. – Per procedere però con ordine, parleremo prima di tutto ciò che si deve cantare nelle Chiese. Poi parleremo del modo e del metodo che si deve tenere nel canto. Infine parleremo degli strumenti musicali adatti alle Chiese, e che devono essere suonati nei sacri Templi.
8. Guglielmo Durando, che visse sotto il Pontificato di Nicolò III, nel suo trattato De modo Generalis Concili i celebrandi (cap. 19), apertamente riprova l’uso, allora frequente, di quelle cantilene dette mottetti: “Sembra assai opportuno togliere dalla Chiesa quel canto non devoto e disordinato dei mottetti e di altre cose simili“. In seguito il Pontefice Giovanni XXII, Nostro Predecessore, promulgò la sua Decretale, che comincia con le parole Docta Sanctorum e che si trova tra le Extravaganti comuni, al titolo De vita et honestate Clericorum. In questa sua Decretale, il Papa si mostra contrario al canto dei mottetti in lingua volgare: “Talora v’inseriscono mottetti in lingua volgare“. – I Teologi hanno fatto oggetto d’indagine siffatto genere di cantilene o mottetti che solitamente si cantano nelle Chiese. Uno di essi, il Paludano (Sentenze, libro IV, dist. 15, q. 5, art. 2), ritenne il canto dei mottetti una specie di canto teatrale, e riprende coloro che ne fanno uso: “coloro, cioè, che nelle solennità cantano i mottetti, poiché il canto (nelle Chiese) non deve essere simile a quello delle tragedie“. – Il Suarez (De Religione, tomo 2, libro 4; De Horis Canonicis, cap. 13, n. 16) sembra favorevole al canto dei mottetti, ancorché essi siano stati scritti in lingua volgare, purché siano seri e devoti. A provare quanto asserisce adduce il costume e l’uso di alcune Chiese governate da sapienti prelati, che non condannano queste cantilene o modulati carmi. Aggiunge inoltre che, nei primi tempi della Chiesa, ogni fedele cantava nel tempio quei pii e devoti inni che egli stesso aveva composti; e che tale antica consuetudine serve, in certo modo, ad approvare l’uso dei mottetti. – Prevedendo l’obiezione che gli si può muovere, che da simili canti modulati, chiamati mottetti, rimane interrotta la salmodia ecclesiastica, ad essa così risponde: “Questa interruzione, o pausa, che per questo fatto viene a stabilirsi tra le parti di un’Ora (canonica), non è da condannarsi. Questa parte dell’ufficiatura rimane moralmente non interrotta, a causa della devozione che questo canto stesso si propone di eccitare. Così questo canto può essere considerato come una preparazione all’ufficiatura che segue, e come una solenne e degna conclusione dell’ufficiatura precedente, e come un ornamento di tutta l’Ora“. – Il Sommo Pontefice Alessandro VII, nell’anno 1657, emanò una Costituzione, che comincia con le parole Piae sollicitudinis, e che è la trentaseiesima tra le Costituzioni di questo Pontefice. In tale documento il Papa comanda di non cantare, nel tempo dei Divini Uffici, e nel tempo in cui nelle Chiese è esposto il Sacramento dell’Eucaristia alla pubblica venerazione dei fedeli, nessun canto che non sia formato da parole desunte dal Breviario o dal Messale Romano. Questi canti possono essere desunti dall’ufficiatura propria o comune della solennità di ciascun giorno, o della festa del Santo; questi brani possono pure essere tolti dalla Sacra Scrittura o dalle opere dei Santi Padri, ma prima devono essere sottoposti alla revisione ed all’approvazione della Sacra Congregazione dei Riti. – Da questa Costituzione pontificia appare, senza alcun dubbio, che il canto dei mottetti, composti seguendo le norme prescritte dallo stesso Alessandro VII, Nostro Predecessore, e riveduti ed approvati dalla Sacra Congregazione dei Riti, fu dichiarato legittimo. Questa Costituzione di Alessandro VII fu confermata dal Venerabile Servo di Dio Innocenzo XI, in un suo Decreto del 3 dicembre 1678. – Essendo però sorto qualche dubbio sul significato e sulla interpretazione della Costituzione di Alessandro e del Decreto di Innocenzo XI, il Nostro Predecessore di felice memoria Innocenzo XII, emise, in data 20 agosto 1692, un nuovo Decreto, che è il settantaseiesimo del suo Bollario. Questo decreto, dissipando la confusione causata dalle diversità di interpretazioni, e illuminando tutta la questione, proibì in genere il canto di ogni cantilena o mottetto. Nelle sante Messe solenni permise soltanto, oltre al canto del Gloria e del Simbolo, di poter cantare l’Introito, il Graduale e l’Offertorio. Nei Vespri non ammise nessun cambiamento, neppure minimo, nelle Antifone che si dicono all’inizio e alla fine di ogni Salmo. – Inoltre volle e comandò che i cantori musici seguissero in tutto le regole del Coro e che con esso si conformassero perfettamente. E siccome nel Coro non è permesso aggiungere qualche cosa all’Ufficio o alla Messa, così proibì pure questo ai musici, e soltanto permise di prendere dall’Ufficio e dalla Messa della solennità del Santissimo Sacramento del Corpo del Signore – ossia dagli inni di San Tommaso o dalle antifone, o da altri brani passati nel Breviario dal Messale Romano – qualche strofa o mottetto, senza cambiarne le parole, e di poterli cantare, al fine di eccitare la devozione nei fedeli, durante l’elevazione della sacra Ostia, o quando è esposta alla venerazione ed all’adorazione del pubblico.
9. Dopo avere con una legge regolato l’uso delle canzoncine, o delle strofe cantate o mottetti, bisogna ammettere che si era già fatto molto per rimuovere dalle Chiese i canti teatrali, ma occorre pure confessare che ciò non era sufficiente per raggiungere lo scopo desiderato. – Era ancora possibile, e troppo ancora ciò si fa con Nostro dispiacere, cantare tutte le parti che è lecito e che si sogliono cantare nelle Messe e nei Vespri, come è stato su riferito (ossia il Gloria, il Simbolo, l’Introito, il Graduale, l’Offertorio e tutto il resto), ma cantarle alla maniera teatrale e con strepito da palcoscenico. – Il grande vescovo Guglielmo Lindano, nella sua Panoplia Evangelica, al libro 4, cap. 78, non è contrario al canto musicale nelle Chiese, ma disapprova le molte ripetizioni, e le confusioni delle voci, e propone che nelle Chiese si adoperi una musica adatta alle cose che si cantano: “So bene, dice egli, che alcuni giudicano più conveniente conservare la musica, con strumenti e musici. Darei volentieri il mio consenso a costoro, qualora avvenisse, nello stesso tempo, la sostituzione del metodo, attualmente in vigore ovunque nelle Chiese, con un metodo più serio, più aderente alle cose, e, se non più vicino alla pronunzia che alla melodia, almeno sia più adattato alle cose che si cantano e più in armonia con esse“. – Il Dresselio, nella sua opera Rhetorica caelestis (libro I, cap. 5), scrive opportunamente in proposito: “Qui, o musicisti, sia detto con vostra pace, prevale ora nelle Chiese un genere di cantare che è nuovo, ma eccentrico, spezzettato, ballabile, e certamente poco religioso; più adatto al teatro ed al ballo che non al Tempio. Si cerca l’artifizio e si perde il primiero desiderio di pregare e di cantare. Abbiamo cura di destare la curiosità, ma in realtà trascuriamo la pietà. Che è infatti questo nuovo e danzante modo di cantare se non una commedia, in cui i cantori si mutano in attori? Essi si esibiscono: ora uno da solo, ora in due, ora tutti assieme, e dialogano tra di loro col canto; poi nuovamente uno domina solo, e poco dopo gli altri lo seguono“. – Uno scrittore moderno, Benedetto Girolamo Feijo o, Maestro Generale dell’Ordine di San Benedetto in Spagna, nel Theatrum criticum universale, discorso 14, basandosi sulla perizia e sulla conoscenza delle note musicali, indica il metodo da seguirsi per ottenere composizioni musicali per le Chiese, del tutto diverse dai concerti musicali dei teatri. – Ma Noi qui Ci contenteremo di ricordare – tenendo presenti le prescrizioni dei Sacri Concili e le sentenze di Scrittori autorevoli – che il canto musicale dei teatri viene fatto in modo (come Ci fu riferito) che il pubblico presente, ascoltando i canti musicali ne riporti diletto, e goda degli artifizi della musica, si esalti per la melodia, per la musica in se stessa; provi piacere per la soavità delle varie voci, senza percepire, il più delle volte, l’esatto significato delle parole. Non cosi invece deve essere nel canto Ecclesiastico; anzi in questo si deve avere di mira l’opposto. – Nel canto Ecclesiastico si deve badare innanzi tutto ad ottenere una audizione perfetta e facile delle parole. Nelle Chiese, infatti, la musica è accolta per elevare le menti degli uomini a Dio, come insegna Sant’Isidoro nel libro I del De Ecclesiasticis Officiis, al cap. 5: “Si usa dalla Chiesa salmeggiare e cantare soavi melodie per indurre più facilmente gli animi alla compunzione“; ciò non può ottenersi se non s’intendono le parole. – Il Concilio di Cambrai (tenuto nel 1565, al titolo 6, cap. 4, tomo 10, p. 582 della Collezione di Arduino) così prescrive: “Del resto ciò che si deve cantare in coro è destinato ad istruire; lo si canti perciò in modo da essere capito dalla mente“. – Nel Concilio di Colonia (riunito nel 1536, al cap. 12 del De officiis privatis) si legge quanto segue: “In alcune Chiese si giunse a commettere l’abuso di omettere o di abbreviare, per favorire l’armonia del canto e del suono, quello che era più importante. E la parte più importante è costituita appunto dalla recita delle parole dei Profeti, degli Apostoli, od Epistola, del Simbolo della fede, del Prefazio o azione di ringraziamento e dell’Orazione del Signore. Per la loro importanza, questi testi devono essere, come tutti gli altri, cantati in modo chiarissimo e intelligibile“. – Nel primo Concilio di Milano (tenuto nell’anno 1565, nella parte 2, n. 51 della Collezione di Arduino, p. 687) si legge: “Negli Uffici Divini, e in generale nelle Chiese, non si devono cantare o suonare cose profane; le cose sacre poi devono essere cantate senza languide flessioni di voce, senza suoni più gutturali che labiali; mai si deve usare un tono di canto passionale. Il canto ed il suono siano seri, devoti, chiari, adatti alla casa di Dio e confacenti con le divine lodi; fatti in modo che coloro che ascoltano capiscano le parole e siano mossi a devozione“. – Sulla materia qui trattata esistono parole assai gravi dei Padri convenuti nell’anno 1566 al Concilio di Toledo (Azione 3, cap. 2, p. 1164 della Collezione di Arduino): “Siccome tutto ciò che si canta nelle Chiese per lodare Dio, deve essere cantato in modo da favorire, per quanto è possibile, l’istruzione dei fedeli, e deve essere un mezzo per regolare la pietà e la devozione e per spronare le menti degli uditori fedeli a prestare a Dio il culto, e a desiderare le cose celesti; stiano in guardia i Vescovi, che mentre ammettono nel coro musicale la pratica di variazioni melodiche in cui le voci si mescolano secondo ordini diversi, le parole dei salmi e delle altre parti che sogliono cantarsi, non rimangano incomprese e soffocate da uno strepito disordinato. I Vescovi coltivino invece una musica così detta organica, che permetta di capire le parole di quelle parti che si cantano, e gli animi degli uditori siano portati a lodare Dio più dalla pronunzia delle parole che da curiosi gorgheggi“. – Ciò giustifica i lamenti espressi dal Vescovo Lindano nel testo citato (Panoplia Evangelica): “Ai nostri giorni, il canto dei musici è piuttosto fatto per distogliere, sviare, allontanare gli animi degli uditori, che non per eccitarli a pietà e a desideri celesti. Ricordo infatti di aver partecipato qualche volta alle divine lodi, di aver prestato grande attenzione mentre si cantava per riuscire a capire le parole, ma non riuscì ad intenderne neppure una sola. Tutto era un groviglio di sillabe ripetute, di voci confuse; il senso rimaneva sommerso da ciò che, più che canto, era un clamore assordante, un boato scomposto“. – Ciò dimostra quanto saggio fosse il desiderio, e quanto prudente sia l’esortazione con la quale Dresselio, pure nell’opera citata (Rethorica caelestis) esorta i musici alla devozione: “Fate rivivere, ve ne supplico, qualche cosa almeno del primiero fervore religioso nella musica sacra. Se voi avete a cuore, se desiderate l’onore divino, adoperatevi per questo, faticate per questo scopo: affinché cioè le parole che si cantano siano pure comprese. Che mi giova sentire nel Tempio varietà di suoni, profusione di voci, se a tutto ciò manca un’anima, se non riesco a comprendere il significato e le parole, che il canto dovrebbe invece instillarmi?” – Ciò finalmente giustifica la risposta data dal Cardinale Domenico Capranica al Sommo Pontefice Nicolò V, dopo aver assistito ad una sacra funzione ed alla Divina Ufficiatura, eseguite in canto musicale, in modo però che non si poterono udire le parole. Il Pontefice chiese al Cardinale che cosa ne pensasse di simile musica; la risposta che il Cardinale diede si può leggere presso Poggio, nella Vita di questo Cardinale edita dal Baluzio, nella Miscellanea (libro 3, § 18, p. 289). – Il grande Padre Agostino racconta di se stesso che sentendo cantare soavemente gli inni nella Chiesa, piangeva dirottamente: “Quanto piansi tra gl’inni ed i cantici tuoi, vivamente commosso alle voci della tua Chiesa soavemente echeggiante! Quelle voci si riversavano nei miei orecchi, stillava la verità tua nel mio cuore, e da essa mi veniva fervore. Di qui provenivano sentimenti di devozione, e scorrevano lacrime, e mi facevano del bene!” (Confessioni, libro 9, cap. 6). Ma poi essendogli venuto lo scrupolo del gran diletto che provava sentendo cantare gli inni nelle Chiese, quasi fosse un’offesa a Dio, e portandolo la severità a disapprovare il detto canto, ritornò però al primo pensiero di approvarlo, perché il suo animo si commuoveva, non per l’armonia solamente, ma per le parole che l’armonia accompagnava, come apertamente egli dichiarò (Confessioni, libro 10, cap. 33). – Piangeva perciò Agostino di devota tenerezza, sentendo cantare nelle Chiese le sacre lodi, e ben intendendo le parole accompagnate dal canto. Piangerebbe forse ancora oggi, se sentisse qualcheduna delle musiche delle Chiese, ma non piangerebbe per devozione, ma per dolore di sentire bensì il canto, ma di non intenderne le parole.
10. Fin qui abbiamo parlato del canto musicale; ora dobbiamo parlare del suono dell’organo musicale, e degli altri strumenti, il cui uso, come abbiamo detto sopra, è ammesso in alcune Chiese. È pure necessario trattare del suono, perché se il canto non deve essere teatrale, altrettanto deve dirsi del suono. Gli Ebrei non avevano bisogno di questa indagine, ossia di stabilire differenze fra il canto nel Tempio e il canto profano nei teatri. Infatti dalle Sacre Scritture si desume che il canto ed il suono degli strumenti musicali erano in uso nel Tempio, ma non nei teatri, come fa notare ottimamente il Calmet nella sua dissertazione sopra la musica degli Ebrei. – Noi abbiamo bisogno di fissare dei limiti tra il canto ed il suono di Chiesa, e quelli dei teatri. Noi dobbiamo definire la diversità tra i due, perché oggi il canto figurato, o armonico, con il suono degli strumenti, si adopera tanto nei teatri come nelle Chiese. – Avendo già a lungo parlato del canto, rimane ora da parlare anche del suono. E per discorrere con ordine, tratteremo prima degli strumenti musicali, che possono essere tollerati nelle Chiese; in secondo luogo parleremo del suono di quegli strumenti che si suole accompagnare al canto; in terzo luogo parleremo del suono separato dal canto, ossia della sinfonia strumentale.
11. Quanto agli strumenti, che possono tollerarsi nelle Chiese, il sopra citato Benedetto Girolamo Feijo o, nel citato discorso (Theatrum criticum universale, discorso 14, par. 11, n. 43) ammette gli organi e altri strumenti, ma vorrebbe escludere le lire tetracorde (violini), perché l’archetto fa emettere alle corde suoni armoniosi, ma troppo acuti, che eccitano in noi piuttosto ilarità puerile, che non composta venerazione per i sacri misteri, e raccoglimento. – Il Bauldry (Manuale nelle sacre cerimonie, § I, cap. 8, n. 14) non vorrebbe nelle Chiese, con l’organo pneumatico, che le trombe o gli strumenti a fiato o pneumatici: “Non si suonino, con l’organo, altri strumenti musicali all’infuori delle trombe, flauti o cornette“. Al contrario, i Padri del Primo Concilio Provinciale di Milano, tenuto sotto San Carlo Borromeo, nel titolo De Musica et Cantoribus, bandiscono dalle Chiese gli strumenti a fiato: “Nella Chiesa vi sia solo l’organo; si escludano i flauti, le cornette e ogni altro strumento musicale“. – Noi non abbiamo omesso di richiedere il consiglio di uomini prudenti e di insigni Maestri di musica. In conformità del loro parere, Ella, venerabile Fratello procurerà che nelle sue Chiese, se in esse vi è l’uso di suonare gli strumenti musicali, con l’organo, siano ammessi soltanto quegli strumenti che hanno il compito di rafforzare e sostenere la voce dei cantori, come sono la cetra, il tetracordo maggiore e minore, il fagotto, la viola, il violino. Escluderà invece i timpani, i corni da caccia, le trombe, gli oboe, i flauti, i flautini, le arpe, i mandolini e simili strumenti, che rendono la musica teatrale.
12. Sul modo poi di usare quegli strumenti che si possono ammettere nella musica sacra, ammoniamo soltanto che essi vengano usati esclusivamente per sostenere il canto delle parole, affinché vieppiù il senso di esse si imprima nella mente degli uditori, e gli animi dei fedeli vengano eccitati alla contemplazione delle cose spirituali, e siano spronati ad amare di più Dio e le cose divine. Il Valenza, parlando dell’utilità della musica e degli strumenti musicali, giustamente dice: “Servono a ravvivare il proprio e l’altrui fervore, specialmente dei rozzi, che spesso sono deboli, e devono essere portati al gusto delle realtà spirituali, non solo a mezzo del canto vocale, ma anche con il suono dell’organo, e di musicali strumenti” (nel tomo 3 sulla 2, 2 di San Tommaso, disp. 6, quest. 9). – Se però gli strumenti suonano in continuazione, e solo qualche volta si chetano, come si usa oggi, per lasciare tempo agli uditori di sentire le armoniche modulazioni, le vibranti puntate delle voci, volgarmente chiamati i trilli; se, per il rimanente, non fanno altro che opprimere e seppellire le voci del coro, e il senso delle parole, allora l’uso degli strumenti non raggiunge lo scopo voluto, diventa inutile, anzi rimane proibito ed interdetto. – Il Pontefice Giovanni XXII, nella citata sua Extravagante Docta Sanctorum, fra gli abusi della musica mette il seguente, che esprime con queste parole: “Spezzettare la melodia con rantoli” ossia con singulti, come spiega Carlo Dufresne nel suo Glossario: questo nome indica quelle concise modulazioni, volgarmente dette trilli. – Il grande Vescovo Lindano, nel luogo citato, inveisce contro l’abuso di coprire, con il suono degli strumenti, le parole dei cantori: “Il clamore delle trombe, lo stridore dei corni, e altro vario fracasso, nulla viene omesso di ciò che può rendere incomprese le parole che si cantano, oscurarle, seppellirne il significato“. – Il pio e dotto Cardinale Bona, nel più volte lodato trattato De Divina Psalmodia (cap. 17, § 2, n. 5), così scrive in proposito: “Prima di terminare, darò un avvertimento ai cantori di Chiesa: non facciano servire ad una illecita passione ciò che i Santi Padri hanno ordinato ad aiutare la devozione. Il suono deve essere eseguito in modo grave e moderato, da non assorbire tutte le facoltà dell’anima, ma da lasciare la maggior parte dell’attenzione per comprendere il significato di quello che si canta, e per i sentimenti di pietà“.
13. Infine, per ciò che riguarda le sinfonie, dove il loro uso è già introdotto, potranno tollerarsi, purché siano serie, e non rechino, a causa della loro lunghezza, noia o grave incomodo a quelli che sono nel Coro, o che funzionano all’Altare, nei Vespri e nelle Messe. Di queste sinfonie parla il Suarez: “Da ciò si comprende che, di per sé, non è da condannarsi l’uso di intercalare agli Uffici Divini il suono dell’organo senza canto, adoperando solo con soavità la musica degli strumenti, come succede qualche volta durante la Messa solenne, o nelle Ore Canoniche, tra i Salmi. In questi casi tale suono non è parte dell’Ufficio, e ridonda a solennità ed a venerazione dell’Ufficio stesso ed a elevazione degli spiriti dei fedeli, affinché più facilmente si muovano a devozione o vi si dispongano. Ancorché però nessun canto vocale si associ a questo suono, occorre che detto suono sia grave e adatto a eccitare la devozione” (Suarez, De Religione, libro 4, cap. 13, n. 7). – Non si deve però qui tacere essere cosa assai sconveniente e da non più tollerarsi, che in alcuni giorni dell’anno si tengano sinfonie sontuose e rumorose, si tengano canti musicali nei Templi, del tutto sconvenienti ai Sacri Misteri che la Chiesa in quel dato tempo propone alla venerazione dei fedeli. – Lo zelo di cui era animato, spinse il più volte nominato Maestro Generale dell’Ordine di San Benedetto in Spagna a protestare nel citato discorso (Theatrum criticum universale, discorso 14, § 9) contro le arie ed i recitativi, ohimè!, troppo usati nel cantare le Lamentazioni del Profeta Geremia, la cui recita è dalla Chiesa prescritta nei giorni della Settimana Santa, e nelle quali ora si piange la distruzione della Città di Gerusalemme ad opera dei Caldei, ora la desolazione del mondo ad opera dei peccati, ora l’afflizione della Chiesa militante nelle persecuzioni, ora le angustie del nostro Redentore nei suoi dolori. – Mentre sedeva sulla Cattedra Apostolica il Nostro santo Predecessore Pio V, la Chiesa di Lucca era governata da Alessandro, Vescovo zelantissimo della disciplina Ecclesiastica. Egli aveva osservato che, durante la Settimana Santa, si facevano nelle Chiese dei concerti solennissimi con numerosi cantori e suono di strumenti svariati. Ciò non era per nulla intonato al clima di mestizia delle sacre funzioni che si celebrano in quei giorni. Ad udire tali concerti accorreva una numerosissima avida folla di uomini e di donne, e succedevano peccati e scandali gravi. Il Vescovo con un suo editto proibì questi concerti nella Settimana Santa e nei tre giorni seguenti la Pasqua. Siccome alcuni, esenti dalla giurisdizione episcopale, pretendevano di non essere tenuti ad obbedire al Vescovo, costui deferì la questione al Sommo Pontefice Pio V, il quale rispose con un Breve, in data 4 aprile 1571. – Il Papa deplora la cecità delle menti umane e degli uomini carnali, che non solo nei giorni sacri, ma specialmente in quelli stabiliti dalla Chiesa in modo speciale per venerare la memoria della passione di Cristo Signore, messa da parte la pietà, e la sincera purità della mente, si lascino trasportare dai piaceri del mondo, e si abbandonino in balìa e si lascino dominare dalle passioni. “Questo – dice poi – deve essere sempre evitato, in ogni periodo sacro, ma deve essere evitato in modo tutto speciale in quel periodo di tempo fissato dalla Chiesa per commemorare la passione del Signore. In tale tempo invece massimamente conviene che tutti i Cristiani rivolgano la loro mente alla contemplazione di così grande ed eccelso beneficio fatto a noi dal Nostro Redentore, e che si tengano liberi ed immuni da ogni impurità di cuore e di sensi“. – Riferisce poi l’abuso introdotto nella Chiesa di Lucca di fare scelta nella Settimana Santa di bravi musici, e di radunare ogni sorta di strumenti per tenere solenni concerti musicali. Dice al Vescovo: “Recentemente, con grande Nostro dispiacere, abbiamo saputo che in codesta Città, ove eserciti l’ufficio di Vescovo, vi è un abuso assai detestabile, di tenere cioè concerti nelle Chiese, durante la Settimana Santa, con la riunione di scelti cantori e di ogni genere di strumenti. A questi concerti, più che non ai Divini Uffici, accorre una folla di giovani di ambo i sessi, attrattavi da una vera passione, e l’esperienza ha dimostrato che si commettono gravi peccati e che avvengono dei non meno gravi scandali“. – Infine loda l’ordine del Vescovo, e, basandosi sui decreti del sacrosanto Concilio di Trento, dichiara che questo ordine si estende ed obbliga anche le Chiese che si dicono esenti dall’autorità dell’Ordinario, per privilegio apostolico o per qualsiasi altra ragione. – Nel Concilio Romano (tenutosi da poco tempo a Roma, nell’anno 1726, al titolo 15, n. 6) si leggono vari decreti sopra l’uso del canto musicale e degli strumenti, durante l’Avvento, nelle Domeniche di Quaresima, e durante le esequie dei defunti. Ci basti avervi accennato. –
14. Ci ricordiamo aver letto che l’Imperatore Carlo Magno, essendosi proposto di ridurre a regole di arte il canto Ecclesiastico, che nelle Chiese della Gallia era allora eseguito in maniera disordinata e rozza, chiedesse al Pontefice Adriano I l’invio da Roma di persone istruite nella musica di chiesa. Questi inviati facilmente introdussero nel Regno delle Gallie il Canto Romano, come ognuno può venire a sapere leggendo la notizia presso Paolo Diacono (Vita di San Gregorio, libro 2, cap. 9); presso Rodolfo de Tongres (De Canonum observantia, prop. 12); presso Sant’Antonino (Summa Historica, parte 2, tit. 12, cap. 3). Il Monaco d’Angoulême (Vita di Carlo Magno, cap. 8), racconta inoltre che i cantori giunti da Roma insegnarono nelle Gallie anche l’arte di suonare l’organo musicale, che era stato introdotto nel regno delle Gallie sotto il re Pipino. – Essendo costume e regola generale che la città di Roma debba precedere, con l’esempio e l’insegnamento, tutte le altre Città, in ciò che concerne i Riti Sacri e le altre cose Ecclesiastiche: anche la storia lo conferma, così come lo conferma quanto Noi ora abbiamo narrato di Carlo Magno, che volendo introdurre il canto Ecclesiastico nel suo Regno, lo fece venire da Roma come dalla sua propria sede. – Questo fatto Ci spinge pressantemente e Ci stimola a fare sparire del tutto e tutti gli abusi che si fossero introdotti nel canto Ecclesiastico, e che Noi sopra abbiamo condannati; a farli sparire da ogni Chiesa, se fosse possibile, ma in modo speciale dalle Chiese della Città di Roma. – E come Noi non lasciamo di dare gli ordini necessari ed opportuni al Nostro Cardinale Vicario in Roma, cosi lei, Venerabile Fratello, non lasci di pubblicare, se è necessario, editti e leggi, che siano in armonia con questa Nostra Lettera circolare, e che regolino il canto Ecclesiastico in base alle disposizioni prescritte e stabilite nella presente Nostra Lettera, affinché si dia finalmente inizio alla riforma della musica ecclesiastica. – Questa riforma fu già ardentemente desiderata e sospirata da moltissimi, tanto che, già cento anni fa Giovanni Battista Doni, patrizio fiorentino, scriveva in un suo trattato, De Praestantia Musicae veteris (libro I, p. 49): “Le cose stanno ora a questo punto, che non si trova nessuno che stabilisca una legge severa che proibisca questo canto quasi effeminato e molle, che si è introdotto ovunque; nessuno che veda la necessità di imporre una disciplina a queste melodie affettate, prolisse e spesso aride; nessuno infine che non sia convinto che i giorni di festa solenni, e gli edifici sacri perderebbero celebrità e non sarebbero più frequentati se non rimbombassero per canti molli e spesso poco decorosi, e per la gran confusione di voci e di suoni in gara tra di loro“.
15. Abbiamo detto “se ve ne sia bisogno“, sapendo Noi molto bene che, nello Stato Ecclesiastico, vi sono alcune Città nelle quali vi è bisogno di riformare la musica delle Chiese; e vi sono invece altre Città che non hanno questo bisogno. – Temiamo però, e ne siamo vivamente preoccupati, che in alcune Città, le Chiese e i sacri Altari abbiano bisogno di una necessaria pulizia e del necessario addobbo. In molte Chiese cattedrali e collegiate il canto corale avrà bisogno di essere riformato, e bene, secondo le regole che Noi abbiamo più sopra date. -Se nella Sua Diocesi è necessario, bisogna che Ella metta tutta la diligenza e sollecitudine possibili, per correggere tali abusi. – Volesse il Cielo che in tutte le Diocesi del Nostro Stato i Sacerdoti celebrassero il sacrosanto Sacrifizio della Messa con quel devoto estrinseco decoro, che è dovuto! Che ogni Sacerdote si presentasse in pubblico vestito con l’abito da prete; e, nel decente vestito del corpo, anche con quei modi di fare, con quella modestia e con tutto quel decoro proprio di un Ecclesiastico! – Su questo argomento Noi non aggiungeremo qui altro, avendone già trattato diffusamente nella Nostra Notificazione XIV (§ 4 e 6, libro 2 edizione italiana, che è la XXXIV nella edizione latina), e nella Notificazione IV (tomo 4, edizione italiana, che è la LXXI nella edizione latina): ad esse rimandiamo quanti sono solleciti della disciplina Ecclesiastica. – Terminiamo spronando il Suo zelo sacerdotale ricordandole che non vi è cosa che si manifesti di più agli uomini se le Chiese sono mal guidate e mal governate dai Vescovi, quanto il vedere i Sacerdoti celebrare le sacre funzioni facendo male od omettendo le cerimonie Ecclesiastiche, portando vestiti indecenti, o non adatti assolutamente alla sacerdotale dignità, eseguendo ogni cosa con precipitazione e negligenza. – Queste cose cadono sotto gli sguardi di tutti, si offrono al giudizio sia degli abitanti del luogo come a quello dei forestieri. Scandalizzano specialmente coloro che provengono da regioni dove i Sacerdoti portano abiti convenienti, e celebrano la Messa con la dovuta devozione. – Il pio e dotto Cardinale Bellarmino, non senza lacrime si lamentava: “È pure causa di grande pianto che i sacrosanti Misteri siano trattati in modo così indecoroso, per l’incuria e l’empietà di alcuni Sacerdoti. Costoro che così fanno dimostrano di non credere che la Maestà del Signore è presente. Così alcuni celebrano Messa senza spirito, senza affetto, senza timore e tremore, con una precipitazione incredibile! Agiscono come se non credessero alla presenza di Cristo Signore, e come se non credessero che Cristo Signore li vede“. – Dopo alcune altre considerazioni, il Cardinale Bellarmino prosegue: “So che vi sono, nella Chiesa di Dio, molti ottimi e religiosissimi Sacerdoti, che celebrano i Divini Misteri con cuore puro, e con paramenti pulitissimi. Per questo tutti devono render grazie a Dio. Ma anche ve ne sono che muovono al pianto, e non sono pochi, il cui esteriore sordido manifesta le turpitudini e l’impurità della loro anima“. – Noi intanto L’abbracciamo, o Venerabile Fratello, nella carità di Cristo, ed impartiamo, di gran cuore, a Lei ed al Gregge alle Sue cure affidato, la Benedizione Apostolica.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 19 febbraio 1749, anno nono del Nostro Pontificato.