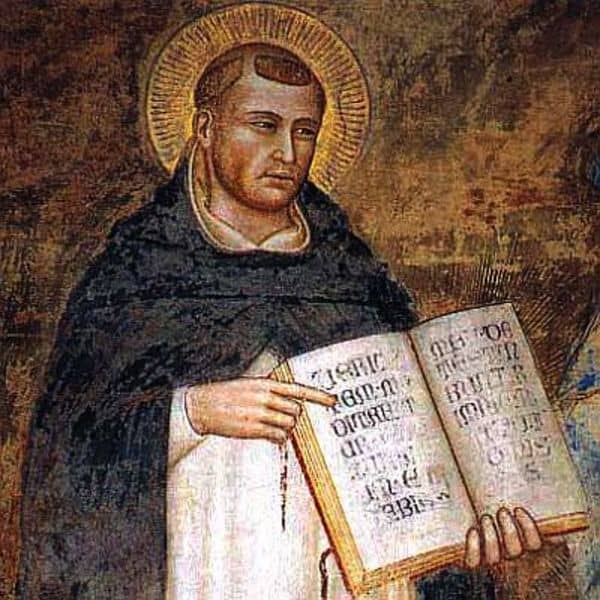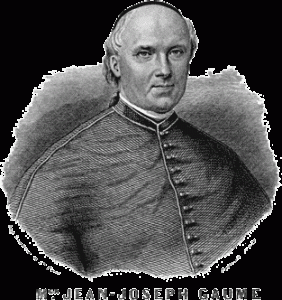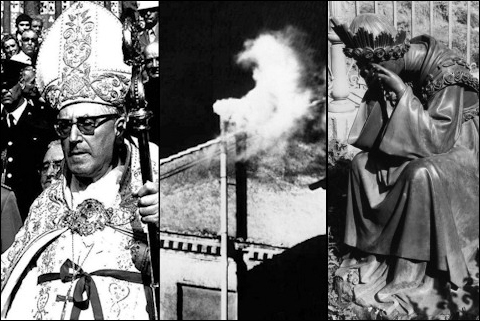DOMENICA DI PASSIONE I (2021)
Stazione a S. Pietro;
Semidoppio, Dom. privit. di I cl. • Paramenti violacei.
« Noi non ignoriamo, dice S. Leone, che il mistero pasquale occupa il primo posto fra tutte le solennità religiose. Durante tutto l’anno, col cercare di migliorarci sempre più, noi ci disponiamo a celebrare questa solennità in maniera degna e conveniente, ma questi ultimi e grandissimi giorni esigono ancor più la nostra devozione, poiché sappiamo che essi sono vicinissimi al giorno in cui celebriamo « il mistero cosi sublime della misericordia divina » (II Notturno). Questo mistero è quello della Passione del Salvatore di cui è ormai prossimo l’anniversario. Pontefice e mediatore del Nuovo Testamento, Gesù salirà ben presto sulla Croce e presenterà al Padre, il sangue, che Egli verserà entrando nel vero Sancta Sanctorum che è il Cielo (Ep.). « Ecco, canta la Chiesa, brilla il mistero della Croce, dove la Vita ha subito la morte e con la Sua morte ci ha reso la vita » (Inno dei Vespri). E l’Eucaristia è frutto dell’amore immenso di un Dio per gli uomini, poiché istituendola, Gesù ha detto: « Questo è il mio corpo, che sarà immolato per voi. Questo è il calice della nuova alleanza nel sangue mio. Fate questo in memoria di me » (Com.). Cosa fecero gli uomini in risposta a tutte queste bontà divine? « I suoi non lo ricevettero » dice S. Giovanni, parlando dell’accoglienza fatta a Gesù dai Giudei: » Gli fu reso il male per il bene » (4 Ant. della Laudi) e gli furono riservati solamente gli oltraggi « Voi mi disonorate » dirà loro Gesù ». Il Vangelo ci mostra in fatti l’odio sempre crescente del Sinedrio, Abramo, [Dopo la festa dei Tabernacoli che ebbe luogo il terzo anno del suo ministero pubblico, Gesù pronunciò nel Tempio le parole del Vangelo d’oggi. Una parte dell’atrio era stata trasformata in deposito Perché il Tempio non era ancora interamente ricostruito. I Giudei vi raccolsero delle pietre per lapidare Gesù che si nascose ai loro sguardi, la sua ora non essendo ancora venuta.] il padre del popolo di Dio, aveva fermamente creduto alle promesse divine che gli annunciavano Cristo futuro e nel Limbo la sua anima che, avendo avuto fede in Gesù, non è stata colpita da morte eterna, si è rallegrata nel vedere il realizzarsi di queste promesse, con la venuta del Salvatore. I Giudei che avrebbero dovuto riconoscere in Gesù il Figlio di Dio, più grande di Abramo e dei profeti perché eterno, misconobbero il senso delle sue parole e, dopo averlo insultato trattandolo da invaso dal demonio e bestemmiatore, lo vollero lapidare (Vang.). « Non temere davanti ad essi, gli dice Dio in persona di Geremia, poiché io farò che tu non tema i loro volti. Poiché oggi Io ti ho reso come una città fortificata, come una colonna di ferro, come un muro di bronzo contro i re di Giuda, i suoi principi, i suoi sacerdoti ed il suo popolo. Essi combatteranno contro te, ma non prevarranno: perché io sono con te, dice il Signore, per liberarti (I Notturno). « Io non cerco la mia gloria, dice Gesù; vi è qualcuno che la cerca e giudica» (Vang.). E per bocca del salmista, Egli continua: « Giudicami, Signore, e discerni la mia causa da quella della gente empia: liberami dall’uomo iniquo ed ingannatore». Questo popolo «bugiardo» (Vang.) afferma Gesù, è il popolo Giudeo. « Liberami dai miei nemici, continua il Salmista; mi strapperai dalle mani dell’uomo iniquo » (Grad.). « Il Signore è giusto. Egli decapiterà i peccatori » (Tratto). Dio infatti, non permise agli uomini di mettere la mano su Gesù prima che la sua ora fosse giunta (Vang.) e quando l’ora dell’immolazione fu suonata, Egli strappò il Suo figlio dalle mani dei malvagi, risuscitandolo. Questa morte e questa resurrezione erano state annunciate dai Profeti ed Isacco ne era stato il simbolo, allorché, mentre per ordine di Dio, stava per essere immolato da Abramo, suo padre, fu salvato da Dio stesso e sostituito da un ariete, che rappresentava l’Agnello di Dio sacrificato per il genere umano (v. p. 288). Gesù doveva dunque nel Suo primo avvento essere umiliato e soffrire; soltanto dopo Egli apparirà in tutta la Sua potenza: ma i Giudei, accecati dalle passioni, non ammisero che una sola venuta: quella che deve prodursi nella gloria e, scandalizzati dalla Croce di Gesù, lo respinsero. Per questo motivo, Dio li respinse a sua volta, mentre accolse con benevolenza coloro che hanno poste le loro speranze nella redenzione di Gesù, ed uniscono le loro sofferenze alle Sue. « Giustamente e per ispirazione dello Spirito Santo, dice S. Leone, i SS. Apostoli hanno ordinato digiuni più austeri durante questi giorni; affinché, con una comune partecipazione alla Croce di Cristo, noi pure facciamo qualche cosa che ci unisca a quello che Egli ha fatto per noi. Come dice l’Apostolo S. Paolo: « Se soffriamo con Lui, saremo anche glorificati con Lui ». Certa e sicura è l’attesa della promessa beatitudine là dove vi è partecipazione alla passione del Signore (IV Lezione). — La Stazione si tiene nella Basilica di S. Pietro, innalzata sull’area dove prima sorgeva il Circo di Nerone, dove il Principe degli Apostoli morì, come il suo Maestro, sopra una Croce. – In ricordo della Passione di Gesù, di cui si avvicina l’anniversario, pensiamo che, per risentirne gli effetti benefici, bisogna, come il Divin Maestro, saper soffrire persecuzioni per la giustizia, E quando, membri della «famiglia di Dio », siamo perseguitati con e come Gesù Cristo, chiediamo a Dio che « custodisca i nostri corpi e le nostre anime » (Or.).
(Messale Romano di S. Bertola e G. Destefani, Comm. di D. G. LEFEBVRE O. S. B; L. I. C. E. – R. Berruti & C. Torino 1950)
# # #
Incipit
In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
Introitus
Ps XLII: 1-2.
Júdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab homine iníquo et dolóso éripe me: quia tu es Deus meus et fortitudo mea.
[Fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia causa da gente malvagia: líberami dall’uomo iniquo e fraudolento: poiché tu sei il mio Dio e la mia forza].
Ps XLII:3
Emítte lucem tuam et veritátem tuam: ipsa me de duxérunt et adduxérunt in montem sanctum tuum et in tabernácula tua.
[Manda la tua luce e la tua verità: esse mi guídino al tuo santo monte e ai tuoi tabernàcoli.]
Júdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab homine iníquo et dolóso éripe me: quia tu es Deus meus et fortitudo mea.
[Fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia causa da gente malvagia: líberami dall’uomo iniquo e fraudolento: poiché tu sei il mio Dio e la mia forza].
Oratio
Orémus.
Quæsumus, omnípotens Deus, familiam tuam propítius réspice: ut, te largiénte, regátur in córpore; et, te servánte, custodiátur in mente.
[Te ne preghiamo, o Dio onnipotente, guarda propízio alla tua famiglia, affinché per bontà tua sia ben guidata quanto al corpo, e per grazia tua sia ben custodita quanto all’ànima.]
Lectio
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Hebræos.
Hebr IX: 11-15
Fatres: Christus assístens Pontifex futurórum bonórum, per ámplius et perféctius tabernáculum non manufáctum, id est, non hujus creatiónis: neque per sánguinem hircórum aut vitulórum, sed per próprium sánguinem introívit semel in Sancta, ætérna redemptióne invénta. Si enim sanguis hircórum et taurórum, et cinis vítulæ aspérsus, inquinátos sanctíficat ad emundatiónem carnis: quanto magis sanguis Christi, qui per Spíritum Sanctum semetípsum óbtulit immaculátum Deo, emundábit consciéntiam nostram ab opéribus mórtuis, ad serviéndum Deo vivénti? Et ideo novi Testaménti mediátor est: ut, morte intercedénte, in redemptiónem eárum prævaricatiónum, quæ erant sub prióri Testaménto, repromissiónem accípiant, qui vocáti sunt ætérnæ hereditátis, in Christo Jesu, Dómino nostro.
“Fratelli: Cristo, essendo venuto come pontefice dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d’uomo, cioè non appartenente a questo mondo creato, e mediante non il sangue di capri e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, entrò una volta per sempre nel santuario, avendo procurato una redenzione eterna. Poiché se il sangue dei capri e dei tori e l’aspersione con cenere di giovenca santifica gli immondi rispetto alla mondezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mediante lo Spirito Santo, ha offerto se stesso immacolato a Dio, monderà la nostra coscienza dalle opere morte, perché serviamo al Dio vivente? E per questo Egli è il mediatore del nuovo testamento, affinché, essendo intervenuta la sua morte a redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo testamento, quelli che sono stati chiamati conseguono l’eterna eredità loro promessa, in Gesù Cristo Signor nostro”. (Ebr. IX, 11-15).
Ci avviciniamo ai grandi misteri della Settimana Santa. La Passione di N. S. Gesù Cristo e la nostra Redenzione — la Redenzione nostra per mezzo della Passione sua — mistero centrale della nostra fede. Il valore del sacrificio di N. S. per noi ce lo illumina S. Paolo nel passo dell’Epistola agli Ebrei che oggi la Chiesa ci fa leggere. Sono poche parole, misurate, contate, direbbe Dante, ciascuna delle quali ha il suo peso e merita la sua attenzione. Eccovele nel loro contesto. Se il sangue degli animali (nella vecchia Legge, nell’economia religiosa ch’essa rappresentava) santifica quelli che sono macchiati d’una purificazione carnale, quanto più non monderà la nostra coscienza il Sangue di Gesù Cristo, che per lo Spirito Santo offrì se stesso immacolato a Dio. Offrì Gesù se stesso. Il Suo fu un sacrificio volontario. Gesù ha voluto soffrire, ha voluto fare la volontà del Padre, fino alla morte; a costo della morte. Nessuno lo costrinse. Volle. Il profumo d’ogni nostro sacrificio, qualunque esso sia, per qualunque causa (buona, s’intende) sia fatto, è nella sua spontaneità. La bellezza di questo fiore che si chiama il sacrificio è in questa sua freschezza di volontà. « Oblatus est quia ipse votuit: » le parole profetiche di Gesù meravigliosamente si adempiono. Il Vangelo sottolinea questa bella libertà in Gesù, nei momenti in cui le apparenze di una violenza usatagli sono più accentuate: quando gli sgherri credono di essere venuti nel Getzemani a prenderlo di viva forza, quando Pilato crede di avere lui nella sua mano onnipotente di funzionario dell’Impero, la vita di Gesù. Libertà intiera, completa, profonda. E offrì se stesso. Ah fratelli miei! che differenza dai redentori o salvatori umani! e che rilievo ne ridonda per questo Salvatore Divino! Quanto è facile e frequente immolare gli altri: pagare con moneta altrui, versare l’altrui sangue! – Gesù ha versato il suo ed ha ardentemente desiderato si spargesse questo solo. Lo ha versato tutto. Il Suo sacrificio è stato un olocausto, senza riserva. La generosità della spontaneità si compie colla generosità, starei per dire, quantitativa del dono. Dà sempre molto chi dà tutto. E offrì se stesso immacolato. Senza macchia. Le vittime, simboliche, del V. T. vittime materiali dovevano essere materialmente così: pure senza macchia, senza macchia l’agnello senza difetto il bove. Gesù non ebbe peccati suoi da espiare; ed ecco perché ha potuto così largamente espiare i peccati altrui. Le sofferenze, anche del peccatore sono sante, sono, a lor modo, belle. Ma quel sacrifizio sa di espiazione personale. È una giustizia, non una generosità. Il martire delle cause più alte doveva essere purissimo, lo fu. Gesù è l’agnello immacolato. Ci ha tenuto in modo particolare. « Chi di voi potrà convincermi di colpa? » ha detto, ha gridato ai suoi avversari. E offrì, liberamente se stesso (generoso olocausto) immacolato a Dio per « Spiritum sanctum ». A Dio. La causa che Gesù è venuto a difendere, che ha difeso da buon soldato col valore e la morte, colla predicazione, la passione, col Vangelo, con la Croce, è la causa di Dio, la causa religiosa. Perché sulle rovine degli Dei falsi e bugiardi regnasse il Dio vero e vivo, perché sulle rovine della Sinagoga sorgesse la grande, universale Chiesa, per questo che significava la maggior gloria di Dio, la maggiore, la vera felicità del genere umano. Egli è caduto martire, Egli si è offerto vittima del più grande sacrificio del mondo.
[G. Semeria: Le Epistole delle Domeniche O. N. M.- d’I. Roma-Milano, 1939 – nihil obs. P. De Ambrogi – Imprim. P. Castiglioni vic. Gen. Cur. Arch.]
Graduale
Ps CXLII: 9, 10
Eripe me, Dómine, de inimícis meis: doce me fácere voluntátem tuam
[Liberami dai nemici, o Sognore: insegnami a fare la tua volontà]
Ps XVII: 48-49
Liberátor meus, Dómine, de géntibus iracúndis: ab insurgéntibus in me exaltábis me: a viro iníquo erípies me.
[Mi libererai dai nemici accaniti, o Signore: e mi eleverai sopra di quelli che si volgono contro di me: mi libererai dall’uomo iniquo]
Tractus
Ps CXXVIII: 1-4
Sæpe expugnavérunt me a juventúte mea.
[Mi hanno più volte osteggiato fin dalla mia giovinezza.]
Dicat nunc Israël: sæpe expugnavérunt me a juventúte mea.
[Lo dica Israele: mi hanno più volte osteggiato fin dalla mia giovinezza.]
Etenim non potuérunt mihi: supra dorsum meum fabricavérunt peccatóres.
[Ma non mi hanno vinto: i peccatori hanno fabbricato sopra le mie spalle.]
V. Prolongavérunt iniquitátes suas: Dóminus justus cóncidit cervíces peccatórum.
[Per lungo tempo mi hanno angariato: ma il Signore giusto schiaccerà i peccatori.]
Evangelium
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Joánnem.
Joann VIII: 46-59
“In illo témpore: Dicébat Jesus turbis Judæórum: Quis ex vobis árguet me de peccáto? Si veritátem dico vobis, quare non créditis mihi? Qui ex Deo est, verba Dei audit. Proptérea vos non audítis, quia ex Deo non estis. Respondérunt ergo Judæi et dixérunt ei: Nonne bene dícimus nos, quia Samaritánus es tu, et dæmónium habes? Respóndit Jesus: Ego dæmónium non hábeo, sed honorífico Patrem meum, et vos inhonorástis me. Ego autem non quæro glóriam meam: est, qui quærat et jdicet. Amen, amen, dico vobis: si quis sermónem meum serváverit, mortem non vidébit in ætérnum. Dixérunt ergo Judaei: Nunc cognóvimus, quia dæmónium habes. Abraham mórtuus est et Prophétæ; et tu dicis: Si quis sermónem meum serváverit, non gustábit mortem in ætérnum. Numquid tu major es patre nostro Abraham, qui mórtuus est? et Prophétæ mórtui sunt. Quem teípsum facis? Respóndit Jesus: Si ego glorífico meípsum, glória mea nihil est: est Pater meus, qui gloríficat me, quem vos dícitis, quia Deus vester est, et non cognovístis eum: ego autem novi eum: et si díxero, quia non scio eum, ero símilis vobis, mendax. Sed scio eum et sermónem ejus servo. Abraham pater vester exsultávit, ut vidéret diem meum: vidit, et gavísus est. Dixérunt ergo Judaei ad eum: Quinquagínta annos nondum habes, et Abraham vidísti? Dixit eis Jesus: Amen, amen, dico vobis, antequam Abraham fíeret, ego sum. Tulérunt ergo lápides, ut jácerent in eum: Jesus autem abscóndit se, et exívit de templo.” Laus tibi, Christe!
[“In quel tempo disse Gesù alla turbe dei Giudei ed ai principi dei Sacerdoti: Chi di voi mi convincerà di peccato. Se vi dico la verità, per qual cagione non mi credete? Chi è da Dio, le parole di Dio ascolta. Voi per questo non le ascoltate, perché non siete da Dio. Gli risposero però i Giudei, e dissero: Non diciamo noi con ragione, che sei un Samaritano e un indemoniato? Rispose Gesù: Io non sono un indemoniato, ma onoro il Padre mio, e voi mi avete vituperato. Ma io non mi prendo pensiero della mia gloria; vi ha chi cura ne prende, e faranno vendetta. In verità, in verità vi dico: Chi custodirà i miei insegnamenti, non vedrà morte in eterno. Gli dissero pertanto i Giudei: Adesso riconosciamo che tu sei un indemoniato. Abramo morì, e i profeti; e tu dici: Chi custodirà i miei insegnamenti, non gusterà morte in eterno. Sei tu forse da più del padre nostro Abramo, il quale morì? e i profeti morirono. Chi pretendi tu di essere? Rispose Gesù: Se io glorifico me stesso, la mia gloria è un niente; è il Padre mio quello che mi glorifica, il quale voi dite che è vostro Dio. Ma non l’avete conosciuto: io sì, che lo conosco; e se dicessi che non lo conosco, sarei bugiardo come voi! Ma io conosco, o osservo le sue parole. Abramo, il padre vostro, sospirò di vedere questo mio giorno: lo vide, e ne tripudiò. Gli dissero però i Giudei: Tu non hai ancora cinquant’anni, e hai veduto Abramo? Disse loro Gesù: In verità, in verità vi dico: prima che fosse fatto Abramo, io sono. Diedero perciò di piglio a de’ sassi per tirarglieli: ma Gesù si nascose, e uscì dal tempio” (Jo. VIII, 46 59)].
Omelia
[Discorsi di San G. B. M. VIANNEY CURATO D’ARS . VOL. II, IV ed. Torino-Roma, C. ed. Marietti, 1933]
Sulla Contrizione.
Vaæ mihi, quia peccavi nimis in vita mea.
Guai a me, perché ho peccato molto nella vita mia.
(Dalle Confes. de S. Agostino, lib. II, c. 10.)
Questo era, fratelli miei, il linguaggio di San Agostino quando ricordava gli anni della sua vita, durante i quali era sprofondato con tanto furore nelle vita infame dell’impurità. « Ah! Guai a me perché ho peccato molto nei giorni della vita mia! » Ed ogni volta che gli veniva questo pensiero, si sentiva il cuore lacerato e distrutto dal rimpianto. « O DIO mio! – esclamava – una vita passata senza amarvi! O DIO mio, quanti anni perduti! Ah! Signore, degnatevi, vi scongiuro di non ricordarvi più delle mie colpe passate! » Ah! lacrime preziose, ah! rimorsi salutari che d’un gran peccatore, hanno fatto un grande santo. Oh! Un cuore distrutto dal dolore ha riguadagnato ben presto l’amicizia del suo DIO! Ah! piacque a Dio che ogni qualvolta rimettiamo i nostri peccati davanti agli occhi, noi possiamo dire, come con lo stesso rimorso di San Agostino: Ah! Guai a me perché ho molto peccato durante gli anni della mia vita! DIO mio, usatemi misericordia! Oh! Le nostre lacrime subito coleranno e la nostra vita non sembrerà più la stessa! Sì, fratelli miei, conveniamo tutti, quanti siamo, con dolore e sincerità, che siamo dei criminali degni di portare tutta la collera di un DIO giustamente irritato dai nostri peccati, che forse sono più numerosi dei capelli della nostra testa. Ma benediciamo sempre la misericordia di DIO che ci apre nei suoi tesori una risorsa ai nostri malanni! Sì, fratelli miei, benché grandi siano i nostri peccati, occorre che il nostro rimorso racchiuda quattro qualità: 1° bisogna che il peccatore odi e detesti sinceramente i suoi peccati con la contrizione; 2° che abbia concepito un fermo proposito di non ricadervi più; 3° che ne faccia un’umile dichiarazione al ministro del Signore; e 4° che ripari, per quanto può, l’ingiuria fatta a DIO ed il torto al prossimo.
I. Per farvi comprendere ciò che è la contrizione, cioè il dolore che dobbiamo avere dei nostri peccati, bisognerebbe poter farvi conoscere, da un lato, l’orrore che ne ha DIO ha in se stesso, i tormenti che ha sofferto per noi per ottenerne il perdono presso il Padre; e dall’altra i beni che perdiamo peccando ed i mali che ci attiriamo per l’altra vita, e questo non sarà mai dato all’uomo comprenderlo. Dove devo condurvi, fratelli miei, per farvelo comprendere? Forse in fondo al deserto, dove grandi santi vi hanno passato venti, trenta, quaranta, cinquanta ed anche ottanta anni a piangere delle colpe che secondo il mondo non sono colpe? Ah! No, no, il vostro cuore non sarebbe ancora toccato. Forse alla porta dell’inferno per ascoltare le grida, le urla ed i digrignamenti dei denti causati dal solo rimorso del loro peccato? Ah! dolore amaro, ma dolore e rimorso infruttuoso ed inutile! Ah! No, fratelli miei, non è ancor là ove imparerete a piangere i vostri peccati con il dolore ed il rimorso che dovete averne! Ah! Ma è ai piedi di questa croce ancora tinta del sangue prezioso di un DIO che non lo ha sparso se non per cancellare i nostri peccati. Ah! se mi fosse permesso di condurvi in questo giardino di dolori dove un DIO uguale a suo Padre piange i nostri peccati, non con lacrime ordinarie, ma con tutto il suo sangue che imporpora tutti i pori del suo corpo, ed ove il suo dolore fu sì violento da gettarlo in una agonia che sembra togliergli la vita e distruggergli il cuore. Ah! se potessi condurvi alla sua sequela, mostrarlo caricato della sua croce nelle vie di Gerusalemme: tanti passi, altrettante cadute, e tante volte rialzato a pedate! Ah! se potessi farvi avvicinare a questo Calvario dove un DIO muore piangendo i nostri peccati! Ah! diremmo ancora: bisognerebbe che DIO ci donasse questo amore ardente del quale aveva infiammato il cuore del grande Bernardo al quale la sola vista della croce faceva versare lacrime con tanta abbondanza! Ah! bella e preziosa contrizione! Felice è colui che la possiede! Ma a chi sto per parlarne, chi è colui che la racchiude nel suo cuore? Ahimè! Io non lo so! Sarebbe a questo peccatore indurito che forse da venticinque, trenta anni, ha abbandonato il suo DIO e la sua anima. Ah! no, no, sarebbe fare come chi vorrebbe ammorbidire una roccia gettandovi sopra acqua, mentre non farebbe che indurirla ancor più. Sarebbe a questo Cristiano che ha disprezzato missioni, ritiri e giubilei e tutte le istruzioni dei suoi pastori? Ah! no, no, sarebbe come voler riscaldare dell’acqua mettendola nel ghiaccio. Sarebbe a queste persone che si contentano di fare le loro pasque continuando il loro genere di vita, che tutti gli anni hanno sempre gli stessi peccati da raccontare? Ah! no, no, queste sono delle vittime che la collera di DIO ingrassa per servire da alimenti alle fiamme eterne. Ah! diciamo meglio, essi sono simili a criminali che hanno gli occhi bendati e che, aspettando di essere giustiziati, si danno a tutto ciò che il loro cuore corrotto può desiderare. Sarebbe ancora a questi Cristiani che si confessano ogni tre settimane od ogni mese, e che ogni giorno ricadono? Ah! no, questi sono dei ciechi che non sanno né quel che fanno, né ciò che devono fare. A chi dunque potrei indirizzare la parola? Ahimè, io non saprei … o DIO mio! dove bisogna andare per trovarla, a chi farla domandare? Ah! Signore, io so essa da dove viene e chi la dà; essa viene dal cielo e siete Voi che la date. O mio DIO! Dateci, se vi piace, questa contrizione che distrugge e divora i nostri cuori. Ah! questa bella contrizione che disarma la giustizia di DIO, che… eternità dannata in una eternità felice! Ah! Signore, non rifiutateci questa contrizione che ci rende prontamente l’amicizia di DIO! Ah! bella virtù, quanto sei necessaria, ma come sei rara! Tuttavia, senza di essa, non c’è perdono, senza di essa, non c’è il cielo; diciamo di più, senza di essa, per noi tutto è perduto, penitenze, carità, elemosine e tutto ciò che possiamo fare. Ma pensate in voi stessi, cosa vuol dire tutto questo, cos’è questa parola “contrizione”, e se forse necessita il conoscere se la si abbia? – Amico mio, desiderate saperlo? Eccolo. Ascoltatemi un momento: andate a vedere se l’avete oppure no, ed in seguito il mezzo per averla. Entriamo in un semplice dettaglio: se voi mi chiedete: che cos’è la contrizione? Io vi direi che è un dolore dell’anima ed un detestare i peccati commessi con una risoluzione ferma di non ricadervi più. Sì, fratelli miei, questa disposizione è la più necessaria di tutte quelle che DIO domanda onde perdonare il peccato; non solo essa è necessaria, ma aggiungo ancora che nulla può dispensarcene. Una malattia che ci toglie l’uso della parola può dispensarci dalla Confessione, una morte rapida può dispensarci dalla soddisfazione, almeno in questa vita; ma non è lo stesso per la contrizione; senza di essa è impossibile, assolutamente impossibile ottenere il perdono dei propri peccati. Sì, fratelli miei, noi possiamo dire gemendo che è questo difetto di contrizione che è la causa di un numero infinito di Confessioni e Comunioni sacrileghe; ma ciò che ancora è più deplorevole e che non ce ne si accorge quasi mai, e che si vive e si muore in questo miserevole stato. Sì, fratelli miei, nulla di più facile da comprendere. Se abbiamo avuto la sventura di cadere in peccato nelle nostre confessioni, questo crimine è continuamente davanti agli occhi come un mostro che sembra divorarci, cosa che fa che sia ben raro che ce ne scarichiamo una volta o l’altra. Ma per la contrizione, non è lo stesso; noi ci confessiamo, il nostro cuore non è per niente nell’accusa che facciamo dei nostri peccati, riceviamo l’assoluzione, ci avviciniamo alla santa mensa con un cuore freddo, ben insensibile, indifferente come se venissimo a fare la recita di una storia; andiamo di giorno in giorno, di anno in anno, infine arriviamo alla morte e crediamo di aver fatto un qualche bene; noi non troviamo e non vediamo che crimini ed i sacrilegi che le nostre Confessioni hanno partorito. O DIO mio! Quante cattive Confessioni per difetto di contrizione! O DIO mio, quanti Cristiani che nell’ora della morte non trovano che confessioni indegne. Ma non andiamo oltre, temo di turbarvi; io dico turbarvi. Ah! È ben al presente che bisognerebbe portarvi a due dita di disperazione affinché, colpiti dal Vostro stato, possiate ripararlo senza aspettare il momento in cui lo conoscerete senza poter riparare. Ma veniamo, fratelli miei, alla spiegazione e vedrete se, ogni qual volta vi siete confessati, avete avuto il dolore necessario, assolutamente necessario per avere la speranza che i vostri peccati siano perdonati. Io dico 1° la contrizione è un dolore dell’anima. Bisogna necessariamente che il peccatore pianga i suoi peccati o in questo mondo o nell’altro. In questo mondo voi potete cancellarli con il rimorso che ne sentite, ma non nell’altro. O quanti di noi dovremo essere riconoscenti alla bontà di DIO di questo! In luogo dei rimorsi eterni e dei dolori i più laceranti che meritiamo di soffrire nell’altra vita, cioè nell’inferno, DIO si contenta solamente che i nostri cuori siano toccati da un vero dolore, seguito poi da una gioia eterna! O DIO mio! Voi vi contentate di ben poca cosa!
1° io dico che questo dolore deve avere quattro qualità, se ne manca una sola, noi non possiamo ottenere il perdono dei nostri peccati. La sua prima qualità: deve essere interiore, cioè venire da profondo del cuore. Essa non consiste dunque nelle lacrime, anche se esse sono buone ed utili, è vero; ma non sono necessarie. In effetti, quando San Paolo ed il buon ladrone si sono convertiti, non è detto che essi abbiano pianto, ed il loro dolore è stato sincero. No. fratelli miei, non è sulle lacrime che bisogna contare: esse sono spesso ingannevoli, molte persone piangono nel tribunale della penitenza e poi ricadono alla prima occasione. Ma il dolore che DIO richiede da noi eccolo! Ascoltate ciò che dice il Profeta Gioele: « Avete il dolore del peccato? Ah! figli miei, distruggete e lacerate il vostro cuore con i rimorsi! » – « Se avete perso il Signore con i vostri peccati, ci dice Mosè, cercatelo con tutto il vostro cuore nell’afflizione e nell’amarezza del vostro cuore. » Perché, fratelli miei, DIO vuole che il nostro cuore si penta? Non è il cuore nostro che ha peccato: è dal nostro cuore, dice il Signore, che sono nati tutti questi cattivi pensieri, questi desideri cattivi; bisogna dunque che assolutamente che se il nostro cuore ha fatto il male, si penta, altrimenti DIO non ci perdonerà mai.
2° Io dico che bisogna che il dolore che dobbiamo sentire per i nostri peccati sia soprannaturale, cioè che sia lo Spirito Santo che lo ecciti in noi, e non delle cause naturali. Distinguo: essere afflitti per aver commesso un tal peccato perché ci esclude dal Paradiso e merita l’inferno; questi motivi sono sovrannaturali, è lo Spirito Santo che ne è l’autore; questo può condurci ad una vera contrizione. Ma affliggersi a causa della vergogna che il peccato necessariamente genera in sé, come i mali che esso ci attira, come la vergogna di una fanciulla che ha perso la sua reputazione, o di un’altra persona che è stata sorpresa a derubare il suo vicino; tutto questo non è che un dolore puramente naturale che non ci merita il perdono. Da qui è facile concepire che il dolore dei nostri peccati, il pentimento dei nostri peccati, possono venire o dall’amore che abbiamo per Dio, o dal timore dei castighi. Colui che nel suo pentimento non considera che DIO, ha una contrizione perfetta, condizione così eminente da purificare il peccatore da se stessa ancor prima di aver ricevuto la grazia dell’assoluzione, qualora sia nella disposizione di riceverla appena può. Ma per colui che non ha il pentimento dei propri peccati se non per i castighi che i suoi peccati gli attirano, ha solo una contrizione imperfetta che non lo giustifica, ma solo lo dispone a ricevere la sua giustificazione nel Sacramento della Penitenza.
Terza condizione della contrizione: essa deve essere sovrana, vale a dire la più grande di tutti i dolori, più grande, direi, di quella che noi proviamo alla perdita dei nostri genitori e della nostra salute, e generalmente di tutto ciò che abbiamo di più caro al mondo. Se dopo aver peccato, non avete questo intenso rimorso, tremate per le vostre confessioni. Ahimè! Quante volte per la Perdita di un oggetto di nove o dieci soldi, si piange, ci si tormenta tanti giorni, fino a non voler mangiare … Ahimè, e per i peccati, e spesso per peccati mortali non si verserà né una lacrima né si emetterà un sospiro. O DIO mio, l’uomo conosce poco quel che fa peccando! – Ma perché, direte, il nostro dolore deve essere così grande? – Amico mio, eccone il motivo: essa deve essere proporzionata alla grandezza della perdita che noi attuiamo ed alla rovina in cui ci conduce il peccato. Pertanto, giudicate quale deve essere il dolore, dal momento che il peccato ci fa perdere il cielo con tutte le sue dolcezza. Ah! Cosa dico? Ci fa perdere il nostro DIO con tutte le sue amicizie e ci precipita nell’inferno che è la più grande di tutte le sventure! Ma voi pensate, come si può dunque riconoscere se questa contrizione vera sia in noi? È cosa molto facile. Se veramente l’avete, voi non agirete, non penserete come in precedenza, essa avrà cambiato totalmente la vostra maniera di vivere: odierete ciò che avete amato, ed amerete ciò che avete fuggito e disprezzato; vale a dire voi avete confessato di avere avuto dell’orgoglio nelle vostre azioni e nelle vostre parole, bisogna ora che facciate comparire in voi una bontà, una carità per tutti. Non occorre che siate voi a giudicare se avete fatto una buona Confessione, perché potreste facilmente ingannarvi; ma occorre che le persone che vi hanno visto o inteso prima della vostra confessione, possano dire: non è più lo stesso; è avvenuto in lui un grande cambiamento. Ahimè! DIO mio! Dove sono queste confessioni che operano questo bene così grande? Oh! Quanto sono rare; ma lo sono pure quelle che sono fatte con tutte le disposizioni che DIO richiede! Confessiamolo, fratelli miei, a nostra confusione, che se sembriamo così poco toccati, questo non può che venire che dalla nostra poca fede e dal nostro poco amore che abbiamo per DIO. Ah! se abbiamo la fortuna di comprendere quanto DIO sia buono e quanto il peccato sia enorme, e quanto nera è la nostra ingratitudine nell’oltraggiare un Padre così buono, ah! senza dubbio sembreremmo afflitti ben altrimenti di come non lo siamo. Ma, voi direte, io vedrò di averla, questa contrizione quando mi confesso e non posso averla. Ma è ciò che ho detto all’inizio? Non vi ho già detto che essa viene dal cielo, e che è a DIO che bisogna chiederla? Cosa hanno fatto i santi, amico mio, per meritare questa felicità di piangere i loro peccati? Essi l’hanno chiesta a Dio con il digiuno, la preghiera, con ogni tipo di penitenza e di opere buone, poiché non dovete contare affatto sulle vostre lacrime. Io vado a provarvelo: aprite i libri santi e ne sarete convinti. Vedete Antioco, quanto piange, quanto chiede misericordia, tuttavia lo Spirito Santo ci dice che piangendo, egli discese all’inferno. Vedete Giuda, egli ha concepito un sì grande dolore del suo peccato, lo piange con tale abbondanza che finisce per perdersi. Vedete Saul, egli lancia le sue gride dolenti per aver avuto la disgrazia di disprezzare il Signore, tuttavia egli è nell’inferno. Vedete Caino, le lacrime che versa dopo aver peccato, tuttavia egli brucia. Chi di noi, fratelli miei, che avrebbe visto scendere tutte le sue lacrime e pentirsi, non avrebbe creduto che il buon Dio non gli avesse perdonato; tuttavia nessuno di essi ne è perdonato; ecco che Davide invece, appena ebbe detto: « Io ho peccato; » subito il suo peccato gli fu rimesso. – E perché questo, voi direte? Perché questa differenza, i primi non furono perdonati, mentre Davide lo è? – Amico mio eccolo. È per il fatto che i primi non si pentono e non detestano i loro peccati se non a causa dei castighi e dell’infamia che il peccato produce necessariamente con sé, e non in rapporto a Dio; invece Davide pianse i suoi peccati non a causa dei castighi che il Signore stava per fargli subire, ma alla vista degli oltraggi che i suoi peccati avevano fatto a Dio. Il suo dolore fu così vivo e sincero che Dio non gli poté rifiutare il suo perdono. Avete chiesto a Dio la contrizione prima di confessarvi? Ahimè, forse non lo avete fatto mai. Ah! tremate per le vostre confessioni; ah! quanti sacrilegi, DIO mio! Quanti Cristiani dannati!
4° Essa deve essere universale. Nella vita dei Santi è riportato, sul soggetto del dolore universale che noi dobbiamo avere dei nostri peccati, che se non li detestiamo tutti, non saranno perdonati né gli uni, né gli altri. Si riporta che San Sebastiano, stante a Roma e facendo dei miracoli i più strepitosi che riempivano di ammirazione, il governatore Cromo che, in questo tempo era gravato da infermità, desiderò ardentemente di vederlo, per chiedergli la guarigione dai suoi mali. Quando il Santo fu davanti a lui: è da molto tempo che gemo, coperto di piaghe, senza aver trovato un uomo al mondo capace di liberarmi; corre voce che voi ottenete tutto ciò che volete dal vostro DIO, se volete domandargli la mia guarigione, io vi prometto che mi farò Cristiano. Ebbene! gli dice il Santo, se voi siete in questa determinazione, io vi prometto da parte del DIO che io adoro, che è il Creatore del cielo e della terra, che dal momento che avrete distrutto tutti i vostri idoli, sarete perfettamente guarito. Il governatore gli dice: non solo io sono pronto a fare questo sacrificio, ma ancor di più se è necessario. Essendosi separati l’uno dall’altro, il governatore cominciò a distruggere i suoi idoli; l’ultimo che prese per eliminarlo, gli sembrò così rispettabile che non ebbe il coraggio di distruggerlo, e si persuase che questa riserva non impedisse la sua guarigione. Ma permanendo i suoi dolori più violenti che mai, andò a trovare il Santo facendogli i rimproveri più obbrobriosi perché, dopo aver distrutto i suoi idoli, come aveva comandato, ben lungi dal guarire, soffriva ancor di più. Ma, gli disse il Santo, li avete distrutti tutti senza riservarne alcuno? Allora egli lo prende e lo distrugge, e nello stesso istante fu guarito. Ecco, fratelli cari, un esempio che ci illumina sulla condotta di un numero pressoché infinito che si pentono di certi peccati e non di tutti e che, similmente a questo governatore, ben lungi dal guarire le piaghe che il peccato ha fatto alla loro povera anima, ne fanno di più profonde; e fintanto che non avranno fatto come lui, distrutto questo ultimo idolo, vale a dire infranto questa abitudine a certi peccati, finché non avranno lasciato questa cattiva compagnia, questo orgoglio, questo desiderio di piacere, questo attaccamento ai beni della terra, tutte le loro confessioni non faranno che aggiungere crimini su crimini, sacrilegi a sacrilegi. Ah! DIO mio, che orrore e che abominio! Ed in questo stato essi vivono tranquilli, mentre il demonio riserva loro un posto nell’inferno. Noi leggiamo nella storia un esempio che ci mostra quanto i Santi riguardassero questo dolore dei nostri peccati come necessario per ottenere il loro perdono. Essendosi un ufficiale del Papa ammalato, il Santo Padre che molto lo stimava per la sua virtù e santità, gli inviò uno dei suoi cardinali per testimoniargli il dolore che gli causava la sua malattia e nello stesso tempo applicargli le indulgenze plenarie. Ahimè, dice il morente al cardinale, riferite al Santo Padre che io gli sono infinitamente riconoscente per la tenerezza del suo cuore verso di me, ma ditegli pure che io sarei infinitamente più felice se egli volesse domandare a DIO per me la contrizione dei miei peccati. Ahimè esclamò, a cosa mi servirà tutto questo se il mio cuore non si lacera e si distrugge dal dolore di avere offeso un DIO così buono! O mio DIO! … Gridò questo povero morente, fate, se possibile, che il dolore dei miei peccati eguagli gli oltraggi che vi ho fatto! … Oh! Fratelli miei, quanto questi dolori sono rari, ed ahimè quanto rare sono le buone confessioni. Sì, fratelli miei, un Cristiano che ha peccato e che vuol ottenerne il perdono deve essere nella disposizione di soffrire le crudeltà più atroci, piuttosto che ricadere nei peccati che sta per confessare. 1° Io cerco di provarvelo con un esempio, e se, dopo esserci confessati, noi non siamo in queste disposizioni, nessun perdono … Leggiamo nella storia del quarto secolo che Sapore, imperatore dei Persiano, divenuto il più crudele nemico dei Cristiani, ordinò che tutti i sacerdoti che non adoravano il sole e non lo riconoscessero come Dio, sarebbero stati messi a morte. Il primo che fece prendere fu l’Arcivescovo di Seleucia, che era San Simone. Iniziò col provare a sedurlo con ogni tipo di promesse. Non potendo cavarne nulla, nella speranza di convincerlo, gli mostrò tutti i tormenti che la sua crudeltà aveva potuto inventare per far soffrire i Cristiani, dicendogli che se la sua ostinazione gli faceva rifiutare qual che egli comandava, l’avrebbe fatto passare per sì atroci e rigorosi tormenti onde farlo obbedire, e per di più avrebbe eliminato tutti i sacerdoti ed i Cristiani del suo regno. Ma vedendolo così fermo come una roccia in mezzo ai mari battuti dalle tempeste, lo fece condurre in prigione nella speranza che il pensiero dei tormenti che gli venivano preparati, gli avrebbero fatto cambiare sentimento. Lungo il cammino egli incontrò un vecchio eunuco che era sovrintendente del palazzo imperiale. Costui, preso da compassione nel vedere un santo Vescovo trattato tanto indegnamente, si prosternò davanti a lui per testimoniargli il rispetto per lui di cui era pieno. Ma il Vescovo, ben lungi dal sembrare sensibile alla testimonianza rispettosa di questo eunuco, si voltò dall’altra parte per rimproverargli il crimine della sua apostasia, perché un tempo egli era Cristiano e Cattolico. A questo rimprovero che non si aspettava, egli fu così sensibile, gli penetrò s’ vivamente il cuore che nello stesso istante non fu più padrone delle sue lacrime, né dei suoi singhiozzi. Il crimine della sua apostasia gli sembrò così odioso, che dismise gli abiti bianchi di cui era rivestito e ne prese dei neri, corse come un disperato a gettarsi fuori dalla porta del palazzo e là darsi a tutti i rimorsi e ad dolore più lacerante. Ah! disgraziato, cosa stai per fare? Ahimè! Quali castighi devi aspettarti da Gesù-Cristo al quale hai rinunciato, se questo è stato così sensibile al rimprovero di un Vescovo che non è che il ministro di Colui che hai così ignominiosamente tradito … Ma l’imperatore avendo appreso tutto quel che succedeva, stupefatto da questo spettacolo, gli domandò: « Qual è la causa dunque del tuo dolore e di tante lacrime? » – Ah! piuttosto a Dio, egli esclamò, che tutte le disgrazie ed i malanni del mondo mi fossero tutti addosso, piuttosto ciò che è la causa del mio dolore. Ah! io piango per il fatto che non sia morto. Ah! potrò ancora guardare il sole che ho la sventura di adorare, temendo di dispiacervi. – L’imperatore che lo amava a causa della sua fedeltà, tentò se potesse convincerlo promettendogli ogni sorta di beni e favori. – Ah! no, no, gridò; Ah! sarò molto felice se posso con la mia morte riparare agli oltraggi che ho fatto a Dio, e ritrovare il cielo che ho perduto. O DIO mio e mio Salvatore, abbiate ancora pietà di me! Ah! se almeno avessi mille vite da darvi per testimoniarvi il mio rimorso ed il mio ritorno. – L’imperatore che sentì il linguaggio che teneva, moriva di rabbia e, disperando di non poterlo convincere, lo condannò a morire tra i supplizi. Ascoltatelo, andando al supplizio: « Ah! Signore, quale felicità morire pere voi; sì, DIO mio, se ho avuto la sventura di rinunciare a voi, almeno avrò la felicità di dare la mia vita per voi. » Ah! dolore sincero, dolore possente, che gli aveva tanto prontamente riguadagnato l’amicizia del mio DIO! … Leggiamo nella vita di Santa Margherita, che ebbe un sì grande dolore di un peccato che aveva commesso in gioventù, che ne pianse tutta a vita: essendo vicino alla morte, le si domandò quale fosse il peccato che aveva commesso e le aveva fatto versare tante lacrime. « Ahimè! Esclamò ella piangendo, come non potrei io piangere! All’età di cinque o sei anni, ebbi la sventura di dire una bugia a mio padre. » Ma, le si disse, non c’era tanto di che piangere. « Ah! tenermi un simile linguaggio! Voi dunque non avete mai concepito ciò che è il peccato, l’oltraggio che si fa a DIO e i malanni che ci attira? » Ahimè, fratelli miei, cosa sarà per noi, se tanti Santi hanno fatto sentire i loro gemiti alle rocce ed ai deserti, hanno formato per così dire dei fiumi con le loro lacrime per peccati di cui noi ci facciamo gioco, mentre noi abbiamo commesso dei peccati mortali forse più numerosi dei capelli della nostra testa. E non una lacrima di dolore e pentimento! Ah! triste accecamento a cui ci hanno condotto i nostri peccati. – Noi leggiamo nella vita dei Padri del deserto, che un ladro chiamato Gionata, perseguito dalla giustizia, corse a nascondersi nei pressi della colonna di San Simeone Stilita, sperando che il rispetto che si teneva per il santo, gli garantisse lo sfuggire alla morte. In effetti nessuno osò toccarlo; essendosi il Santo posto in preghiera per chiedere a Dio la sua conversione, nel momento stesso, risentì di un dolore sì vivo dei suoi peccati che per giorni e notti non fece che piangere. Il Santo gli disse: « Amico mio, tornate nel mondo a ricominciare con i vostri disordini. » – Ah! DIO mi preservi da questo malanno; io vi domando che fare per andarmene in cielo; io ho visto Gesù Cristo che mi ha detto che tutti i miei peccati mi erano perdonati dal gran dolore che ne ho sentito. – « Andate, figlio mio, gli dice il Santo; andate a cantare nel cielo le grandi misericordie di Dio per voi. » In questo momento egli cade morto, ed il Santo riporta egli stesso che vide Gesù-Cristo che conduceva la sua anima al cielo. O morte bella e preziosa, il morire con il dolore di avere offeso DIO! Ah! se almeno noi non moriamo di dolore come questi grandi penitenti, vogliamo fratelli miei, eccitarci ad una vera contrizione, imitiamo questa santo Vescovo morto ultimamente, che ogni volta che si presentava al tribunale delle penitenza per avere un vivo dolore dei propri peccati, faceva tre stazioni. La prima in inferno, la seconda in cielo, la terza sul Calvario. Dapprima portava il suo pensiero in questi luoghi di orrore e di tormento, e figurava di vedere i dannati che vomitavano torrenti di fiamme dalla bocca, che urlavano divorandosi gli uni con gli altri; questo pensiero gli ghiacciava il sangue nelle vene, e credeva di non poter più vivere alla vista di un tale spettacolo, soprattutto considerando che i suoi peccati avevano varie volte meritato questi supplizi. Da qui il suo spirito si portava nel cielo e faceva la rivista di tutti questi troni di gloria sui quali erano seduti i beati, e si rappresentava le lacrime che essi avevano sparso e le penitenze che avevano fatto durante la loro vita per peccati così leggeri e che egli stesso aveva commesso tante volte senza far nulla per espiarli, cosa che faceva piombare in una tristezza così profonda che sembrava che le sue lacrime non potevano asciugarsi. Non contento di tutto ciò dirigeva i suoi passi sul luogo del Calvario e là, man mano che i suoi sguardi si avvicinavano alla croce, ove un DIO era morte per lui, le forze gli mancavano, restava immobile alla vista delle sofferenze che i suoi peccati avevano causato al suo DIO. In ogni istante lo si sentiva ripetere queste parole con dei singhiozzi: « DIO mio, DIO mio, posso mai vivere ancora considerando gli orrori che i miei peccati vi hanno causato? » Ecco, fratelli miei, ciò che possiamo chiamare una vera contrizione, perché vediamo che egli non considerava i suoi peccati che in rapporto a DIO.
II. — Abbiamo detto che una vera contrizione deve racchiudere un buon proposito, cioè una ferma risoluzione di non peccare più per l’avvenire; occorre che la nostra volontà sia determinata e non ci sia il benché minimo desiderio di non correggersi; non si otterrà mai il perdono dei propri peccati se non vi si rinunzia con tutto il cuore. Noi dobbiamo essere nello stesso sentimento del santo Re-Profeta: « sì, DIO mio, io vi ho promesso di essere fedele nell’osservare i vostri comandamenti: e vi sarò fedele con il soccorso della vostra grazia. » Il Signore stesso ci dice: « Che l’empio lasci la via delle sue iniquità ed il suo peccato gli sarà rimesso. » Non c’è da sperare misericordia che per colui solo che rinunci ai suoi peccati di tutto cuore e per sempre, perché DIO non ci perdona fintanto ché il nostro pentimento non sia sincero e facciamo tutti gli sforzi per non ricadervi. Sarebbe infatti beffarsi di DIO il domandargli perdono per un peccato che ancora si vorrebbe commettere. – Ma, voi mi direte, come si può distinguere un fermo proposito da un desiderio debole ed insufficiente? Se desiderate saperlo, fratelli miei, ascoltatemi un istante e vado a dimostrarvelo: questo si può conoscere in tre maniere: 1° il cambiamento di vita; 2° la fuga dalle occasioni prossime del peccato, e 3° il lavorare con tutto ciò che si può per correggere e distruggere le proprie cattive abitudini. Dico innanzitutto che il primo risultato di un buon proposito, è il cambiamento della vita; è questo che ce lo mostra con maggior sicurezza ed è meno soggetto ad ingannarci. Veniamo ad una spiegazione: una madre di famiglia si accuserà di essersi spesso rivoltata contro i suoi figli o suo marito; dopo la sua confessione, andate a visitarla all’interno del suo focolare domestico: non c’è più traccia di ribellione, né di maledizioni; al contrario vedete in ella questa dolcezza, questa bontà, il darsi pensiero anche per i propri inferiori; le croci, i dispiaceri e le perdite non le fanno perdere la pace dell’anima. E sapete perché ciò, fratelli miei? Eccolo: perché il suo ritorno a Dio è stato sincero, la sua contrizione perfetta e di conseguenza ella ha ricevuto veramente il perdono dei suoi peccati; infine, la grazia ha preso delle radici profonde nel suo cuore ed ella ne trae frutti in abbondanza una giovane donna verrà ad accusarsi di aver seguito i piaceri del mondo, le danze, le veglie serali ed altre cattive compagnie. Dopo la sua confessione, se questa è ben fatta, andate a cercarla in questa serata, a richiederla in queste occasioni di piacere e che cosa vi si dirà? « Da un po’ di tempo non la vediamo più; io credo che se volete trovarla. Bisogna andare in chiesa, o a casa dei genitori. » In effetti, se andate dai suoi genitori, la troverete e di cosa si occupa? Parlare di vanità come un tempo o a rimirarsi davanti ad uno specchio, o a folleggiare con altri giovani? Ah! No! Fratelli miei, non sono più qui il suo operato, ella ha calpestato tutto ciò; voi la vedrete fare una lettura di pietà, aiutare sua madre nella conduzione delle faccende di casa, istruire i suoi fratelli e sorelle verso l’obbedienza e la premura verso i genitori; ella amerà la loro compagnia. Se non la trovate a casa, allora è in chiesa, la vedrete testimoniare a DIO la sua riconoscenza per aver operato in ella un sì gran cambiamento: vedrete in ella quella modestia, questo ritiro, questa premura per tutti, sia per i poveri che per i ricchi; la modestia si dipinge sulla sua fronte, la sola sua presenza vi porta a DIO. E perché questo, fratelli miei – mi direte – tanti beni vi sono in ella? Perché, fratelli miei, il suo dolore è stato sincero ed ella ha ricevuto veramente il perdono dei suoi peccati. – Altra volta sarà un giovanotto che sta per accusarsi di essere stato nelle bettole e nei giochi; ora che egli ha promesso a Dio di lasciare quel che a Lui potrebbe dispiacergli, mentre prima amava le bettole ed i giochi, ora invece li rifugge. Prima della sua confessione il suo cuore non era occupato che da cose terrene, cattive; al presente i suoi pensieri non sono che per DIO, ed il disprezzo per le cose del mondo. Tutto il suo piacere è intrattenersi con il suo DIO e pensare ai mezzi per salvare la propria anima. Ecco, fratelli cari, i segni di una vera e sincera contrizione; se dopo la vostra confessione, sarete così, potrete sperare che la vostra confessione sia stata buona ed i vostri peccati perdonati. Ma se fate tutto il contrario di ciò che vi ho appena detto; se qualche giorno dopo le confessioni si vede questa giovane che aveva promesso a DIO di lasciare il mondo ed i suoi piaceri per non dedicarsi che a piacergli, se la vedo, come prima, in questi ritrovi mondani; se vedo questa madre maldisposta e negligente verso i suoi figli ed i domestici, e litigiosa con i vicini come prima della confessione; se io ritrovo questo giovanotto di nuovo ai giochi ed alle bettole, o orrore! O abominio! O mostro di ingratitudine che sei! O DIO grande! In quale stato è questa povera anima! O orrore! O sacrilegio! I tormenti dell’inferno saranno lunghi e rigorosi per punire un tale attentato.
2° Diciamo che il secondo risultato di una vera contrizione è la fuga dalle occasioni prossime del peccato. Ve ne sono di due tipi: gli uni vi portano per se stessi, come sono i libri cattivi, le commedie, i balli, le danze, le pitture, i quadri o le canzoni disoneste, e la frequentazione di persone di sesso differente; le altre sono occasione di peccato per le cattive disposizioni di coloro che vi sono: come i cabarettisti, i mercanti che ingannano o vendono nelle domeniche; una persona in un impiego che non compie i suoi doveri sia per rispetto umano sia per ignoranza. Che deve fare una persona che si trova in una di queste posizioni? Eccolo: ella deve lasciare tutto, a qualunque costo, senza salutare nemmeno. Gesù-Cristo ci ha detto che se il nostro occhio o la nostra mano ci scandalizza, dobbiamo strapparli e gettare lontano da noi, perché – ci dice – è molto meglio andare in cielo con un braccio ed un occhio solo, che essere gettati nell’inferno con tutto il corpo; vale a dire, a qualsiasi costo, qualunque sia la perdita che ne abbiamo, non dobbiamo omettere il lasciarle; senza di questo, nessun perdono.
3° Diciamo che il terzo segno di un buon proposito, è il lavorare con tutto ciò che si può, per distruggere le cattive abitudini. Si chiama abitudine la facilità che si ha nel ricadere nei vecchi peccati. Bisogna: vegliare accuratamente su se stesso, fare spesso delle azioni che siano contrarie: se siamo soggetti all’orgoglio, bisogna applicarsi a praticare l’umiltà, esser contenti di essere disprezzati, non cercare la stima del mondo, sia nelle parole, sia nelle azioni; credere sempre che ciò che facciamo sia fatto male; se facciamo bene, rappresentarci che siamo indegni che Dio si serva di noi, non guardandoci nel mondo che come una persona che non faccia che disprezzare DIO durante la sua vita, e che meritiamo ben più di quanto si possa dire di male di noi. Siamo soggetti alla collera? Bisogna praticare la dolcezza, sia nelle parole, sia nella maniera di comportarci verso il prossimo. Se siamo soggetti alla sensualità bisogna mortificarci nel bere, nel mangiare, nelle nostre parole, nei nostri sguardi, imporci delle penitenze ogni volta che ricadiamo. E se non prendete queste precauzioni, tutte le volte che commetterete nuovamente i vostri peccati, potrete concludere che tutte le vostre confessioni non valgono a nulla e non avete fato che sacrilegio, crimine sì orribile, per il quale sarebbe impossibile poter vivere se ne conosceste tutta l’orribile natura, la tenebrosità, le atrocità … Ecco la condotta che dobbiamo tenere, facciamo come il figliuol prodigo che colpito dallo stato in cui i suoi disordini lo avevano sprofondato, fu soggetto a tutto ciò che suo padre esigeva da lui per avere la felicità di riconciliarsi con lui. Innanzitutto lasciò sul posto il paese in cui aveva provato tanti mali, e le persone che per lui erano state occasione di peccato; non si degnò nemmeno di guardarli, ben convinto che non avrebbe avuto la felicità di riconciliarsi con suo padre se non quando si fosse allontanato da essi: di modo tale che dopo il suo peccato, per mostrare a suo padre che il suo ritorno era sincero, e non cercò se non di fargli piacere facendo tutto il contrario di ciò che aveva fatto fino al presente. – Ecco il modello sul quale noi dobbiamo conformare la nostra contrizione: la conoscenza che dobbiamo avere dei nostri peccati, il dolore che dobbiamo averne, devono metterci nella disposizione di sacrificare tutto per non ricadere nei nostri peccati. Oh! Quanto rare sono queste contrizioni: Ahimè! Dove sono coloro che sono pronti ad intraprendere la medesima via, piuttosto che commettere di nuovo i peccati che hanno già confessato? Ah! non saprei! Ahimè! Quanti al contrario, dice San Giovanni Crisostomo, non fanno che delle confessioni da teatro, che cessano di peccare per qualche istante senza lasciare interamente il peccato; questi sono, ci dice, simili a quei commedianti che rappresentano combattimenti sanguinosi ed accaniti, e sembrano accusare colpi mortali. Vi si vede uno che è abbattuto, steso, sanguinante: sembrerebbe veramente che abbia perso la vita, ma aspettate che la tela si abbassi, e vedrete rialzarsi pieno di forza e di salute, sarà come era prima della rappresentazione teatrale. Ecco precisamente – ci dice – lo stato in cui si trova la maggior parte delle persone che si presentano al tribunale della penitenza. A vederli sospirare e gemere sui peccati che accusano, voi direste che veramente essi non sono più gli stessi, che si comportano in maniera tutta diversa di quanto abbiano fatto fino al presente. Ma ahimè, aspettate, io non dico cinque giorni, ma uno o due giorni, li ritroverete simili a prima della confessione: stesso comportamento, stessa vendetta, stessa avidità, medesima negligenza nei doveri verso la religione. Ahimè! Quante confessioni e cattive confessioni! Ah! Figli miei, ci duce San Bernardo, volete avere una vera contrizione dei vostri peccati? Voltatevi dal lato di questa croce ove il vostro DIO è stato inchiodato per l’amore verso di voi; ah! piuttosto vedrete scorrere le vostre lacrime, ed il vostro cuore si lacererà. In effetti, fratelli miei, quel che fece versare tante lacrime a Santa Maddalena, la quale fu nel suo deserto, ci dice il grande Salviano … , non fu altra cosa che la vista della croce. Noi leggiamo nella sua vita che, dopo l’Ascensione di Gesù-Cristo, essendosi ritirata in solitudine, domandò a DIO la gioia di piangere per tutta le vita le colpe della sua giovinezza. Dopo la sua preghiera, San Michele Arcangelo le apparve presso la sua solitudine, piantò una croce davanti alla sua porta, ella si gettò ai piedi come aveva fatto sul Calvario, pianse per tutta la sua vita con tale abbondanza che i suoi occhi erano simili a due fontane. Il grande Ludolfo riporta che un solitario chiedeva un giorno a DIO cosa potesse essere più capace si scuotere il suo cuore per piangere i suoi peccati. In questo momento, DIO gli apparve così com’era sull’albero della croce, tutto coperto di piaghe, tremante, caricato di una pesante croce, dicendogli: « guardami, il tuo cuore fu più duro delle rocce del deserto, esso si struggerà e non potrà più vivere alla vista dei dolori che i peccati del genere umano mi hanno causato. » Questa apparizione lo toccò talmente che fino alla sua morte, la sua vita non fu che una vita di lacrime e singhiozzi. Molto spesso si rivolgeva agli Angeli ed ai Santi, pregandoli di venire a piangere con lui sui tormenti che i suoi peccati avevano causato ad un DIO così buono. Leggiamo nella storia di San Domenico, che un religioso, chiedendo a DIO la grazia di piangere i propri peccati, Gesù-Cristo gli apparve con le cinque piaghe aperte, e il sangue scorreva in abbondanza. – Nostro Signore, dopo averlo abbracciato, gli disse di avvicinare la sua bocca all’apertura delle sue piaghe; egli ne sentì tale felicità che non poteva comprendere come i suoi occhi potessero versare tante lacrime. Oh! Come erano felici, questi penitenti, fratelli miei, di trovare tante lacrime per piangere i propri peccati, temendo poi di piangerli nell’altra vita! oh! Qual differenza tra essi ed i Cristiani dei giorni nostri che hanno commesso tanti peccati! E nessun rimorso o lacrime! … Ahimè, cosa diverremo? Quale sarà la nostra dimora? Oh! Quanti Cristiani perduti perché bisogna piangere i propri peccati o in questo mondo o andarli a piangere negli abissi! Cosa dobbiamo concludere da quanto detto, fratelli miei? eccolo: è il domandare incessantemente a DIO questo orrore del peccato, il fuggire le occasioni del peccato e non perdere mai di vista che i dannati non bruciano e non piangono nell’inferno se non perché non si sono pentiti dei loro peccati in questo mondo e che essi non hanno voluto lasciare. No, quanto grandi possano essere i sacrifici che abbiamo da fare, essi non devono esser capaci di trattenerci; bisogna assolutamente combattere, soffrire e gemere in questo mondo, se vogliamo avere l’onore di andare a cantare le lodi di DIO per tutta l’eternità, è la felicità che vi auguro.
Credo …
IL CREDO
Offertorium
Orémus Ps CXVIII: 17, 107
Confitébor tibi, Dómine, in toto corde meo: retríbue servo tuo: vivam, et custódiam sermónes tuos: vivífica me secúndum verbum tuum, Dómine.
[Ti glorífico, o Signore, con tutto il mio cuore: concedi al tuo servo: che io viva e metta in pràtica la tua parola: dònami la vita secondo la tua parola.]
Secreta
Hæc múnera, quaesumus Dómine, ei víncula nostræ pravitátis absólvant, et tuæ nobis misericórdiæ dona concílient.
[Ti preghiamo, o Signore, perché questi doni ci líberino dalle catene della nostra perversità e ci otténgano i frutti della tua misericórdia.]
COMUNIONE SPIRITUALE
Communio
1 Cor XI: 24, 25
Hoc corpus, quod pro vobis tradétur: hic calix novi Testaménti est in meo sánguine, dicit Dóminus: hoc fácite, quotiescúmque súmitis, in meam commemoratiónem.
[Questo è il mio corpo, che sarà immolato per voi: questo càlice è il nuovo patto nel mio sangue, dice il Signore: tutte le volte che ne berrete, fàtelo in mia memoria.]
Postcommunio
Orémus.
Adésto nobis, Dómine, Deus noster: et, quos tuis mystériis recreásti, perpétuis defénde subsidiis.
[Assístici, o Signore Dio nostro: e difendi incessantemente col tuo aiuto coloro che hai ravvivato per mezzo dei tuoi misteri.]
PREGHIERE LEONINE (dopo la Messa)
RINGRAZIAMENTO DOPO LA COMUNIONE (2)
ORDINARIO DELLA MESSA