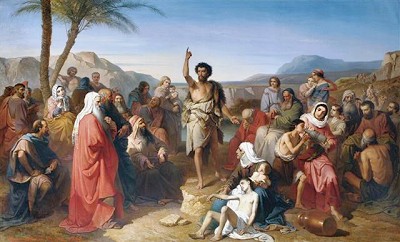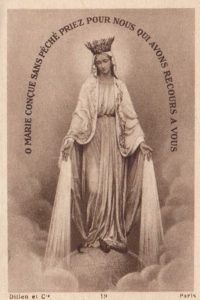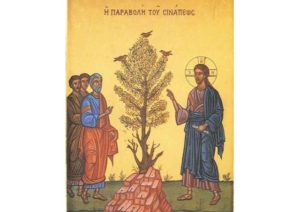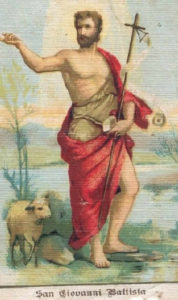
Incipit
In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
Introitus
Phil IV:4-6
Gaudéte in Dómino semper: íterum dico, gaudéte. Modéstia vestra nota sit ómnibus homínibus: Dóminus enim prope est. Nihil sollíciti sitis: sed in omni oratióne petitiónes vestræ innotéscant apud Deum. [Godete sempre nel Signore: ve lo ripeto: godete. La vostra modestia sia manifesta a tutti gli uomini: il Signore è vicino. Non siate ansiosi per alcuna cosa, ma in ogni circostanza fate conoscere a Dio i vostri bisogni]
Ps LXXXIV: 2
Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Jacob. [Hai benedetto, o Signore, la tua terra: hai liberato Giacobbe dalla schiavitù.]
Gaudéte in Dómino semper: íterum dico, gaudéte. Modéstia vestra nota sit ómnibus homínibus: Dóminus enim prope est. Nihil sollíciti sitis: sed in omni oratióne petitiónes vestræ innotéscant apud Deum. [Godete sempre nel Signore: ve lo ripeto: godete. La vostra modestia sia manifesta a tutti gli uomini: il Signore è vicino. Non siate ansiosi per alcuna cosa, ma in ogni circostanza fate conoscere a Dio i vostri bisogni.]
Oratio
Orémus.
Aurem tuam, quǽsumus, Dómine, précibus nostris accómmoda: et mentis nostræ ténebras, grátia tuæ visitatiónis illústra: [O Signore, Te ne preghiamo, porgi benigno ascolto alle nostre preghiere e illumina le tenebre della nostra mente con la grazia della tua venuta.]
Lectio
Lectio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Philippénses
Philipp IV:4-7
Fratres: Gaudéte in Dómino semper: íterum dico, gaudéte. Modéstia vestra nota sit ómnibus homínibus: Dóminus prope est. Nihil sollíciti sitis: sed in omni oratióne et obsecratióne, cum gratiárum actióne, petitiónes vestræ innotéscant apud Deum. Et pax Dei, quæ exsúperat omnem sensum, custódiat corda vestra et intellegéntias vestras, in Christo Jesu, Dómino nostro.
R. Deo gratias.
OMELIA I
[Mons. Bonomelli: Omelie, Vol. I; Torino 1899 – Omelia V.]
“Rallegratevi sempre nel Signore: da capo ve lo dico, rallegratevi. La vostra benignità sia nota a tutti gli uomini: il Signore è vicino. Non siate ansiosi di nulla: ma in ogni cosa le vostre domande siano manifestate a Dio nell’orazione, nella preghiera e nel rendimento di grazie. E la pace di Dio, che supera ogni mente, custodisca i vostri cuori e le vostre menti in Gesù Cristo „ (Ai Pilipp. IV, 4-7).
Con questi quattro versetti l’apostolo Paolo chiude la sua breve, ma bella ed affettuosissima lettera ai fedeli della Chiesa di Filippi, città principale della Macedonia. Nessuna difficoltà nella spiegazione di queste sentenze dell’Apostolo: ma i documenti, che vi si contengono, sono d’una importanza pratica grandissima e meritano tutta la vostra attenzione. – “Rallegratevi sempre nel Signore: da capo vel dico, rallegratevi. „ S. Paolo scrisse questa lettera da Roma, come si fa manifesto dai saluti, che in fine della lettera manda a quei di Filippi. La scrisse certamente dalla carcere, in cui fu gettato la prima volta, circa l’anno sessantesimo dell’era nostra. Uomo veramente ammirabile questo Apostolo per eccellenza! Egli è oppresso da ogni maniera di tribolazioni e in molti luoghi delle sue lettere, e in questa stessa, ne fa una viva descrizione. Da Gerusalemme è condotto a Roma incatenato: è là in carcere, imperando Nerone; si vede innanzitutto il patibolo: molti lo hanno abbandonato ed alcuni dei suoi lo amareggiano perfino in carcere: eppure, ripieno d’un sacro entusiasmo, l’entusiasmo della fede e della carità, grida ai suoi cari: rallegratevi. „ Ciò non gli basta, ed aggiunge: “Rallegratevi sempre; „ non gli basta ancora: lo ripete di nuovo: “Da capo vel dico, rallegratevi. „ Ma come rallegrarsi in mezzo ai timori e ai terrori della persecuzione, con le catene alle mani, lì, a pochi passi di quel mostro di crudeltà, che si chiama Nerone? — L’Apostolo leva in alto gli occhi, li fissa con fede viva in Dio ed è in Lui, in Lui solo, che egli attinge ogni conforto e perfino l’allegrezza, che vorrebbe trasfondere nei suoi cari figliuoli. – Vi è una doppia allegrezza, 1’una celeste, l’altra terrena: l’una che viene dagli uomini, l’altra che viene da Dio; l’una che si fa sentire nel corpo, l’altra che riempie l’anima, la fa trasalire e si riflette eziandio nel corpo. Vi è la gioia dell’avaro, che guarda estatico lo scrigno riboccante d’oro; vi è la gioia del superbo, del vanitoso, che si delizia degli applausi e si inebria dell’incenso, che le turbe gli profondono: vi è la gioia dell’epulone, che si bea tra vini e vivande; vi è la gioia del voluttuoso che lussureggia per ogni fibra: son gioie basse turpi, indegne dell’uomo, inette a farlo felice, perché non sono durevoli, passano rapidamente e se pur saziano per alcuni istanti la parte inferiore, il corpo, che se ne va tutto con la morte, lasciano vuota, desolata, riarsa la povera anima, come se vi passasse sopra un soffio infuocato. Domandate a questi beati del mondo, che corsero tutte le vie del piacere, che colsero tutti i fiori trovati lungo la via; che ammassarono i milioni; che salirono alto e videro le turbe prostrate ai loro piedi; che alla loro bocca non negavano mai né un cibo, né una bevanda, fossero pure a peso d’oro; che ebbero tutto ciò che poterono desiderare; domandate loro: “Siete felici?,, Ad una voce vi risponderanno: “Siamo sazi della vita; la noia ci opprime; il nostro cuore è vuoto. „ – Ecco la gioia del mondo! Vi è poi la gioia dell’umile, che conosce se stesso, del poverello rassegnato e contento dei suo pane quotidiano, dell’uomo, che comanda alle passioni e le vede obbedienti; vi è la gioia del casto, del giusto, del caritatevole; gioia tranquilla, sempre eguale, che inonda l’anima, che ne ricerca tutte le fibre più riposte, che dura in mezzo alle pene ed alle amarezze della vita, che è come un effluvio del cielo, che ci fa sentire Dio presente e quasi ce lo fa toccare: ecco la gioia del Signore, di cui scrive S. Paolo. Non cercate, non amate mai la gioia del mondo, ma la gioia di Dio: Gaudete semper in Domino: iterum dico, gaudete. Questa gioia della virtù, gioia pura e santa, raddolcisce i dolori, che sulla terra sono nostri compagni inseparabili; infonde una forza meravigliosa nell’anima e ci fa correre speditamente le vie del cielo. S. Francesco d’Assisi sul miserabile giaciglio delle sue agonie, cantava. S. Luigi Gonzaga esclamava: Lætantes imus: ce ne andiamo pieni di gioia. S. Francesco di Sales, S. Vincenzo dei Paoli, S. Filippo erano sempre sorridenti e in mezzo alle fatiche, alle cure, alle pene della vita erano lieti e felici. E la gioia dei figli di Dio, quella di S. Paolo, che scrive: Rallegratevi sempre nel Signore. – “La vostra benignità sia nota a tutti gli uomini. „ La parola greca usata da S. Paolo e che io ho voltato nella parola benignità, ha un significato amplissimo e vuol dire modestia, temperanza di modi, affabilità, dolcezza. Qui l’Apostolo in sostanza vuole che nel nostro esterno, parole, opere e contegno c i mostriamo con tutti tali, da non recar loro molestia alcuna e da essere loro graditi. Tutto questo non è che il frutto e la manifestazione della carità, la quale vuole, che per quanto è possibile, non facciamo mai cosa che spiaccia ai nostri prossimi e facciamo loro ciò che onestamente piace. Il cristiano, secondo S. Paolo, deve essere l’uomo più caro, più amabile, più accettevole a tutti nella stessa società civile, perché in ogni cosa è informato alla carità di Gesù Cristo. E perché questa benignità con tutti? Perché, risponde S. Paolo, “Il Signore è vicino — Dominus prope est. „ Il Signore è vicino: forseché è vicino il giorno del finale giudizio, come alcuni sognarono? No: perché Gesù Cristo non volle dire quando verrà, e lo stesso Apostolo, nella sua lettera seconda a quei di Tessalonica, vuole che nessuno si turbi, quasi che quel giorno sia vicino (Capo II, 2 ) . — Il Signore è vicino; — vicino, perché il giorno della nostra morte e per conseguenza del giudizio per ciascuno, sia quanto si voglia lontano, è sempre vicino, dacché la nostra vita passa come un’ombra. — Il Signore è vicino; — vicino, perché viviamo in Lui, in Lui ci muoviamo, in Lui siamo; perché in qualunque luogo e in qualunque istante Egli ci vede, scruta i nostri pensieri e i nostri affetti. Siamo in ogni cosa composti, grida S. Paolo, perché siamo sempre al suo cospetto. Qual motivo più efficace di questo per vivere santamente? Segue un altro versetto, nel quale S. Paolo» ci dà un ammaestramento pratico per regolare cristianamente la nostra condotta. Eccovelo: “Non siate ansiosi di nulla. „ In mezzo alle nostre occupazioni, tribolazioni, privazioni ed anche in mezzo alla abbondanza d’ogni bene,, noi siamo facilmente inquieti e inquietiamo quelli, coi quali abbiamo comune la vita. Temiamo, speriamo, affannosamente desideriamo,, ci agitiamo senza tregua e così la pace fugge dai nostri cuori. Quando S. Paolo ci dice: “Non siate ansiosi di nulla,„ non intende già che trascuriamo le cose nostre, che viviamo spensierati, dimentichi del domani, con la stolta pretensione che ogni nostra cura si abbandoni alla Provvidenza divina: se così fosse, S. Paolo avrebbe predicata la negligenza, inculcato 1’ozio, avrebbe condannata l’intera sua vita e ci avrebbe imposto di tentare la Provvidenza. Egli vuole che adempiamo ogni nostro dovere e poi ci rimettiamo alla provvidenza di Dio, perfettamente rassegnati a tutto ciò ch’essa disporrà, senza turbarci, sapendo ch’essa tutto va ordinando al nostro vero bene. E ciò che si fa? Sventuratamente nella nostra condotta cadiamo troppo spesso nei due estremi. Ora noi domandiamo tutto alle nostre forze, al nostro ingegno, alla nostra abilità, dimenticando che se Dio non è con noi, tutto fallisce: ed ora tutto pretendiamo da Dio, come se nulla si esigesse da noi e Dio dovesse premiare i pigri, gli oziosi. La verità è, carissimi, che si domanda sempre in ogni cosa l’aiuto di Dio ed il nostro concorso, e se l’uno o l’altro fa difetto, follia sperare il compimento dell’opera. Può esso il sole illuminare i vostri occhi, se voi non li aprite? Può essa il campo coprirsi di messi, se voi non lo seminate e coltivate? Possono i vostri polmoni respirare se l’aria vien meno? Non dimenticate mai, che se Dio ci ha creati senza di noi, senza di noi non ci salva. Lavoriamo, facciamo il nostro dovere, ma senza ansietà, sicuri che se noi dal canto nostro faremo ciò che è in poter nostro, Dio non mancherà mai dal lato suo, e le due forze unite, l’umana e la divina, ci daranno l’opera compiuta. – E per cessare questa ansietà, che sì spesso turba i nostri cuori, che faremo? Ce lo insegna l’Apostolo : “In ogni cosa le vostre domande siano manifestate a Dio nella orazione, nella preghiera e nel rendimento di grazie. „ Allorché ci assale il timore che le cose nostre volgano male e l’anima nostra è sopraffatta da sollecitudini moleste ed è in preda al turbamento, solleviamo gli occhi a Lui che tutto vede e può; a Lui, che ci è sempre vicino e ci ama teneramente, e come figli a padre amoroso, apriamogli l’anima nostra con l’orazione; e se la tempesta dell’anima non cessa, instiamo più fortemente nella orazione, che allora diventa preghiera. Qui è notata la differenza tra orazione e preghiera; la preghiera è l’orazione con insistenza, con ardore, e quando incalza il bisogno, deve pur crescere la nostra orazione e diventare preghiera. – Se Dio ci esaudisce, noi gli porgeremo rendimento di grazie per l’ottenuto beneficio: se per gli occulti consigli della sua sapienza, Egli ritarda l’esaudimento della nostra preghiera e ci lascia ancora in balia della tempesta, noi lo ringrazieremo egualmente, perché ci conforta col suo aiuto, perché ciò vuole a nostro maggior bene e perché la sua volontà benedetta è pur sempre la nostra legge inviolabile. Non dimentichiamo mai, o carissimi, questo sì prezioso insegnamento dell’Apostolo: in ogni cosa ricorriamo a Dio; la preghiera è il farmaco dell’anima afflitta, è l’ancora della nostra salvezza. – L’Apostolo chiude il tratto della epistola per noi citato con questo augurio, che non potrebb’essere più bello: “E la pace di Dio, che supera ogni mente, custodisca i vostri cuori e le vostre menti in Gesù Cristo. „ La pace! Non vi è cosa che suoni più dolce ai nostri orecchi, che maggiormente si desideri e che più studiosamente si conservi quanto la pace. Tutti cerchiamo, tutti vogliamo la pace: tutti la salutiamo come il sommo bene che si possa avere quaggiù. Che è dessa la pace? Fu definita da sant’Agostino: “Tranquillitas ordinis — Tranquillità dell’ordine! „ Quando serbiamo l’ordine, che è quanto dire, osserviamo la giustizia con tutti, allora abbiamo la pace. Noi tutti abbiamo dei doveri verso noi stessi, verso i nostri simili, verso Dio. Abbiamo doveri verso noi stessi, che ci impongono di vegliare sui pensieri e sugli affetti nostri, di reprimere le passioni scomposte, che ci travagliano, la superbia, l’amore sregolato dei beni della terra, la sensualità, l’intemperanza, l’invidia, l’ira e via dicendo. Vogliamo noi la pace con noi? Ebbene: ristabiliamo l’ordine nell’anima nostra, le passioni ribelli siano ridotte alla ubbidienza, vi regnino le virtù e legge nostra sia la fede, che regoli ogni nostro atto. — Abbiamo doveri coi nostri simili e quanti son padri, sono madri, sono figli, padroni, servi, ricchi, poveri; adempia ciascuno i suoi doveri, sempre e fedelmente: esercitando i nostri doveri, vediamo di non offendere quelli degli altri; pieni di compatimento e di amore vero ed operoso verso di tutti, cerchiamo il bene altrui come il nostro, ed avremo l’ordine, cioè la pace coi fratelli nostri. — Abbiamo doveri con Dio, e sono i primi e il fondamento degli altri; osserviamo la sua legge, temiamo il suo giudizio, amiamolo, come il Padre nostro, non facendo mai cosa che lo possa offendere, ed avremo 1’ordine e la pace con Dio. Oh la pace! come la può avere colui che vive in peccato, che sa d’avere per nemico Dio stesso? Un uomo che sa d’avere commesso un delitto e di meritare l’estremo supplizio; che sa d’avere sulle sue orme gli esecutori della giustizia, che lo cercano, non ha un’ora di pace. Ogni rumore, ogni stormire di foglie, la vista d’un uomo, che muove alla sua volta, tutto lo turba, lo agita, lo riempie di sospetto e di terrore. É l’uomo, che sa d’aver offeso Dio onnipotente, a cui non può sfuggire; Dio, che lo attende e lo coglierà all’estremo passo; questo uomo potrà mai aver pace? É impossibile. Quegli solo ha la pace, la pace di Dio, la pace cioè che viene da Dio, il quale signoreggia le sue passioni, ama i fratelli come se stesso, che fugge il peccato, che vive nella grazia di Dio. Uomo avventurato! Questa pace, tesoro di tutti preziosissimo, custodirà la sua mente ed il suo cuore, gli farà gustare anche sulla terra quanto dolce e soave è il Signore con quelli che lo amano!
Graduale
Ps 79:2; 79:3; 79:2
Qui sedes, Dómine, super Chérubim, éxcita poténtiam tuam, et veni. [O Signore, Tu che hai per trono i Cherubini, súscita la tua potenza e vieni.]
V. Qui regis Israël, inténde: qui dedúcis, velut ovem, Joseph. [Ascolta, Tu che reggi Israele: che guidi Giuseppe come un gregge. Allelúia, allelúia.]
Alleluja
Allelúja, allelúja,
V. Excita, Dómine, potentiam tuam, et veni, ut salvos fácias nos. Allelúja. [Suscita, o Signore, la tua potenza e vieni, affinché ci salvi. Allelúia.]
Evangelium
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Joánnem
R. Gloria tibi, Domine!
Joann l:19-28
“In illo tempore: Misérunt Judaei ab Jerosólymis sacerdótes et levítas ad Joánnem, ut interrogárent eum: Tu quis es? Et conféssus est, et non negávit: et conféssus est: Quia non sum ego Christus. Et interrogavérunt eum: Quid ergo? Elías es tu? Et dixit: Non sum. Prophéta es tu? Et respondit: Non. Dixérunt ergo ei: Quis es, ut respónsum demus his, qui misérunt nos? Quid dicis de te ipso? Ait: Ego vox clamántis in desérto: Dirígite viam Dómini, sicut dixit Isaías Prophéta. Et qui missi fúerant, erant ex pharisaeis. Et interrogavérunt eum, et dixérunt ei: Quid ergo baptízas, si tu non es Christus, neque Elías, neque Prophéta? Respóndit eis Joánnes, dicens: Ego baptízo in aqua: médius autem vestrum stetit, quem vos nescítis. Ipse est, qui post me ventúrus est, qui ante me factus est: cujus ego non sum dignus ut solvam ejus corrígiam calceaménti. Hæc in Bethánia facta sunt trans Jordánem, ubi erat Joánnes baptízans.”
R. Laus tibi, Christe!
Omelia II
[Del canonico G. B. Musso – Omelie: Seconda edizione napoletana, Vol. I -1851-]
(Vangelo sec. S. Giovanni I, 19-28)
Superbia.
Avevano i Giudei concepita una sì alta opinione di Giovanni il Battista per la sua vita irreprensibile, per l’austera penitenza, per la zelante predicazione, che credettero esser egli il Messia da Dio promesso, e da gran tempo da loro aspettato. Spedirono perciò da Gerosolima Sacerdoti e Leviti ad interrogarlo chi egli fosse, e s’era il Cristo tanto desiderato dalla loro nazione. Giovanni non si dimenticò di sé stesso.. Ben lungi dall’arrogarsi un nome sì glorioso, prese anzi motivo da un’interrogazione lusinghiera di vieppiù umiliarsi; “ … ed io, rispose, e ripeté la seconda e la terza volta, io non sono Cristo. Questi vive, ed è in mezzo a voi, e voi nol conoscete; dopo di me si farà manifesto, ed è tanto nella dignità e nella grandezza a me superiore, ch’io neppur son degno di sciogliere i legacci dei suoi calzari!”. “Chi dunque sei tu? Tornarono a chiedergli, forse Elia, o alcun dei Profeti?” Non sono Elia, rispose, non sono Profeta, ma sono una voce, che va gridando nel deserto: preparate la via del Signore, “ego vox clamantis in deserto; parate viam Domini”. – Fin qui l’odierno Vangelo. Che dite, ascoltatori, di questa umiltà del Precursore di Gesù Cristo, del maggiore fra i Santi? Gl’inviati a far tante interrogazioni erano Farisei, gente gonfia della più fina superbia, dovevan confondersi in sentire l’umile confessioni del Battista. Ma no! Di guarigione difficilissima è un tal vizio; ed oh quanto regna nel mondo, e la virtù a questo opposta oh quanto nel mondo è sconosciuta! Contro di questa superbia è diretta la presente spiegazione, e per ridurre me stesso e voi a sbandirla dal nostro cuore, io passo a dimostrarvi prima il castigo di questa passione detestabile, poscia il rimedio nella virtù della cristiana umiltà …
I. Il castigo della superbia secondo l’ordine stabilito dalla giustizia di Dio, che necessariamente odia i superbi, è comprovato dalla speranza e dalla storia di tutti i secoli, è una vergognosa caduta. Il superbo si può paragonare ad un epilettico. Porta seco quest’infelice una malattia, che o per improvviso sconcerto del Cerebro, o per istraordinaria alterazione de’ nervi, ovunque lo colga, lo getta a terra, senza che possa stendere un braccio a suo riparo, fossa pur egli sull’orlo d’un precipizio. Tal è un superbo. Con questa legge però, dice un gravissimo autore (Scupoli), che quanto egli s’innalza superbamente, tanto miseramente precipita, e l’altezza del suo esaltamento è la precisa misura della profondità della sua caduta. Infallibile è il detto evangelico: “Qui se exàltat, humiliabitur”,..’ .(Luc. XIV, 11). Né ciò deve far meraviglia, entra; qui il reale Profeta, conciossiachè la superbia un mostro, che ha un sol piede, e perciò non può a lungo contenersi in dritta positura. Immaginate un uomo, che si tenga sopra un piede solo. Con qualche sforzo si terrà diritto per poco d’ora, ma non potrà a lungo durare in quella situazione violenta. Se poi a quest’uomo si accosti una mano che l’urti, un nemico che lo spinga, sarà necessariamente stramazzato a terra. – E questa appunto la più viva. immagine della superbia, onde il citato re Profeta, a Dio rivolto, Signore, diceva, “non veniat mihi pes superibiæ, et manus pcccatorìs non moveat me” (Ps. XXV). E poi soggiunge. “Ibi cecidcrunt qui operantur iniquitatem .. èxpulsi sunt, nec potuerunt stare”. Un’esperienza funesta, prosegue lo stesso reale Salmista, mi mostrò quanto sia certa e inevitabile la caduta de’ superbi. Ben mi ricordo d’un Saul, che sebbene da Dio riprovato, pure, sulle armi fidando e sui suoi armati, fu sconfitto da’ Filistei vincitori, e per disperato rimedio a sottrarsi dai loro insulti, si lasciò cadere sulla punta della sua spada applicata al petto. “Non salvatur Rex per multam virtutem (Ps. XXII, 16). Ben mi rammento del superbissimo Filisteo gigante, dispregiatore delle falangi del popolo di Dio, che. sfidando a singolar tenzone i prodi d’Israele, fu a terra steso pel colpo di un semplice pastorello qual io già fui, “et gigas non salvabitur in multitudine virtutis suæ” (ibid.). Ben mi si sveglia l’acerba memoria del mio figlio Assalonne, che per sfrenata ambizione di regnare mi mosse guerra, e in questa abbattuto, mentre sperava salvarsi su veloce destriero, per quel mezzo stesso sospeso pei suoi capèlli ad un ramo perdé la vita, ferito da tre colpi di lancia. “Fallax equus ad salutem in abundantia virtutis suæ non salvabitur”: (ib. V. 17). – Un ritratto al naturale d’un gran superbo, e del suo straordinario e obbrobrioso castigo, ci presenta il Profeta Daniele nella persona di Nabucco re di Babilonia. Stava passeggiando costui nella sua reggia tutto gonfio; tutto in compiacenza di sé stesso, “in aula Babilonis deambalabat”; (Dan., IV, 26) e inebriato dalla propria stima si fa a rispondere a chi non l’interroga, a chi neppur è presente, “responditque” (Reg. XXVII). E come avesse intorno la turba de’suoi adulatori, “ … e non è questa, dice egli, quella gran città, quella Babilonia da me edificata? “Et ait: nonne hæc est Babilon magna, quam ædificavi?” (Ibid.). Falso; Babilonia fu edificata da Belo, e da lui soltanto ingrandita: bugia manifesta, vizio proprio de superbi millantatori, che alla propria gloria fanno anche servir la menzogna. Indi crescendo la sua pazza alterigia, attribuisce alla forza di sua virtù, e a lustro della sua gloria, quanto vi ha di splendido e di grandioso nella sua reggia e nel suo regno, “in domum regni, in robore fortitudinis meæ, et in gloria decoris mei” (Ibid.). Nello stesso, tempo in cui parlando il borioso si pascea di vento, ecco una voce improvvisa discende dal cielo: “a te Nabucco, a te si parla, tu sarai privo di regno, cacciato dalla reggia, e dalla comunanza degli uomini e da strana mania spinto al bosco e alla foresta, abiterai colle fiere, e ti pascerai come bestia irragionevole di fieno e d’erbe selvagge. “Regnum tuum transibit a te, et ab hominibus eiicient te, et cum bestiis et feris habitatio tua, foenum quasibos comedes (Idem). – Fin qui il castigo di questi superbi umiliati è piuttosto nell’ordine delle umane cose, ed è meno a temersi. Quel che deve incutere timore e tremore è lo spirituale castigo, per cui si chiude al superbo il fonte d’ogni grazia celeste. “Deus superbis resistit” (Jacob. IV, 6). Io, dice il Crisostomo, amerei meglio aver tutt’i peccati del mondo coll’umiltà del pubblicano, che le virtù di tutti i santi del cielo con la superbia del fariseo. Con la prima si dileguano tutte le colpe, come neve in faccia al sole: con la seconda si dissipano tutte le virtù, come polvere in faccia al vento. Iddio neppur un istante soffrì nel cielo empireo il superbo Lucifero: la sua superbia da angelo lo fece demonio. Le ruinose cadute degli Eresiarchi s’attribuiscono tutte da S. Girolamo alla superbia. “Hæreticorum mater superbia”. Oltre la perdita inestimabile della grazia e dell’eterna salute, permise Iddio a loro perpetua confusione che cadessero nel fango della disonestà, castigo proprio de’ superbi, che avvilisce lo spirito altero fino ad abbassarlo alla condizione de’ bruti. Così l’Anticristo, che sarà il più superbo degli uomini, sarà altresì’, dice il Profeta Daniele, il più immerso nelle carnali immondezze, “erit in concupiscentiis fæminarum” (Dan XI, 37).
II. A tanto male quale rimedio? Gesù Cristo, dice il Pontefice S. Gregorio, medico celeste, ha prescritto a tutt’i vizi l’opportuno rimedio; agli avari la liberalità, ai disonesti la continenza, agl’iracondi la mansuetudine, e l’umiltà ai superbi. Quest’ultima si distingue in umiltà d’intelletto e umiltà del cuore. L’umiltà d’intelletto è una cognizione del proprio essere, secondo i lumi della ragione e della fede. Per acquistarla basta uno sguardo al passato, al presente, e al futuro. “Semper in mente sabea”, avviso di S. Bernardo, “quid fuisti? quid es? quid eris?” (in for. Honest. vitae). Uno sguardo al passato. Quid fuisti? Che cosa era io venti, trenta, cinquanta, cento anni addietro: un nulla. Senza di me esisteva questo gran mondo. Se Dio s’eccettui, io né pur era nel numero delle cose possibili. Era dunque infinitamente più di me un filo d’erba, un atomo di polvere; dappoiché dall’essere al non essere passa un’infinita distanza. Era io dunque un nulla. Così è, così di sé stesso diceva il reale Profeta, “substantia mea tamquam nihilum ante te” (Ps. XXXVIII, 6); e il nulla di che può gloriarsi, di che può insuperbire? Uno sguardo al presente. Quid es? Che cosa è l’uomo se si separi il prezioso dal vile? Cioè quel che è dell’uomo, e quel ch’è di Dio? In quanto al corpo egli è un composto di quattro tra loro contrari elementi, che per la minima alterazione cagionano in noi tante infermità, tante doglie, tanti malori. Egli è, dice S. Bernardo, un vaso pieno di putredine, “vas stercorum”, un letamaio, di cui non può trovarsi il più vile, “vilius sterquilium numquam vidisti”. La putredine, soggiunge il S. Giobbe, è come il padre che lo genera, la madre che lo nutrisce, la sorella che l’accompagna col seguito di vilissimi vermi, “Putredini dixi: Pater meus es: mater mea, et soror mea, vermibus”. (Giob. XVII, 14). Gran cose! Entra qui Papa Innocenzo parlando del disprezzo del mondo, gran cosa! gli alberi producono foglie verdeggianti, fiori odoriferi, gustosi, e l’uomo vili e molesti insetti, putridi umori, flemme stomachevoli, fecce puzzolenti. O vergognosa condizione dell’umana viltà! “O indigna vilitatis humanæ conditio!”(Lib. 8 c. 3). In quanto poi allo spirito, è vero essere egli uno spirito nobilissimo, una immagine viva del suo Creatore, ma questa eccellente prerogativa non è sua propria. Ed oh quanto fu deformata dal peccato originale immagine sì bella! Ferita l’anima nelle sue facoltà, leso restò l’intelletto e propenso all’errore, lesa la volontà ed inclinata al male. Immaginate un serraglio di fiere selvagge, che affamate digrignano, ed alzano ruggiti, e poi dite, tal’è il cuore dell’uomo prevaricato, le cui passioni ne fanno crudo governo. – Sente ora le spinte dell’iracondia, ora gl’impulsi della concupiscenza, quando l’odio l’infiamma, quando l’agghiaccia l’accidia, la superbia lo gonfia, l’invidia lo strugge, l’avarizia lo dissecca. In questo ammasso di tante disordinate pendenze, di tanti brutali appetiti, di che l’uomo potrà invanire, di che gloriarsi? – Uno sguardo finalmente al futuro. “Quid eris”? Che sarà un giorno di questo grande uomo? Già si sa, la morte lo spoglierà di tutto, lo toglierà per sempre dall’umana società, lo getterà a marcire in un sepolcro, ove divorato da schifosissimi vermi diverrà un nudo scheletro, che si ridurrà poi in tanta “polvere da poter capire nel concavo a una mano, e con un soffio di bocca disperdersi per l’aria. “Quid superbis”, si può qui giustamente insultare all’umana alterigia, “quid superbis, terra, et cinis?” (Eccles. X, 9). Ma questo non è il tutto. Verrà tempo in che non si saprà se quest’uomo sia mai stato al mondo, perirà la sua memoria, e cadrà il suo nome in dimenticanza totale e perpetua: “oblivione delebitur nomen eius” (Eccli. VI,4). Queste serie riflessioni ben ponderate ci portano all’umiltà di cognizione e d’intelletto. Ma ciò non basta. Anche un Filosofo è capace di quest’umile cognizione di se stesso. All’umiltà dell’intelletto fa d’uopo accoppiare l’umiltà del cuore. Gesù Cristo, come riflette il mellifluo dottore, non ebbe né aver poteva l’umiltà di intelletto, poiché quantunque vero uomo e in sembianza di peccatore, come vero ed eterno Figliuol di Dio, conosceva la sua divina eccellenza e l’infinito suo merito; “sciebat se ipsum”. (Serm. 42 in Cant.) Non pertanto per farsi nostro esemplare si è voluto appigliare all’umiltà del cuore, e di questa s’è fatto e proposto nostro maestro, invitandoci ad imitarlo, “discite a me, quìa mitis sum, et humilis corde”. (Matth. XI, 29). In effetti, Egli volle nascere umile e povero in una capanna, visse umile ed abbietto in una bottega, morì umile ed umiliato sopra una croce; e con queste divine lezioni ed eroici esempi d’estrema umiliazione potrà fra i cristiani trovarsi un superbo? Oh Dio! Cristo umile soffre gl’insulti e i disprezzi, e il cristiano superbo disprezza i suoi simili; Cristo umile nasce, vive e muore da vero povero, il cristiano superbo, a costo dell’anima propria e della sua eterna salute, vuol vivere e morire da malvagio ricco; Cristo umile implora perdono per i suoi crocifissori, il cristiano superbo vuol vendicarsi dei suoi nemici. Che strano diabolico contrapposto è mai questo? Un seguace di Gesù Cristo che fa tutto il rovescio di quanto insegnò e praticò Gesù Cristo, come merita il nome di cristiano, come può sperare di regnare un giorno con Cristo chi col fatto è nemico di Cristo? – Non ci lusinghiamo, miei cari. Quanto è necessario il battesimo per tutti i figli d’Adamo; quanto è necessaria la penitenza per i caduti in colpa mortale, tanto è necessaria 1’umiltà per entrare nel regno de’ Cieli, “nisi effìciamini sicut parvuli, non intrabitis in regnum cælorum” (Matth. XVIII, 3). Colle stesse formule sta espressa nelle divine Scritture questa triplice necessità. A finirla. Tutt’i Beati del Cielo furono tutti umili, cominciando da Gesù Cristo, e dalla sua santissima Madre: tutti gli abitatori dell’inferno tutti i superbi, cominciando da Lucifero, e da’ suoi seguaci. La superbia è quella che danna, l’umiltà è quella che salva. Vedeste il castigo, udiste il rimedio, la scelta sta in vostra mano.
CREDO …
Offertorium
Orémus
Ps LXXXIV:2
Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob: remisísti iniquitatem plebis tuæ. [Hai benedetto, o Signore, la tua terra: liberasti Giacobbe dalla schiavitù: perdonasti l’iniquità del tuo popolo.]
Secreta
Devotiónis nostræ tibi, quǽsumus, Dómine, hóstia iúgiter immolétur: quæ et sacri péragat institúta mystérii, et salutáre tuum in nobis mirabíliter operétur. [Ti sia sempre immolata, o Signore, quest’ostia offerta dalla nostra devozione, e serva sia al compimento del sacro mistero, sia ad operare in noi mirabilmente la tua salvezza.]
Communio
Is XXXV:4.
Dícite: pusillánimes, confortámini et nolíte timére: ecce, Deus noster véniet et salvábit nos. [Dite: Pusillànimi, confortatevi e non temete: ecco che viene il nostro Dio e ci salverà.]
Postcommunio
Orémus.
Implorámus, Dómine, cleméntiam tuam: ut hæc divína subsídia, a vítiis expiátos, ad festa ventúra nos præparent. [Imploriamo, o Signore, la tua clemenza, affinché questi divini soccorsi, liberandoci dai nostri vizii, ci preparino alla prossima festa.]
V. Ite, Missa est.
R. Deo gratias.