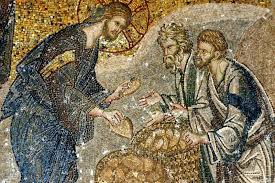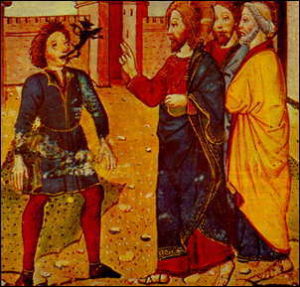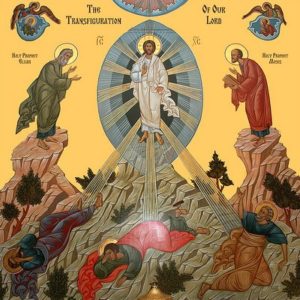DOMENICA DELLE PALME [2018]
Benedictio Palmorum
Ant. Hosánna fílio David: benedíctus, qui venit in nómine Dómini. O Rex Israël: Hosánna in excélsis. [Osanna al Figlio di David, benedetto Colui che viene nel nome del Signore. O Re di Israele: Osanna nel più alto dei cieli!]
Orémus.
Bene ☩ dic, quǽsumus, Dómine, hos palmárum ramos: et præsta; ut, quod pópulus tuus in tui veneratiónem hodiérna die corporáliter agit, hoc spirituáliter summa devotióne perfíciat, de hoste victóriam reportándo et opus misericórdiæ summópere diligéndo. Per Christum Dominum nostrum.[ Bene ☩ dici Signore, te ne preghiamo, questi rami di palma e concedi che quanto il tuo popolo ha celebrato materialmente in tuo onore, lo compia spiritualmente con somma devozione, vincendo il nemico e corrispondendo con profondo amore all’opera della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.]
De distributione ramorum
Ant. Púeri Hebræórum, portántes ramos olivárum, obviavérunt Dómino, clamántes et dicéntes: Hosánna in excélsisI [I fanciulli ebrei, portando rami di olivo, andarono incontro al Signore, acclamando e dicendo: Osanna nel più alto dei cieli.].
Dómini est terra et plenitúdo eius, orbis terrárum et univérsi qui hábitant in eo. Quia ipse super mária fundávit eum et super flúmina præparávit eum.
Ant. Púeri Hebræórum, portántes …
Attóllite portas, príncipes, vestras: et elevámini, portæ æternáles: et introíbit rex glóriæ.
Quis est iste rex glóriæ? Dóminus fortis et potens: Dóminus potens in prǽlio.
Ant. Púeri Hebræórum, portántes…
Attóllite portas, príncipes, vestras: et elevámini, portæ æternáles: et introíbit rex glóriæ. Quis est iste rex glóriæ? Dóminus virtútum ipse est rex glóriæ.
Ant. Púeri Hebræórum, portántes …
Ant. Púeri Hebræórum, portántes …
Ant. Púeri Hebræórum vestiménta prosternébant in via, et clamábant dicéntes: Hosánna filio David; benedíctus qui venit in nómine Dómini. . [I fanciulli Ebrei stendevano le loro vesti sulla via e acclamavano dicendo: Osanna al Piglio di David! Benedetto Colui che viene nel nome del Signore!]
Omnes gentes pláudite mánibus: iubiláte Deo in voce exultatiónis.
Quóniam Dóminus excélsus, terríbilis, rex magnus super omnem terram.
Ant. Púeri Hebræórum …
Subiécit pópulos nobis: et gentes sub pédibus nóstris.
Elegit nobis hereditátem suam: spéciem Iacob quam diléxit.
Ant. Púeri Hebræórum …
Ascéndit Deus in iúbilo: et Dóminus in voce tubæ.
Psállite Deo nostro, psállite: psállite regi nostro, psállite.
Ant. Púeri Hebræórum …
Quóniam rex omnis terræ Deus: psállite sapiénter.
Regnávit Deus super gentes: Deus sedit super sedem sanctam suam.
Ant. Púeri Hebræórum vestiménta …
Príncipes populórum congregáti sunt cum Deo Abraham: quóniam Dei fortes terræ veheménter elevati sunt.
Ant. Púeri Hebræórum vestiménta …
Ant. Púeri Hebræórum vestiménta prosternébant in via, et clamábant dicéntes: Hosánna filio David; benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Evangelium
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
“In illo témpore: Cum appropinquásset Jesus Jerosólymis, et venísset Béthphage ad montem Olivéti: tunc misit duos discípulos suos, dicens eis: Ite in castéllum, quod contra vos est, et statim inveniétis ásinam alligátam et pullum cum ea: sólvite et addúcite mihi: et si quis vobis áliquid dixerit, dícite, quia Dóminus his opus habet, et conféstim dimíttet eos. Hoc autem totum factum est, ut adimplerétur, quod dictum est per Prophétam, dicéntem: Dícite fíliae Sion: Ecce, Rex tuus venit tibi mansuétus, sedens super ásinam et pullum, fílium subjugális. Eúntes autem discípuli, fecérunt, sicut præcépit illis Jesus. Et adduxérunt ásinam et pullum: et imposuérunt super eos vestiménta sua, et eum désuper sedére tecérunt. Plúrima autem turba stravérunt vestiménta sua in via: álii autem cædébant ramos de arbóribus, et sternébant in via: turbæ autem, quæ præcedébant et quæ sequebántur, clamábant, dicéntes: Hosánna fílio David: benedíctus, qui venit in nómine Dómini”.
OMELIA I
[Mons. Bonomelli: Nuova serie di Omelie, vol. II; Omelia XII, Marietti ed. Torino, 1898).
“E come si furono avvicinati a Gerusalemme e venuti a Betfage, presso il monte Oliveto, allora Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: Andate nel villaggio, che sta davanti a voi, e tosto troverete una giumenta legata ed un puledro con essa: scioglieteli e menateli a me: e se alcuno vi dice nulla, dite che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà. Ora tutto ciò avvenne, perché si adempisse la parola del profeta, che dice: Dite alla figliuola di Sion: Ecco il tuo re viene a te, mansueto, assiso sopra un asinello e puledro di asinella da giogo. E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro comandato, e condussero l’asinella e il puledro, e posero sopra di quello le loro vesti e ve lo fecero montare. E intanto una turba grandissima distese le sue vesti nella via; altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano per la via, e le turbe che andavano innanzi e quelle che seguivano, gridavano, dicendo: Osanna al Figliuolo di Davide! Benedetto Colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi. „ (S. Matteo, XXI, 1-9).
Gesù Cristo, lasciata la cittadella di Geco, dove aveva ridonata la vista a due ciechi, il sabato precedente l’ultima sua Pasqua, era giunto a Betania, a due chilometri circa da Gerusalemme. Ivi fu accolto da Lazzaro, che non molto prima aveva risuscitato, e dalle due sorelle, Marta e Maddalena, con qual cuore e con qual gioia vel dica Iddio. La sera stessa di quel sabato accettò l’invito di sedere alla mensa di Simone, detto il lebbroso, come più innanzi ci narra lo stesso S. Matteo (XXVI, 6 seg.). Il giorno appresso, cioè la Domenica, che noi chiamiamo delle Palme, per la commemorazione che ne facciamo tuttora, avvenne l’ingresso solenne in Gerusalemme, che qui si narra e che forma l’oggetto della presente Omelia, e che, attesa la insolita lunghezza della funzione, sarà più breve delle altre. – “Come si furono avvicinati a Gerusalemme e furono venuti a Betfage, presso il monte Oliveto, allora Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: Andate nel villaggio, che sta davanti a voi, e tosto troverete un’asinella legata ed un puledro con essa: scioglieteli e menateli a me: e se alcuno vi dice nulla, dite che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà. „ Gesù, movendo da Betania, saliva le pendici del colle Oliveto, che sta ad oriente di Gerusalemme, e giungeva al villaggio di Betfage, che in nostra lingua significa Gasa della valle o della bocca, perché posto all’imboccatura della valletta di Giosafat, a mezzo chilometro circa dalla città. Egli era accompagnato dai suoi discepoli, che lo seguivano dovunque. La voce del suo arrivo a Betania e della sua venuta in Gerusalemme erasi sparsa dovunque e particolarmente nella città, dove aveva molti discepoli e maggiori e potenti nemici, che avevano giurata la sua morte. Gerusalemme formicolava di pellegrini per la imminente festa della Pasqua venuti da tutta la Giudea, dalla Galilea e dalle regioni più lontane. Il nome Gesù era sulle bocche di tutti: si narravano le sue virtù, i suoi miracoli operati da un capo all’altro della Palestina e fresca e viva era in tutti la memoria della risurrezione di Lazzaro, avvenuta nella prossima Betania, sulle porte di Gerusalemme, alla presenza di tanti testimoni, amici e nemici. Era dunque naturale che tutta Gerusalemme si commovesse alla fama della sua venuta e il popolo, nel suo entusiasmo, gli preparasse un’accoglienza trionfale. Vedete, o cari, differenza di giudizi e sentimenti! il popolo, il buon popolo, specialmente, io credo, delle campagne, accorso a Gerusalemme, crede che Gesù sia un profeta, anzi l’aspettato Messia, e che il suo regno sia per cominciare, e nell’ardore della sua fede si precipita sulla via di Betania per festeggiare la sua venuta. Non si cura degli scribi, dei farisei, dei suoi capi, pieni di livore e di odio implacabile contro di Gesù; esso ubbidisce all’impulso del suo cuore e della sua fede, impulso sempre retto e generoso, se non è traviato per opera dei tristi, come avverrà cinque giorni dopo. L’entusiasmo del popolo è contagioso e si allarga e cresce in un baleno, fa tacere e soffoca le opposizioni, soverchia e trascina anche gli indifferenti, a guisa di torrente impetuoso. Mentre le turbe, uscendo da Gerusalemme ed ingrossando ad ogni istante, si incamminavano confusamente incontro a Gesù, Gesù dall’altra parte, fattosi condurre l’umile cavalcatura, di cui parla il Vangelo, s’avvicinava alla città. E giunto sul colle degli Olivi (Il colle degli Olivi giace ad oriente di Gerusalemme. Il suo versante orientale fino a Betania è dolce, sparso di olivi scarsi e poveri: il versante occidentale, cioè verso Gerusalemme, è ripido a talché non si può discendere che per sentieri (strade non vi sono) girando e rigirando il colle. Sul suo vertice, da cui si gode la più bella vista di tutta Gerusalemme, si mostra il luogo dove Gesù si fermò e pianse. Il pellegrino che giunge e si arresta in quel luogo e contempla la città, e vede in alto la torre di Davide, più basso la cupola della Moschea di Omar e quella del sepolcro di Cristo e col pensiero abbraccia la storia da Davide a Cristo, ai Crociati, a noi, ricorda che i suoi piedi premono la terra che fu premuta dai piedi di Cristo e che li Egli pianse, prova ciò che lingua umana non sa ridire), d’onde si poteva contemplare la città, come narra altrove S. Luca, s’arrestò, pieno di tristezza la rimirò, i suoi occhi si gonfiarono, pianse e singhiozzò, pronunziando quelle parole piene di tenerezza inesprimibile: “Gerusalemme! oh! se tu avessi conosciuto, almeno in questo giorno, le cose appartenenti alla tua pace! Ma ora sono nascoste ai tuoi occhi! „ Gesù in mezzo al trionfo pacifico, che il popolo gli prepara, è sopraffatto da profonda mestizia e versa lagrime amare. Prima che venga il giorno (ed è vicinissimo) delle lotte supreme e dei supremi dolori, il Padre gli ha preparato un’ora di gioia, di spontaneo trionfo, ed Egli lo dimentica per non pensare che al suo popolo, all’ingrata e colpevole città ed alla catastrofe spaventosa in cui deve piombare, e ch’Egli vede e predice. Ah! il cuore di Gesù si rivela tutto in quel pianto, in quei singhiozzi, in quelle parole. – Il potere supremo religioso, che risiede in Gerusalemme, si accieca, si ostina, si irrita, si scandalizza, freme contro di Gesù e ne delibera la morte; il popolo, i semplici, i poveri, i disprezzati, gli ignoranti riconoscono, sentono che Gesù è il Messia: i maestri della legge, i capi del popolo, i dotti lo bestemmiano; la coscienza del popolo lo proclama Figlio di Davide! — Sono misteri che opprimono l’anima, ma che si spiegano facilmente alla luce della fede e della ragione: la verità è rigettata dai superbi ed entra nelle anime umili: “Dio resiste ai superbi e abbonda delle sue grazie con gli umili — Deus resistit superbis, huniilibus autem dat gratiam. „ – Qui, o dilettissimi, si affaccia una domanda troppo naturale, perché io la possa passare sotto silenzio. Il Vangelo di quest’oggi descrive in poche ma brillanti linee il trionfo di Gesù, che entra in Gerusalemme, salutato come profeta, come Messia, anzi come re. Ora noi sappiamo che Gesù Cristo in tutta la sua vita pose ogni studio in nascondersi, in fuggire gli onori, in vietare persino che si pubblicassero alcuni dei suoi miracoli e nominamente la sua gloriosa trasfigurazione: sappiamo dagli Evangelisti, ch’Egli si sottrasse al popolo allorché, visto il miracolo della moltiplicazione del pane, voleva a forza proclamarlo re. Come sta che oggi Gesù Cristo non solo non si sottrae al trionfale ingresso, che i discepoli e i suoi ammiratori gli apparecchiano, ma vi si presta, e diremmo quasi lo incoraggia ed Egli stesso in parte lo vuole regolare, chiedendo una cavalcatura, approva e difende chi lo acclama? Come comporre questa condotta, che sembra affatto nuova, del Salvatore divino? Alla vigilia della sua morte riceve e gradisce quegli onori che in tutta la sua vita mostrò di non curare, dirò meglio, studiosamente sfuggì: come spiegare questo fatto? Non è mestieri il dirlo; tutti gli atti di Gesù Cristo devono essere degni della infinita sua sapienza, e perciò lo deve essere questo pure, checché al corto nostro vedere possa sembrare Gesù Cristo era re e re supremo, come Figlio di Dio, e l’affermò solennemente dinanzi a Pilato: re delle intelligenze, re dei cuori, re spirituale, non temporale, re umile e mansueto, come l’aveva annunziato il profeta Zaccaria, citato dal Vangelista. Inoltre, permettendo e volendo questo trionfo popolare, ravvivava la fede dei suoi cari, si preparava alle prove vicine, mostrava ai suoi nemici la fede delle turbe, ed era come un ultimo appello, un ultimo invito ad abbracciare la verità. Più in quei giorni nella città di Gerusalemme si introducevano gli agnelli destinati al sacrificio, e Gesù, adombrato da quelli, entrava pur esso come il vero Agnello, come vittima coronata, che si conduce al sacrificio. Fors’anche l’amabile Gesù volle quel breve, ma pubblico trionfo; volle quelle grida festose “Osanna al Figlio di Davide, benedetto chi viene nel nome del Signore, „ per rendere più umiliante e più vituperosa la scena di cinque giorni appresso, la sua passione e la sua condanna al grido: “Toglilo, toglilo; alla croce, alla croce — Tolle, tolle; crucifige, crucifige eum. „ – Gesù, sedendo, come sembra, alternativamente ora sull’asinella, ora sul puledro, si avanzava verso la città, mentre gli Apostoli e le turbe stendevano le loro vesti e spargevano frondi e rami sulla via per rendergli onore, e gridavano: “Osanna al Figlio di Davide: Benedetto Colui che viene in nome del Signore, osanna nel più alto de’ cieli, „ ch’era un riconoscere in Gesù il Messia promesso nella famiglia di Davide, che veniva come mandato da Dio: Osanna a Lui! era come per noi il gridare: Viva, salute, onore sulla terra e in cielo: il cielo lo protegga! Una osservazione comunissima, o cari, ed ho finito. Non è raro udire certuni riprovare le manifestazioni esterne del culto cattolico, le processioni pubbliche, il canto del popolo, la pompa degli apparati e via dicendo. Il fatto narratoci dall’Evangelista, il trionfale ingresso di Cristo, ci mostrano in qual conto dobbiamo tenere questi giudizi degli uomini del mondo. Noi imiteremo, ogni qualvolta sia opportuno, gli Apostoli e le turbe che condussero trionfalmente in Gerusalemme il Salvatore benedetto: noi lo accompagneremo per le vie allorché vi è portato come in trionfo nel divino Sacramento: noi le adorneremo; noi canteremo le sue lodi, noi lo benediremo, noi ci inginocchieremo sul suo passaggio, certi che Egli accoglierà i nostri omaggi e le nostre adorazioni, come già accolse le lodi, gli applausi e le benedizioni degli Apostoli e delle turbe fedeli che lo accompagnavano in Gerusalemme, sotto gli occhi dei suoi nemici che ne fremevano e ne mossero lamento a Gesù Cristo istesso, certi di far cosa grata a Lui, che mostrò di gradire il trionfo procacciatogli dagli Apostoli e dalle turbe.
De processione cum ramis benedictis
Procedámus in pace.
Occúrrunt turbæ cum flóribus et palmis Redemptóri óbviam: et victóri triumphánti digna dant obséquia: Fílium Dei ore gentes prædicant: et in laudem Christi voces tonant per núbila: «Hosánna in excélsis». [Con fiori e palme le folle vanno ad incontrare il Redentore e rendono degno ossequio al Vincitore trionfante. Le nazioni lo proclamano Figlio di Dio e nell’etere risuona a lode di Cristo un canto: Osanna nel più alto dei cieli!]
Cum Angelis et púeris fidéles inveniántur, triumphatóri mortis damántes: «Hosánna in excélsis». [Facciamo di essere anche noi fedeli come gli Angeli ed i fanciulli, acclamando al vincitore della morte: Osanna nel più alto dei cieli!]
Turba multa, quæ convénerat ad diem festum, clamábat Dómino: Benedíctus, qui venit in nómine Dómini: «Hosánna in excélsis». [Immensa folla, convenuta per la Pasqua, acclamava ai Signore: Benedetto Colui che viene nel nome del Signore! Osanna nell’alto dei cieli!]
Cœpérunt omnes turbæ descendéntium gaudéntes laudáre Deum voce magna, super ómnibus quas víderant virtútibus, dicéntes: «Benedíctus qui venit Rex in nómine Dómini; pax in terra, et glória in excélsis».[Tutta la turba dei discepoli discendenti dal monte Oliveto cominciò con letizia a lodar Dio ad alta voce per tutti i prodigi che aveva veduti dicendo: Benedetto il Re che viene nel nome del Signore; pace in terra e gloria nell’alto dei cieli.]
Hymnus ad Christum Regem
Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.
Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.
Israël es tu Rex, Davidis et ínclita proles: Nómine qui in Dómini, Rex benedícte, venis.
Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.
Coetus in excélsis te laudat caelicus omnis, Et mortális homo, et cuncta creáta simul.
Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.
Plebs Hebraea tibi cum palmis óbvia venit: Cum prece, voto, hymnis, ádsumus ecce tibi.
Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.
Hi tibi passúro solvébant múnia laudis: Nos tibi regnánti pángimus ecce melos.
Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.
Hi placuére tibi, pláceat devótio nostra: Rex bone, Rex clemens, cui bona cuncta placent.
Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium
Gloria, lode e onore sia a te, Re Cristo Redentore, al quale i migliori fanciulli cantarono piamente: Osanna.
Gloria, lode e onore sia a te, Re Cristo Redentore, al quale i migliori fanciulli cantarono piamente: Osanna.
Tu sei il Re di Israele, il nobile figlio di David, o Re benedetto che vieni nel nome del Signore.
Gloria, lode e onore sia a te, Re Cristo Redentore, al quale i migliori fanciulli cantarono piamente: Osanna.
L‘intera corte angelica nel più alto dei cieli, l’uomo mortale e tutte le creature celebrano insieme le tue lodi.
Gloria, lode e onore sia a te, Re Cristo Redentore, al quale i migliori fanciulli cantarono piamente: Osanna.
Il popolo Ebreo ti veniva dinanzi con le palme, ed eccoci dinanzi a te, con preghiere, con voti e cantici.
Gloria, lode e onore sia a te, Re Cristo Redentore, al quale i migliori fanciulli cantarono piamente: Osanna.
Essi ti offrivano il tributo del loro omaggio, quando tu andavi a soffrire; noi eleviamo questi canti a te che ora regni.
Gloria, lode e onore sia a te, Re Cristo Redentore, al quale i migliori fanciulli cantarono piamente: Osanna.
Ti piacquero essi: ti piaccia anche la nostra devozione, o Re di bontà, Re clemente, a cui ogni cosa buona piace.
Gloria, lode e onore sia a te, Re Cristo Redentore, al quale i migliori fanciulli cantarono piamente: Osanna.]
Ant. Omnes colláudant nomen tuum, et dicunt: «Benedíctus qui venit in nómine Dómini: Hosánna in excélsis».
Psalmus 147
Lauda, Jerúsalem, Dóminum: * lauda Deum tuum, Sion.
Quóniam confortávit seras portárum tuárum: * benedíxit fíliis tuis in te.
Qui pósuit fines tuos pacem: * et ádipe fruménti sátiat te.
Qui emíttit elóquium suum terræ: * velóciter currit sermo ejus.
Qui dat nivem sicut lanam: * nébulam sicut cínerem spargit.
Mittit crystállum suam sicut buccéllas: * ante fáciem frígoris ejus quis sustinébit?
Emíttet verbum suum, et liquefáciet ea: * flabit spíritus ejus, et fluent aquæ.
Qui annúntiat verbum suum Jacob: * justítias, et judícia sua Israël.
Non fecit táliter omni natióni: * et judícia sua non manifestávit eis.
Ant. Omnes colláudant nomen tuum, et dicunt: «Benedíctus qui venit in nómine Dómini: Hosánna in excélsis».
Fulgéntibus palmis prostérnimur adveniénti Dómino: huic omnes occurrámus cum hymnis et cánticis, glorificántes et dicéntes: «Benedíctus Dóminus». Di festosi rami ornati, ci prostriamo al Signor che viene: a Lui incontro corriamo tra inni e canti, Lui glorifichiamo dicendo: Benedetto il Signore!
Ave, Rex noster, Fili David, Redémptor mundi, quem prophétæ praedixérunt Salvatórem dómui Israël esse ventúrum. Te enim ad salutárem víctimam Pater misit in mundum, quem exspectábant omnes sancti ab orígine mundi, et nunc: «Hosánna Fílio David. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis». [Ave, o nostro Re, Figlio di David, Redentore del mondo, preannunciato dai Profeti come Salvatore venuto per la casa d’Israele. Il Padre mandò Te come vittima di redenzione per il mondo; T’aspettavano tutti i santi sin dall’origine del mondo, ed ora: Osanna, Figlio di David. Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. Osanna nel più alto dei Cieli!]
Oremus.
Dómine Jesu Christe, Rex ac Redémptor noster, in cuius honórem, hoc ramos gestántes, solémnes laudes decantávimus: concéde propítius ut, quocúmque hi rami deportáti fúerint, ibi tuæ benedictiónis grátia descéndat, et quavis dǽmonum iniquitáte vel illusióne profligáta, déxtera tua prótegat, quos redémit: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.
Ingrediénte Dómino in sanctam civitátem, Hebræórum púeri resurrectiónem vitæ pronuntiántes,
Cum ramis palmárum: «Hosánna, clamábant, in excélsis».
Cum audísset pópulus, quod Jesus veníret Jerosólymam, exiérunt óbviam ei.
Cum ramis palmárum: «Hosánna, clamábant, in excélsis». [Mentre il Signore entrava nella città santa, i fanciulli ebrei proclamavano la risurrezione alla vita,
Agitando rami di palma e acclamando: Osanna nel più alto dei cieli!
Avendo il popolo sentito che Gesù si avvicinava a Gerusalemme, gli mosse incontro
Agitando rami di palma e acclamando: Osanna nel più alto dei cieli!]
Oremus.
Dómine Jesu Christe, Rex ac Redémptor noster, in cuius honórem, hoc ramos gestántes, solémnes laudes decantávimus: concéde propítius ut, quocúmque hi rami deportáti fúerint, ibi tuæ benedictiónis grátia descéndat, et quavis dǽmonum iniquitáte vel illusióne profligáta, déxtera tua prótegat, quos redémit: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. [Signor Gesù Cristo, Re e Redentore nostro, in onore del quale abbiamo cantato lodi solenni, portando questi rami, concedi propizio che la grazia della tua benedizione discenda dovunque questi rami saranno portati e che la tua destra protegga i redenti togliendo di mezzo a loro ogni iniquità ed illusione diabolica. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.]
Introitus
Ps XXI:20 et 22.
Dómine, ne longe fácias auxílium tuum a me, ad defensiónem meam áspice: líbera me de ore leonis, et a córnibus unicórnium humilitátem meam. [Tu, o Signore, non allontanare da me il tuo soccorso, prendi cura della mia difesa: salvami dalla bocca del leone, e salva la mia debolezza dalle corna dei bufali.]
Ps XXI:2 Deus, Deus meus, réspice in me: quare me dereliquísti? longe a salúte mea verba delictórum meórum. Dio mio, Dio mio, guardami: perché mi hai abbandonato? La salvezza si allontana da me alla voce dei miei delitti.
Dómine, ne longe fácias auxílium tuum a me, ad defensiónem meam áspice: líbera me de ore leonis, et a córnibus unicórnium humilitátem meam. [Tu, o Signore, non allontanare da me il tuo soccorso, prendi cura della mia difesa: salvami dalla bocca del leone, e salva la mia debolezza dalle corna dei bufali.]
Oratio
Omnípotens sempitérne Deus, qui humáno generi, ad imitandum humilitátis exémplum, Salvatórem nostrum carnem súmere et crucem subíre fecísti: concéde propítius; ut et patiéntiæ ipsíus habére documénta et resurrectiónis consórtia mereámur. [ Onnipotente eterno Dio, che per dare al genere umano un esempio d’umiltà da imitare, volesti che il Salvatore nostro s’incarnasse e subisse la morte di Croce: propizio concedi a noi il merito di accogliere gli insegnamenti della sua pazienza, e di partecipare alla sua risurrezione.]
LECTIO
Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Philippénses. Phil II:5-11
“Fratres: Hoc enim sentíte in vobis, quod et in Christo Jesu: qui, cum in forma Dei esset, non rapínam arbitrátus est esse se æqualem Deo: sed semetípsum exinanívit, formam servi accípiens, in similitúdinem hóminum factus, et hábitu invéntus ut homo. Humiliávit semetípsum, factus oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltávit illum: ei donávit illi nomen, quod est super omne nomen: hic genuflectitur ut in nómine Jesu omne genu flectátur coeléstium, terréstrium et inférno rum: et omnis lingua confiteátur, quia Dóminus Jesus Christus in glória est Dei Patris.” [Fratelli: Abbiate in voi gli stessi sentimenti dai quali era animato Cristo Gesù: il quale, essendo nella forma di Dio, non reputò che fosse una rapina quel suo essere uguale a Dio, ma annichilò se stesso, prese la forma di servo, fatto simile agli uomini, e per condizione riconosciuto quale uomo. Egli umiliò se stesso, facendosi ubbidiente sino alla morte e morte di croce. Perciò Dio stesso lo esaltò e gli donò un nome che è sopra qualunque nome: qui si genuflette onde nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio in cielo, in terra e negli abissi; e affinché ogni lingua confessi che il Signore Gesù Cristo è nella gloria di Dio Padre.]
OMELIA
[Mons. Bonomelli: Nuova serie di Omelie, vol. II; Omelia XI, Marietti ed. Torino, 1898).
“Abbiate in voi lo stesso sentimento, che fu anche in Gesù Cristo; il quale essendo la forma di Dio, non tenne per usurpato il suo essere pari a Dio; ma, presa forma di servo, annichilò se stesso, fatto alla somiglianza degli uomini e giudicato esternamente simile all’uomo, abbassò se stesso, essendosi reso ubbidiente fino a morte e morte di croce. Per la qual cosa Iddio sovranamente lo innalzò e gli diede un nome, che è sopra ogni nome, affinché nel nome di Gesù si curvi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri ed infernali, ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre „ (Ai Filippesi, capo II, 5-11).
L’Apostolo trovavasi in Roma l’anno 60 circa dell’era nostra, tenutovi in ceppi: è questa la sua prima prigionia, che cominciò in Gerusalemme, continuò in Cesarea, e poi, dopo il suo appello a Cesare, si protrasse per due anni in Roma. I cristiani di Filippi, città di Macedonia, che S. Paolo aveva convertiti alla fede, sapendolo in carcere, gli mandarono soccorsi per mezzo di Epafrodito, suo discepolo. Questi si ammalò gravemente a Roma; riavutosi, dovette ritornare a Filippi, portatore della lettera. In essa S. Paolo effonde l’anima sua in sensi vivissimi di affetto e gratitudine verso quei suoi neofiti e a rapidi tratti tocca alcuni punti dogmatici e morali della dottrina evangelica, senza discendere ai particolari. I versetti, che vi ho sopra riferiti, si leggono nella epistola di questa Domenica delle Palme, e devono essere il soggetto delle mie parole e delle mie e delle vostre considerazioni. S. Paolo, dopo avere fortemente eccitati e ingiuriati i suoi cari Filippesi a stare uniti nella carità, umili nel deferire agli altri, e nel cercare non il proprio, ma sì l’altrui bene, propone il modello che essi debbono tenere innanzi agli occhi nell’esercizio di queste sì alte e pratiche virtù, e scrive: “Abbiate in voi lo stesso sentimento che fu anche in Gesù Cristo. „ Non occorre il dirlo, Gesù Cristo, perché Dio-Uomo, fu e sarà sempre il sovrano esemplare d’ogni umana perfezione, sotto qualunque rispetto lo si consideri, e quegli tra gli uomini meglio si accosterà alle supreme altezze della perfezione morale, ossia della virtù, che sarà maggiormente simile a Gesù Cristo, e perciò il grande Apostolo in cento luoghi delle sue lettere inculca la necessità di ritrarre Cristo in sé, e qui vuole che abbiamo in noi lo stesso sentimento che Gesù Cristo ebbe in sé. I frutti dell’albero, o cari, donde traggono la loro vita, l’alimento e lo sviluppo della medesima? Dall’albero stesso, dal suo umore, dalle sue radici; essi sono una emanazione, una efflorescenza dell’albero, tantoché quelli seguono la natura di questo, e se l’albero avvizzisce e muore, anche i frutti avvizziscono e muoiono. Che cosa sono le virtù? Sono i frutti di quest’albero, che è l’uomo: esse traggono la loro esistenza e la loro conservazione e perfezione dall’anima, dall’intima vita del cuore, dalla grazia divina che lo informa. Se questa regna nel fondo del nostro cuore, se ne vedranno tosto i frutti nelle parole e nelle opere; se questa fa difetto, l’uomo sarà somigliante ad un albero disseccato od inselvatichito. Se in ciascuno di noi abitasse la grazia, ossia la vita di Gesù Cristo, vale a dire se pensassimo, se amassimo, se sentissimo come Lui, non è vero o cari, che si vedrebbero in noi le opere stesse di Cristo? L’Apostolo svolge la verità, e nel supremo modello d’ogni virtù, che è Cristo, mette in rilievo ammirabile quella che più gli sta a cuore. Vuole, S. Paolo, che i suoi Filippesi siano uniti tra loro col vincolo soave della carità e d’una mutua deferenza. Ora quali sono gli ostacoli principali a questa carità e mutua deferenza? Sono due: l’orgoglio e l’egoismo; l’orgoglio e l’egoismo, che non vedono che sé, tutto ordinano a sé, che disprezzano gli altri, che immolerebbero il mondo intero al proprio interesse. Togliete l’orgoglio, soffocate l’egoismo, e la carità e la scambievole deferenza regnano nei cuori; così se abbassate i rialzi del terreno e riducete a perfetto livello, le acque vi si spanderanno sopra in modo eguale. Ora l’Apostolo per atterrare l’orgoglio e fiaccare l’egoismo dell’uomo e spargere nel suo cuore le acque vivifiche della umiltà e della carità, che sono inseparabili, grida: “Figli miei, levate i vostri occhi, rimirate Cristo, di cui siete discepoli e dovete essere immagini fedeli; Cristo, il quale, essendo nella forma di Dio, non tenne per usurpato il suo essere pari a Dio, ma, presa forma di servo, annichilò se stesso. „ Che importano, che vogliono dire queste parole? Cristo, essendo per natura, o nella natura Dio (la parola forma qui usata da S. Paolo, vuol dire quello che v’è di più perfetto in ogni cosa, ciò che dà o fa l’essere, la perfezione d’ogni cosa, secondo Aristotele; e questo è la natura o l’essenza della cosa. Perciò il dire che Cristo era nella forma di Dio è come dire che era nella essenza di Dio, nella natura di Dio, che era Dio e quindi pari a Dio, a Dio Padre, ecc. Il che apparisce dall’antitesi che segue, cioè prese la forma o forma di servo o di uomo), e perciò avendo coscienza di non fare usurpazione di sorta, dichiarandosi pari a Dio, contuttociò, prendendo la natura di servo, la natura umana, ossia facendosi, uomo, si annichilò. In questa espressione si racchiude l’affermazione precisa e chiarissima di tre dogmi fondamentali riguardanti i misteri della Trinità e della Incarnazione: si afferma che Gesù Cristo è Dio, poi che si dice “lui essere nella forma, ossia nella matura di Dio, e non usurpare la dignità di Dio quando afferma d’essere eguale a Dio; „ si afferma in pari tempo, benché in modo indiretto, la distinzione personale di Cristo da Dio Padre, dicendo, che è verità, Lui essere eguale a Dio Padre; si afferma il mistero della Incarnazione, allorché Paolo insegna che questo Dio, eguale al Padre, prese la forma, cioè assunse la natura di servo, o di uomo; e finalmente si afferma l’unità di persona in Gesù Cristo, fatto uomo, perché si dice, che Colui che è Dio, eguale al Padre, si è fatto uomo, e come uomo fu riconosciuto: Cristo è Dio, eguale al Padre: Cristo è uomo, vero e perfetto uomo, e il medesimo che è Dio, è anche uomo: ecco le tre grandi verità della fede contenute in queste poche parole dell’Apostolo. – Ora veniamo all’applicazione morale, secondo la mente di S. Paolo. Il Verbo, il Figlio di Dio, eterno, immutabile, onnipotente, come il Padre, col quale ha comune la natura! Vi può essere alcun che di più grande, di più eccelso? In Lui sono tutte le perfezioni, in grado sommo, incomparabili, infinite: tutto ciò che apparisce nel mondo, anzi nell’universo, non è che una pallida immagine, un povero riflesso di ciò ch’Egli precontiene in se stesso. Tutto è da Lui, e nulla è senza di Lui, ed Egli non riceve nulla da chicchessia. Egli è il primo, che non ripete l’essere da altri, ma l’ha da sé, ed è perché è: in questo Verbo stanno gli esemplari eterni, perfettissimi di tutte le cose che esistono e di quelle che potrebbero esistere; tutti raccolti in uno, eppure distintissimi, e secondo essi e per essi le cose tutte son fatte e sussistono. Ebbene; questo Verbo, o Figlio di Dio, che si ammanta dell’infinita sua gloria , annichilò se stesso, e letteralmente, vuotò se stesso, exinanivìt, non già della divinità, che sarebbe assurdo, ma si vuotò, cioè si spogliò di tutte quelle grandezze e prerogative che si competevano alla natura umana assunta da Lui personalmente. Egli, il Verbo, prese la forma o la natura di uomo per guisa che fu simile in tutto ed eguale agli uomini, e da tutti esternamente fu giudicato uomo: In similitudinem hominum factus, et habitu inventus ut homo. Si può concepire abbassamento maggiore o maggior carità? L’infinito è divenuto finito, l’immutabile si è fatto mutabile, l’immortale mortale, l’impassibile passibile, Dio uomo! Il sole di eterna giustizia, sfolgorante di luce nel pieno meriggio, in un cielo senz’ombra di nube, si è ecclissato, si è avvolto nel fitto velo d’una nube, la nube dell’umanità, ma solo per accostarsi all’uomo, per comunicarsi all’uomo. Quest’uomo, povera creatura, soggetta ai sensi, che ha sempre bisogno dei sensi per pensare, per elevarsi a ciò che sta sopra i sensi, come l’uccello, che ha bisogno del ramo dell’albero per riposare, nell’umanità di Cristo trova il ponte che lo conduce a Dio, trova Dio stesso: in essa ode la voce di Dio, vede Dio, tocca Dio, si unisce a Dio. Oh! il mistero di Dio fatto uomo è il mistero dell’abbassamento di Dio, dell’amore di Dio, e in pari tempo dell’innalzamento dell’uomo. – Ma qui non s’arresta l’Apostolo. Dopo aver detto che Dio, rimanendo pur sempre Dio, si vuotò, si annichilò, a nostro modo di dire, facendosi uomo, va più innanzi e scrive: “Abbassò se stesso, essendosi reso ubbidiente fino alla morte. „ Badate bene, in sostanza dice S. Paolo, badate bene: al Figlio di Dio non bastò discendere fino all’uomo, e farsi uomo, ed essere stimato uomo: volle essere uomo soggetto, ubbidiente. Non c’è dubbio: il Figlio di Dio poteva farsi uomo, ma anche come uomo avrebbe potuto essere il Re della terra, stringere in pugno lo scettro di tutte le nazioni, circondarsi di tutte le grandezze e magnificenze del potere, della scienza e della gloria: avrebbe potuto fare in modo che i fulgori della sua divinità avvolgessero l’umile natura assunta a talché i popoli tutti si prostrassero riverenti dinanzi a Lui. Chi ne può dubitare? In quella vece Gesù Cristo non pure volle essere uomo e uomo soggetto a tutte le miserie comuni della natura del peccato e della ribellione delle passioni inferiori: ubbidiente a tutte le autorità domestiche e pubbliche, civili, politiche e religiose, ma ubbidiente fino alla morte, il supremo dei dolori e dei mali nell’ordine fisico. E basta? No. Gesù Cristo poteva discendere ancora: v’era ancora un gradino più basso, l’ultimo nella grande scala delle umiliazioni: e quale? La morte, e la morte di croce: “Usque ad mortem, mortem autem crucis”. Era un immenso abbassamento quello della Incarnazione, in cui Dio per poco scompariva, ma restava uomo: quest’uomo si abbassa e si impiccolisce anche nella natura sua assunta, mettendosi all’ultimo posto, rilegandosi volontariamente in una officina, soggetto a tutti: Et erat subditus illis. Ma restava pur sempre la vita d’un uomo quale che apparisse agli occhi del popolo. Anche questa vita naturale cessa col sacrificio della morte, sacrificio dell’obbedienza al volere del Padre: ma poteva rimanere ancora agli occhi degli uomini almeno un po’ di nome, un po’ d’onore, un estremo riverbero d’una vita immolata per obbedienza: ancor questa è totalmente annientata: Cristo muore, e muore in croce, sopra il patibolo destinato agli schiavi; vi muore come un ribelle alle autorità politiche e religiose del suo paese, come un nemico e ribelle a Dio stesso, di cui usurpa il nome e la dignità; vi muore abbandonato da tutti, sotto gli occhi d’una intera città, la capitale della patria sua, e proprio allora che colà si raccoglieva tutta la nazione e d’ogni parte della terra vi convenivano i credenti. Abbassamento, umiliazione, annientamento come quello di Gesù non è possibile a concepirsi: dal seno del Padre in quello della Vergine: dal seno della Vergine in una stalla, nell’esilio, in una officina, nelle angosce della morte e d’una morte vituperosissima: Exinanivit semetipsum semetipsum humiliavit factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. La vostra onnipotenza, o Gesù, ha toccato il fondo di tutti gli abbassamenti possibili. Ma è legge di provvidenza giustissima, che brilla dovunque, che chi volontariamente si abbassa sia sollevato in alto, chi si umilia sia esaltato. Che un ricco signore entri in un miserabile tugurio per soccorrere un poverello; il popolo lo applaude; che un monarca lasci la sua reggia, e passi di casa in casa, di ospedale in ospedale per visitare e confortare i percossi dal cholera, e le moltitudini si accalcheranno intorno a lui, acclamandolo e benedicendolo: quel signore, quel monarca si sono abbassati, e i popoli li innalzano e celebrano il loro nome. Cristo per salvare gli uomini, per ammaestrarli, consolarli e così glorificare il Padre suo, è disceso fino agli uomini infermi, fino a farsi uno di loro, patire e morire ignominiosamente per loro; gli uomini adunque dovevano glorificarlo, e lo fecero e lo fanno: lo doveva glorificare sovra tutto il Padre suo, e tanto quanta era la umiliazione volontaria, a cui si era sottomesso. E lo fece. Udite S. Paolo: “Per la qual cosa Dio sovranamente lo innalzò e gli diede un nome, che è sovra ogni altro nome. „ Per la qual cosa, che è quanto dire, in vista, in premio di tanto abbassamento del Figliuol suo fatto uomo, il Padre lo innalzò sovranamente, ossia gli diede una gloria altissima, che trascende ogni gloria e pareggia il suo abbassamento. E come lo innalzò? Come lo glorificò? ” Col dargli un Nome, che è sovra ogni altro nome. ,, Gli pose nome Gesù, che vale Dio-Salute, o Dio-Salvatore (Il nome di Gesù, secondo i glossologi, è composto di Jehova Shuah, nome proprio di Dio il primo; il secondo, di Dio fatto uomo e divenuto Salvatore del mondo), e rivela la sua dignità e il suo ufficio che a nessun altro, né uomo, né Angelo può competere. Questo nome pertanto, che a Gesù perfettamente conviene, annunzia tutta la sua grandezza e rivela tutta la sua gloria, che i secoli prima in terra, poi in cielo, confermeranno pienamente. Per indicare la grandezza e la gloria di Gesù e del nome, che ne esprime l’ufficio, S. Paolo prosegue: “Affinché nel nome di Gesù si curvi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri ed infernali. „ Ecco, o cari, il frutto dell’abbassamento volontario di Gesù Cristo al di sotto di tutte le creature: esse, tutte, senza eccezione, curvano il ginocchio, vale a dire si prostrano a lor modo e lo adorano: lo adorano gli Angeli del cielo, e lo riconoscono loro re: lo adorano i buoni sulla terra, e lo proclamano loro salvatore: lo adorano lor malgrado gli spiriti infernali ed i malvagi giù nell’abisso eterno, tremando sotto quella mano che li punisce. Questo trionfo di Cristo, che risponde alle inenarrabili sue umiliazioni, ora non è compiuto, ma iniziato: esso avrà il suo pieno compimento al termine dei secoli, quando ogni cosa sarà soggetta a Cristo; Cristo stesso, come uomo, sarà soggetto a Colui che gli ha sottoposta ogni cosa, acciocché Dio sia ogni cosa in tutto, giusta la espressione di S. Paolo (I Cor. XV, 28). Allora ogni lingua delle creature intelligenti del cielo, della terra e dell’inferno, volontariamente o forzatamente confesserà che Gesù Cristo è Signore per la gloria del Padre, in altri termini, siede alla destra del Padre, ha eguale la potenza, la maestà e la gloria col Padre, è Dio come il Padre. Evidentemente qui S. Paolo stabilisce, che la gloria immensa di Cristo è una mercede dovuta alle opere sue, alle sue umiliazioni, e necessariamente suppone che Gesù Cristo meriti una ricompensa. Ad alcuni parve strano che Gesù Cristo potesse meritare a se stesso una gloria, che gli è dovuta necessariamente, essendo egli Dio. Ma non vi è ombra di difficoltà, quando le cose si intendano a dovere. L’umanità di Gesù poté essa meritare l’onore ineffabile di essere congiunta in unità di persona al Figliuolo di Dio? La risposta non può essere dubbia: non meritò, né poté meritare tanto onore, perché questa umanità non poté esistere, e quindi non poté meritare cosa alcuna prima della sua unione: che se avesse anche potuto esistere prima dell’unione (il che sarebbe contro la fede), non avrebbero mai potuto meritare l’unione ipostatica, la quale è grazia, che supera al tutto qualunque merito di creata natura. Gesù Cristo poté Egli meritare la visione beatifica all’anima sua benedetta? No, perché questa visione beatifica l’anima di Gesù Cristo l’ebbe nell’istante istesso della sua unione ipostatica e precedette qualunque suo atto che avesse ragione di merito. Gesù Cristo pertanto con le sue umiliazioni, con i suoi dolori, con la sua morte meritò la redenzione e la grazia agli uomini ed anche agli Angeli, e meritò a se stesso non la gloria interna, sostanziale, dovuta a Lui come Figlio di Dio, ma la gloria esterna, accidentale, avventizia, che riceve e riceverà per tutti i secoli da tutte le creature, e di questa ragiona l’Apostolo nei versetti ora spiegati. E perché gli ammaestramenti di S. Paolo, racchiusi nel breve tratto che vi ho chiosato, rimangano impressi negli animi vostri, ve li riduco in poche parole. Vuole S. Paolo che abbiamo lo stesso sentimento che ebbe Gesù Cristo, il quale dalla somma altezza discese per amore, per il bene degli uomini all’ultima bassezza, Dio si fece uomo: vuole che crediamo, Lui essere Dio eguale al Padre, Lui essere uomo vero e perfetto e Lui essere nell’assunta natura unica persona, e questa divina. Vuole che impariamo che, alla umiliazione estrema, a cui Gesù Cristo si sottopose, risponderà la massima gloria, quale ricompensa a Lui dovuta.
Graduale
Ps LXXII:24 et 1-3 Tenuísti manum déxteram meam: et in voluntáte tua deduxísti me: et cum glória assumpsísti me. [Tu mi hai preso per la destra, mi hai guidato col tuo consiglio, e mi ‘hai accolto in trionfo.]
Quam bonus Israël Deus rectis corde! mei autem pæne moti sunt pedes: pæne effúsi sunt gressus mei: quia zelávi in peccatóribus, pacem peccatórum videns. [Com’è buono, o Israele, Iddio con chi è retto di cuore. Per poco i miei piedi non vacillarono; per poco i miei passi non sdrucciolarono; perché io ho invidiato i peccatori, vedendo la prosperità degli empi.]
Tractus Ps. XXI:2-9, 18, 19, 22, 24, 32
Deus, Deus meus, réspice in me: quare me dereliquísti?
Longe a salúte mea verba delictórum meórum.
Deus meus, clamábo per diem, nec exáudies: in nocte, et non ad insipiéntiam mihi.
Tu autem in sancto hábitas, laus Israël.
In te speravérunt patres nostri: speravérunt, et liberásti eos.
Ad te clamavérunt, et salvi facti sunt: in te speravérunt, et non sunt confusi.
Ego autem sum vermis, et non homo: oppróbrium hóminum et abjéctio plebis.
Omnes, qui vidébant me, aspernabántur me: locúti sunt lábiis et movérunt caput.
Sperávit in Dómino, erípiat eum: salvum fáciat eum, quóniam vult eum.
Ipsi vero consideravérunt et conspexérunt me: divisérunt sibi vestiménta mea, et super vestem meam misérunt mortem.
Líbera me de ore leónis: et a córnibus unicórnium humilitátem meam.
Qui timétis Dóminum, laudáte eum: univérsum semen Jacob, magnificáte eum.
Annuntiábitur Dómino generátio ventúra: et annuntiábunt coeli justítiam ejus.
Pópulo, qui nascétur, quem fecit Dóminus.
Evangelium
Pássio Dómini nostri Jesu Christi secúndum Matthǽum.
[Matt XXVI:1-75; XXVII:1-66].
“In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: J. Scitis, quid post bíduum Pascha fiet, et Fílius hóminis tradétur, ut crucifigátur. C. Tunc congregáti sunt príncipes sacerdótum et senióres pópuli in átrium príncipis sacerdótum, qui dicebátur Cáiphas: et consílium fecérunt, ut Jesum dolo tenérent et occíderent. Dicébant autem: S. Non in die festo, ne forte tumúltus fíeret in pópulo. C. Cum autem Jesus esset in Bethánia in domo Simónis leprósi, accéssit ad eum múlier habens alabástrum unguénti pretiósi, et effúdit super caput ipsíus recumbéntis. Vidéntes autem discípuli, indignáti sunt, dicéntes: S. Ut quid perdítio hæc? pótuit enim istud venúmdari multo, et dari paupéribus. C. Sciens autem Jesus, ait illis: J. Quid molésti estis huic mulíeri? opus enim bonum operáta est in me. Nam semper páuperes habétis vobíscum: me autem non semper habétis. Mittens enim hæc unguéntum hoc in corpus meum, ad sepeliéndum me fecit. Amen, dico vobis, ubicúmque prædicátum fúerit hoc Evangélium in toto mundo, dicétur et, quod hæc fecit, in memóriam ejus. C. Tunc ábiit unus de duódecim, qui dicebátur Judas Iscariótes, ad príncipes sacerdótum, et ait illis: S. Quid vultis mihi dare, et ego vobis eum tradam? C. At illi constituérunt ei trigínta argénteos. Et exínde quærébat opportunitátem, ut eum tráderet. Prima autem die azymórum accessérunt discípuli ad Jesum, dicéntes: S. Ubi vis parémus tibi comédere pascha? C. At Jesus dixit: J. Ite in civitátem ad quendam, et dícite ei: Magíster dicit: Tempus meum prope est, apud te fácio pascha cum discípulis meis. C. Et fecérunt discípuli, sicut constítuit illis Jesus, et paravérunt pascha. Véspere autem facto, discumbébat cum duódecim discípulis suis. Et edéntibus illis, dixit: J. Amen, dico vobis, quia unus vestrum me traditúrus est. C. Et contristáti valde, coepérunt sínguli dícere: S. Numquid ego sum, Dómine? C. At ipse respóndens, ait: J. Qui intíngit mecum manum in parópside, hic me tradet. Fílius quidem hóminis vadit, sicut scriptum est de illo: væ autem hómini illi, per quem Fílius hóminis tradétur: bonum erat ei, si natus non fuísset homo ille. C. Respóndens autem Judas, qui trádidit eum, dixit: S. Numquid ego sum, Rabbi? C. Ait illi: J. Tu dixísti. C. Cenántibus autem eis, accépit Jesus panem, et benedíxit, ac fregit, dedítque discípulis suis, et ait: J. Accípite et comédite: hoc est corpus meum. C. Et accípiens cálicem, grátias egit: et dedit illis, dicens: J. Bíbite ex hoc omnes. Hic est enim sanguis meus novi Testaménti, qui pro multis effundétur in remissiónem peccatórum. Dico autem vobis: non bibam ámodo de hoc genímine vitis usque in diem illum, cum illud bibam vobíscum novum in regno Patris mei. C. Et hymno dicto, exiérunt in montem Olivéti. Tunc dicit illis Jesus: J. Omnes vos scándalum patiémini in me in ista nocte. Scriptum est enim: Percútiam pastórem, et dispergéntur oves gregis. Postquam autem resurréxero, præcédam vos in Galilaeam. C. Respóndens autem Petrus, ait illi: S. Et si omnes scandalizáti fúerint in te, ego numquam scandalizábor. C. Ait illi Jesus: J. Amen, dico tibi, quia in hac nocte, antequam gallus cantet, ter me negábis. C. Ait illi Petrus: S. Etiam si oportúerit me mori tecum, non te negábo. C. Simíliter et omnes discípuli dixérunt. Tunc venit Jesus cum illis in villam, quæ dícitur Gethsémani, et dixit discípulis suis: J. Sedéte hic, donec vadam illuc et orem. C. Et assúmpto Petro et duóbus fíliis Zebedaei, coepit contristári et mæstus esse. Tunc ait illis: J. Tristis est ánima mea usque ad mortem: sustinéte hic, et vigilate mecum. C. Et progréssus pusíllum, prócidit in fáciem suam, orans et dicens: J. Pater mi, si possíbile est, tránseat a me calix iste: Verúmtamen non sicut ego volo, sed sicut tu. C. Et venit ad discípulos suos, et invénit eos dormiéntes: et dicit Petro: J. Sic non potuístis una hora vigiláre mecum? Vigiláte et oráte, ut non intrétis in tentatiónem. Spíritus quidem promptus est, caro autem infírma. C. Iterum secúndo ábiit et orávit, dicens: J. Pater mi, si non potest hic calix transíre, nisi bibam illum, fiat volúntas tua. C. Et venit íterum, et invenit eos dormiéntes: erant enim óculi eórum graváti. Et relíctis illis, íterum ábiit et orávit tértio, eúndem sermónem dicens. Tunc venit ad discípulos suos, et dicit illis: J. Dormíte jam et requiéscite: ecce, appropinquávit hora, et Fílius hóminis tradétur in manus peccatórum. Súrgite, eámus: ecce, appropinquávit, qui me tradet. C. Adhuc eo loquénte, ecce, Judas, unus de duódecim, venit, et cum eo turba multa cum gládiis et fústibus, missi a princípibus sacerdótum et senióribus pópuli. Qui autem trádidit eum, dedit illis signum, dicens: S. Quemcúmque osculátus fúero, ipse est, tenéte eum. C. Et conféstim accédens ad Jesum, dixit: S. Ave, Rabbi. C. Et osculátus est eum. Dixítque illi Jesus: J. Amíce, ad quid venísti? C. Tunc accessérunt, et manus injecérunt in Jesum et tenuérunt eum. Et ecce, unus ex his, qui erant cum Jesu, exténdens manum, exémit gládium suum, et percútiens servum príncipis sacerdótum, amputávit aurículam ejus. Tunc ait illi Jesus: J. Convérte gládium tuum in locum suum. Omnes enim, qui accéperint gládium, gládio períbunt. An putas, quia non possum rogáre Patrem meum, et exhibébit mihi modo plus quam duódecim legiónes Angelórum? Quómodo ergo implebúntur Scripturae, quia sic oportet fíeri? C. In illa hora dixit Jesus turbis: J. Tamquam ad latrónem exístis cum gládiis et fústibus comprehéndere me: cotídie apud vos sedébam docens in templo, et non me tenuístis. C. Hoc autem totum factum est, ut adimpleréntur Scripturæ Prophetárum. Tunc discípuli omnes, relícto eo, fugérunt. At illi tenéntes Jesum, duxérunt ad Cáipham, príncipem sacerdótum, ubi scribæ et senióres convénerant. Petrus autem sequebátur eum a longe, usque in átrium príncipis sacerdótum. Et ingréssus intro, sedébat cum minístris, ut vidéret finem. Príncipes autem sacerdótum et omne concílium quærébant falsum testimónium contra Jesum, ut eum morti tráderent: et non invenérunt, cum multi falsi testes accessíssent. Novíssime autem venérunt duo falsi testes et dixérunt: S. Hic dixit: Possum destrúere templum Dei, et post tríduum reædificáre illud. C. Et surgens princeps sacerdótum, ait illi: S. Nihil respóndes ad ea, quæ isti advérsum te testificántur? C. Jesus autem tacébat. Et princeps sacerdótum ait illi: S. Adjúro te per Deum vivum, ut dicas nobis, si tu es Christus, Fílius Dei. C. Dicit illi Jesus: J. Tu dixísti. Verúmtamen dico vobis, ámodo vidébitis Fílium hóminis sedéntem a dextris virtútis Dei, et veniéntem in núbibus coeli. C. Tunc princeps sacerdótum scidit vestiménta sua, dicens: S. Blasphemávit: quid adhuc egémus téstibus? Ecce, nunc audístis blasphémiam: quid vobis vidétur? C. At illi respondéntes dixérunt: S. Reus est mortis. C. Tunc exspuérunt in fáciem ejus, et cólaphis eum cecidérunt, álii autem palmas in fáciem ejus dedérunt, dicéntes: S. Prophetíza nobis, Christe, quis est, qui te percússit? C. Petrus vero sedébat foris in átrio: et accéssit ad eum una ancílla, dicens: S. Et tu cum Jesu Galilaeo eras. C. At ille negávit coram ómnibus, dicens: S. Néscio, quid dicis. C. Exeúnte autem illo jánuam, vidit eum ália ancílla, et ait his, qui erant ibi: S. Et hic erat cum Jesu Nazaréno. C. Et íterum negávit cum juraménto: Quia non novi hóminem. Et post pusíllum accessérunt, qui stabant, et dixérunt Petro: S. Vere et tu ex illis es: nam et loquéla tua maniféstum te facit. C. Tunc cœpit detestári et juráre, quia non novísset hóminem. Et contínuo gallus cantávit. Et recordátus est Petrus verbi Jesu, quod díxerat: Priúsquam gallus cantet, ter me negábis. Et egréssus foras, flevit amáre. Mane autem facto, consílium iniérunt omnes príncipes sacerdótum et senióres pópuli advérsus Jesum, ut eum morti tráderent. Et vinctum adduxérunt eum, et tradidérunt Póntio Piláto praesidi. Tunc videns Judas, qui eum trádidit, quod damnátus esset, pæniténtia ductus, réttulit trigínta argénteos princípibus sacerdótum et senióribus, dicens: S. Peccávi, tradens sánguinem justum. C. At illi dixérunt: S. Quid ad nos? Tu vidéris. C. Et projéctis argénteis in templo, recéssit: et ábiens, láqueo se suspéndit. Príncipes autem sacerdótum, accéptis argénteis, dixérunt: S. Non licet eos míttere in córbonam: quia prétium sánguinis est. C. Consílio autem ínito, emérunt ex illis agrum fíguli, in sepultúram peregrinórum. Propter hoc vocátus est ager ille, Hacéldama, hoc est, ager sánguinis, usque in hodiérnum diem. Tunc implétum est, quod dictum est per Jeremíam Prophétam, dicéntem: Et accepérunt trigínta argénteos prétium appretiáti, quem appretiavérunt a fíliis Israël: et dedérunt eos in agrum fíguli, sicut constítuit mihi Dóminus. Jesus autem stetit ante praesidem, et interrogávit eum præses, dicens: S. Tu es Rex Judæórum? C. Dicit illi Jesus: J. Tu dicis. C. Et cum accusarétur a princípibus sacerdótum et senióribus, nihil respóndit. Tunc dicit illi Pilátus: S. Non audis, quanta advérsum te dicunt testimónia? C. Et non respóndit ei ad ullum verbum, ita ut mirarétur præses veheménter. Per diem autem sollémnem consuéverat præses pópulo dimíttere unum vinctum, quem voluíssent. Habébat autem tunc vinctum insígnem, qui dicebátur Barábbas. Congregátis ergo illis, dixit Pilátus: S. Quem vultis dimíttam vobis: Barábbam, an Jesum, qui dícitur Christus? C. Sciébat enim, quod per invídiam tradidíssent eum. Sedénte autem illo pro tribunáli, misit ad eum uxor ejus, dicens: S. Nihil tibi et justo illi: multa enim passa sum hódie per visum propter eum. C. Príncipes autem sacerdótum et senióres persuasérunt populis, ut péterent Barábbam, Jesum vero pérderent. Respóndens autem præses, ait illis: S. Quem vultis vobis de duóbus dimítti? C. At illi dixérunt: S. Barábbam. C. Dicit illis Pilátus: S. Quid ígitur fáciam de Jesu, qui dícitur Christus? C. Dicunt omnes: S. Crucifigátur. C. Ait illis præses: S. Quid enim mali fecit? C. At illi magis clamábant,dicéntes: S. Crucifigátur. C. Videns autem Pilátus, quia nihil profíceret, sed magis tumúltus fíeret: accépta aqua, lavit manus coram pópulo, dicens: S. Innocens ego sum a sánguine justi hujus: vos vidéritis. C. Et respóndens univérsus pópulus, dixit: S. Sanguis ejus super nos et super fílios nostros. C. Tunc dimísit illis Barábbam: Jesum autem flagellátum trádidit eis, ut crucifigerétur. Tunc mílites praesidis suscipiéntes Jesum in prætórium, congregavérunt ad eum univérsam cohórtem: et exuéntes eum, chlámydem coccíneam circumdedérunt ei: et plecténtes corónam de spinis, posuérunt super caput ejus, et arúndinem in déxtera ejus. Et genu flexo ante eum, illudébant ei, dicéntes: S. Ave, Rex Judæórum. C. Et exspuéntes in eum, accepérunt arúndinem, et percutiébant caput ejus. Et postquam illusérunt ei, exuérunt eum chlámyde et induérunt eum vestiméntis ejus, et duxérunt eum, ut crucifígerent. Exeúntes autem, invenérunt hóminem Cyrenaeum, nómine Simónem: hunc angariavérunt, ut tólleret crucem ejus. Et venérunt in locum, qui dícitur Gólgotha, quod est Calváriæ locus. Et dedérunt ei vinum bíbere cum felle mixtum. Et cum gustásset, nóluit bibere. Postquam autem crucifixérunt eum, divisérunt vestiménta ejus, sortem mitténtes: ut implerétur, quod dictum est per Prophétam dicentem: Divisérunt sibi vestiménta mea, et super vestem meam misérunt sortem. Et sedéntes, servábant eum. Et imposuérunt super caput ejus causam ipsíus scriptam: Hic est Jesus, Rex Judæórum. Tunc crucifíxi sunt cum eo duo latrónes: unus a dextris et unus a sinístris. Prætereúntes autem blasphemábant eum, movéntes cápita sua et dicéntes: S. Vah, qui déstruis templum Dei et in tríduo illud reædíficas: salva temetípsum. Si Fílius Dei es, descénde de cruce. C. Simíliter et príncipes sacerdótum illudéntes cum scribis et senióribus, dicébant: S. Alios salvos fecit, seípsum non potest salvum fácere: si Rex Israël est, descéndat nunc de cruce, et crédimus ei: confídit in Deo: líberet nunc, si vult eum: dixit enim: Quia Fílius Dei sum. C. Idípsum autem et latrónes, qui crucifíxi erant cum eo, improperábant ei. A sexta autem hora ténebræ factæ sunt super univérsam terram usque ad horam nonam. Et circa horam nonam clamávit Jesus voce magna, dicens: J. Eli, Eli, lamma sabactháni? C. Hoc est: J. Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquísti me? C. Quidam autem illic stantes et audiéntes dicébant: S. Elíam vocat iste. C. Et contínuo currens unus ex eis, accéptam spóngiam implévit acéto et impósuit arúndini, et dabat ei bíbere. Céteri vero dicébant: S. Sine, videámus, an véniat Elías líberans eum. C. Jesus autem íterum clamans voce magna, emísit spíritum.
Hic genuflectitur, et pausatur aliquantulum. …
Et ecce, velum templi scissum est in duas partes a summo usque deórsum: et terra mota est, et petræ scissæ sunt, et monuménta apérta sunt: et multa córpora sanctórum, qui dormíerant, surrexérunt. Et exeúntes de monuméntis post resurrectiónem ejus, venérunt in sanctam civitátem, et apparuérunt multis. Centúrio autem et qui cum eo erant, custodiéntes Jesum, viso terræmótu et his, quæ fiébant, timuérunt valde, dicéntes: S. Vere Fílius Dei erat iste. C. Erant autem ibi mulíeres multæ a longe, quæ secútæ erant Jesum a Galilaea, ministrántes ei: inter quas erat María Magdaléne, et María Jacóbi, et Joseph mater, et mater filiórum Zebedaei. Cum autem sero factum esset, venit quidam homo dives ab Arimathaea, nómine Joseph, qui et ipse discípulus erat Jesu. Hic accéssit ad Pilátum, et pétiit corpus Jesu. Tunc Pilátus jussit reddi corpus. Et accépto córpore, Joseph invólvit illud in síndone munda. Et pósuit illud in monuménto suo novo, quod excíderat in petra. Et advólvit saxum magnum ad óstium monuménti, et ábiit. Erat autem ibi María Magdaléne et áltera María, sedéntes contra sepúlcrum.
[In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: J. Sapete bene che tra due giorni sarà Pasqua, e il Figlio dell’uomo verrà catturato per essere crocifisso. C. Si radunarono allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo nell’atrio del principe dei sacerdoti denominato Caifa, e tennero consiglio sul modo di catturar Gesù con inganno, e così poterlo uccidere. Ma dicevano: S. Non però nel giorno di festa perché non sorga un qualche tumulto nel popolo. C. Mentre Gesù si trovava in Betania nella casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna che portava un vaso d’alabastro, pieno d’unguento prezioso, e lo versò sopra il capo di lui che era adagiato alla mensa. Ma nel veder ciò, i discepoli se ne indignarono e dissero: S. Perché tale sperpero? Poteva esser venduto quell’unguento a buon prezzo, e distribuito [il denaro] ai poveri. C. Ma, sentito questo, Gesù disse loro: J. Perché criticate voi questa donna? Ella invero ha fatto un’opera buona con me. I poveri infatti li avete sempre con voi, mentre non sempre potrete avere me. Spargendo poi questo unguento sopra il mio corpo, l’ha sparso come per alludere alla mia sepoltura. In verità io vi dico che in qualunque luogo sarà predicato questo vangelo, si narrerà altresì, in memoria di lei, quello che ha fatto. C. Allora uno dei dodici, detto Giuda Iscariote, se ne andò dai capi dei sacerdoti, e disse loro: S. Che mi volete dare, ed io ve lo darò nelle mani? C. Ed essi gli promisero trenta monete di argento. E da quel momento egli cercava l’occasione opportuna per darlo nelle loro mani. Or il primo giorno degli azzimi si accostarono a Gesù i discepoli e gli dissero: S. Dove vuoi tu che ti prepariamo per mangiare la Pasqua? C. E Gesù rispose loro: J. «Andate in città dal tale e ditegli: Il Maestro ti fa sapere: Il mio tempo oramai si è approssimato; io coi miei discepoli faccio la Pasqua da te». C. E i discepoli eseguirono quello che aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta poi la sera [Gesù], si era messo a tavola coi suoi dodici discepoli; e mentre mangiavano, egli disse: J. In verità vi dico che uno di voi mi tradirà. C. Sommamente rattristati, essi cominciarono a uno a uno a dirgli: S. Forse sono io, o Signore? C. Ma egli in risposta disse: J. Chi con me stende [per intingere] la mano nel piatto, è proprio quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo, è vero, se ne andrà, come sta scritto di lui; ma guai a quell’individuo, per opera del quale il Figliuolo dell’uomo sarà tradito! Era bene per lui il non esser mai nato! C. Pigliando la parola, Giuda, che poi lo tradì, gli disse: S. Sono forse io, o Maestro? C. Gli rispose [Gesù]: J. Tu l’hai detto. C. Stando dunque essi a cena, Gesù prese un pane, lo benedisse, lo spezzò e lo porse ai suoi discepoli, dicendo: J. Prendete e mangiate; questo è il mio Corpo. C. E preso un calice, rese le grazie, e lo dette loro, dicendo: J. Bevetene tutti. Questo è il mio Sangue del nuovo testamento, che sarà sparso per molti in remissione dei peccati. E vi dico ancora, che non berrò più di questo frutto della vite fino a quel giorno, in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. C. Recitato quindi l’inno, uscirono, diretti al Monte oliveto. Disse allora Gesù: J. Tutti voi in questa notte proverete scandalo per causa mia. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò resuscitato, vi precederò in Galilea. C. In risposta, Pietro allora gli disse: S. Anche se tutti fossero scandalizzati per te, io non mi scandalizzerò mai. C. E Gesù a lui: J. In verità ti dico che in questa medesima notte, prima che il gallo canti, tu mi avrai già rinnegato tre volte. C. E Pietro gli replico: S. Ancorché fosse necessario morire con te, io non ti rinnegherò. C. E dissero lo stesso gli altri discepoli. Arrivò alfine ad un luogo, nominato Getsemani, e Gesù disse ai suoi discepoli: J. Fermatevi qui, mentre io vado più in là a fare orazione. C. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a farsi triste e ad essere mesto. E disse loro: J. È afflitta l’anima mia fino a morirne. Rimanete qui e vegliate con me. C. E fattosi un poco più in avanti, si prostrò a terra colla faccia e disse: J. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. In ogni modo non come voglio io [si faccia], ma come vuoi tu. C. E tornò dai suoi discepoli e li trovò che dormivano. Disse quindi a Pietro: J. E cosi, non poteste vegliare un’ora con me? Vegliate e pregate, perché non siate sospinti in tentazione. Lo spirito, in realtà, è pronto, ma è fiacca la carne. C. Di nuovo se ne andò per la seconda volta, e pregò, dicendo: J. Padre mio, se non può passar questo calice senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. C. E ritornò di nuovo a loro, e li ritrovò addormentati. I loro occhi erano proprio oppressi dal sonno. E, lasciatili stare, andò nuovamente a pregare per la terza volta, dicendo le stesse parole. Fu allora che si riavvicinò ai suoi discepoli e disse loro: J. Dormite pure e riposatevi. Oramai l’ora è vicina, e il Figlio dell’uomo sarà consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi e andiamo; ecco che è vicino colui che mi tradirà. C. Diceva appunto così, quando arrivò Giuda, uno dei dodici e con lui una gran turba di gente con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore, aveva dato loro questo segnale, dicendo: S. Quello che io bacerò, è proprio lui; pigliatelo. C. E, senza indugiare, accostatosi a Gesù, disse: S. Salve, o Maestro! C. E gli dette un bacio. Gesù gli disse: J. Amico, a che fine sei tu venuto? C. E allora si fecero avanti gli misero le mani addosso e lo catturarono. Ma ecco che uno di quelli che erano con Gesù, stesa la mano, sfoderò una spada e, ferito un servo del principe dei sacerdoti, gli staccò un orecchio. Allora gli disse Gesù: J. Rimetti al suo posto la spada, perché chi darà di mano alla spada, di spada perirà. Credi tu forse che io non possa pregare il Padre mio, e che egli non possa fornirmi all’istante più di dodici legioni di Angeli? Come dunque potranno verificarsi le Scritture, dal momento che deve succedere così? C. In quel punto medesimo disse Gesù alle turbe: J. Come un assassino siete venuti a prendermi, con spade e bastoni. Ogni giorno io me ne stavo nel tempio a insegnare, e allora non mi prendeste mai. C. E tutto questo avvenne, perché si compissero le scritture dei Profeti. Dopo ciò, tutti i discepoli lo abbandonarono, dandosi alla fuga. Ma quelli, afferrato Gesù, lo condussero a Caifa; principe dei sacerdoti, presso il quale si erano radunati gli scribi e gli anziani. Pietro però lo aveva seguito alla lontana fino all’atrio del principe dei sacerdoti; ed, entrato là, si era messo a sedere coi servi allo scopo di vedere la fine. I capi dei sacerdoti intanto e tutto il consiglio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per aver modo di metterlo a morte; ma non trovandola, si fecero avanti molti falsi testimoni. Per ultimo se ne presentarono altri due, e dissero: S. Costui disse: Io posso distruggere il tempio di Dio, e in tre giorni posso rifabbricarlo. C. Levatosi su allora il principe dei sacerdoti, disse [a Gesù]: S. Io ti scongiuro per il Dio vivo, che tu ci dica, se sei il Cristo, figlio di Dio. C. Gesù rispose: J. Tu l’hai detto. Anzi vi dico che vedrete altresì il Figlio dell’uomo, assiso alla destra della Potenza di Dio, venir giù sulle nubi del cielo. C. Il principe dei sacerdoti allora si strappò le vesti, dicendo: S. Egli ha bestemmiato! Che abbiamo più bisogno di testimoni? Voi stessi ora ne avete sentito la bestemmia! Che ve ne pare? C. Egli ha bestemmiato! Che abbiamo più bisogno di testimoni? Voi stessi ora ne avete sentito la bestemmia! Che ve ne pare? C. È reo di morte! C. Allora gli sputarono in faccia e lo ammaccarono coi pugni. Altri poi lo schiaffeggiarono e gli dicevano: S. Indovina, o Cristo, chi è che ti ha percosso. C. Pietro intanto se ne stava seduto fuori nell’atrio. Or gli si accostò una serva e gli disse: S. Anche tu eri con Gesù di Galilea. C. Ma egli, alla presenza di tutti, negò, dicendo: S. Non capisco quello che dici. C. Mentre poi stava per uscire dalla porta, lo vide un’altra serva e disse ai presenti: S. Anche lui era con Gesù Nazareno! C. E di nuovo egli negò giurando: S. Io non conosco quest’uomo! C. Di lì a poco gli si avvicinarono coloro che si trovavano là, e dissero a Pietro: S. Tu sei davvero uno di quelli, perché anche il tuo accento ti da a conoscere per tale. C. Cominciò allora a imprecare e a scongiurare che non aveva mai conosciuto quell’uomo. E a un tratto il gallo cantò; allora Pietro si rammentò del discorso di Gesù: «Prima che il gallo canti, tu mi avrai rinnegato tre volte»; ed uscito di là, pianse amaramente. Fattosi poi giorno, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo congiurarono insieme contro Gesù per metterlo a morte; e, legatolo, lo portarono via e lo presentarono al governatore Ponzio Pilato. Il traditore Giuda, allora, visto che Gesù era stato condannato, sospinto dal rimorso, riportò ai capi dei sacerdoti e agli anziani i trenta denari, e disse: S. Ho fatto male, tradendo il sangue d’un innocente! C. Ma essi risposero: S. Che ci importa? Pensaci tu! C. Gettate perciò nel tempio le trenta monete d’argento, egli si ritirò di là, andando a impiccarsi con un laccio. I capi dei sacerdoti per altro, raccattate le monete, dissero: S. Non conviene metterle colle altre nel tesoro, essendo prezzo di sangue. C. Dopo essersi consultati tra di loro, acquistarono con esse un campo d’un vasaio per seppellirvi i forestieri. Per questo, quel campo fu chiamato Aceldama, vale a dire, campo del sangue; e ciò fino ad oggi. Così si verificò quello che era stato predetto per mezzo di Geremia profeta: «Ed hanno ricevuto i trenta denari d’argento, prezzo di colui che fu venduto dai figliuoli d’Israele, e li hanno impiegati nell’acquisto del campo d’un vasaio, come mi aveva imposto il Signore». Gesù pertanto si trovò davanti al governatore, che lo interrogò, dicendogli: S. Sei tu il re dei giudei? C. Gesù gli rispose: J. Tu lo dici. C. Ed essendo stato accusato dai capi dei sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Gli disse allora Pilato: S. Non senti di quanti capi d’accusa ti fanno carico? C. Ma egli non replicò parola, cosicché il governatore ne rimase fortemente meravigliato. Nella ricorrenza della festività [pasquale] il governatore era solito di rilasciare al popolo un detenuto a loro piacimento. Ne aveva allora in prigione uno famoso, chiamato Barabba. A tutti coloro perciò che si erano ivi radunati, Pilato disse: S. Chi volete che io vi lasci libero? Barabba, oppure Gesù, chiamato il Cristo? C. Sapeva bene che per invidia gliel’avevano condotto lì. Mentre intanto egli se ne stava seduto in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: S. Non aver nulla da fare con quel giusto, perché oggi in sogno ho dovuto soffrire tante ansie per via di lui! C. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani sobillarono il popolo, perché fosse chiesto Barabba e fosse ucciso Gesù. In risposta allora il governatore disse loro: S. Chi volete che vi sia rilasciato? C. E quei risposero: S. Barabba. C. Replicò loro Pilato: S. Che ne farò dunque di Gesù, chiamato il Cristo? C. E ad una voce, tutti risposero: S. Crocifiggilo! C. Disse loro il governatore: S. Ma che male ha fatto? C. Ed essi gridarono più forte, dicendo: S. Sia crocifisso! C. Vedendo Pilato che non si concludeva nulla, ma anzi che si accresceva il tumulto, presa dell’acqua, si lavò le mani alla presenza del popolo, dicendo: S. Io sono innocente del sangue di questo giusto; è affar vostro! C. E per risposta tutto quel popolo disse: S. Il sangue di lui ricada sopra di noi e sopra i nostri figli! C. Allora rilasciò libero Barabba; e, dopo averlo fatto flagellare, consegnò loro Gesù, perché fosse crocifisso. I soldati del governatore poi trascinarono Gesù nel pretorio e gli schierarono attorno tutta la coorte; e lo spogliarono, rivestendolo d’una clamide di color rosso. Intrecciata poi una corona di spine, gliela posero in testa, e nella mano destra [gli misero] una canna. E piegando il ginocchio davanti a lui, lo deridevano col dire: S. Salve, o re dei Giudei. C. E dopo avergli sputato addosso, presagli la canna, con essa lo battevano nel capo. E dopo che l’ebbero schernito, gli levarono di dosso la clamide, gli rimisero le sue vesti, e lo condussero via per crocifiggerlo. Nell’uscire [di città], trovarono un tale di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a pigliare la croce. E arrivarono a un luogo, detto Golgota, cioè, del cranio. E dettero da bere [a Gesù] del vino mescolato con fiele; ma avendolo egli gustato, non lo volle bere. E dopo che l’ebbero crocifisso, se ne divisero le vesti, tirandole a sorte. E ciò perché si adempisse quello che era stato detto dal Profeta, quando disse: «Si sono divisi i miei abiti ed hanno messo a sorte la mia veste». E, postisi a sedere, gli facevano la guardia. E al di sopra del capo di lui, appesero, scritta, la causa della sua condanna: – Questi è Gesù, re dei Giudei -. Furono allora crocifissi insieme con lui due ladroni: uno a destra ed uno a sinistra. E quelli che passavano di li, lo schernivano, crollando il capo, e dicevano: S. Tu che distruggi il tempio di Dio e che lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso; se sei il Figlio di Dio, scendi giù dalla croce. C. Parimenti anche i capi dei sacerdoti lo deridevano, beffandosi di lui cogli scribi e cogli anziani del popolo, e dicendo: S. Salvò gli altri, e non può salvare se stesso. Se è il re d’Israele, discenda ora dalla croce, e noi gli crederemo. Confidò in Dio. Se vuole, Iddio lo liberi ora! O non disse che era Figliuolo di Dio? C. E questo pure gli rinfacciavano i ladroni che erano stati crocifissi con lui. Si fece poi un gran buio dall’ora sesta fino all’ora nona. E verso l’ora nona Gesù gridò con gran voce: J. Eli, Eli, lamma sabacthani; C. cioè: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed alcuni che erano li vicini, sentitolo, dissero: S. Costui chiama Elia! C. E subito uno di loro, correndo, presa una spugna, l’inzuppò nell’aceto, e fermatala in vetta a una canna, gli dette da bere. Gli altri invece dicevano: S. Lasciami vedere, se viene Elia a liberarlo. C. Ma Gesù, gridando di nuovo a gran voce, rese lo spirito. Si genuflette per un momento. Ed ecco che il velo del tempio si divise in due parti dall’alto in basso; e la terra tremò; e le pietre si spaccarono, le tombe si aprirono, e molti corpi di Santi che vi erano sepolti, resuscitarono. Usciti anzi dai monumenti dopo la resurrezione di Lui, entrarono nella città santa e comparvero a molti. Il centurione poi e gli altri che con lui facevano la guardia a Gesù, veduto il terremoto e le cose che succedevano, ne ebbero gran paura e dissero: S. Costui era davvero il Figliuolo di Dio. C. C’erano pure lì, in disparte, molte donne che avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra le quali era Maria Maddalena, e Maria di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Essendosi poi fatta sera, arrivò un uomo, ricco signore di Arimatea, chiamato Giuseppe, discepolo anche lui di Gesù. Egli si era presentato a Pilato per chiedergli il corpo di Gesù; e Pilato aveva dato ordine che ne fosse restituito il corpo. E, presolo, Giuseppe lo avvolse in un lenzuolo pulito, e lo pose in un sepolcro nuovo, che si era già fatto scavare in un masso; e, dopo aver ribaltata alla bocca della tomba una gran lapide, se ne andò. Erano ivi Maria Maddalena e l’altra Maria, sedute di davanti al sepolcro.]
Credo…
Offertorium
Orémus Ps LXVIII:21-22.
Impropérium exspectávit cor meum et misériam: et sustínui, qui simul mecum contristarétur, et non fuit: consolántem me quæsívi, et non invéni: et dedérunt in escam meam fel, et in siti mea potavérunt me acéto. [Oltraggio e dolore mi spezzano il cuore; attendevo compassione da qualcuno, e non ci fu; qualcuno che mi consolasse e non lo trovai: per cibo mi diedero del fiele e assetato mi hanno dato da bere dell’aceto.]
Secreta
Concéde, quæsumus, Dómine: ut oculis tuæ majestátis munus oblátum, et grátiam nobis devotionis obtineat, et efféctum beátæ perennitátis acquírat. [Concedi, te ne preghiamo, o Signore, che quest’ostia offerta alla presenza della tua Maestà, ci ottenga la grazia della devozione e ci acquisti il possesso della Eternità beata.]
Communio Matt XXVI:42.
Pater, si non potest hic calix transíre, nisi bibam illum: fiat volúntas tua. [Padre mio, se non è possibile che questo calice passi senza chi lo beva, sia fatta la tua volontà.]
Postcommunio.
Orémus.
Per hujus, Dómine, operatiónem mystérii: et vitia nostra purgéntur, et justa desidéria compleántur. [O Signore, per l’efficacia di questo sacramento, siano purgati i nostri vizi e appagati i nostri giusti desideri.].