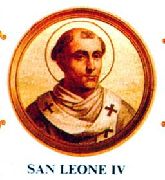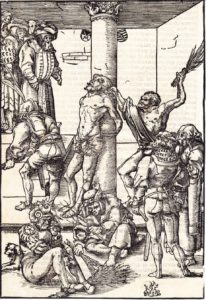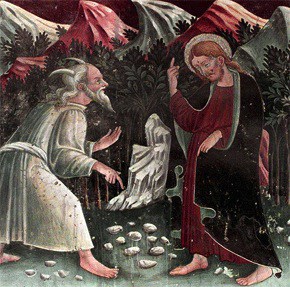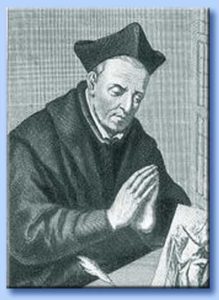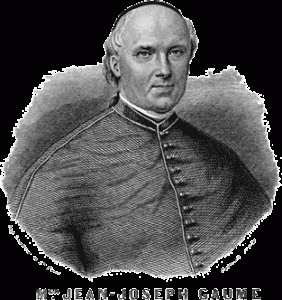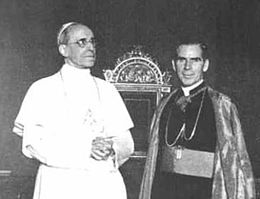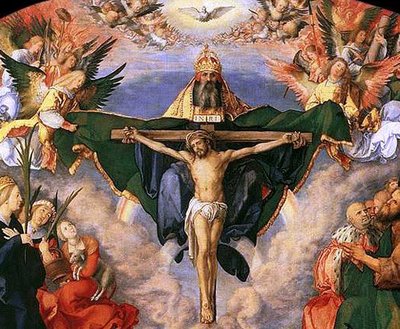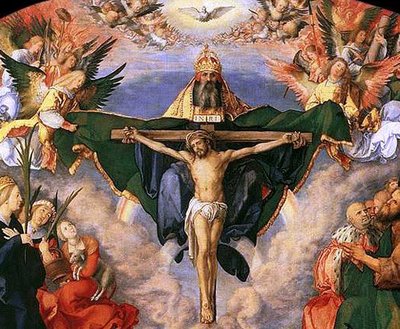
LE TRE VERITA’ CHE DISTRUGGONO
I FALLACI INGANNI DEL “nemico” INFERNALE [e cioè:
1° L’ECUMENISMO MASSONICO,
2° L’INDIFFERENTISMO RELIGIOSO MONDIALISTA,
3° IL NOACHISMO TALMUDICO!]
[da: “IL CRISTIANO RAGIONEVOLE” – Discorso preliminare sopra la verità della Religione Cristiana, il quale servir deve di fondamento a tutte le istruzioni. – Mons. Billot: “Discorsi parrocchiali per le Domeniche”; S. Cioffi ed. Napoli, 1840]
Dopo lo stabilimento della religione cristiana i ministri del Vangelo credevano soddisfare al loro dovere, applicandosi solamente a ben stabilire la verità della sua morale, e ad ispirare ai popoli la pratica delle virtù, che ella insegna. Ma da che nel seno medesimo del Cristianesimo si è formata una fazione di spiriti increduli che, per abbattere sin dai fondamenti la morale della religione, si sollevano sfacciatamente contro i dogmi, e, non contenti di scuoter essi il giogo della fede, si sforzano di distruggerla negli altri, è dovere di un ministro del Vangelo 1’affaticarsi, quanto mai può e sa, a stabilire la verità della religione, sia per confondere l’empietà di quelli che non vogliono credere, sia per assodare ed animar la credenza dei fedeli, che è esposta al naufragio tra le tempeste da cui è agitala, e che non è sterile in un gran numero di cristiani se non perché non si fa da essi attenzione sufficiente ai motivi di credibilità che muover debbono ogni spirito ragionevole a sottomettersi alle verità della fede. Prima di entrare nella materia, si richiede una ragione esente da ogni pregiudizio e libera dalla schiavitù delle passioni, le quali sono gli ostacoli ordinari alle buone impressioni che questi motivi far possono sopra lo spirito: una ragione ben purificata deve arruolarsi sotto lo stendardo di una religione che se la presenta in tutta la sua maestà e con tutto lo splendore delle verità che l’accompagnano. – Vi è tanta armonia tra la religione e la ragione che basta esser ragionevole per diventar ben presto cristiano. Questo soggetto per altro è tanto più importante quanto che si tratta di combattere i nemici domestici della religione, più a temersi da essa che i nemici stranieri, i quali l’hanno attaccata a forza aperta, e le cui guerre non hanno servito che a darle un nuovo lustro; laddove a combattere, le porta colpi tanto più pericolosi quanto che assale l’uomo per il suo debole, servendosi delle sue passioni per sottrarlo all’impero della fede. Potessimo noi dissipare le nebbie che lo spirito delle tenebre ha di già sparso in qualche spirito tra noi! Potessimo noi svellere la zizzania che l’uomo nemico ha sopra seminato nel campo del padre di famiglia! Per riuscire in questo disegno facciamo vedere:
1.° che vi è una Religione rivelata da Dio;
2.°che questa è la Religione Cristiana;
3.° che la vera religione non si trova che nella CHIESA Cattolica, Apostolica Romana.
PRIMA VERITÀ
Necessità di una Religione rivelata
da Dio.
Vi è un Dio Creatore di tutte le cose, il quale si manifesta in una maniera si sensibile nelle sue opere che bisogna chiudere gli occhi alla luce per dubitare della sua esistenza. Questo bel mondo che noi vediamo non si è fatto da sé stesso; incapace di agire, non ha potuto darsi l’esistenza; egli è dunque 1’effetto di una cagione superiore, che era prima di lui. Il bell’ordine che noi ammiriamo nell’universo, che vi regna da tanti secoli con una maniera si costante, non può essere altresì che l’effetto di un’intelligenza infinita, la quale il tutto col suo potere sostiene, e colla sua sapienza governa. Queste idee di un primo principio di tutte le cose son nate con noi; non vi ha alcun uomo ragionevole che possa cancellarle dalla sua mente e che non senta la sua dipendenza da un Essere supremo. Sarebbe essere tanto cieco quanto il caso l’attribuirgli un’opera così perfetta come l’universo. Ora la più perfetta, la più eccellente delle opere di Dio è fuori di dubbio l’uomo » che racchiude in sé le perfezioni delle altre e ne è, per così dire, il compendio. Ma per qual fine ha Dio formato questa creatura così perfetta? Ciò non poteva essere che per venire da essa servito e glorificato: e per questo appunto le ha dato un’anima capace di conoscerlo e di amarlo. Infatti un essere intelligente e buono nulla fa invano, neppur agisce se non per fini buoni: or siccome Dio è un agente infinitamente perfetto, Egli si propone sempre nelle sue operazioni il fine più perfetto, che è Egli stesso. Per essere dunque conosciuto, amato e glorificato dall’uomo, Dio gli ha dato l’essere: altrimenti converrebbe dire che Dio non ha fatto l’uomo che per l’uomo stesso; il che non si può supporre in un artefice così eccellente, in un’intelligenza così perfetta, come Dio. Giacché Dio nulla fa invano, avrebbe Egli dato all’uomo delle facoltà che lo portano a Lui per via di conoscenza, affinché l’uomo non ne facesse alcun uso? E se 1’uomo deve far uso delle facoltà che Dio gli ha date, se egli deve conoscere, amare e glorificare l’Autor del suo essere, deve sperarne delle ricompense, perché Dio è un padrone infinitamente buono, il quale non può lasciar senza ricompensa i servigi che l’uomo può e deve rendergli; se l’uomo ricusa a Dio il culto che gli è dovuto, deve temere i suoi castighi, perché Dio è un padrone infinitamente giusto, il quale non può lasciare impunita l’ingiustizia che 1’uomo farebbe alla sua gloria, ricusandogli il culto che è obbligato di rendergli. – Supposti questi principi, conviene dunque accordare che v’è una religione rivelata da Dio, che deve insegnare all’uomo la maniera di glorificare il suo Creatore, i mezzi di cui deve servirsi per meritare le sue ricompense e per evitare i suoi castighi. Imperciocché, se la gloria di Dio esigeva che l’uomo riconoscesse con alcuni omaggi la sovranità del suo essere, esigeva la sua sapienza ch’egli insegnasse all’uomo il genere di culto che praticar doveva per dimostrare a Dio la sua dipendenza. Ora si è la religione che all’uomo tutto questo insegna; poiché la religione altro non è che un commercio tra Dio e l’uomo pel quale Iddio manifesta i suoi voleri all’uomo, insegnandogli gli omaggi che da lui esige, e l’uomo adempie verso Dio quanto gli deve. Ed esigeva pure la grandezza ed autorità di Dio che intimasse egli stesso i voleri all’uomo, e l’uomo non poteva apprendere che da Dio medesimo quel che far doveva per glorificarlo. – Ed in vero, non è forse cosa giusta che il servo sia sottomesso al suo padrone, il suddito al suo re, la creatura a Dio? Non è forse convenevole che questa creatura riconosca con qualche omaggio la sua dipendenza dal Creatore? Ma da chi il servo ed il suddito apprender devono i servigi al loro padrone dovuti, se non dal padrone medesimo? Qual sarebbe l’autorità di un padrone che avessi servi i quali far non volessero se non se ciò che loro piacesse e disponessero di sé medesimi e delle loro azioni senza consultare il loro padrone e senza aver altra regola che la propria fantasia ed il proprio capriccio? Non tocca forse al padrone piuttosto che al servo il regolare e prescrivere i servigi che gli sono dovuti? Vi sarebbe forse subordinazione o piuttosto non sarebbe un disordine nella società se un suddito non rendesse al suo padrone, al suo re, che un servizio arbitrario? E che? L’autorità di Dio sopra le sue creature è forse minore, o piuttosto non è ella superiore a quella di tutti i padroni sopra i loro servi, di tutti i re sopra i loro sudditi? Non è cosa giusta per lo meno di accordare a Dio il medesimo privilegio che i padroni e i re della terra hanno, in virtù della loro autorità, di far delle leggi? Tocca dunque a Dio, che ha ogni autorità sopra l’uomo, a prescrivergli, e non già all’uomo a prescrivere a sé stesso il culto e i servigi che dovuti sono all’Essere supremo: in conseguenza Dio ha dovuto comunicarsi all’ uomo per mezzo d’una religione rivelata, nella quale l’uomo imparasse il genere di servigio ch’egli deve rendere all’Autore del suo essere. Voleva la gloria dì Dio ch’egli si servisse di questa via per far sentire all’uomo la sua autorità; voleva altresì la sua sapienza ch’ ei gli desse questa regola di condotta per guidarlo. Imperciochè il dire, come gl’increduli, che Dio ha dato all’uomo la ragione per condurlo o che tocca ad essi insegnargli il culto ch’egli deve al suo sovrano egli è un cadere nei più grandi assurdi. La ragione stessa ci fornisce 1’armi per combattere questo sistema: poiché in primo luogo sarebbe sempre vero in questa supposizione che Iddio avrebbe abbandonato la sua autorità alla volontà dell’uomo, il quale diverrebbe il solo arbitro del culto e dell’omaggio che vorrebbe rendere al suo Creatore: il che è contrario ai principi che abbiamo pur ora stabiliti. Ma l’ammettere questo mostruoso sistema egli è esporre l’uomo ai più grandi eccessi ed aprir la porta alla sfrenatezza di tutte le passioni. Non deve forse la sapienza di Dio ovviare a tutti questi inconvenienti, dando all’uomo tutt’altra guida che la sua ragione? Infatti di che non è capace l’uomo abbandonato a se stesso? In quali errori non può egli cadere con la sola sua ragione? Chiaramente ce lo insegna l’esperienza di tanti secoli. Non si sono forse veduti uomini, che si vantano di averne assai, offrire incensi ai loro simili, ad uomini soggetti alle loro passioni medesime, prostrarsi ancora avanti statue di legno o di pietra, e per fino render gli onori divini ai più vili animali, alle piante più comuni?Ah! se non fossimo rischiarati dal lume della fede, noi stessi forse caduti saremmo in simili mancamenti. Ma voglio che, facendo noi un miglior uso di nostra ragione, riconosciamo un Essere supremo Creatore di tutte le cose, cui noi dobbiamo servire e glorificare; sin là giunger può la ragione: tra qual genere di culto c’insegnerà ella a rendergli questa ragione? Sa ella il trae a cui Iddio creandoci ci ha destinati? Può ella da sé stessa scoprire le ricompense che dobbiamo sperarne, i castighi che dobbiamo temerne, i mezzi di cui dobbiamo servirci per meritare le une ed evitare gli altri? questo è ciò ch’ella non potrà decidere giammai. Essa riconoscerà sempre l’insufficienza delle sue cognizioni ed il bisogno che ha di un lume superiore per guidarla nella strada che tener deve. Perciocché finalmente non si può negare che questa è limitata nelle sue cognizioni, variabile nelle sue idee, incerta nei giudizi che forma sopra le cose che non le sono evidenti, incapace per conseguenza a fissarci a qualche cosa di certo. Sono forse necessarie altre prove che i diversi pareri, i quali diviso hanno i più grandi ingegni del mondo intorno alla religione? Tra tutte le sette opposte che regnano nel mondo non vediamo noi forse che ciascuno pretende di aver la ragione della sua parte, che ciascuno abbonda nei suoi sentimenti? Donde procede dunque tanta diversità di opinioni tra coloro che pretendono di seguire la ragione? Prova certissima che ella non è una regola infallibile e che ha bisogno di una regola superiore per determinarsi. Ah! se noi avessimo altra guida che questa guida cieca in materia di credere, cadremmo ben presto nel precipizio dell’errore; il nostro spirito, dice l’Apostolo, sarebbe qua e là fluttuante, come un fanciullo, trasportato da ogni vento di dottrina, senza sapere a che attenersi. Ora è egli credibile che la previdenza di Dio, che il tutto governa con tanta sapienza; che ha stabilito un sì bell’ordine dell’universo tra le creature anche inanimate, che ha provveduto con tanta bontà a tutti i bisogni dell’uomo, 1’abbia abbandonato in un punto cosi essenziale e lasciato nelle sue incertezze in continua perplessità sopra ciò che far deve per glorificare il suo Creatore, meritar te sue ricompense, evitare i suoi castighi? Il dire che Dio ha lasciato all’uomo la libertà di condursi con i suoi lumi e di seguire la religione che gli piacerebbe val quanto dire che Dio approva il capriccio e la menzogna; poiché è impossibile che la verità, la quale è una sola, si trovi in diversi sentimenti contrari gli uni agli altri; val quanto dire che Dio, indifferente sulla condotta degli uomini, soffrirebbe tranquillamente negli uni l’idolatria, la superstizione; negli altri il vizio, 1’empietà. Queste idee sono elleno compatibili con quella di una provvidenza in finitamente saggia? Richiedeva dunque la sapienza di Dio ch’Egli non abbandonasse 1’uomo a sé stesso, ma che gli fissasse in una religione rivelata troverebbe la maniera d’adempier agli omaggi ch’ egli deve al suo Creatore. Questa religione era necessaria all’uomo non solo per preservare il suo spirito dagli errori in cui poteva cadere, ma ancora per servire di freno alle sue passioni e rattenerlo dai disordini ai quali abbandonar si poteva. – Ed invero, se non vi fosse religione alcuna che servisse di riparo alle passioni dell’uomo, non vi sarebbe alcun vizio che non innalzasse lo stendardo: si vedrebbe l’ingiustizia, la vendetta, l’impurità regnar baldanzoso; il mondo non sarebbe più che un teatro spaventevole di disordine, di libertinaggio, di ogni sorta di dissolutezza. Imperciocché, se non vi è religione alcuna, chi terrà in freno le passioni ? Forse i castighi di un Dio? Ma, rigettata la religione, più non si temono i castighi che Dio minaccia ai peccatori. E che temer non si deve da un uomo che nulla teme, che nulla spera? Forse la giustizia degli uomini? Ma la giustizia umana non punisce che i delitti pubblici: tutto ciò dunque che si facesse in segreto resterebbe impunito. La ragione potrebbe ella servir di ritegno alle passioni? Ma questa ragione non è forse spesse fiate talmente accecata dalla passione che confuse restano l’una con l’altra? Quanti pretesti oppone questa ragione per giustificar i propri sregolamenti? Non riguardasi forse come giusto e ragionevole, dice S. Agostino, tutto ciò ch’è conforme alle inclinazioni? Perciò se la religione non viene in aiuto della ragione sedotta dalla passione, 1’uomo si crederà lecito di accordar alle sue passioni tutto quello ch’esse gli domanderanno: non vi sarà alcuno eccesso cui 1’uomo non si abbandoni per soddisfare ai suoi desideri; i piaceri del senso saranno riguardati come inclinazioni e diritti della natura; i beni dei privati non saranno più sicuri dalle invasioni di un ingiusto usurpatore, né la vita stessa contro le persecuzioni di un vendicativo. Non vi sarà più subordinazione tra gli uomini, perché ogni uomo, riguardandosi uguale ad un altro, si crederà libero da ogni dipendenza. Non vi saranno più amici in cui altri confidare si possa, non promessa su cui riposare, non fedeltà nei matrimoni, non integrità nel commercio; la società umana non sarà più che un orribile composto di traditori, di perfidi, contro cui converrà sempre star in guardia; i più astuti e i più forti daranno sempre la legge ai più semplici e ai più deboli. Imperciocché, torno a dirvi, se non vi è religione alcuna che proponga all’uomo delle ricompense per la virtù e che riserbi dei castighi ai vizi; se non vi è alcun’eternità avvenire, qual ce l’insegna la religione, che incoraggiamento vi sarà per la virtù, e qual argine si potrebbe opporre al vizio? Se tutto perir deve col corpo, 1’uomo si riguarderà in questa vita come suo ultimo fine, riferirà ogni cosa ai suoi piaceri, ai suoi interessi; pretenderà aver diritto di tutto loro sacrificare « nulla risparmierà per rendersi felice quanto potrà in questo mondo; e su questo principio, ch’egli crederà fondato sulla ragione, non vi sarà disordine alcuno cui non si abbandoni, allorché vi troverà un qualche piacere; sacrificherà insomma alla sua passione la giustizia, la buona fede, le promesse eziandio più sacre. Tali sono le conseguenze a cui conduce l’irreligione: tale è altresì la condotta ordinaria dei nemici della religione, i quali non la rigettano, se non perché essa contraria le loro passioni e li molesta nel godimento dei loro piaceri: essi crederebbero volentieri quanto ella insegna, se viver li lasciasse a loro genio. Ma in vano pretendono di sottrarsi al suo impero: all’ora della morte saranno anch’essi giudicati secondo la verità e le massime del santo Vangelo. – Inoltre, se questi increduli di cui il mondo è inondato seguitassero i lumi di una retta ragione, accorderebbero senza difficoltà che la religione era necessaria per contener le passioni dentro i limiti del dovere, per assicurare la pace e la tranquillità tra gli uomini: se non s’accecano a sostenere che la provvidenza di Dio abbia loro anche in questo punto mancato e che la sua divina sapienza, la quale regola con tanta armonia l’universo, abbia abbandonato il genere umano alla con incredibile, né si può senza bestemmia asserire. Ah! riconosciamo piuttosto nella religione uno dei più amabili effetti della provvidenza sopra gli uomini, giacché questa religione serve di freno alle loro passioni, le allontana dal vizio e le anima alla virtù; essa è che mantiene il buon ordine nella società, che produce ed assicura 1’unione nelle famiglie; essa è che fa render giustizia a chi e dovuta e ispira l’ubbidienza ai superiori, essa è il fondamento di tutte le virtù, il carattere dell’uomo dabbene, il principio e la cagione dei buoni uffici che gli uomini ricevono gli uni dagli altri. La sola differenza tra un uomo che ha religione, e colui che non ne ha, basta per far decidere in suo favore e farne riconoscere la necessità. Ma qual è la vera religione? questo è ciò che conviene dimostrare.
SECONDA VERITÀ
La Religione Cristiana è la sola vera.
Siccome non havvi che un Dio solo così non può esservi che una sola religione, perciocché la religione è la strada per andare a Dio. Non si può andare a Dio che per la strada della verità: or la verità, la quale non è che una sola, non può trovarsi in differenti religioni opposte le une alle altre. Ma qual è questa sola religione vera che si dee seguire a preferenza di tutte le altre? Ella è senza dubbio la religione cristiana, perché essa sola è munita dei caratteri di divinità, i quali non si trovano in alcun’altra, e che devono farla riguardare come una religione rivelata da Dio. Questi caratteri noi li troveremo nell’ adempimento delle profezie che hanno annunziato i misteri di lei, nei miracoli che Dio ha fatto per confermarla, e nella santità della dottrina e della morale ch’ella insegna. Questi sono i segni da cui dobbiamo riconoscerla per una religione divina, con quest’arme deve essa convincere ogni spirito ragionevole.
Le profezie. A Dio solo spetta il predire l’avvenire, le cui circostanze non dipendono dalla concatenazione delle cause naturali, ma dalla pura determinazione delle cause libere. L’umano intendimento è troppo limitato per poter penetrare in questa sorta di avvenimenti. – Or la religione cristiana è stata annunciata prima del suo stabilimento da profezie di cui ricusare non si può l’autenticità, poiché ci sono state trasmesse dai Giudei medesimi, nemici della nostra religione: profezie sì chiare e sì circostanziate che, a confrontarle con tutti i misteri della religione da esse predetti, si direbbe che sono piuttosto storie di cose passate che predizioni di fatti futuri. Vi si vede chiaramente il luogo della nascita del Messia, la sua missione, i suoi prodigi, le circostanze della sua vita e della sua morte, la sua risurrezione, la sua sepoltura, la sua ascensione al cielo, lo stabilimento della Chiesa su le rovine della sinagoga, la desolazione, la dispersione del popolo ebreo, che non ha voluto riconoscere il Messia. Tutti questi avvenimenti predetti sono accaduti in una maniera si conforme alle predizioni fatte che i pagani medesimi col solo lume della ragione ne hanno riconosciuto il compimento; e questa conformità di fatti colle profezie faceva tanta impressione sul loro spirito che si determinavano ad abbracciare la religione cristiana. Su di che S. Agostino fa questo ragionamento, capacissimo a convincere qualunque spirito in favore della religione cristiana: una religione che è stata predetta da tanti oracoli verificati in tutte le loro circostanze, deve senza dubbio essere riguardata come una religione divina. Or tale è la religione cristiana: basta confrontare i fatti colle profezie. Ma donde sapete voi, dicono i pagani, che gli oracoli sopra la religione hanno un carattere di divinità? Non alla nostra testimonianza dovete voi rapportarvene, rispondiamo loro; ella vi potrebbe essere sospetta: ma sono i Giudei nostri nemici che ci hanno trasmessi questi oracoli nei libri che li contengono e che essi ci assicurano esser divini. Voi dovete tanto più loro prestar fede quanto che han conservato questi libri di generazione in generazione come il loro più prezioso tesoro, come la storia della loro nazione, che i padri avevano cura di far leggere ai propri figliuoli, che i re e i sudditi avevano tra le mani e che conteneva la religione di un popolo intero. Lo stesso s. Agostino, indirizzandosi ai Giudei per convincerli della verità della nostra religione, “voi ci avete trasmessi, lor dice, i libri contenenti le profezie che annunziano i nostri misteri; voi ciò non ostante non volete riconoscere l’adempimento di questi misteri, che noi vi riconosciamo. Ma se non volete creder a noi, ascoltate su questo soggetto la testimonianza dei pagani, i quali, guidati dal solo lume della ragione, trovano tanto di conformità tra le profezie e i fatti da esse annunziati, che se questi libri sono divini, non può alcuno non riconoscerla per una religione rivelata da Dio. Voi ci dite che questi libri sono divini: i pagani riconoscono la connessione tra le profezie ch’essi contengono e gli avvenimenti che sono venuti dopo. E perché dunque ricusare di abbracciar una religione la cui verità è appoggiata sopra i vostri oracoli e sopra la ragion medesima dei pagani?”. – Cosi è, conchiude S. Agostino, i nostri nemici ci somministrano l’armi contro sé medesimi a favore della nostra religione, ed il loro proprio consenso ridonda in nostro vantaggio: “Salutem ex inimicis”. Sarebbe questo il luogo di riferire alcune di queste profezie, il cui adempimento prova la verità della religione cristiana: ma tra il gran numero che potrebbe citarsene fermiamoci a quella il cui avvenimento si fa sentire nel modo più palpabile, nella situazione in cui si trova oggi giorno il popolo ebreo. Questo popolo, che di sua propria confessione, e per testimonianza delle altre nazioni, era un popolo assai florido, che possedeva una delle più ricche porzioni della terra, che aveva i suoi re, il suo tempio, i suoi sacrifici, si trova al giorno d’oggi in un’intera desolazione, senza forma di governo, senza sacerdoti, senza tempio, senza sacrifici, errante, vagabondo nelle diverse parti del mondo, odiato, aborrito da tutte le nazioni della terra, senza speranza di mai più ricuperare il suo primiero splendore. Sì può qui non riconoscere la famosa profezia di Daniele, il quale lungo tempo aranti aveva predetto che, venuto il Messia e messo a morte dal suo popolo, questo popolo sarebbe disperso, desolato, che sarebbe distrutto il suo tempio, aboliti i suoi sacrifici, e che la sua desolazione durerebbe sino alla consumazione dei secoli? Dallo stesso popolo ebreo abbiamo noi ricevuta questa profezia, dunque non è supposta: essa si è verificata in tutte le sue circostanze; noi ne vediamo sotto i nostri occhi l’adempimento; questo popolo sarà un monumento eterno della verità della nostra religione. Si sono veduti sparire i più grandi imperi del mondo; quello degli Assiri, dei Babilonesi, dei Medi, dei Persiani, dei Greci, quello anche dei Romani, che ha distrutti gli altri imperi e quello dei Giudei non sussistono più: nulla di meno questa nazione sussiste sempre senza capo, senz’appoggio, carica dell’odio delle altre nazioni. Iddio ciò permette per far vedere in essa la verità della nostra religione, di cui ne sono, per cosi dire, i predicatori muti e forzati; perciocché la loro situazione fa vedere in una maniera sensibile la missione del Legislatore divino, che essi non han voluto riconoscere, che è venuto a compire ciò che la loro religione aveva predetto, e che, sostituendo la realtà del Nuovo Testamento alle figure del Vecchio, ci ha dato una religione egualmente antica che il mondo; perché la sostanza di questa religione era rinchiusa nella religione giudaica, e questa non era vera avanti del Messia che per la unione e la relazione che aveva colla religione cristiana. – Veniamo ora alle prove dei miracoli.
I miracoli. Si può dire dei miracoli riguardo alla religione ciò che il reale Profeta diceva dell’opere di Dio, le quali annunziano la sua gloria, che è un linguaggio chiaro ed intelligibile che si fa intendere a tutto il mondo, essendo adattato alla capacità sì del savio che dell’ignorante: “Non sunt loquelæ neque sermones quorum non audiamur voces eorum”. È una luce viva e penetrante che rischiara le menti più grossolane. Non avvi intelletto sì ottuso che non debba arrendersi ad una evidenza così convincente. Infatti non si ricerca gran raziocinio per convenire che Dio, fare un miracolo per confermare una menzogna: se dunque ha fatto miracoli per autorizzare la religione cristiana, conviene conchiudere ch’essa è vera. Or, che Dio abbia manifestate con prodigi le verità della nostra religione, non si può negare senza contraddire i principi della certezza e i lumi del buon senso. Leggansi le storie dell’antico e del nuovo Testamento, gli annali della Chiesa, gli scritti di tanti eruditi: si osservi nei monumenti di quei miracoli, che ancora sussistono, e si vedranno miracoli d’ogni genere operati in favore della religione: malattie d’ogni sorta in un subito risanate, ciechi illuminati, ossessi liberati, morti risuscitati, tempeste calmate, elementi che hanno sospeso la loro attività, leggi della natura interamente cangiate in mille occasioni in cui si trattava della gloria e della verità della religione: miracoli operati non in un sol luogo né avanti a qualche testimonio, ma in un’infinità di luoghi, innanzi a migliaia di testimoni, che li hanno esaminati con l’ultima esattezza, che gli hanno attestati per tutto ciò che eravi di più sacro, che li han sostenuti col sacrificio di quanto avevano di più caro, coll’effusione medesima del loro sangue; il che non avrebbero fatto, se non ne fossero stati ben convinti e ben persuasi: miracoli che han convertito alla religione i suoi più crudeli nemici, non solo il basso popolo, ma eziandio i grandi e i dotti, i quali non l’avrebbero certamente abbracciata, se non avessero conosciuta 1’evidenza dei miracoli: miracoli di cui si vedono ancora in molti luoghi monumenti autentici, che non avrebbero innalzati, se i fatti non fossero stati ben provati: miracoli per altro che riguardar non si potevano come effetti del caso, poiché si sono operati in circostanze di elezione, alle preghiere di quelli che domandavano qualche favore dal cielo o che volevano confermare qualche dogma della fede: miracoli per conseguenza che non potevano riguardarsi come l’effetto di qualche causa naturale ed incognita; ma che potevano sicuramente attribuirsi all’onnipotenza di Dio, che operava contro le leggi fisiche della natura in favore della religione. Imperciocché egli è certo che Dio ha dato all’uomo lumi per giudicar delle cose secondo 1’esperienza che ne ha; conseguentemente, quando in materia di credere vede un fatto che sorpassa le forze della natura, può giudicare che Dio n’è l’autore: poiché, se fosse l’effetto d’una causa naturale, né gli desse Iddio alcun mezzo per scoprirne l’illusione, sopra Dio medesimo ricadrebbe il suo errore: conseguenza che non si può ammettere senza far ingiuria alla somma veracità e alla provvidenza di Dio. Perciocché bisogna o negar la provvidenza o dire che non ha potuto permettere fatti straordinari che ci avrebbero indotti in errore in materia di religione; molto meno ancora dar all’uomo cognizioni che lo porterebbero a credere cose che non sono. Vedano gl’increduli il partito che prender vogliono. Negheranno che questi miracoli siano accaduti? Ma conviene per questo accusare di falsità tutta la rispettabile antichità, le storie di più secoli e di molti paesi del mondo, gli scritti di tanti uomini sapienti, di tanti santi personaggi, da cui sono stati raccontati appunto come li avevano appresi da testimoni oculari, e a cui avrebbero data certamente la mentita, se le cose non erano in tal modo accadute come le han pubblicate. Come mai questi santi e dotti personaggi avrebbero spacciato come tante verità fatti i quali non sarebbero stati che favole e chimere, essi che nessun interesse avevano a spacciarli, e all’opposto sarebbe stato di loro vantaggio il rigettarli? Come questi fatti avrebbero ottenuta la credenza non solo del semplice popolo, ma eziandio dei più grandi ingegni del mondo? É forse credibile che tante nazioni, di diversi paesi e di secoli differenti, abbiano tutte insieme dato nel delirio e nell’illusione sopra cose che contrariavano le loro passioni e che conseguentemente loro importava di non credere? Le persone illuminate avrebbero prese tante favole come verità per sì lungo tempo e sì costantemente come han fatto? Forse non dobbiamo almeno prestar tanta fede alle storie dei miracoli della religione, quanta alle storie profane degli imperatori, dei re, dei popoli della terra? Non abbiamo maggior fondamento di ricusarla alle une che alle altre. Se si vuol mettere in dubbio tutto quello che si è fatto nei secoli scorsi. nulla più vi è di certo nel mondo; i secoli avvenire saranno in diritto di non credere ciò che ai giorni nostri succede: tali sono gli assurdi a cui l’irreligione conduce. Quando gli increduli volessero contrastare qualche fatto miracoloso che si cita in favore della religione, possono essi ragionevolmente dubitare di quelli, che Gesù Cristo e gli Apostoli hanno operato? L’universo che li ha veduti, non ha potuto resistervi; strascinato dalla forza di questi miracoli l’universo ha cangiato di credenza ed è divenuto cristiano. Possono dubitare di quelli che sono approvati dalla Chiesa dopo un esame il più esatto e che reggono alla prova della critica più severa? E se a tutti questi fatti se ne aggiunge un’infinità d’altri riferiti da autori degni di fede, può negarsi che non ne sia almen accaduto qualcheduno? E non sarebbe una follia il metterli tutti in dubbio? Come poter resistere ad un’infinità di testimoni, ad un cumulo di prove cavate da tante storie, dalla morte di tanti migliaia di martiri, da tanti monumenti che ancora sussistono? E ciò tutto insieme non fa un peso di ragioni, sotto cui ogni mente deve piegare? Se noi non abbiamo qui un’evidenza appoggiata sopra la testimonianza dei sensi, abbiamo almeno una morale evidenza, ch’equivale alla più grande certezza e che non si può prudentemente rigettare. E quante cose non credono gl’increduli di cui non hanno tanta certezza, quanta loro se ne fa vedere nei fatti della religione? Appunto perché questa religione non si accomoda alle loro perverse inclinazioni, perciò loro piace di contrastare la verità dei suoi miracoli. Ma almeno contrastare non possono un prodigio, che hanno a vanti gli occhi, il quale suppone e sorpassa anche tutti gli altri, ed è la religione medesima. SI, la religione cristiana deve comparire a qualunque pensi dirittamente il più grande dei prodigi, ossia che la consideri nel suo stabilimento, ossia che la esamini nel suo progresso e nella sua durata. Ch’era la religione cristiana nel suo cominciamento, e come si è ella stabilita? Noi tutti lo sappiamo, e i suoi nemici negare non possono. Simile al piccolo grano della senapa, per servirmi delle parole del Vangelo e nello stesso tempo giustificarlo, questa religione non fu da principio conosciuta che in un piccolo angolo del mondo dove fu annunziata da un uomo povero ed abbietto nel suo esteriore, che non aveva alcun soccorso umano per attirar gli uomini al suo partito, che fu scacciato, disprezzato da quei medesimi tra i quali era nato. Quali uomini si associò Egli per lo stabilimento di questa religione? Non furono né conquistatori che con lo strepito delle loro armi abbiano portato il terrore tra le nazioni della terra, né sapienti che colla loro eloquenza abbiano trionfato degl’intelletti: se questo fosse stato, la religione si sarebbe riguardata come opera degli uomini. Si valse al contrario di ciò che vi era di più debole e di più abbietto per confondere e ridurre quanto vi era di più forte e di più grande. Furono dodici poveri, ignoranti, rozzi, deboli ed imperfetti, che non avevano né talenti né eloquenza né ricchezze. E che cosa insegnare dovevan agli altri questi uomini sì poco capaci d’istruirli? Una religione ripiena di oscurità, che propone misteri impenetrabili allo spirito umano, massime del tutto opposte alle inclinazioni più naturali, l’odio di sé medesimo, l’amore dei nemici, la mortificazione dei sensi, il crocifiggimento della carne. E a chi questi uomini insegnar dovevano questi misteri impenetrabili, queste massime ripugnanti? Non al semplice popolo soltanto, ma ai più grandi ingegni del mondo, ai re, ai potentati della terra, che avevano in orrore e la dottrina che loro si predicava e gli uomini che l’annunziavano; che il minacciavano dei supplizi più orribili, della morte più crudele. Ciò non pertanto, oh prodigio dell’ onnipotenza e della sapienza di Dio! Questa religione, benché impenetrabile alla mente umana, benché tutta spiacevole alle inclinazioni del cuore, è stata non solo annunziata ma persuasa al popolo e, quel che è più, ai sapienti, ai più dotti filosofi, che non erano capaci di lasciarsi sorprendere e che non l’avrebbero certamente abbracciata, se non avessero avute ragioni bastanti che li convincessero. Essa è stata annunziata, persuasa ai re, ai potentati più formidabili: essa ha fatto piegare sotto il suo giogo le teste coronate: essa è stata seguita, abbracciata da un’infinità di nazioni, le quali tutte varie di costumi, di carattere, di lingua, riunite si sono sotto i suoi stendardi, e questo non ostanti tutti gli ostacoli che formati si sono contro il suo stabilimento, malgrado tutte le persecuzioni che suscitate le hanno contro, alla vista dei supplizi orribili di cui si minacciavano i seguaci di lei, e a cui molti sono stati condannati. Il sangue stesso dei discepoli era come una semente che ne produceva un’infinità d’altri. E non bisogna dunque convenire ch’eravi in ciò del miracoloso, e che un tale cambiamento nell’universo non poteva essere che opera dell’onnipotenza di Dio? “A Domino factum est istud”. Imperciocché, per ragionare quivi con S. Agostino, o la conversione del mondo alla religione cristiana è stata la conseguenza e l’effetto dei miracoli, o si è fatta senza miracoli. Se questa conversione fu l’effetto dei miracoli, dunque Dio ne fu l’autore: se si è fatta senza miracoli, egli è il più grande dei miracoli che il mondo siasi convertito senza miracoli; e chi non vuol credere deve esser riguardato come un prodigio di incredulità. Ora è certo 1.° che la Religione non si è stabilita senza miracoli, perché la conversione dell’universo è un miracolo il quale suppone tutti gli altri. Infatti, come mai schiere innumerevoli di persone d’ogni stato, d’ogni sesso, d’ogni paese avrebbero abbracciato una religione sì impenetrabile nei suoi misteri, sì ripugnante nelle sue massime, non avessero avuto prove convincenti della sua verità? Negar non si può che gli Apostoli non abbiano convertito un gran numero di Giudei loro contemporanei. Ad essi primieramente fu annunziato il Vangelo; ne furono essi le prime conquiste, principalmente allorché alla festa della Pentecoste i giudei radunati da diversi paesi del mondo udirono predicar gli Apostoli e se ne convertirono più migliaia. Ora una conversione sì pronta e sì generale si sarebbe ella operata, se Gesù Cristo e gli Apostoli non avessero fatto alcun miracolo per persuadere la religione che predicavano? Poiché, se gli Apostoli avessero annunziato miracoli che Gesù Cristo non avesse operati, non avrebbero data loro la mentita quelli che, avendolo veduto, potevano rendere testimonianza del contrario? o se gli Apostoli stessi non avessero operati miracoli, li avrebbero creduti? li avrebbero seguiti? Giudichiamone da quanto sono per supporre: se qualche uomo della feccia del popolo dicendosi inviato da Dio, intraprendesse al giorno d’oggi a promulgare una nuova religione; che si associasse a quest’effetto dodici persone della sua medesima condizione, senza talenti, senza ricchezze, senza credito, che quest’uomo in odio della sua religione fosse messo a morte con un supplizio infame, e che né egli né i suoi seguaci avessero data altra prova della Religione che predicherebbero se non la loro semplice testimonianza, chi è che seguir vorrebbe questa religione, quand’anche fosse meno severa di quella che noi professiamo? Come dunque Gesù Cristo e gli apostoli avrebbero stabilita una religione sì austera sopra le rovine dell’idolatria, la quale favoriva tutte le passioni, se non avessero date altre prove che la loro semplice testimonianza, e se la forza della loro parola non fosse stata sostenuta, come dice s. Paolo, da quella dei prodigi? Non sono gli uomini sì facili a rinunziare ai loro primi pregiudizi; non si abbandona così facilmente e senza motivi tutto ciò che lusinga le naturali inclinazioni per abbracciare tutto ciò che vi è di più austero e di più malagevole. Giudichiamone da noi medesimi, i quali, benché istruiti e convinti delle verità di nostra religione, proviamo tanta fatica a seguirne le massime. I predicatori del Vangelo avrebbero avuto bel dire che predicavano la pura verità e che dovevasi loro prestar fede: ciascuno si sarebbe beffato di essi, nè li avrebbe alcuno seguiti giammai, se non avessero dati segni evidenti di una missione divina. Inoltre, come mai questi predicatori del Vangelo, come gli Apostoli intrapreso avrebbero di stabilire la loro dottrina a costo di quanto avevano di più caro della loro vita medesima? Come si sarebbero essi offerti a soffrire tutto il furor dei tiranni, il rigor dei supplizi più orrendi per sostenere una religione di cui avrebbero conosciuta la falsità? – Se Gesù Cristo che aveva dato per prova della sua missione il miracolo del suo risorgimento non fosse, siccome disse loro, risuscitato, come continuato avrebbero a seguir il partito di un uomo, il quale ingannati li avesse, non avendo essi alcun interesse di seguirlo, essendo all’opposto di loro grande vantaggio l’abbandonarlo, giacché si trattava della loro fortuna, della loro vita? Non sarebbe stato in essi un eccesso di follia e di stravaganza il sostenere, a sì gran costo un’insigne falsità? È egli credibile che gli Apostoli e tanti altri abbiano preso piacere a lasciarsi imprigionare, tormentare, crocifiggere per render testimonianza alla risurrezione di Gesù Cristo e alla verità della religione, se non ne avessero avute prove certe ed evidenti? Una testimonianza che tanto ha costato non deve essere per noi una prova invincibile che la religione cristiana si è stabilita per via di miracoli? – Se questa religione si è stabilita senza miracoli, ho detto in secondo luogo, ch’era il più grande dei miracoli, che ciò si sia fatto senza miracolo. E una più grande meraviglia, dice S. Giovanni Grisostomo, che dodici poveri pescatori, come erano gli Apostoli, abbiano convertito il mondo intero, che non se dodici uomini della feccia del popolo senza forze, senza danaro, senz’armi, senza equipaggi militari avessero intrapreso di far la conquista dell’impero romano, che dava la legge a tutta la terra, e ne fossero venuti a capo. Questa meraviglia è accaduta, noi la vediamo coi nostri occhi; non cerchiamo più altri miracoli. Infatti al vedere che, malgrado le guerre più sanguinose e crudeli che suscitate si sono contro la religione, ella si è stabilita con tanta rapidità e sostenuta con tanto successo, come se ciò accaduto fosse a forza d’eloquenza e d’armi; ch’ella ha estese le sue conquiste con la povertà della croce più lungi che i Cesari non hanno estesi i confini del loro impero con armate formidabili e milioni di soldati, si può egli non riconoscervi l’opera dell’onnipotenza di Dio? Al vedere che questa religione è stata abbracciata cosi universalmente, che ha durato sì lungo tempo, malgrado la severità delle sue massime cotanto ripugnanti alla natura, dobbiamo conchiudere che Dio solo poteva assoggettare in tal modo lo spirito ed il cuore dell’ uomo. – Se questa religione era opera d’uomini, sarebbe ben presto caduta da sé stessa; ben presto il mondo se ne sarebbe annoiato. Questo è il ragionamento che faceva un famoso dottor della legge tra i Giudei radunati per condannare a morte gli Apostoli. “Se questa impresa, diceva loro, è opera d’uomini; essa cadrà da sé stessa, siccome abbiamo veduto cadere altre sette; ma se è opera di Dio, invano tentate distruggerla; essa sussisterà vostro mal grado. Ora se, per testimonianza di un nemico dichiarato della religione cristiana, potevasi riguardare come opera di Dio ove si fosse sostenuta anche senza contraddizione, tanto più deve ella esser riguardata per tale dopo di aver sostenuto tutto il fuoco delle persecuzioni e sofferta tutta la violenza delle tempeste. Io domando ad ogni men ragionevole se questo non è portare un carattere di divinità e se tutt’altra autorità, fuorché quella di Dio, poteva in tal modo sottoporre i cuori degli uomini alle più severe leggi, alle massime più ripugnanti: “A Domino factum est istud”. – No, non possiamo ricusare di seguire una religione che mostrasi con tanto splendore sia dell’adempimento delle sue profezie, sia nell’evidenza dei suoi miracoli, sia nel suo prodigioso stabilimento. Se noi restiamo ingannati seguitandola, sopra Dio ricadrebbe il nostro errore, poiché la sua verità è stabilita sopra tante prove capaci ad appagar la ragione, che Dio ci ha dato per condurci. O non vi è in Dio provvidenza alcuna, e ci ha dato lumi fallaci per giudicar delle cose; o se vi è una provvidenza ed una retta ragione nell’uomo, bisogna necessariamente convenire della verità della religione cristiana.
Santità della religione. Aggiungiamo ancora un tratto di verità, che il carattere di santità di cui è munita la religione nostra, che riguardar si deve come un carattere di divinità. Vi fu mai infatti religione sì santa nel suo Autore, nella sua dottrina, nei suoi seguaci? Vediamolo partitamente, e ne resteremo ben presto convinti. L’autore della religione cristiana è Gesù Cristo, l’uomo più santo che sia stato giammai. Uno sguardo sulla storia della sua vita ci fa vedere l’innocenza più pura, lo staccamento più universale, 1’umiltà più profonda, la mansuetudine più inalterabile, la purità più esatta, la mortificazione più austera, la condotta più irreprensibile, in una parola, le virtù più eroiche. Si diportò durante tutta sua vita mortale in un modo sì santo e sì edificante che non temeva di sfidare i suoi nemici a fargli il minimo rimprovero: Quis ex vobis arguet me de peccato? non sono solamente i suoi storici, i suoi discepoli, ma ancora i suoi nemici hanno reso testimonianza alla sua santità. Quantunque 1’abbiano accusato avanti ai giudici per farlo condannare, l’esame più critico non trovò giammai motivo di condanna sopra le sue azioni ; Pilato stesso non poté tenersi dal riconoscere la innocenza dì Lui; “Nullam Invenio in eo causam”. La fama ed il grido della santità di Lui aveva fatta tanta impressione sopra lo spirito dei pagani medesimi, i quali lo conoscevano, che un imperatore romano propose in senato di metterlo nel numero degli Dei, Giuseppe ebreo, storico non sospetto, lo riguarda carne uomo divino. Maometto stesso gli dà la qualità di gran profeta. Ma lasciamo questi elogi stranieri per venire a quello che merita la santità della dottrina di Lui. Qual dottrina ci ha Egli insagnata nel suo Vangelo! Che purità nella sua morale! Che perfezione nelle massime che la compongono! Questa dottrina non solo condanna tutti i vizi, ma abbraccia ancora la pratica di tutte le virtù. Non solo condanna i vizi più gravi e che da sè stessi fanno orrore alla natura, come l’omicidio, il furto, l’adulterio; ma ancora i mancamenti più leggieri, così i vizi che si formano nel cuore come quelli che si manifestano al di fuori. Essa proibisce sino i cattivi desideri, sino lo stesso pensar male. – Vuole questa santa religione che il cuore dell’uomo sia talmente regolato che soffochi sino i primi principi, sino i primi sentimenti del male, Non vuole che si conservi il minimo risentimento e neppure l’indifferenza contro del suo prossimo; che alcuno si fermi anche ad un solo pensiero contrario alla modestia. Si può portar più lungi l’odio e l’orrore del peccato? Essa abbraccia la pratica di tutte le virtù e di tutti i doveri riguardo a Dio, al prossimo è a sé stesso. Riguardo a Dio, ella prescrive il culto più perfetto, i sacrifici più grandi, le cerimonie più maestose nel divino servizio. Riguardo al prossimo, l’amore più sincero e più efficace; amore che deve portarsi sino ad amare i suoi più crudeli nemici, sino a fare del bene a quelli che ci fan del male, sino a pregare pei propri persecutori. Vi è forse un’altra religione, fuorché quella rivelata da Dia, che possa portare l’uomo ad atti sì eroici? Riguardo a noi medesimi, quali sono mai i doveri che questa santa religione ci prescrive? Un intero staccamento dai beni del mondo; una rinunzia perfetta ai piaceri del senso, un generoso dispregio degli onori, e della gloria del secolo, la pazienza nelle afflizioni, l’amore delle umiliazioni e dei patimenti, 1’abnegazione di sé stesso, una mortificazione continua dei sensi e delle passioni. Un altra religione, ripeto, fuorché quella rivelata da Dio poteva portar l’uomo ad una perfezione sì alta? Possiamo, leggendo il Vangelo, non convenire che la dottrina in essa contenuta è venuta dal cielo ed è stata dettata da una sovrana sapienza? Sente ciascuno, anche suo malgrado, che la morale di essa viene da Dio ed a Dio conduce, che non possiamo temere d’ingannarci seguitandola e che dobbiamo tutto sperare osservando i suoi precetti. – Lo splendore della sua santità fu quello ancora che le attirò un si gran numero di discepoli, e la santità dei suoi discepoli non ebbe minor forza per propagarla di quel che abbia avuto l’autenticità dei suoi miracoli. E nel vero qual sono stati i discepoli della religione? Qual vita santa non hanno essi menata? Leggiamo le vite dei santi che hanno edificato il mondo coi loro esempi. Voi vi vedrete uomini sì staccati dai beni del mondo che rinunziavano a tutto e vendevano tutto quel che avevano per darlo ai poveri, che amavano il loro prossimo sino a perdonare le ingiurie più atroci ed abbracciare i carnefici che li facevano morire; che si davano interamente a tutti i rigori della penitenza; che ancor vivi si seppellivano nelle solitudini per non occuparsi che di Dio e della speranza di un’eterna felicità. E quante ancora ne vediamo di queste anime generose che fanno simili sacrifici! Quante anime sante che rinunziano a tutte le speranze del secolo per prendere il partito del ritiro, dove menano una vita più angelica che umana! Quanti in mezzo al mondo medesimo si vedono ancora fedeli cristiani che seguitando i sentimenti della loro religione, adempiono con edificazione tutti i doveri che loro impone; che sono poveri nell’abbondanza, umili negli onori, pazienti nelle afflizioni, sobri, casti, temperanti, e che perdonano le ingiurie e gli affronti più atroci. Se tutti i discepoli della religione non sono tali non bisogna ad essa imputarlo, ma bensì alle malvagie disposizioni di coloro che non vogliono seguirne le massime. Se tutti seguissero queste massime sante e salutevoli, la società dei cristiani sarebbe la più perfetta e la più felice: sarebbe una società di santi i quali non avrebbero che un cuore ed un’anima sola; dove non vi sarebbero né dispute né contese sopra i beni e gli onori del mondo, dove i ricchi non si solleverebbero con orgoglio sopra i poveri; dove i poveri riceverebbero dai ricchi tutti gli aiuti necessari alle loro miserie; dove ciascuno, in una parola, sarebbe a gara premuroso di prevenirsi, di rendersi servigio gli uni agli altri. Tali furono i primi discepoli che la religione formò, e fu il loro esempio che attirò al seno di lei un sì gran numero d’idolatri, i quali non potevano persuadersi che una religione che regolava sì bene la società e portava gli uomini a sì gran virtù non fosse una religione inspirata od emanata dal cielo. I nemici che l’attaccano le renderebbero al giorno d’oggi la medesima testimonianza, se non fossero accecati dalle loro sregolate passioni, che molestate si trovano dalla severità del Vangelo, del quale non per altro motivo si sforzano di scuotere il giogo che per vivere a loro capriccio. Ma in ciò ancora rendono essi, senza volerlo, testimonianza alle verità della fede; poiché non rigettano la religione se non perché si oppone alle loro inclinazioni perverse, prova certissima ch’ella è santa e che viene da Dio, il quale è il principio di ogni santità. Siamo santi, siamo ragionevoli, e persuasi saremo facilmente della verità della religione. Questo è il migliore ed il più sicuro partito che l’uomo possa prendere per esser tranquillo, felice e contento anche in questa vita, lo non chiedo all’incredulo che una seria riflessione su questo punto per determinarlo a sottoporsi al giogo della religione. Vedrà egli senza fatica che il cristiano è più prudente e più ragionevole di lui, e che gli torna più conto il seguir il partito della religione che il combatterla e rigettarla. – Infatti ragioni l’incredulo, l’empio, il libertino quanto gli piacerà sopra la religione; metta in dubbio, neghi pure le verità più sodamente stabilite, inventi sistemi a suo grado per combattere i misteri delle fede: oltreché egli cade in assurdi più incomprensibili che i misteri medesimi ch’ei vuole combattere, qualunque sistema possa egli immaginare per mettere al coperto le sue passioni, non potrà giammai assicurarsi contro i terrori che una religione conforme al buon senso deve ispirargli. Derida pure la credenza del fedele; cerchi pure qualche apparenza di ragione per accecarsi e far illusione a se stesso sopra le terribili verità che non vuol credere; ardisco sfidarlo che, con tutte le sue sottigliezze, i suoi raggiri, le sue critiche maligne sopra la religione arrivi a persuadersi ch’ella non è vera. Tutto quel che può fare si è di negare, di dubitare, di combattere con qualche sofisma le verità sante che noi crediamo; ma potrà egli mai avanzare qualche cosa di positivo e di certo che le distrugge? Imperciocché, per persuadersi che la religione è falsa, converrebbe far vedere ad evidenza che tutto ciò che si dice della sua propagazione miracolosa, dei prodigi operati da Gesù Cristo, dagli Apostoli e dai suoi seguaci non è vero. E come mai il proverebbe l’incredulo? È egli forse stato in tutti i luoghi ed in tutti i tempi in cui le cose sono accadute, per scoprire l’inganno, se stato vi fosse, e per rigettare come falsi tutti quei fatti? Non vi è per lo meno altrettanto fondamento di credere tutto ciò che ne vien riferito che di non crederlo? Quanto dunque potrebbe guadagnare di più l’incredulo sarebbe di dubitare e di un dubbio assai malfondato. Non andrà mai più lungi, qualunque sforzo possa fare la sua mente e qualunque sistema possa egli immaginare. Già in questo dubbio, io domando, chi dei due è il più tranquillo? il cristiano, che ha la fede, o l’incredulo, che non l’ha? Egli è facile il provare che il cristiano; perciocché o la nostra religione è vera, o tale non è. Se essa non è vera, se quanto ci si dice delle ricompense e dei castighi di un’altra vita è falso, se non v’è né paradiso né inferno, il cristiano nulla arrischia nel crederlo poiché, se non ve n’è alcuno, non arrischia punto di essere eternamente infelice. Ma se la religione cristiana è vera, come è dimostrato da tutte le prove che si sono date e che sono capaci di appagare qualunque spirito ragionevole, voi, o empi, voi, o increduli, aspettar vi dovete di essere un giorno rinchiusi in quel luogo d’orrore e di disperazione che sarà il soggiorno dei peccatori, voi attender dovete di provare a vostro danno ciò che la religione mi obbliga di credere su questo soggetto. Qualunque ragione allegar possiate per giustificare la vostra condotta, dubitare per lo meno dovete di correr ogni rischio di una eterna disgrazia col non prendere il partito migliore per evitarla. Ora, in un dubbio ed in un rischio si grande come questo, può alcuno essere felice e tranquillo? E il cristiano che crede ed opera conformemente alla sua credenza non è egli più saggio e più tranquillo che colui che non crede? Si priva, è vero, il cristiano di qualche piacere che trova il libertino nell’appagar le sue passioni, ma non è forse meglio privarsi di qualche piacere passeggero per assicurarsi una felicità eterna, che mettersi al pericolo di uno stato eternamente infelice, per goder d’un piacere che a guisa d’un baleno svanisce ? Per poco che voglia l’incredulo rientrar in se stesso lo sfido a poter calmare i rimorsi della sua coscienza ed esser tranquillo sopra il timore d’una eternità infelice. Imperciocché, cosi deve dir tra sé stesso, se la religione cristiana è vera, ed io non la seguito, l’inferno sarà dopo questa vita la mia sorte; almeno corro rischio di precipitarmivi. Or questo pensiero, quest’agitazione, questo timore, che è sì ben fondato, non è egli capace d’intorbidare tutti i piaceri? Non ha forse qualche cosa di più amaro che i piaceri non hanno di dolce? Qualunque cosa l’empio possa fare, dire o pensare, l’infelicità avvenire non dipende dalle sue idee: sebbene non la creda, non è perciò men vera, e deve per lo meno temere di cadervi. Invano vorrebbe assicurarsi contro se stesso, la fede metterà sempre il terrore nel suo cuore. Or vi è piacere al mondo che possa uguagliare questo timore, o si può godere di qualche tranquillità in questo stato? Laddove il cristiano privo dei piaceri vietati, oppresso, se il volete, dai mali della vita, se ne sta tranquillo sopra la sua eterna sorte e può dire a se stesso: i mali di questa vita passeranno; ma se la religione che professo è vera, come ho tutto il fondamento di credere, io sarò ben ricompensato con un bene eterno, che mi è serbato nel cielo. Il cristiano dunque non arrischia che di soffrire per qualche tempo e non per un’eternità, egli sacrifica poco per aver molto, ed anche non sacrifica che piaceri che Dio gli proibisce; anzi gode egli, mentre vive di qualche soddisfazione permessa: laddove l’incredulo, 1’empio sacrifica tutto per aver poco, si espone ad una miseria eterna per alcuni piaceri d’un momento, di cui non gli resta altro che una trista rimembranza. Or io domando: chi dei due è il più saggio ed il più contento? Ah! per poco che l’incredulo abbia a cuore i suoi veri interessi, sarà ben tosto il discepolo di una religione che tutti rende beati i suoi seguaci, All’ora della morte soprattutto noi l’aspettiamo per sapere che cosa penserà. Potrà egli allora esser tranquillo sopra i sistemi che ha avuto durante sua vita? Potrà persuadersi che la sua anima morrà insieme col corpo e che non debba essa comparire avanti ad un Giudice supremo che deciderà della sua eterna sorte? Persisterà egli a credere che la religione non è che un pregiudizio della nascita e della educazione? O piuttosto non riconoscerà egli forse che questo preteso pregiudizio era appoggiato con giudizio sopra un sodo fondamento? Oh allora si che le passioni ammorzate daranno luogo alla religione, che si risveglierà e si mostrerà in tutta la sua forza ed in tutto lo splendore della sua verità! Oh allora si che questi pretesi spiriti forti diverranno deboli in faccia allo spavento di un giudizio terribile che li minaccia e li aspetta! Vorrebbe allora l’incredulo aver creduto e vissuto da buon cristiano. Ve ne ha ben pochi che non chiamino allora la religione in loro soccorso e non cerchino nei rimedi ch’ella offre al peccatore di che assicurarsi contro un avvenire infelice. – Ma è troppo tardi aprir gli occhi quando le tenebre son venute, e farsi a viaggiare quando il sole è tramontato, lo non domando ai nemici della religione che di essere ragionevoli e di aver a cuore i loro veri interessi per seguir il partito.
TERZA VERITÀ’.
La vera religione non si trova che nella
Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana.
Dimostrata la necessità d’una religione rivelata e la verità della religione cristiana, è cosa facile provare che nella sola Chiesa Romana si trova la vera religione. E che sia la verità, gl’increduli medesimi, che irresoluti sono sul partito della religione, convengono non esser d’ uopo di seguirne alcuna; ma che, se devesi seguirne una, alla sola religione romana bisogna attaccarsi, perché nelle altre tante falsità e varietà s’incontrano che riguardar non si possono come religioni da Dio rivelate. – Non tratteremo noi questo punto in tutta l’estensione con che trattar si potrebbe: ne daremo soltanto alcune prove principali, capaci di convincere ogni spirito ragionevole. La Religione è la strada che dee condurci a Dio ed il mezzo di cui Iddio vuol servirsi per salvare gli uomini. In conseguenza questa religione non ha potuto esser nascosta, ma ha dovuto e deve ancora essere conosciuta e manifestata da segni che visibile la rendano a coloro che vogliono e debbono abbracciarla per esser salvi. Imperciocché come mai si potrebbe seguire, se non si conoscesse? É dunque necessario che vi sia una società d’uomini che ne facciano professione pubblica e che insegnar la possano a quelli che l’ignorano. In questa società esser vi debbono capi rivestiti dell’autorità di Dio, i quali possano condurla, ossia per istruire gl’ignoranti e i semplici che fanno il maggior numero e che capaci non sono di giudicare né di determinarsi da sé stessi sopra i punti della loro credenza, ossia per finire le dispute tra le persone dotte che pensano differentemente sopra la Religione, che spesse volte si ostinano nelle opinioni le più contrario alla fede e al buon senso e che hanno bisogno, come il semplice popolo, di un’autorità suprema ed infallibile la quale corregga i loro pregiudizi, fissi la loro incertezza e la riduca all’unità della fede. Se Dio non avesse stabilito nella Religione un tribunale infallibile per decider le differenze tutte che ad ogni momento insorgono tra gli uomini, la sua provvidenza avrebbe loro mancato in un punto essenziale; vi sarebbero state altrettante religioni, quanti spiriti privati, che a loro talento ne avrebbero spiegato i dogmi: assurdità che non si può ammettere in modo alcuno. – Or questa società d’uomini condotti da capi rivestiti dell’ autorità di Dio o, per meglio dire, questi capi medesimi che conducono la società dei fedeli son ciò che noi chiamiamo la Chiesa. Essa è che conserva il deposito della Religione, colonna della verità e regola di nostra fede; essa è, secondo l’oracolo di Gesù Cristo, quella città posta sul monte alla vista di tutto il mondo, in cui le nazioni tutte della terra possono radunarsi. Essa è la fiaccola collocata sul candeliere per illuminar tutti i popoli; e coll’aiuto di questa fiaccola possiamo noi camminare con sicurezza negli oscuri sentieri della fede. Ma tra tutte le società che si vantano al giorno d’oggi di seguitare la religione cristiana, dove troveremo noi questa vera Chiesa depositaria degli oracoli di Gesù Cristo ed appoggio della verità? Non ne cerchiamo altra fuorché la Chiesa Romana, di cui noi siamo i figliuoli. Essa sola, ad esclusione di tutte le altre sette, può gloriarsi di essere la vera Chiesa di Gesù Cristo. Ed invero qual è la Chiesa di Gesù Cristo? È quella ch’Egli stesso ha fondata, di cui ha dato il governo ai suoi Apostoli e stabilito per capo s. Pietro principe degli Apostoli, allorché gli disse: Tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell’inferno non prevarranno giammai contro di essa: “Tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo ecclesiam meam; et portæ inferi non prævalebunt adversus eam”. Questa Chiesa non è stabilita per un qualche tempo; essa deve durare sino alla consumazione dei tempi, professando sempre la medesima fede. Dunque bisogna che, non essendo sulla terra s. Pietro e gli Apostoli per governare la Chiesa, i loro successori abbiano la stessa autorità per conservare il sacro deposito della fede; altrimenti Gesù Cristo avrebbe abbandonata la sua Chiesa all’errore e alla menzogna. Ma chi sono i successori di s. Pietro e degli Apostoli? Sono i Sommi Pontefici e i Vescovi. Dunque hanno ricevuto nella loro persona la giurisdizione e l’autorità infallibile per governare la chiesa di Roma. Qual altra società, fuorché la chiesa di Roma, può vantarsi di avere la successione degli Apostoli e dei primi pastori? La tradizione e la Storia di tutti i secoli ne sono una prova convincente. Sappiamo l’origine di tutte le sette, il tempo in cui hanno incominciato senz’avere alcuna missione; nel loro stabilimento mostrano esse un carattere di divisione e di falsità. Avanti la nascita di queste sette dunque sussisteva la Chiesa Romana; essa era la vera Chiesa: altrimenti converrebbe dire che pel corso di più secoli non v’è stata alcuna Chiesa visibile; il che è contro l’oracolo di Gesù Cristo, che ha stabilita la sua durata sino alla consumazione dei secoli. – Non è forse la Chiesa di Roma quella che fu sempre vittoriosa di tutte le eresie che insorte sono nel mondo dopo lo stabilimento della Religione Cristiana? Quanti di questi mostri non ha Ella atterrati, di cui più non si vede vestigio alcuno? Per confessione dei suoi nemici medesimi, Ella è stata nei primi secoli riconosciuta per vera. Ora, se essa è stata tale nel suo cominciamento, deve sempre esserlo; perché, secondo l’oracolo di Gesù Cristo, le porte dell’inferno prevaler non possono contro la vera Chiesa: il che sarebbe nulladimeno avvenuto; se la Chiesa di Roma fosse caduta nell’errore. Ma no: 1’oracolo di Gesù Cristo sussisterà sempre, sarà egli sempre colla sua Chiesa come ha promesso, sino alla consumazione dei secoli. Dobbiamo noi dunque ascoltare la voce dei pastori i quali governano questa Chiesa come la voce di Gesù Cristo medesimo; disprezzar questa voce si è disprezzare quella di Gesù Cristo, come Egli stesso ce ne assicura: “Qui vos spernit, me spernit”. Se i Pastori della Chiesa ci ingannassero, sopra Gesù Cristo medesimo ricadrebbe questo errore, poiché sono stati da Lui stesso destinati a condurci: “Posuit episcopos regere ecclexiam Dei”. Ora Gesù Cristo non può ingannarci, né per conseguenza la Chiesa, che è suo oracolo. Tale si è la regola che i grandi uomini han sempre seguita, come un S. Agostino, un S. Girolamo. Il primo aveva tanto rispetto per l’autorità della Chiesa che protestavasi che senza di essa non presterebbe fede alcuna allo stesso Vangelo: “Ego Evangelio non crederem, nisi me moveret Ecclcsiæ auctoritas”; poiché, a dir vero, si è per l’autorità della Chiesa che noi siamo assicurati essere il Vangelo la parola di Dio. Più cose, diceva questo santo dottore, mi ritengono nel seno della Chiesa: la successione dei pastori non interrotta, l’autorità confermata dai miracoli, la conformità di dottrina dei secoli presenti con quella dei secoli primitivi, lo mi unisco, diceva S. Girolamo, colla cattedra di S.Pietro: chiunque non è nella sua nave, è sicuro di naufragare. Tralascio per brevità molte e molte altre autorità di egual peso. – Finalmente, per ristringere in poche parole quanto sin qui abbiamo detto, la santa Chiesa Romana possiede sola i caratteri della vera Chiesa, i quali non si trovano in verun’altra società, e sono l’antichità, l’infallibilità, la santità. Carattere di antichità: ella sussiste da Gesù Cristo in poi per una successione di pastori che ha durato sino a noi. Carattere d’infallibilità, che Gesù Cristo le ha dato e che le conserverà sino al fine dei secoli: dal suo tribunale tutti gli errori che sono comparsi nel Cristianesimo hanno ricevuta la loro condanna. Carattere di santità: egli è in questa Chiesa che s’insegna la morale più perfetta e che si trovano i mezzi più sicuri per giungere alla più alta santità. Dal suo seno sono uscite quelle schiere innumerabili di martiri che han sigillato col loro sangue le verità della fede; quel gran numero di dottori che hanno illuminato il mondo col loro sapere ed i cui scritti vengono dai nemici medesimi della Chiesa ammirati ed adottati. E non appartiene finalmente a questa Chiesa quella prodigiosa moltitudine di santi d’ogni stato, i quali dai primi secoli sino a noi hanno edificato il mondo colla loro virtù, e la cui memoria è in venerazione in tutto il mondo cristiano? Questi santi sono stati della comunione della Chiesa Romana, sono stati suoi allievi, suoi figliuoli. Si può a questi tratti non riconoscerla per la vera Chiesa? E se è la vera Chiesa, dunque essa sola è depositaria della vera Religione e la regola di nostra fede, regola infallibile che deve terminar tutte le differenze sopra gli articoli della Religione. E però non prima la Chiesa ci propone qualche verità a credere ovvero condanna alcun errore, noi dobbiamo sottometterci, credere senza esitare ed interdirci ogni, disputa: l’umiltà cristiana c’insegnerà questa sommissione di spirito e di cuore; il solo orgoglio negli uni e il diletto di carità negli altri rendono perpetue tra di noi queste dispute. Convinti che obbedire alla Chiesa è lo stesso che obbedire a Dio, temiamo di porre limiti alla nostra obbedienza per voler troppo accordare al nostro proprio sapere. – Quando la Chiesa ha parlato, tutto è finito; altro partito a prendere non ci resta che una intera sommissione: ora noi dobbiamo questa sommissione alla Chiesa, ossia che Ella c’istruisca con la voce dei pastori radunati in Concilio, oppure dispersi nelle loro sedi, perciocché fanno sempre un corpo medesimo con Gesù Cristo, che è il Capo invisibile della Chiesa, ed essi sono si nell’uno che nell’altro caso la voce di Dio. Di più Gesù Cristo ha promesso di esser sempre colla sua Chiesa sino alla consumazione dei secoli: ora i pastori non sono sempre radunati insieme; dunque hanno la medesima autorità essendo dispersi. Un’altra prova: la Chiesa radunata non ha autorità se non in quanto che rappresenta la Chiesa dispersa: ma chi rappresenta un altro non può avere maggiore autorità di lui: dunque la Chiesa dispersa è un giudice infallibile, come la Chiesa radunata. – Eccovi prove bastanti per soddisfare qualunque spirito ragionevole, il quale altro non cerca che la verità. Quantunque la fede ci presenti misteri impenetrabili allo spirito umano, Iddio li ha resi credibili questi misteri con l’evidenza della rivelazione e con l’autorità, ch’Egli ha dato alla sua Chiesa per assicurarci della sua divina parola. – L’oscurità dei misteri la il merito della fede, l’evidenza della rivelazione rende ragionevole il nostro ossequio. Non si lamenti dunque l’incredulo che Dio esiga da lui una sommissione cieca e tirannica, poiché egli nulla chiede di contrario alla ragione e ci permette di valerci della nostra ragione per sottometterci al giogo della fede. Conveniva forse, per credere i misteri, che Dio li mettesse in tale evidenza che tolto ci avesse il merito della fede? Perciocché qual merito vi è a credere ciò che comparisce evidente e facilmente si comprende? Bastava dunque che la rivelazione di questi misteri fosse posta in tale evidenza da non potere essere rigettati senza colpa. Ecco quanto poteva l’uomo domandare da Dio. Ha egli forse diritto di non credere misteri impenetrabili alla mente umana, perché non li comprende? Ma quanti segreti nella natura in cui siamo astretti a confessare la nostra ignoranza! Sarebbe alcuno ben fondato a non crederli perché non li comprende? Teniamoci dunque entro i limiti del nostro corto intendimento, camminiamo con la semplicità della fede per le strade in cui ella ci conduce; poiché non possiamo trovare felicità se non nella sommissione ad una Religione che è si conforme al buon senso: “Beati qui non viderunt et crediderunt”. Invano l’incredulo cercar vorrebbe questa soda felicità negli oggetti creati, nei piaceri dei sensi; non vi troverà mai onde soddisfare pienamente i suoi desideri, e mancherà sempre qualche cosa nel suo cuore che gli impedirà di essere interamente felice. Questo cuore, che è infinito nei suoi desideri, sospirerà sempre per tutt’altra felicità che quella di quaggiù, ne troverà giammai una stabile assicuranza che nella sommissione alle verità della fede e nella pratica delle sue massime, il che fa la vera pace dell’anima; egli è impossibile trovarne una più pura e più vera. Invitiamo gl’increduli a farne l’esperienza; non potranno tenersi dal rendere giustizia ala verità, si risparmieranno il timore di un’eterna miseria, e troveranno nella fede la consolazione più soda contro le amarezze della vita presente ed un pegno sicuro della felicità della vita avvenire. Cosi sia.

… et IPSA conteret caput tuum!