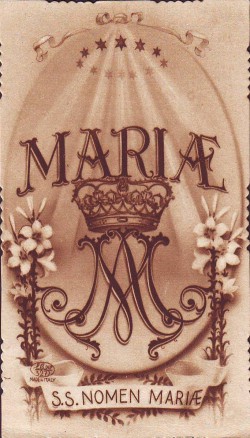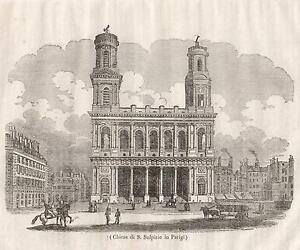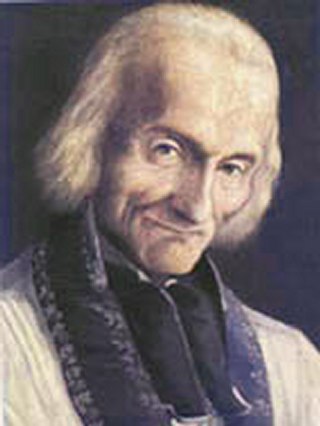CHAINE D’OR SUR LES PSAUMES
ou LES PSAUMES TRADUITS, ANALYSÉS, INTERPRÉTÉS ET MÉDITÉS A L’AIDE D’EXPLICATIONS ET DE CONSIDÉRATIONS SUIVIES, TIRÉES TEXTUELLEMENT DES SAINTS PÈRES, DES ORATEURS ET DES ÉCRIVAINS CATHOLIQUES LES PLUS RENOMMÉS.
[I Salmi tradotti, analizzati, interpretati e
meditati con l’aiuto delle spiegazioni e delle considerazioni seguite, tratte
testualmente dai santi Padri, dagli oratori e dagli scrittori cattolici più
rinomati da …]
Par M. l’Abbé
J.-M. PÉRONNE,
CHANOINE TITULAIRE DE L’ÉGLISE DE SOISSONS, Ancien Professeur d’Écriture sainte et d’Éloquence sacrée.
TOME PREMIER.
PARIS
LOUIS
VIVES, LIBRAIRE-ÉDITEUR RUE DELAMMIE, 13
1878
IMPRIM.
Soissons, le 18 août 1878.
f ODON, Evêque de Soissons et Laon.
SALMO XXX
[1] In finem. Psalmus David, pro extasi.
[2] In te, Domine, speravi; non confundar in aeternum;
in justitia tua libera me.
[3] Inclina ad me aurem tuam; accelera ut eruas me. Esto mihi in Deum protectorem, et in domum refugii, ut salvum me facias:
[4] quoniam fortitudo mea et refugium meum es tu; et propter nomen tuum deduces me et enutries me.
[5] Educes me de laqueo hoc quem absconderunt mihi, quoniam tu es protector meus.
[6] In manus tuas commendo spiritum meum; redemisti me, Domine Deus veritatis.
[7] Odisti observantes vanitates supervacue; ego autem in Domino speravi.
[8] Exsultabo, et laetabor in misericordia tua, quoniam respexisti humilitatem meam; salvasti de necessitatibus animam meam.
[9] Nec conclusisti me in manibus inimici; statuisti in loco spatioso pedes meos.
[10] Miserere mei, Domine, quoniam tribulor; conturbatus est in ira oculus meus, anima mea, et venter meus.
[11] Quoniam defecit in dolore vita mea, et anni mei in gemitibus. Infirmata est in paupertate virtus mea; et ossa mea conturbata sunt.
[12] Super omnes inimicos meos factus sum opprobrium, et vicinis meis valde, et timor notis meis; qui videbant me foras fugerunt a me.
[13] Oblivioni datus sum, tamquam mortuus a corde. Factus sum tamquam vas perditum;
[14] quoniam audivi vituperationem multorum commorantium in circuitu. In eo dum convenirent simul adversum me, accipere animam meam consiliati sunt.
[15] Ego autem in te speravi, Domine; dixi: Deus meus es tu;
[16] in manibus tuis sortes meae: eripe me de manu inimicorum meorum, et a persequentibus me.
[17] Illustra faciem tuam super servum tuum; salvum me fac in misericordia tua.
[18] Domine, non confundar, quoniam invocavi te. Erubescant impii, et deducantur in infernum;
[19] muta fiant labia dolosa, quae loquuntur adversus justum iniquitatem, in superbia, et in abusione.
[20] Quam magna multitudo dulcedinis tuæ, Domine, quam abscondisti timentibus te! Perfecisti eis qui sperant in te, in conspectu filiorum hominum.
[21] Abscondes eos in abscondito faciei tuae, a conturbatione hominum; proteges eos in tabernaculo tuo, a contradictione linguarum.
[22] Benedictus Dominus, quoniam mirificavit misericordiam suam mihi in civitate munita.
[23] Ego autem dixi in excessu mentis meae: Projectus sum a facie oculorum tuorum: ideo exaudisti vocem orationis meae, dum clamarem ad te.
[24] Diligite Dominum, omnes sancti ejus, quoniam veritatem requiret Dominus, et retribuet abundanter facientibus superbiam.
[25] Viriliter agite, et confortetur cor vestrum, omnes qui speratis in Domino.
[Vecchio Testamento secondo la VolgataTradotto in lingua italiana da mons. ANTONIO MARTINI Arciv. Di Firenze etc.
Vol. XI
Venezia, Girol.
Tasso ed. MDCCCXXXI]
SALMO XXX
Per la fine, salmo di David per la festa
2. In te ho posta, o Signore, la mia speranza, non resti io confuso giammai; salvami tu che sei giusto.
3. Piega le tue orecchie verso di me; affrettati a liberarmi. Sii tu a me Dio protettore, e casa di asilo per farmi salvo.
4. Imperocché mia fortezza e mio rifugio
sei tu; e pel nome tuo sarai mia guida, e mi darai il sostentamento.
5. Mi trarrai fuori da quel laccio, che
mi han teso occultamente, perché tu sei mio protettore.
6. Nelle mani tue raccomando il mio spirito; tu mi hai redento, o Signore Dio di verità.
7. Tu hai in odio coloro che, senza prò, vanno dietro alle vanità. Ma io sperai nel Signore;
8. Esulterò, e mi rallegrerò nella tua misericordia. Perocché tu gettasti lo sguardo sopra la mia abbiezione, salvasti dalle angustie l’anima mia.
9. Né mi chiudesti tra le mani dell’inimico; apristi spazioso campo a’ miei piedi.
10. Abbi misericordia di me, o Signore, perché io sono afflitto; per l’indignazione è turbato il mio occhio, il mio spirito e le mie viscere.
11. Perché nel dolore si va consumando la vita mia, e ne’ gemiti gli anni miei.
Si è infiacchita nella miseria la mia fortezza, e le ossa mie sono in tumulto.
12. Presso tutti i miei nemici son divenuto argomento di obbrobrio, e massime pei miei vicini, e argomento di timore pe’ miei familiari. Quelli, che mi vedevano, fuggivan lungi da me;
13. Si scordaron di me in cuor loro, come d’un morto. Fui stimato qual vaso rotto:
14. Perocché io udiva i rimproveri di molti, che mi stavano intorno. Quando si radunarono contro di me, consultarono di por le mani sulla mia vita.
15. Io però in te sperai, o Signore; io
dissi: Tu se’ il mio Dio.
16. Nelle mani tue la mia sorte. Strappami
dalle mani dei miei nemici, e di coloro che mi perseguitano.
17. Splenda il chiarore della tua faccia
sopra il tuo servo: salvami nella tua misericordia.
18. Ch’io non sia confuso, o Signore, perocché ti ho invocato. Sieno svergognati gli empi e condotti all’inferno.
19. Ammutoliscano le labbra ingannatrici;
Le quali perversamente parlano contro del giusto per superbia e disprezzo.
20. Quanto è grande, o Signore, la molteplice bontà, che tu ascosa serbi per coloro che ti temono! E la hai tu dimostrata perfettamente, a vista dei figliuoli degli uomini, con quelli che sperano in te.
21. Li nasconderai nel segreto della tua faccia dai turbamenti degli uomini. Li porrai in sicuro nel tuo tabernacolo dalla contraddizione delle lingue.
22. Benedetto il Signore, poiché la sua
misericordia mostrò a me mirabilmente nella forte città.
23. Ma nella costernazione dell’animo mio io dissi: Sono stato rigettato dalla vista degli occhi tuoi. Per questo tu esaudisti la mia orazione, mentre io alzava a te le mie grida.
24. Santi del Signore, voi tutti amatelo; perché il Signore sarà fautore della verità, e renderà misura colma a coloro che operano con superbia.
25. Operate virilmente, e si fortifichi
il cuor vostro, o voi tutti che nel Signore avete posta speranza.
Sommario
analitico
Davide, circondato e oppresso da
ogni lato dai suoi nemici, abbandonato dai suoi amici ai tempi della
persecuzione di Saul o di Assalonne, è figura che la Chiesa applica – in questo
salmo – di Gesù Cristo in croce, così come di ogni Cristiano in preda alle
persecuzioni della carne, del mondo e del demonio.
I – Egli prega Dio di venire in suo soccorso nel pericolo estremo in cui si trova, e porta come motivo in appoggio alla sua preghiera:
1° Gli attributi di Dio: a) il suo titolo di sovrano Signore e maestro; b) la sua giustizia (1); c) la sua bontà, facile da comprendere, pronta da eseguire (2); d) la sua onnipotenza per attaccare, così come per proteggere e difendere (3, 4); e) la sua liberalità e la sua paterna provvidenza; f) la sua saggezza preveggente (5); g) la sua fedeltà e la sua verità nell’eseguire le sue promesse (6); h) il suo odio per le osservanze vane e menzognere (7); i) la sua misericordia (8); j) la sua vigilante sollecitudine sui suoi fedeli servitori nel liberarli dalle mani dei loro nemici (9).
2° – La grandezza della sua tribolazione (11): egli è colpito:
a) nei beni dello spirito, tutte le
facoltà della sua anima sono nello scompiglio (10);
b) nei beni del corpo, la sua vita
scorre nella tristezza ed i gemiti, le sue forze sono esaurite (11);
c) nei beni della fortuna e della
reputazione: – 1) i suoi nemici l’insultano a causa dell’estrema miseria nella
quale è ridotto; – 2) è un soggetto di timore, anche per i suoi amici che lo
hanno messo nell’oblio e cancellato dal loro cuore (12); – 3) è in preda ai
rimproveri imperiosi di coloro che lo circondano; – 4) i suoi nemici tengono
consiglio per togliergli la vita (13, 14).
II. – Davide chiede a Dio un
soccorso particolare in rapporto a ciascuna delle ragioni che adduce ed a
ciascuno dei pericoli che egli segnala.
1° Egli prega Dio di aver pietà di
lui, come un buon padrone ha pietà del suo servitore, e dichiara ora che ripone
tutta la sua affezione, tutta la sua fiducia in Dio come suo Signore, e che non
vuole dipendere che da Lui;
2° Manifesta a Dio di essere nella
tribolazione, e che i suoi occhi, le facoltà della sua anima, sono nello
scompiglio, e chiede allora che Dio diffonda su di sé la luce del suo volto
(17);
3° Rappresenta a Dio lo stato di
debolezza in cui il suo corpo è ridotto, e chiede a Dio di salvarlo da questo
stato per la sua misericordia (18);
4° Si lamenta di essere di essere in
preda agli oltraggi calunniosi dei suoi nemici, e chiede a Dio che gli stessi
vengano precipitati nell’obbrobrio e ridotti al silenzio (19).
III. – Davide, esaudito e
liberato dai suoi nemici, rende grazie a Dio (22):
1° Descrive la felicità di cui Dio
lo ha ricolmato, e che Egli riserva a tutti i giusti, a) essa è grande, b) è
abbondante, c) è nascosta come una gemma preziosa nel tesoro di Dio, d) è perfetta
(20), e) è gloriosa, f) non teme né gli attacchi, né la contraddizione delle
lingue, g) è ammirabile (21).
2° Egli indica i gradi attraverso i
quali sia giunto a questa felicità, e come tutti gli uomini possano anch’essi
pervenirvi, a) si accusa della mancanza di fiducia che ha mostrato all’inizio
dei suoi malanni (23);
b) riconosce
in seguito che Dio l’ha esaudito, perché egli ha sperato in Lui; c) invita
tutti gli uomini ad amarlo (24); d) e li esorta a prendere coraggio ed a
fortificare il loro cuore in questa speranza, in questo amore (25).
Spiegazioni e Considerazioni
I. — 1-14.
ff. 1. – « C’è una confusione che conduce al peccato, ed una
confusione che attira la gloria e la grazia » (Eccli. IV, 25). –
Io ho orrore, dice il Re-Profeta, di questa confusione che dura eternamente!
Perché c’è una certa confusione passeggera che è utile: è lo scompiglio di
un’anima che considera i suoi peccati, che ha orrore di ciò che essa considera,
che arrossisce di ciò di cui ha orrore, e che corregge ciò di cui arrossisce. È
ciò che fa dire all’Apostolo: « Quale gloria avete tratto dalle cose di cui
oggi vi vergognate? » (Rom. VI, 21). – Egli dice dunque che i
fedeli arrossiscono, non dei doni che essi ricevono ora, ma dei peccati che
hanno commesso altre volte. Ma il Cristiano non tema questa confusione, perché
se egli non subisce questa confusione temporanea, subirà quella che dura
eternamente (S. Agost.). – « Liberatemi nella vostra giustizia »;
perché se non fate attenzione che alla mia giustizia, voi mi condannerete. C’è
in Dio una giustizia che diviene la nostra, quando ci viene comunicata; è per
questo che è chiamata la giustizia di Dio, perché l’uomo non possa credere di
possedere la giustizia da se stesso. Siccome voi non avete trovato in me una
giustizia che sia la mia, liberatemi per la vostra stessa giustizia; cioè che io
sia liberato per ciò che mi giustifica, per ciò che da empio mi renda pio, per
ciò che da ingiusto mi faccia giusto, per ciò che da cieco mi renda
chiaroveggente, per ciò che da uomo caduto mi faccia diventare uomo rialzato,
per ciò che da uomo condannato alle lacrime mi faccia possedere la gioia più
dolce (S. Agost.). – « Inclinate il vostro orecchio su di me ». È
ciò che Dio ha fatto, quando ha inviato il Cristo a noi. Egli ha inviato verso
di noi Colui che, avendo inclinato la testa, scriveva col dito sulla sabbia,
mentre la donna adultera Gli veniva presentata come tale perché Egli la
condannasse.
ff. 2. – « Affrettatevi a liberarmi ». Tutto ciò che ci sembra
lungo nel corso del tempo, non è realmente che un punto. Ciò che ha un fine non
può essere lungo. Che ne è del tempo trascorso da Adamo fino a noi, e questa
durata è certamente più considerevole di quella che ancora ci resta da
percorrere. Se Adamo vivesse ancora e morisse oggi, a cosa gli sarebbe servito
l’essere esistito tanto tempo, l’aver vissuto per tanto tempo? Perché dunque
questa fretta di cui parla il Profeta? Perché i tempi sfuggono! Ciò che ci
sembra ritardare, è breve agli occhi di Dio; e colui che prega aveva compreso,
nella sua estasi, questa rapidità del tempo (S. Agost.).
ff. 3,4. – « Siate per me un Dio protettore ». Dio è qui considerato
sotto due punti di vista che devono costituire la consolazione dei veri Cristiani.
Egli è loro protettore o, secondo il testo ebraico, la loro forza, il loro
scudo, la roccia salda sulla quale appoggiare la loro speranza. Egli è loro
asilo, il loro rifugio sicuro. Nel combattimento ci vogliono delle armi, un
sostegno; dopo il combattimento, un luogo di riposo. – Spesso sono in pericolo
e voglio fuggire, ma dove fuggire? Verso quale luogo potrei fuggire per
trovarmi in sicurezza? Ovunque io andrò seguirò me stesso. O uomo, tu puoi
fuggire tutto ciò che vuoi, eccetto la tua coscienza. Invece di fuggire,
ritirati nella tua casa, cerca il riposo nel tuo letto, penetra nel più intimo
di te stesso; tu non hai in te un angolo così profondo nel quale scappare dalla
tua coscienza, se il rimorso del tuo peccato ti rode. Ma così come ha detto « affrettatevi
a liberarmi, e nella vostra giustizia ritraetemi dall’abisso, perdonando i miei
peccati e mettendo in me la vostra giustizia », ha detto anche « voi sarete per
me una casa di rifugio », perché dove fuggire per sfuggirvi? (Ps.
CXXXVIII, 7). – Dunque, ovunque io vada, dovunque vi trovo, vendicatore
dei miei peccati se siete irritato; mio protettore se siete placato. Non mi resta
quindi che fuggire verso di Voi, e non lontano da Voi. Per sfuggire ad un uomo
vostro padrone, se schiavi, voi vi rifugiate in un luogo dove non ci sia il
vostro padrone; ma per sfuggire a Dio, rifugiatevi in Dio (S. Agost.).
– Il Re-Profeta non tralascia affatto di chiamare Dio sua forza, suo rifugio,
suo protettore, titoli che sono in effetti il fondamento della nostra speranza:
noi siamo deboli, Dio è la nostra forza, e tutto noi possiamo in Colui che ci
fortifica (Filip. IV, 13). – Noi siamo senza appoggio, senza
risorse dal lato degli uomini, e Dio è nostro asilo; noi siamo circondati da
nemici, e Dio è nostro protettore (Berthier). – « Voi mi
nutrirete », affinché io divenga capace di mangiare il pane di cui nutrite gli
Angeli; perché il Cristo – che ci ha promesso il nutrimento celeste – ci ha dapprima
nutrito con il latte, usando verso di noi una misericordia materna. In effetti,
come la madre che allatta fa passare per il proprio corpo il nutrimento che il
bambino non è ancora capace di prendere e lo riversa nel latte che beve, così
il Signore, per trasformare in latte la sua divina saggezza, è venuto a
rivestirci della nostra carne (S. Agost.).
ff. 5, 6. – Noi dobbiamo lottare contro nemici potenti,
contro dei nemici abili, contro nemici pubblici, contro nemici occulti; noi
dobbiamo salvaguardarci da insidie esposte e scoperte, e da trappole tese in
segreto. Non avremmo alcun mezzo per difenderci da tanti nemici, se Dio non
fosse il nostro protettore (Dug.). – « Io pongo il mio spirito
nelle vostre mani ». Queste parole sono state consacrate da Gesù Cristo quando
era prossimo a spirare sulla croce, cosa che prova che almeno questa parte del
salmo Lo riguardi totalmente. Il Salvatore vuol parlare qui della sua anima,
prossima a separarsi dal corpo. Egli non poteva che rimettere questa parte di
sé nelle mani del Padre, poiché il suo corpo, che pertanto non si chiama
spirito, doveva essere rinchiuso nella tomba; e quest’anima di Gesù Cristo
doveva sopravvivere al suo corpo poiché Egli la rimette nelle mani del Padre (Berthier).
– Sull’esempio di Gesù Cristo, rimettere la nostra anima e la nostra vita tra
le mani di Colui che è onnipotente per salvarle, dicendo con i grande Apostolo:
« Io so a chi mi sono affidato, e sono sicuro che Egli sia potente per custodire
il mio deposito fino al giorno dell’eternità » (II Tim. I, 12). –
Nessuna Potenza ci rapirà ciò che abbiamo depositato in queste mani divine. « Io
gli do la vita eterna perché essi non periscano giammai, e nessuno le rapirà
dalla mia mano ». Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e
nessuno può strapparle dalle mani di mio Padre (Giov. X, 29). –
Colui che ci ha riscattato dandoci il proprio Figlio, potrebbe forse rifiutarci
nulla dopo averci fatto questo gran dono? (Rom. VIII, 32). – Egli
che è il Dio di verità, il Dio che è la verità stessa, potrebbe mancare
nell’essere fedele alle promesse che ci fatto? – O Signore, mi si annuncia la
mia morte, ma quando mi si annuncia la vostra, io non temerò più nulla. Si, ora
io potrò cantare con il Salmista: « Se cammino in mezzo all’ombra della morte,
io non temerò nulla, perché Voi siete con me ». Ah! Dolce ricordo quello della
vostra morte che ha cancellato i miei peccati, che mi ha assicurato il vostro Regno!
Mio Salvatore, io mi unisco alla vostra agonia; io dico con Dio il mio « In
manus! » Mio Dio, io rimetto il mio spirito nelle vostre mani. Signore Gesù,
ricevete il mio spirito » (Bossuet, Med. sur l’Ev. LI° jour.).
ff. 7-10. – « Voi odiate coloro che si attaccano alla vanità ». Ma
io che non mi lego alla vanità, io ho messo la mia speranza nel Signore. Voi altri
ponete la vostra speranza nel danaro: voi siete attaccati alla vanità; voi
mettete la vostra speranza nell’uomo e nell’eccellenza della potenza umana: voi
siete attaccati alla vanità; voi riponete la vostra speranza in qualche amico
potente: siete attaccati alla vanità. Poiché voi riponete la vostra speranza in
queste cose, voi morirete e sarete costretti a lasciare tutto quaggiù; oppure
nel corso della vostra vita, esse periranno e voi sarete delusi nelle vostre
speranze (S. Agost.). – Il mondo, non soltanto frivolo, ma spesso
anche l’empio ed ateo, non ha qualche esteriorità religiosa? No, eccetto in
certo regioni del mondo ove ancora si rispettano, si conservano delle
convenienze religiose o si conservano delle abitudini, si colora un ateismo
pratico con una certa religiosità di parvenza, e di bon ton. Il Salmista ha una
parole ammirevole per caratterizzare questa religiosità dei mondani: « Essi
hanno delle osservanze, ma vane e superflue ». Essi giocano alla Religione come
una cosa qualsiasi (Doublet, Psaunes, etc.). – Queste vanità,
sono ancora ogni sagacia, ogni scienza umana, ogni consiglio, ogni soccorso che
sia contro Dio e senza il suo concorso, cose vane che non servono a niente. Lo
sono ancora certe pratiche esteriori alle quali si è superstiziosamente
attaccati, senza andare all’essenziale della legge, che è l’amore di Dio e la
pratica dei suoi Comandamenti, osservanze vane e senza frutto, devozioni false
e farisaiche alle quali si tiene scrupolosamente, mentre si calpestano i doveri
sacrosanti del Cristianesimo. – La speranza unica nella misericordia di Dio, è
la devozione più solida e sicura di tutte queste vane osservanze, ed è un
soggetto della vera gioia. – Quali sono queste necessità per cui desideriamo
che la nostra anima sia salva? Chi potrebbe contarle? Chi potrebbe riunirle in
un solo blocco? Chi potrebbe enumerare completamente quelle che bisogna evitare
e fuggire? E pertanto è una dura necessità della condizione umana non conoscere
il cuore degli altri, diffidare il più spesso di un amico fedele e fidarsi
sovente di amici infedeli. O dura necessità! Cosa potete fare per leggere oggi
nel cuore del vostro fratello? E necessità ancora più dura, voi non vedere
nemmeno ciò che sarà il vostro cuore domani. E che dire delle necessità che ci
impone la morte? È una necessità morire, e nessuno lo vuole, nessuno non vede
ciò che è necessario; nessuno vede ciò che arriverà, che lo si voglia o no.
Dura necessità è il non volere ciò che è inevitabile! … Quali sono ancora queste
penose necessità di vincere le bramosie inveterate, le cattive abitudini,
consolidate negli anni? Voi vedete che ciò che fate è cattivo, quanto fate dovreste
averlo in orrore, quanto ne soffrite, e nonostante questo, voi lo fate, l’avete
fatto ieri, lo rifarete oggi. Se ne avete una tale avversione quando vi parlo,
quale avversione non ne avrete quando vi riflettete? E ciò nonostante, voi lo
farete. Quale forza vi costringe, quale potenza vi cattura? Non è quella legge
delle membra che è in lotta con la legge dello spirito? gridate dunque: « Maledetto
uomo qual sono! Chi mi libererà da un corpo sottomesso ad una tale morte? La
grazia di Dio, per Gesù Cristo nostro Signore » (S. Agost.). –
Questo passaggio continuo dalla gioia della liberazione, al timore di un nuovo
pericolo, da un’azione di grazia ad una supplica, è un’immagine della vita cristiana.
Tutti coloro che desiderano seriamente la loro salvezza, che si osservano, che
si raccolgono, che lottano incessantemente contro le loro passioni e che a
volte resistono, a volte soccombono, che sentono i loro piedi vacillare, poi si
stabilizzano, la loro carità raffreddarsi, la loro pazienza perdersi, la pace
interiore turbarsi, provano questa eterna alternanza di gioia e di dolore
religioso. E come le anime così attente a se stesse si interessano
necessariamente alla Chiesa, come esse si associano ai suoi beni e ai suoi
mali, alle sue sofferenze ed ai suoi trionfi, esse trovano nei Salmi ciò che
conviene così bene all’espressione dei propri sentimenti, una sorgente
inesauribile di ferventi preghiere e di canti di gioia per la santa società di
cui essi sono membra fedeli (A. Rendu). – I partigiani del mondo
non possono sottomettersi alla legge di Dio, alle massime del Vangelo, perché
esse provocano in essi un certo fastidio che va loro troppo stretto; essi
vogliono vivere in modo più largo: illusione, accecamento deplorevole; è questa
una verità di esperienza e pertanto poco compresa, ancor meno gustata, che i
servitori di Dio sono i soli che siano veramente nel largo, mentre gli schiavi
del mondo sono strettamente rinchiusi sotto la tirannia del demonio e delle
loro passioni.
ff. 10-14. – Tutte le tempeste del dolore più estremo sono
espresse in questi versetti. Il Profeta non ne omette alcuna, persuaso che non
si sarebbero trovate in tutti i tempi, delle anime così afflitte come la sua;
ma, in capo a questa descrizione, c’è il ricorso a Dio, l’unico consolatore dei
grandi dolori, il solo medico delle malattie disperate (Berthier).
– Trattasi qui di una collera santa, che nasce non dall’impazienza, ma
dall’amore per la giustizia, collera molto più vantaggiosa della compiacenza di
colui che lusinga il peccatore e lo conferma nel suo peccato. – Per ogni uomo
che viene in questo mondo, i giorni sono brevi e cattivi come per il patriarca
Giacobbe; la vita si consuma nel dolore e gli anni nei gemiti. Le speranze
della vita appassiscono, le speranze si scolorano e cadono come le foglie d’autunno;
il cuore è un abisso in cui ogni giorno c’è posto per un nuovo gemito. Man mano
che si avanza sul sentiero dell’esistenza, e che si consumano gli anni, il sole
sembra diventare più ardente, il cielo più in fiamme … chissà cosa ci riserva
l’avvenire? Ognuno degli anni che ci restano da vivere porterà forse un nuovo
corollario a questa parola del Patriarca dell’Idumea (Giob. VII).
– « La vita dell’uomo è un combattimento sulla terra, ed i suoi giorni sono come
quelli di un mercenario; così come il mercenario, egli attende la fine della
sua opera » (Mgr. Landriot, Prière chrét. 2° Part.). – Da questo
momento di tristezza alla vista degli anni che passano, da questa figura del
mondo che svanisce, si passa agli anni eterni che non passano. Ogni anno
quaggiù non ha che un certo numero di giorni, ogni anno non ha che un
determinato numero di ore, non c’è alcun evento che possa impedire al domani di
arrivare. Uno di questi domani sarà il giorno della morte. Non c’è alcun
tiranno che possa impedirci di morire. Ecco una bella massima di Santa Teresa:
« … che nulla ti inquieti, nulla ti spaventi, tutto passa: ma Dio non passerà
mai ». Felice la vita che si consuma nel dolore profondo per aver offeso Dio!
Felici le lacrime che un vero spirito di compunzione fa scorrere dagli occhi e
che sono come il sangue di un cuore ferito! Dolci e gradevoli gemiti che
vengono dal sentimento della profondità delle piaghe nelle quali l’anima è
colpita per la perdita di Dio (Duguet). – Nuove prove sono aggiunte
alle prime, la povertà, lo svanire della salute e delle forze, la perdita della
reputazione e degli amici, l’oblio da parte di persone che ci erano care, i
rimproveri, le ingiurie, gli odi, i complotti. – Essere un obbrobrio a causa di
Dio è mezzo infallibile per essere onorato presso Dio. I vicini, gli amici
apparenti, coloro dai quali si è conosciuti, spesso i più ardenti ed i più
ingiusti persecutori; quasi non c’è vita di un santo che non venga a confermare
questa verità. – Nella prosperità, mille manifestazioni di servigi, di
devozione. Se si viene a cadere in qualche disgrazia, tutti coloro che in
precedenza erano conosciuti, non vi conoscono più: si diviene per essi soggetto
di orrore. – Ci si deve ricordare che non si è mai più felici di quando si sia
più abbandonati dalle creature, di quando si sia nella felice necessità di
ricorrere al Creatore (Duguet).
ff. 13. – Ci sono dei buoni cuori, delle belle anime che sembravano avervi atteso per amarvi; della loro frequentazione si era fatta un’abitudine, essi riscuotevano ogni vostra fiducia, si pensava si potesse sempre contare su di loro … non le si vedrà più … Inizialmente ci si consola con il pensiero che i legami così preziosi non saranno mai interrotti, anche se rilassati, ma questa povera consolazione dura poco! Pian piano si formano altre amicizie, si fa tra le due parti un oblio, si finisce per perdere quasi ogni ricordo di coloro che si erano tanto amati; essi finiscono per perdere ogni ricordo di voi; è proprio una morte, ed il cuore è una terra che consuma tutti i suoi morti (L. Veuillot, Rome et Lorete, II, 13.). – Si pensi allora a Gesù Cristo, a questo divino solitario dei nostri tabernacoli. La moltitudine passa indifferente e sprezzante davanti all’unico monumento che onora una ospite divino. Talvolta la curiosità varca i gradini del tempio; essa ha sguardi per ciò che gli uomini hanno messo con le loro ricchezze e le loro arti nell’edificio; ma essa non ne ha per ciò che Dio stesso ha messo di Se stesso nei tabernacoli. Gesù Cristo può ben dire che Egli è questo morto spirituale di cui parla il Re-profeta, così assente dal pensiero che i morti che la tomba ha ricevuto e che hanno perso, con il loro posto nella città, il loro posto nei nostri cuori (id.).
ff. 14. – È questa l’immagine viva di ciò che è avvenuto alla morte del Figlio di Dio trattato
come un vaso frantumato e distrutto, come l’ultimo degli uomini, caricato da
obbrobriose ingiurie, dagli oltraggi di tutti coloro che Lo circondavano, che
Lo consideravano un uomo perso e senza risorse, e Lo rimproveravano che ben
lungi dall’essere il Salvatore degli altri, Egli non poteva salvare neppure se
stesso. – Quanti Cristiani vivono attorno a Lui nella Chiesa, e con la loro
vita totalmente opposta alla sua, Gli fanno oltraggi molto più cruenti di
quelli sofferti sulla croce, rimproverandogli l’umiliazione della sua vita con
l’orgoglio della loro vita, il fasto e l’ostentazione della loro condotta (Duguet).
II. — 15 – 19.
ff. 15-19. – Colui che può dire a Dio con verità: « Voi siete il mio Dio », cioè: io amo Lui solo, è incrollabile ed invincibile contro tutti i nemici visibili ed invisibili? – Per sorte, il Profeta intende – per quanto io possa credere – la grazia per mezzo della quale noi siamo salvati. Perché chi è che chiama la grazia di Dio col nome di sorte? Perché la sorte non suppone delle scelte, ma la volontà di Dio; perché là dove si dice: questo fa, quest’altro non fa tale cosa, si considerano i meriti di ciascuno, e laddove si considerano i meriti, non c’è più sorte. Ma Dio, non avendo trovato in noi alcun merito, ci ha salvati con la sorte della sua volontà, perché Egli lo ha voluto, e non perché noi l’abbiamo meritato (S. Agost.). – Il nostro destino è nelle mani di Dio. Ciò che noi siamo e ciò che deve succederci non dipende che da Dio. Tutte le creature insieme non cambieranno la benché minima circostanza; esse non abbrevieranno di un solo giorno la nostra vita; esse non ci faranno perdere un capello della nostra testa; tutti i loro sforzi non porteranno che a far giungere al successo ciò che esse vogliono impedire. « La nostra sorte è nelle mani di Dio ». Se noi pecchiamo, noi siamo nella sua mano come i suoi nemici; se noi non pecchiamo, noi siamo nella sua mano come suoi amici. Nulla può strapparci da questa mano sovrana, onnipotente per salvarci o perdere. – La sorte della nostra eternità è nelle mani di Dio, consolazione degli umili, soggetto di inquietudine e spavento per i superbi. Noi vogliamo, noi facciamo, ma « è Dio che opera in noi il volere ed il fare ». – Doppio errore egualmente pericoloso è il credere che la nostra salvezza dipenda da noi, o che dipenda talmente da Dio che noi non abbiamo nulla da fare (Dug.). – Ciò che deve fare il colmo della nostra gioia è poter dire, come Davide: nelle vostre mani è il mio destino, non solo la mia fortuna temporale, ma la mia eternità. Quando sarà in mio potere mettere la mia sorte altrove, ove potrò io riporla più sicuramente se non tra le mani di Dio, che è nello stesso tempo buono, potente e fedele? Se essa restasse nelle mie mani, ove sarei io? Ed io così leggero, fragile come sono, su chi potrei contare, ove sarebbe la mia fiducia ed il mio appoggio? Quale pensiero più dolce è per un Cristiano considerare Dio come il guardiano ed il depositario della mia salvezza? (Bourdal. Prédestin.).
ff. 17. – Colui che geme per essere in mezzo a cattivi Cristiani
grida come il Profeta: « fate splendere la luce del vostro volto sul vostro
servo »; perché si potrebbe credere che ci sia qualche confusione nella Chiesa,
ove tutti, di condotta buona o cattiva, portano il nome di Cristiani; ove tutti
sono marcati con lo stesso carattere, ove tutti si avvicinano allo stesso
altare, ove tutti sono lavati nello stesso Battesimo, ove tutti pronunciano la
stessa Orazione domenicale, ove tutti assistono alla celebrazione degli stessi
misteri. Come dunque, questi che gemono, saranno distinti da coloro sui quali
essi gemono, se il Signore non fa splendere sui suoi servi la luce del suo
volto? Cosa vuole allora dire il Profeta? « … che si veda chiaramente che io vi
appartenga »; e che il Cristiano empio non possa dire che vi appartenga
ugualmente, in modo tale che io vi abbia fatto inutilmente questa preghiera in
un altro salmo (Salmo XLII, 1): « giudicatemi o mio Dio, e discernete la mia
causa da quella di un popolo empio » (S. Agost.).
ff. 18 – « Che io non sia confuso, perché vi ho
invocato ». Voi volete che colui che vi abbia invocato sia confuso? Volete che
gli sia detto « dov’è Colui in cui tanto ha sperato »? Ma pure, chi è tra gli
empi colui che non invoca Dio? Se dunque il Profeta dicesse: « Io vi ho
invocato », nel modo a lui proprio, egli non oserebbe in alcun modo reclamare
per questa invocazione una così grande ricompensa. Dio gli risponderebbe: cosa
domandate per non essere confuso? E per quale ragione? Perché mi avete
invocato? Ma tutti i giorni gli uomini non mi invocano per essere appagati da
bramosie adulterine? Tutti i giorni gli uomini non mi invocano per coloro dai
quali attendono l’eredità, una volta morti? Tutti i giorni gli uomini che
meditano le frodi non mi invocano perché abbiano pieno successo? Cosa hai tu
dunque da esigere da me così grande ricompensa per dirmi: « … che non sia
confuso, perché io vi ho invocato? » Si, questi uomini vi invocano in verità,
ma non siete Voi che essi invocano. Voi invocate Dio quando chiamate Dio in
voi: invocarlo è chiamarlo in voi, invitarlo in qualche modo ad entrare nella
casa del vostro cuore. Ora voi osereste invitare un padre di famiglia tanto
considerevole, se non gli preparereste una dimora? Cosa accadrebbe in effetti
se Dio vi dicesse: ecco che mi voi mi avete chiamato presso di voi, Io vengo,
ma dove entrerò? Dovrò sopportare le sozzure abominevoli della vostra
coscienza? Se voi invitate uno dei miei servitori nella vostra casa, non
comincereste con il pulirla? Voi mi chiamate nel vostro cuore, ma esso è pieno
di rapine. Il luogo ove il vostro Dio è chiamato dalle vostre invocazioni è
pieno di bestemmie, pieno di adulteri, pieno di frodi, pieno di cupidigie
colpevoli, e voi mi invocate! (S. Agost.).
ff. 19. – Questo giusto è il Cristo. Molte bocche tramano contro
di Lui, con orgoglio e disprezzo … il linguaggio dell’iniquità. Perché con
orgoglio e disprezzo? Perché sembrava spregevole agli orgogliosi quando Egli venne
sulle terra con tanta umiltà. Voi non volete che sia disprezzato da coloro che
amano gli onori, Egli che ha sopportato tanti oltraggi? Voi non volete che Egli
sia disprezzato da coloro che reputano questa vita un bene prezioso, Egli che
ha sofferto la morte? Voi non volete che sia disprezzato da coloro che
considerano come una condanna vergognosa il supplizio della croce, Egli che è
stato crocifisso? Voi non volete che Egli sia disprezzato dai ricchi, Egli che
ha sopportato in questo mondo una vita povera, benché fosse il Creatore del
mondo? Tutte quelle cose che amano gli uomini, il Cristo non ha voluto averle,
non che non fosse in suo potere il possederle, ma al fine di mostrare, non
possedendole, che esse sono da disprezzare; ed anche da disprezzare da tutti
coloro che amano queste cose; ed ogni servo di Gesù Cristo che voglia seguire
le sue orme e camminare egli stesso nella strada dell’umiltà ove sa che ha
camminato il suo Maestro è disprezzato in Gesù Cristo, come membro di Gesù
Cristo … ora quando queste labbra diventeranno mute … in questo secolo? Mai!
Tutti i giorni esse gridano contro i Cristiani, e soprattutto contro gli umili.
Tutti i giorni esse lo bestemmiano. Tutti i giorni esse latrano, aumentano con
il loro linguaggio, la sete vendicativa che le attende nell’inferno, ove esse
imploreranno una goccia di acqua senza poterla ottenere. Così dunque, le labbra
ingannatrici non diventeranno mute ora, ma quando dunque? Quando le loro
iniquità si leveranno contro di esse e le condanneranno … ora esse ci dicono:
dov’è il vostro Dio? Cosa adorate voi? Cosa vedete? Voi credete e prendete
pena: la vostra pena è certa, l’oggetto della vostra speranza incerta. Quando
sarà venuto ciò che noi speriamo con certezza, allora le labbra ingannatrici
diverranno mute (S. Agost.).
III. —
20-22.
ff. 20, 21. – Nell’ignoranza sono i peccatori e gli uomini
del mondo delle dolcezze celesti, delle quali invece i giusti gioiscono nel
fondo dell’anima. – Se essi ci dicono: dov’è l’abbondanza di questa dolcezza,
noi risponderemo loro: come vi farò gustare l’abbondanza di questa dolcezza, a
voi cui la febbre dell’iniquità ha distrutto il palato? Se voi non conoscete il
miele, non potrete compiacervi del suo gusto gradevole, a meno di averlo
gustato. Se voi non avete il palato del cuore per gustare di questi beni, cosa
posso fare? Come mostrarvi ciò che voi mi chiedete? Voi non siete un uomo al
quale io possa dire: « gustate e vedete come è dolce il Signore » (Sal.
XXXIII, 18) (S. Agost.). – « Oh quale abbondanza di
dolcezza Voi avete riservato a coloro che vi temono! Esse sono dunque per
coloro che vi amano, per coloro che vi servono con tutto il loro cuore? Sono
veramente ineffabili, le delizie di cui inondate coloro che vi amano, quando la
loro anima vi contempla (Imit. De J.-C. III, 10). – Due sono gli
stati degli uomini del bene: uno è quello della solitudine e del silenzio, ove
sono penetrati con il timore filiale del Signore; l’altro è quello del
combattimento e della persecuzione, dove essi mettono solo in Dio la loro
fiducia. Nel primo stato Dio li colma in segreto di una grande dolcezza, e nel
secondo, Egli manifesta agli occhi degli uomini la protezione che accorda loro
(Berthier).
ff. 21. – Il Profeta non ha detto: Voi li accoglierete
nel vostro cielo; non ha detto: Voi li accoglierete nel Paradiso: egli non ha
detto: Voi li nasconderete nel seno di Abramo … Tutto ciò che è fuori di Dio ci
sembra poca cosa. Colui che ci protegge nel luogo ove passiamo questa vita, sia
Egli stesso, dopo questa vita, il luogo della nostra dimora … Noi saremo dunque
nascosti nel volto di Dio. Ma aspettate che vi segnali quale segreto profondo
si trovi in questo volto divino. Purificate il vostro cuore, affinché Dio vi
rischiari, e Colui che invocate entri in voi. Siate sua casa, ed Egli sarà
vostra casa; che abiti in voi, e voi abiterete in Lui. Se durante questa vita
voi Lo riceverete nel vostro cuore, dopo questa vita, Egli vi riceverà nel suo
volto (S. Agost.).- « Voi li proteggerete nella vostra tenda
contro le contraddizioni delle lingue ». Un giorni Voi li nasconderete nel
segreto del vostro volto, per salvarli dagli sconvolgimenti che vengono dagli
uomini, affinché essi siano oramai completamente al riparo delle afflizioni
umane; ma nell’attesa, mentre sono nel loro viaggio in questo mondo e, come
coloro che vi servono, devono soffrire numerose contraddizioni, cosa farete per
loro? « Voi li proteggerete nella vostra tenda ». Qual è questa tenda? La
Chiesa di questo mondo è chiamata con il nome di tenda, perché essa viaggia
ancora su questa terra (S. Agost.). – Per le anime privilegiate
che Dio chiama alla vita religiosa, questo tabernacolo, questa tenda, sono
questi ritiri solitari, tanto lontani dalle voce del secolo e separate da ogni
commercio col mondo, in cui queste anime sante, nascoste nel segreto del volto
di Dio, sono al coperto dalle turbe e dalla corruzione del mondo, vivendo nel
silenzio, nella meditazione delle verità eterne, ed imitano lo stato dei Santi
in cielo. – Se il volto di Dio è un rifugio tanto sicuro in questa vita, in cui
« noi lo vediamo come in uno specchio e in enigma », che sarà quando vedremo
Dio faccia a faccia? (S. Agost.).
ff. 22, 23. – Dio fa cadere la sua misericordia suo suoi
servi, ponendoli in luoghi talmente sicuri che non hanno da temere gli attacchi
dei loro nemici. – Ci si metta in guardia contro un eccessivo timore, contro un
sentimento di scoraggiamento che spesso si fa strada anche nelle anime più
solidamente virtuose, quando, vedendosi come oppressi dalla violenza delle
tentazioni e delle prove, in pericolo di soccombere, esse credono e dicono, nel
trasporto del loro spirito, di essere rigettate lontano dagli occhi di Dio. –
Si ricorre allora a Dio con una preghiera più fervente.
ff. 24. – « Santi del Signore, amatelo tutti »; cioè
amate il Signore, voi che non amate il mondo, « voi tutti che siete i suoi
santi »; perché è forse a colui che ama ancora i piaceri del teatro, che io
dico di amare Dio? È a colui che ama ancora gli eccessi della tavola, o a colui
che ama ancora le pompe del secolo, le sue vanità e le sue follie menzognere,
che io dico di amare Dio? A questi io dico: imparate a non più amare, per
imparare ad amare; distoglietevi dal male per ritornare al bene; svuotatevi per
essere riempiti (S. Agost.). – « Perché il Signore cercherà la verità ». Egli
saprà ben discernere tra le proteste d’amore, che sono solo sulle nostre labbra,
ed il vero amore che lo preferisce a tutto, cercando unicamente la sua gloria.
Il Signore, che cerca la verità, punirà necessariamente i superbi secondo la
grandezza del loro orgoglio. Ma, voi direte, quando li punirà? Quando Egli
vorrà! Siate certi che Dio li punirà; non dubitate del castigo, ma non abbiate
l’audacia di dare consigli a Dio sull’ora della sua giustizia. Alcuni saranno
puniti quaggiù, noi l’abbiamo visto ed imparato … anche se in effetti non
appare così allo sguardo di taluni, e la sua divina provvidenza sembrerebbe in
qualche modo che non vegli sul mondo; se Egli agisse così con tutti, la sua
divina pazienza sembrerebbe essere esausta … « Santi del Signore, amatelo
tutti, perché Egli ricercherà la verità, e punirà i superbi secondo la grandezza
del loro orgoglio ». Oh! Se li punisse subito, … io li vorrei vedere ora
umiliati ed abbattuti. Ascoltate ciò che segue: « agite con coraggio ». Badate,
nelle tribolazioni, di lasciar cadere le vostre mani stanche, che le vostre
ginocchia non vacillino; che il vostro cuore si rinsaldi per sopportare tutte
le miserie di questo mondo. Ma chi sono coloro ai quali il Profeta ha detto: « agite
con coraggio e che il vostro cuore sia saldo »? A coloro che amano il mondo?
No! « … voi tutti, egli dice, che ponete la vostra speranza nel Signore ». (S.
Agost.).