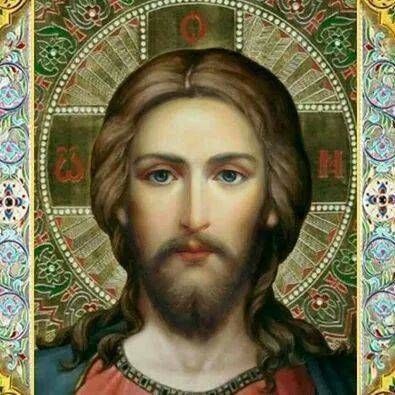SALMO 36: “Noli æmulari in malignantibus”
CHAINE D’OR SUR LES PSAUMES
ou LES PSAUMES TRADUITS, ANALYSÉS, INTERPRÉTÉS ET MÉDITÉS A L’AIDE D’EXPLICATIONS ET DE CONSIDÉRATIONS SUIVIES, TIRÉES TEXTUELLEMENT DES SAINTS PÈRES, DES ORATEURS ET DES ÉCRIVAINS CATHOLIQUES LES PLUS RENOMMÉS.
[I Salmi tradotti, analizzati, interpretati e
meditati con l’aiuto delle spiegazioni e delle considerazioni seguite, tratte
testualmente dai santi Padri, dagli oratori e dagli scrittori cattolici più
rinomati da …]
Par
M. l’Abbé J.-M. PÉRONNE,
CHANOINE TITULAIRE DE L’ÉGLISE DE SOISSONS, Ancien Professeur d’Écriture sainte et d’Éloquence sacrée.
TOME
PREMIER.
PARIS – LOUIS VIVES, LIBRAIRE-ÉDITEUR; RUE DELAMMIE, 13 – 1878
IMPRIM.
Soissons, le 18 août 1878.
f ODON, Evêque de Soissons et Laon.
SALMO XXXVI
[1] Psalmus ipsi David.
Noli æmulari in malignantibus,
neque zelaveris facientes iniquitatem;
[2] quoniam tamquam fœnum velociter arescent, et quemadmodum olera herbarum cito decident.
[3] Spera in Domino, et fac bonitatem; et inhabita terram, et pasceris in divitiis ejus.
[4] Delectare in Domino, et dabit tibi petitiones cordis tui.
[5] Revela Domino viam tuam, et spera in eo, et ipse faciet.
[6] Et educet quasi lumen justitiam tuam, et judicium tuum tamquam meridiem.
[7] Subditus esto Domino, et ora eum. Noli æmulari in eo qui prosperatur in via sua, in homine faciente injustitias.
[8] Desine ab ira, et derelinque furorem; noli æmulari ut maligneris.
[9] Quoniam qui malignantur exterminabuntur; sustinentes autem Dominum, ipsi hæreditabunt terram.
[10] Et adhuc pusillum, et non erit peccator; et quæres locum ejus, et non invenies.
[11] Mansueti autem haereditabunt terram, et delectabuntur in multitudine pacis.
[12] Observabit peccator justum, et stridebit super eum dentibus suis.
[13] Dominus autem irridebit eum, quoniam prospicit quod veniet dies ejus.
[14] Gladium evaginaverunt peccatores, intenderunt arcum suum, ut dejiciant pauperem et inopem, ut trucident rectos corde.
[15] Gladius eorum intret in corda ipsorum, et arcus eorum confringatur.
[16] Melius est modicum justo, super divitias peccatorum multas;
[17] quoniam brachia peccatorum conterentur, confirmat autem justos Dominus.
[18] Novit Dominus dies immaculatorum, et haereditas eorum in æternum erit.
[19] Non confundentur in tempore malo, et in diebus famis saturabuntur,
[20] quia peccatores peribunt. Inimici vero Domini mox ut honorificati fuerint et exaltati, deficientes quemadmodum fumus deficient.
[21] Mutuabitur peccator, et non solvet, justus autem miseretur et tribuet;
[22] quia benedicentes ei haereditabunt terram: maledicentes autem ei disperibunt.
[23] Apud Dominum gressus hominis dirigentur; et viam ejus volet.
[24] Cum ceciderit, non collidetur, quia Dominus supponit manum suam.
[25] Junior fui, etenim senui; et non vidi justum derelictum, nec semen ejus quærens panem.
[26] Tota die miseretur et commodat; et semen illius in benedictione erit.
[27] Declina a malo, et fac bonum, et inhabita in sæculum saeculi;
[28] quia Dominus amat judicium, et non derelinquet sanctos suos; in æternum conservabuntur. Injusti punientur, et semen impiorum peribit.
[29] Justi autem hæreditabunt terram, et inhabitabunt in sæculum sæculi super eam.
[30] Os justi meditabitur sapientiam, et lingua ejus loquetur judicium.
[31] Lex Dei ejus in corde ipsius, et non supplantabuntur gressus ejus.
[32] Considerat peccator justum, et quærit mortificare eum.
[33] Dominus autem non derelinquet eum in manibus ejus, nec damnabit eum cum judicabitur illi.
[34] Exspecta Dominum, et custodi viam ejus; et exaltabit te ut hæreditate capias terram; cum perierint peccatores, videbis.
[35] Vidi impium superexaltatum, et elevatum sicut cedros Libani;
[36] et transivi, et ecce non erat; et quæsivi eum, et non est inventus locus ejus.
[37] Custodi innocentiam, et vide æquitatem, quoniam sunt reliquiæ homini pacifico.
[38] Injusti autem disperibunt simul; reliquiæ impiorum interibunt.
[39] Salus autem justorum a Domino; et protector eorum in tempore tribulationis.
[40] Et adjuvabit eos Dominus, et liberabit eos; et eruet eos a peccatoribus, et salvabit eos, quia speraverunt in eo.
[Vecchio Testamento secondo la VolgataTradotto in lingua italiana da mons. ANTONIO MARTINI Arciv. Di Firenze etc.
Vol. XI
Venezia, Girol.
Tasso ed. MDCCCXXXI]
SALMO XXXVI.
I pusilli non imitino le opere
dei malvagi, perché li vedono prosperare, e non dubitino della Provvidenza di
Dio. È una raccolta di sentenze distribuite alfabeticamente, cosi da contenere
ogni sentenza due versetti.
Salmo dello stesso David.
1. Non voler imitare i maligni, e non
portar invidia a coloro che operano l’iniquità.
2. Perocché seccheranno ben presto: come
il verde fieno e come la tenera erbetta, appassiranno velocemente.
3. Spera nel Signore, ed opera il bene,
e abiterai la terra, e sarai pasciuto di sue ricchezze.
4. Metti la tua consolazione nel
Signore, ed ei ti darà quello che il tuo cuore domanda.
5. Esponi al Signore il tuo stato, e in
lui confida, e farà egli.
6. E renderà manifesta come la luce la
tua giustizia, e la tua virtù come il mezzodì.
7. Sta soggetto al Signore e pregalo. Non
riscaldarti per ragion di colui che è prosperato nelle sue vie; dell’uomo che
fa ingiustizie.
8. Lascia andare lo sdegno, e metti da parte
l’impazienza: non averne invidia, per poi fare il male.
9. Imperocché saranno sterminati i
maligni; ma quelli che aspettano in pazienza il Signore, saranno eredi della
terra.
10. E un po’ di pazienza, e il peccatore
più non sarà: e cercherai del luogo dov’ei si stava, e nol troverai.
11. I mansueti poi saranno eredi della
terra, e goderanno abbondanza di pace.
12. Il peccatore mirerà di mal occhio il
giusto, e digrignerà i denti contro di lui.
13. Ma il Signore si farà beffe di lui, perché vede che il suo giorno verrà.
14. I peccatori sguainarono la spada,
tesero il loro arco. Per abbatter il povero e il miserabile, per trucidare gli
uomini di retto cuore.
15. La loro spada trapassi i loro cuori,
e l’arco loro si spezzi.
16. Più giova il poco al giusto, che le
molte ricchezze al peccatore;
17. Perocché le braccia del peccatore
saranno rotte; ma il Signore corrobora i giusti.
18. Il Signore ha cura dei giorni degli uomini senza macchia; e la eredità loro sarà eterna.
19. Non abbiano da godere del mio male
quelli saranno confusi nel tempo cattivo, e nei giorni di carestia saranno
satollati;
20. Imperocché i peccatori periranno, E
i nemici del Signore, appena saranno stati messi in onore ed esaltati,
mancheranno e spariranno come fumo.
21. Il peccatore prenderà in prestito, e non restituirà; ma il giusto è misericordioso, e donerà.
22. Perocché quelli che a lui danno
benedizione, saranno eredi della terra; ma quei che lo maledicono, andranno in
perdizione.
23. Dal Signore saranno diretti i passi
dell’uomo, e le sue vie saranno approvate da lui.
24. Se egli cadrà, non sarà infranto,
perché il Signore pone sotto di lui la sua mano.
25. Sono stato giovane, perocché son già
vecchio, e non ho veduto derelitto il giusto, né la stirpe di lui cercante del
pane.
26. Ogni giorno egli è liberale, e dà in
prestito: in benedizione sarà la sua stirpe.
27. Fuggi il male e opera il bene; ed
avrai un’abitazione sempiterna.
28. Imperocché il Signore ama la rettitudine, e non abbandonerà i suoi santi; eglino saranno conservati in eterno. Gl’ingiusti saran puniti, e perirà la stirpe degli empi.
29. Ma i giusti saranno eredi della
terra, e l’abiteranno in perpetuo.
30. La bocca del giusto parlerà
meditazioni di saviezza, e la lingua di
lui di buone cose ragionerà.
31. La legge del suo Dio egli ha nel suo
cuore, e i piedi di lui non saran vacillanti.
32. Il peccatore adocchia il giusto, e
cerca di ucciderlo;
33. Ma il Signore non lo abbandonerà
nelle mani di colui; né lo condannerà, quando di lui farassi giudizio.
34. Aspetta il Signore, e osserva sua
legge, ed egli ti esalterà, affinché erede tu sii della terra; quando i
peccatori siano periti, allor vedrai.
35. Io vidi l’empio a grande altezza
innalzato come i cedri del Libano.
36. E passai, ed ei più non era; e ne
cercai, e non si trovò il luogo dov’egli era.
37. Custodisci l’innocenza, e osserva la
rettitudine, perocché qualche cosa rimane per l’uomo di pace.
38. Ma l’iniqui tutti periran malamente;
quel che resta degli empi andrà in perdizione.
39. La salute de’ giusti vien dal
Signore, ed egli è lor protettore nel tempo della tribolazione.
40. E il Signore li aiuterà e li
libererà, e li trarrà dalle mani de’ peccatori, e li salverà, perché in lui
hanno sperato.
Sommario analitico
Il salmista, alla vista delle fluttuazioni, dello scoraggiamento
dell’uomo giusto indignato dalla prosperità dei peccatori, lo invita a moderare
la sua indignazione e a non invidiare una simile prosperità, prezzo della loro
vita criminale, perché questi sono i beni che in abbondanza possiedono gli empi
ed i malvagi [Questo salmo è uno degli alfabetici, ma le lettere vi appaiono
ogni uno o due versetti, vi si nota una grande analogia di forme ed anche
qualche somiglianza di fondo con i salmi alfabetici XXIV e XXXIV. I versetti 3,
11, 22, 29, 34, sembrano designare l’epoca in cui il reame di Giuda versava in
rovina, e qualche autore pensa che sia stato scritto nel tempo in cui Geremia
dissuadeva i Giudei dal ritirarsi in Egitto, promettendo loro che non avrebbero
avuto nulla da soffrire se avessero acconsentito a restare nella terra di
Israele. Secondo Rosen-Müller, il salmista non avrebbe osservato alcun ordine
stabilito, ed alcun legame ci sarebbe tra le differenti parti di questo Salmo.
È fuor di dubbio – egli dice – che in certi scritti dell’Antico Testamento, le
parti di cui si compongono, sono talmente legate ed incatenate tra loro, che si
possono comparare ai legami stretti che uniscono tra loro le membra del corpo
umano. Ma non è meno certo che in altri scritti, le sentenze siano riunite come
tanti fiori in un sol fascio e legate tra loro da un legame comune, senza
tuttavia dipendere più l’una dall’altra come tante perle che, attraversate da
un filo comune, servono a formare una sola collana. Questo apprezzamento
nell’applicazione a questo Salmo, ci sembra solo in parte fondata, a causa
della ripetizione di alcuni pensieri, ma non tanto da escludere, come fa
Rosen-Muller, ogni legame, ogni concatenazione tra le diverse parti del Salmo].
I – Sono per loro natura fragili e
deperibili.
1° Malgrado essi, i loro beni, la loro prosperità, le
loro grandezze, si seccheranno rapidamente come succede ben presto alle erbe
dei campi (1, 2);
2° Invece i giusti possiederanno dei beni molto
superiori, come compenso della loro speranza in Dio e la pratica del bene e
avranno come parte: a) una felicità stabile: « voi abiterete la terra », b) una
beatitudine abbondante « e sarete nutriti dalle sue ricchezze » (3), – c) Una
felicità piena di soavità e che colmerà tutti i desideri del loro cuore (4); – d)
una felicità gloriosa: i giusti riveleranno a Dio le loro vie e metteranno in
lui la loro speranza; e come ricompensa: 1) Dio si dichiarerà loro protettore
(5), 2) farà brillare in loro tutte le luci di grazie e di gloria (6); e) i
mezzi per giungere a queste felicità sono: 1) sottomettersi umilmente a Dio, 2)
essergli unito con una fervente preghiera (7); 3) non invidiare il benessere
dei malvagi; 4) frenare la collera e l’indignazione che eccita la vista del
loro benessere; 5) detestare e fuggire gli esempi della loro vita criminale
(8).
II – Questi beni,
indipendentemente dalla loro fragile natura, sono strappati con violenza agli
empi, mentre il benessere dei giusti sarà stabile e perseverante (9).
1° Quanto ai malvagi: a) questa somma rovina che li
minaccia arriverà ben presto (10); b) sarà terribile tanto che non resterà
traccia dei luoghi che essi abitavano, mentre i giusti erediteranno la terra e
si vedranno: c) ricolmi di gioia nell’abbondanza di una pace beata (11); – d)
essi saranno maledetti nei tempi nel tempo stesso in cui si credono e si proclamano
i beati della terra: 1) a causa delle pene che si danno nel tendere insidie ai
giusti, e dell’invidia che nutrono verso di essi (12); 2) a causa della paura
del giusto Giudice, che essi sanno che non lascerà i loro crimini impuniti; 3)
a causa della crudeltà che essi dispiegano, delle menzogne e delle frodi alle
quali essi hanno fatto ricorso (14); 4) a causa della tristezza nella quale li
sprofonderà la vista dei loro sforzi impotenti, dei quali saranno essi le prime
vittime, e della felicità dei giusti. (15).
2° Quanto ai giusti: – a) essi saranno felici anche in
mezzo alla mediocrità (16), – b) Dio dà loro la salute e la forza, mentre
snerva e fiacca la forza dei peccatori (17); – c) Dio dà loro una lunga vita,
esente da pene; – d) conserverà l’eredità ai loro figli (18); – e) li nutrirà
abbondantemente in tempi di fame (19); f) distruggerà i loro nemici, la cui
rovina è proporzionata alla loro elevazione (20); mentre i peccatori prendono
in prestito e non possono pagare, i giusti danno largamente e sono sempre
nell’abbondanza, perché essi benedicono Dio ricevendo la terra in eredità (21,
22).
III – Questi beni non possono affatto paragonarsi ai beni riservati ai giusti:
1° Essi vedono Dio: – a) che li dirige sulla strada
lungo la quale camminano (23); – b) che li risolleva se essi cadono (24); – c)
che li nutre abbondantemente in tempo di fame (25); – d) che associa i loro
figli al loro benessere (26); – e) che li aiuta nella fuga dal male e la
pratica del bene, e dà loro la ricompensa eterna che i loro meriti e la loro
giustizia esigono (27, 28), mentre gli empi riceveranno il castigo dovuto per i
loro crimini (29).
2° La loro occupazione è: – a) lodare il Signore con
la bocca (30); – b) amarLo fino al fondo del cuore (31); – c) fuggire i loro
nemici con l’aiuto della protezione di Dio (32, 33); – d) attendere
pazientemente l’eredità promessa a coloro che seguono fedelmente la via del
Signore (34).
3° essi ammirano come gli empi siano travolti e
distrutti senza ritorno (35, 36), mentre Dio pone loro nell’abbondanza (37), li
conserva, li protegge e li libera dalla mano dei peccatori (38, 40).
Spiegazioni
e Considerazioni
I. — 1-8.
ff. 1, 2. – La prosperità dei malvagi in questo mondo è la prova più cruda che i buoni
debbano subire. È un gran male, di cui la vita futura è la sola spiegazione ed
il solo rimedio. Questa prosperità irrita le anime forti, e troppo spesso esse
sono tentate dal mormorare contro la divina provvidenza. Le anime deboli ne
sono scandalizzate, ed hanno pena col difendersi da una segreta gelosia. Il
Profeta oppone a queste due cattive impressioni, un doppio pensiero: la brevità
della vita e la sorte funesta riservata a questi felici del secolo. L’erba dei
campi che piace tanto agli occhi e che dissecca così rapidamente, o che cade
così vilmente sotto la falce, è una immagine viva di quanto destinato ai
malvagi. Il “velociter arescent”, e il “cito decident”, risponde a tutto. Così
la pensa S. Agostino, in questo bel brano del suo “Enarrationes” (Rendu).
– Ma indubbiamente voi siete turbati dal veder felici coloro che vivono male;
dal veder affluire intorno ad essi in abbondanza, i beni di questo mondo. Voi
vedete i loro costumi detestabili, apprezzate le immense ricchezze e nel vostro
cuore voi dite che non c’è giustizia divina, che tutto va secondo la volontà
degli avvenimenti e fluttua al vento casualmente … tutte le malattie dello
spirito hanno il loro rimedio nelle Scritture: e colui che è malato fino al
punto da tener questi discorsi, beva la salutare pozione che contiene questo
Salmo. Prendete questa pozione, bevetene; il Profeta ha preparato questa
bevanda sul soggetto dei vostri mormorii. Solo non respingete questa coppa che contiene
la salute. Aprite con le vostre orecchie la bocca del vostro cuore, e bevete
ciò che intendete. « Astenetevi dal serbare invidia verso i malvagi, e di
essere gelosi di coloro che commettono l’iniquità, perché essi disseccheranno
semplicemente come il fieno, e cadranno ben presto come le erbe dei campi ».
Ciò che vi sembra lungo, è breve agli occhi di Dio: sottomettetevi a Dio e lo
stesso tempo sarà breve anche per voi. Il fieno ha lo stesso senso delle erbe
dei campi. Queste erbe non hanno un prezzo, spuntano su tratti assolati, e non
posseggono radici profonde, cominciano a verdeggiare in inverno, e quando
giungono i primi calori dell’estate, ingialliscono e disseccano. Noi siamo ora
nella stagione invernale, e la vostra gloria non appare ancora. Ma se la carità
ha messo profonde radici in inverno, come fa un gran numero di alberi, quando
il freddo cesserà e l’estate sarà giunta, cioè al giudizio, allora si disseccherà
il verde del fieno mentre la gloria degli alberi apparirà nel suo splendore;
perché « … voi siete morti » (Coloss. III, 3), dice l’Apostolo,
nello stesso modo che d’inverno gli alberi sembrano disseccati e come morti.
Qual è dunque la nostra speranza se noi siamo morti? Noi abbiamo una radice
interiore; dov’è la nostra radice interiore, la è la nostra vita, perché là è
la nostra carità! « E la vostra vita, dice l’Apostolo, è nascosta con il Cristo
in Dio » (Ibid.). chi dunque può disseccarsi avendo una simile
radice? Ma quando verrà la vostra primavera? Quando verrà la vostra estate?
Quando saremo rivestiti dalla bellezza del nostro fogliame ed arricchiti
dall’abbondanza dei frutti? Ascoltate il seguito: « Quando il Cristo che è la
vostra vita apparirà, allora anche voi apparirete nella gloria, e allora cosa
faremo? » – « Badate di non portare invidia ai malvagi e gelosia verso coloro
che commettono iniquità, perché essi disseccheranno rapidamente come il fieno e
cadranno presto come le erbe dei campi. » (S. Agost.). – O mondo!
È dunque invano che per farti comprendere la tua brevità, Dio ha messo dappertutto
erbe che appassiscono e piccoli fiori nei campi che durano solo un mattino! O
mondo! I piaceri passano ancora più presto, e nessuna primavera li farà mai rivivere
(Mgr. De la Bouillerie, Symb.).
ff. 3-5. – Solido fondamento della speranza
cristiana è « … sperare nel Signore e fare il bene ». Colui che non è sostenuto
dalla pratica delle buone opere è falso e presuntuoso. – Qual è questa terra che
il Re-Profeta ci consiglia di abitare, se non la vostra anima, che dovete
coltivare con cura, lavorare frequentemente con il vomere dell’aratro
spirituale, così che non sia colpita da sterilità? (S. Ambrog.).
Cosa dovete allora fare? « … mettete la vostra speranza nel Signore », perché
essi sperano, ma non nel Signore: la loro speranza è effimera, la loro speranza
è caduca, fragile, fuggitiva, passeggera, … sarà ridotta a nulla. « Mettete la
vostra speranza nel Signore ». Ebbene, io spero in Lui, ed ora cosa farò? «
Fate il bene ed abitate la terra; non fate il bene al di fuori della terra che
dovete abitare; perché la terra del Signore è la sua Chiesa, essa è irrorata,
coltivata dal Padre, che ne è il lavorante ». (Giov. XV, 1).
Molti in apparenza fanno delle buone opere; ma poiché non abitano la vera
terra, essi non appartengono al celeste agricoltore; fate dunque del bene, ma
non al di fuori della terra. « E cosa me ne verrà? … Voi sarete nutriti dalle
sue ricchezze ». Quali sono le ricchezze di questa terra? Questa terra ha come
ricchezza il suo Signore; essa ha per ricchezza il suo Dio, lo stesso al Quale
il profeta ha detto: « Signore, voi siete la mia parte » (Ps. LI, 26)
– (S. Agost.). – « Dilettatevi nel Signore », amate, cercate di
piacergli, e mettete la vostra gioia, come pure la vostra gloria: allora la
vostra gioia sarà compiuta; essa sarà perfetta come il vostro amore (Bossuet,
Médit. Sur l’Evang.). – Perché il Re Profeta non ha detto: « Egli vi
accorderà … ciò che domanderete », ma « … le domande del vostro cuore » ? È
perché c’è una grande differenza tra le domande dell’uomo esteriore e quelle
dell’uomo interiore; non tutte infatti sono gradite a Dio, perché la legge
della carne è spesso contraria alla legge dello spirito. Ma le domande
dell’uomo che è stato rinnovato dallo Spirito Santo, sono sempre esaudite da
Dio. Ecco ciò che allora fa dire a David: « Egli vi concede ogni cosa secondo
il vostro cuore, e compie tutti i vostri desideri » (Ps. XIX, 5).
Ricordate: « … secondo il vostro cuore » e non secondo i desideri della carne,
e che Egli esaudisce le domande che provengono dal fondo del cuore, e non
quelle che originano dai desideri delle gioie terrene. – Discernete con cura le
domande del vostro cuore dalle domande della carne, perché non è inutilmente
che il Profeta dice in un altro Salmo: « … e Dio è mia parte di eredità
nell’eternità » (Ps. LXXII, 26). Prendiamo un esempio: un uomo è
cieco, chiede di recuperare la vista. Questi lo domanda perché è Dio che fa la
vista e che la dona; ma anche i malvagi la chiedono: questa è una domanda della
carne. Un uomo è malato, chiede la sua guarigione, e in effetti, già sul punto
di morire, ottiene di guarire. È ancora questa una domanda della carne, così
come tante altre domande dello stesso genere. Ma che cos’è una domanda del
cuore? È una domanda della carne il pregare che Dio ci renda la vista, per
gioire di questa luce che i nostri occhi di carne possono percepire; così è una
domanda del cuore quella che si rapporta ad un’altra luce. « Beati coloro che
hanno il cuore puro, perché vedranno Dio. » (Matt. V, 8) – (S.
Agost.). – Lasciarsi condurre dal Signore, scoprirgli semplicemente i
propri bisogni, e poi lasciarlo fare; « dipendere da Dio come un servo dal suo
maestro, che non vuole prevenire i suoi ordini, ma seguirli » (Dug.).
– « Ed Egli farà Lui stesso – compirà la sua opera ». Quanta forza in queste
parole « Egli farà Lui stesso »! il profeta non specifica l’oggetto di questa
azione, ma fa intendere, con questa stessa reticenza, che Dio farà tutto, che
Egli sa meglio di noi stessi ciò che per noi è più utile, e che noi dobbiamo
riferirci soltanto a Lui (Berthier).
ff. 6. – L’impazienza umana non vuole attendere i momenti di Dio. Quando siamo
esposti alla persecuzione degli uomini, o il vento della tribolazione si leva
contro di noi, è per noi sufficiente rappresentare a Dio l’innocenza della
nostra vita; attendiamo con pazienza, teniamoci in silenzio davanti a Dio,
siamo perfettamente sottomessi e contentiamoci di pregarlo (Dug.).
– « … Ed Egli farà brillare la vostra giustizia come la luce e come lo
splendore del meriggio ». Ecco la luce in tutto il suo splendore. È poco il
dire: come la luce. In effetti, noi diciamo già « la luce », quando spunta
l’alba; noi ugualmente diciamo « la luce », quando sorge il sole, ma mai la
luce è così splendente come nel mezzo giorno. Dunque non solo la vostra
giustizia brillerà come la luce, ma ancora il vostro giudizio brillerà come il
sole a mezzodì. Perché ora avete deciso di seguire il Cristo, ne avuto preso la
risoluzione, l’avete scelto: ecco il vostro giudizio, ma nessuno vi ha mostrato
ciò che Egli ha promesso. Ora, voi avete certo una promessa, ma voi ne attendete
la realizzazione, voi avete dunque scelto, nel giudizio della vostra fede di
seguire ciò che non vedete. È là il vostro giudizio; ma quale sia il valore del
vostro giudizio, questo non appare ancora. Questo secolo è come il tempo della
notte. Quando dunque il Signore farà brillare il vostro giudizio come il sole a
mezzodì? « Quando il Cristo, che è la vostra vita, apparirà e vi apparirà nella
sua gloria » (S. Agost.).
ff. 7, 8. – Ecco che lo faccio: io sono sottomesso al Signore e Lo prego insistentemente.
Ma cosa ve ne pare? Questo mio vicino è un malvagio, fa il male, e gode di una
prosperità piena; come resistere davanti ad un tale sovvertimento? Voi siete
malato se pensate così; bevete la pozione che vi guarirà: « … non portate
segretamente invidia a colui che prospera nella sua via; egli prospera, ma
nella sua strada; voi avete delle pene sì, ma sulla strada di Dio; egli trova
delle prosperità nella sua via; per lui, prosperità nella strada e sciagura
all’arrivo, per voi, pena lungo la strada e felicità all’arrivo; perché il
Signore conosce le vie dei giusti ma il cammino degli empi sarà distrutto » (Ps.
I, 6 – S. Agost.). – « Reprimete la vostra collera e
contenete la vostra indignazione »; cioè la natura vi travolge, la passione vi
agita, un’offesa, un oltraggio eccita la vostra indignazione; reprimete questi
moti, che abbiano una misura, un limite, un termine, così che non cadiate nel
peccato. Dio non vi comanda affatto di non montare assolutamente in collera;
Egli cede per un istante a questo moto naturale. Il medico non applica
immediatamente il rimedio all’ammalato, se il dolore è violento, egli impiega
dei calmanti per lenirlo; se la febbre è ardente, egli attende il momento
favorevole, rifiuta anche al malato ogni bevanda. Non gli dice: non avete la
febbre quando essa è al suo apogeo; ma: attendete che la febbre sia cessata,
che questa violenta agitazione si calmi. Così il profeta non dice all’uomo la
cui carne è agitata da tanta passione: « non montate in collera »; ma gli dice.
« … reprimete la vostra collera e contenete la vostra indignazione », per non
cadere in peccato, perché la collera è la grande maestra del peccato (S.
Ambr.).
II. —
9-22
ff. 9, 10. – Dio soffre per qualche tempo e porta
pazienza; ma infine, quando è arrivato il suo tempo, stermina l’empio con la
sua empietà (Dug.). Ma per quanto tempo il peccatore sarà
fiorente? Quanto tempo aspetterò? Voi correte verso questo momento: esso è così
breve anche se vi sembra lungo. È la vostra debolezza che vi fa sembrare lungo
ciò che passa così in fretta. Quali sono ai nostri occhi i desideri di un
malato? Nulla è così lungo per lui, nella sua sete, che il tempo che gli si
prepari la sua bevanda. Gli astanti si impressionano per la paura di vedere il
malato così impaziente. Quando sarà fatto? Quando me lo si darà? Non c’è che
celerità da parte di quelli che vi servono; ma è la vostra malattia che vi va
sembrare lungo ciò che si fa celermente. Così, guardate il vostro medico, come
calma l’impazienza del malato che si lamenta: quando tempo dovrò sopportare,
quanto durerà tutto questo? Ancora un po’ di tempo ed il peccatore non ci sarà
più! Ricordate gli anni trascorsi da Adamo fino al presente; e se voi avreste
trascorso tutto il tempo dalla cacciata di Adamo dal Paradiso fino al presente,
voi vedreste sicuramente che la vostra vita, passata così rapidamente, non
sarebbe stata abbastanza lunga. Ma qual è la durata della vita di un uomo?
Aggiungete tutti gli anni che vorrete, prolungate ancora ed ancor più la vostra
vecchiaia, e che cos’è questo, se non la rugiada del mattino? Se noi
consideriamo così lontano il giorno del giudizio, e che in questo giorno sarà
reso, secondo le loro opere, ai malvagi ed ai giusti, certamente non è il
vostro ultimo giorno. Preparatevi a questo giorno. Come in effetti uscirete da
questa vita, entrerete nell’altra vita (S. Agost.).
ff. 11. – Che l’empio trovi dunque quaggiù le sue delizie nell’abbondanza dell’oro,
nell’abbondanza dell’argento, nell’abbondanza dei suoi possedimenti, nella
ricchezza delle sue case di piacere, nell’abbondanza delle sue rose, nelle
ubriachezze e negli splendori dei suoi festini voluttuosi! È questa dunque la
potenza che invidiate? È questo il fiore che vi affascina? E se anche questa
felicità fosse durevole, non sarebbe ancora l’empio da compiangere? Ma voi, di
quelle delizie gioireste? « … essi troveranno le loro delizie nell’abbondanza
della pace ». La pace sarà il vostro oro, la pace sarà il vostro argento, la
pace sarà la vostra proprietà, la pace sarà la vostra vita ed il vostro Dio
sarà la vostra pace. Tutto ciò che desiderate sarà la vostra pace. Ciò che
quaggiù è oro, non potrà essere per voi danaro; ciò che è vino non può essere
per voi pane; ciò che è luce per voi, non può essere una bevanda. Il vostro Dio
è tutte queste cose per voi; Egli vi possederà interamente, essendo Egli stesso
tutto intero. Là non sarete nella ristrettezza con colui che come voi Lo
possederà tutto intero. Voi Lo possederete per intero ed un altro pure lo possederà,
perché voi ed ogni altro, non farete che una sola cosa, che il vostro
possessore possederà interamente (S. Agost.). – La pace è
l’ordine perfetto; e la turba, i dissensi, le discordie, la guerra, non sono
entrate nel mondo che per la violazione dell’ordine e per il peccato. Così, non
c’è pace ove regni l’orgoglio ed il peccato; non c’è pace nell’uomo i cui
pensieri, le affezioni, le volontà, non siano in tutto conformi all’ordine o
alla verità e alla volontà di Dio; nessuna pace nella società le cui dottrine o
leggi si allontanano dalla legge e dalla dottrina rivelata di Dio; e chiunque,
uomo o popolo, distrugge questa legge, nega queste dottrine, anche in un solo
punto, quest’uomo, questo popolo ribelle a Dio, subisce all’istante il castigo
del suo crimine. Un malessere sconosciuto si impossessa di lui; … io non so
quale forza disordinata lo spinga e lo respinga in tutti i sensi, e da nessuna
parte trovi riposo (Mgr. Pie). No, la pace non è in effetti se
non per i miti, gli umili, i veri figli di Dio; essi la gustano in se stessi,
essi si rallegrano nell’abbondanza della pace, e la espandono sugli altri:
essa, per così dire cola dal loro cuore come questi fiumi che bagnavano il
felice soggiorno del nostro primo padre, ai tempi della sua innocenza.
ff. 12, 13. – C’è un’attenzione maligna del peccatore nell’osservare tutti gli sforzi
del giusto, per trovare così l’occasione di perderlo. Se non scopre in lui
alcun male, li inventerà, e se non può far esplodere il suo furore, digrignerà
i denti contro di lui (Dug.). – Noi concepiamo facilmente come
Dio, il cui sguardo abbraccia il mondo e l’eternità, non rida delle pretese e
delle violenze del malvagio. Attraverso tutti i loro successi, ed a dispetto di
ogni loro sicurezza, Egli vede giungere il loro giorno. E a noi non resta che,
illuminati dal Vangelo, e fortificati dalla grazia, approfittare di questa
lunga veduta di Dio, e giudicarne, come giudica Egli stesso, il presente e
l’avvenire dei giusti e dei peccatori (Rendu). – Il Signore vede
avanzare questo giorno ma voi non lo vedete. Ora Colui che lo vede ve lo ha
mostrato. Voi ignorate il giorno in cui l’empio sarà punito; ma Colui che lo
conosce non lo ha nascosto. È avere una gran parte di scienza l’essere unito a
Colui che sa. Dio ha gli occhi della scienza; voi abbiate quelli della fede;
ciò che Dio vede, credetelo, perché il giorno dell’empio arriverà, e Dio lo
vede anzitempo (S. Agost.). « Dio, dice Tertulliano, avendo posto
il giudizio alla fine dei secoli, non precipita il discernimento, che ne stima
condizione necessaria »: è la verità stessa che Gli ha dettato questo pensiero.
Perché non avete notato questa parola ammirevole: Dio non precipita il
discernimento? Precipitare gli affari, è proprio della debolezza che è
contraria al premurarsi nell’esecuzione dei propri disegni, perché essa dipende
dalle occasioni, e queste occasioni sono certi momenti di cui la fuga subitanea
causa una necessaria precipitazione a coloro che sono obbligati ad attaccarvisi.
Ma Dio, che è arbitro di tutti i tempi, che dal centro della sua eternità sviluppa
tutto l’ordine dei secoli, che conosce la sua Onnipotenza, e che nulla può
sfuggire alle sue mani sovrane, ah! … Egli non precipita i suoi consigli. Egli
sa che la saggezza non è nel fare sempre le cose prontamente, ma nel farle nei
tempi necessari. Egli lascia censurare questi disegni ai folli e ai temerari,
ma non ritiene di doverne anticipare l’esecuzione per il mormorio degli uomini.
« … per Lui è abbastanza, Cristiani, che i suoi amici ed i suoi servitori
guardino da lontano venire il suo giorno con umiltà e tremore; per gli altri,
Egli sa ove attenderli, ed il giorno per punirli è segnato; Egli non si cura
dei loro rimproveri, perché vede venire il suo giorno rapidamente ». (Bossuet.
Serm. Sur le 3° Dim. Ap. Paques, Provid.). – Uscendo dalle nostre idee
ristrette, prolungheremo i nostri sguardi come quelli di Dio, giudicheremo Dio
come fa dalla sua eternità immobile, possessore del tempo, Creatore dei secoli,
che vede tutto scorrere davanti a Lui, che passa rapidamente come l’onda
follemente irritata, come schiuma impotente che si frange per perdersi e
svanire per sempre. Eleviamoci fino al Dio vero, fino al Dio eterno. Egli vede
le iniquità della terra, il suo occhio segue il lavorio perverso dei suoi
nemici, lo sviluppo vittorioso dei loro disegni, i loro complotti sapienti, le
loro audaci imprese, sempre coronate da successo; essi fanno la guerra a Dio;
essi vogliono annientare la sua Chiesa; già l’edificio vacilla; essi trionfano;
essi predicono la decadenza prossima del Cristo, l’avvenire è per loro! Che fa
Dio? Dio se ne ride di tutti loro. E perché? « Perché vede avvicinarsi il suo
giorno ». Ecco la parola rivelatrice, ecco la spiegazione luminosa intorno alla
quale ruota la trama della storia (Doublet, Psaumes étud. En vue de la
Préd.).
ff. 14, 15. – È facile per i malvagi raggiungere con la propria arma o la loro spada il
vostro corpo, come il persecutore ha raggiunto il corpo dei martiri; ma se il
corpo è stato colpito, il cuore è rimasto intatto; al contrario, il cuore di
colui che ha colpito con la spada il corpo del giusto, non è evidentemente
rimasto intatto: ciò che prova il salmo. Esso non dice: … che la loro arma
entra nei loro corpi, ma che la loro arma entra nel proprio cuore. Essi hanno
voluto portare la morte nel corpo del giusto; essi portano la morte nella loro
anima. Gli insensati somigliano a colui che per strappare la tunica ad un altro,
passerebbe il ferro attraverso il proprio corpo. Voi guardate ed avete colpito,
e non guardate ove siete passati; voi avete strappato il vestito di un altro ed
avete trafitto la vostra carne (S. Agost.). – Voi vedete due
specie di armi tra le mani del peccatore. Un arco per tirare da lontano, una
spada per colpire da vicino. L’arco si rompe ed è inutile; la spada porta il
colpo, ma contro se stesso. Comprendiamo il senso di queste parole: il peccatore
tira da lontano, egli tira contro il cielo e contro Dio, e non solo i dardi non
arrivano, ma ancora l’arma si rompe al primo sforzo. Ma non è sufficiente che
l’arco di spezzi e che la sua impresa sia inutile; bisogna che la sua spada gli
trapassi il cuore e che, per aver tirato da lontano contro Dio, egli si dà da
vicino un colpo senza rimedio, se Dio non lo guarisce con un miracolo. È il
destino comune a tutti i peccatori. Il peccato, che turba tutto l’ordine del
mondo, mette disordine primariamente in colui che lo commette. La vendetta, che
esce dal cuore per distruggere tutto, porta sempre il suo primo colpo, il più
mortale, sul cuore che la produce e la nutre. L’ingiustizia, che vuol
profittare del bene altrui, fa la prima prova sul suo autore, che essa spoglia
del suo bene più grande, che è la dirittura, prima che possa rapire ed usurpare
quella degli altri. Il maldicente non distrugge negli altri che la rinomanza,
ma distrugge in lui la stessa virtù. L’impudicizia che vuole corrompere tutto,
comincia in effetti dalla sua sorgente, perché nessuno può attentare
all’integrità altrui, senza perdere la propria. Così ogni peccatore è nemico di
se stesso, corruttore nella propria coscienza del bene più grande della natura
razionale: cioè l’innocenza (Bossuet, Serm. Pour la 3 Dim. De l’Av.).
ff. 17. – Le ricchezze della terra sono incapaci di rendere felici coloro che le
posseggono. Essi d’ordinario, ne sono posseduti a loro volta. Un uomo ha dei
beni, ma non ne ha affatto; egli non manca di nulla ma tutto gli manca. Le
modiche risorse profittano più al giusto, che le immense ricchezze al
peccatore. La ragione è che Dio dirige il giusto nell’uso che fa dei suoi beni.
– Un’altra ragione per la quale il giusto mette la sua fiducia in Dio, è che è
più felice con pochi beni, mentre la forza e la potenza dei peccatori sono
distrutte nell’ora stessa in cui le loro ricchezze sono a loro tolte, spesso
durante la loro vita, ed infallibilmente al momento della loro morte (Dug.).
– Non sono le ricchezze in se stesse che il Re profeta accusa, ma le ricchezze
dei peccatori. Forse parla così perché il peccatore per eccellenza ha detto: «
tutte queste cose mi sono state assegnate, ed io le do a colui che voglio » (Luc.
IV, 16). – Un’altra ragione, è che le ricchezze attirano i bollori
della cupidigia, e colui che desidera possedere grandi ricchezze non evita
ordinariamente gli ostacoli dai quali la vita dei peccatori è disseminata. « …
La loro eredità sarà eterna », perché essi hanno cercato i beni eterni e non i
beni fragili delle eredità terrene, e non avranno da arrossirne « (S.
Ambr.).
ff. 18. « Il Signore conosce i giorni di quelli che sono senza macchia ». Colui
che conosce il Signore è conosciuto dal Signore. Egli conosce i giusti e non
conosce gli ingiusti; anche ad essi un giorno dirà « allontanatevi da me voi
tutti operatori di iniquità, Io non vi conosco » (Matt. VII, 23),
cioè: voi siete indegni della conoscenza divina. Io non vi conosco perché voi
non avete voluto conoscermi. Le vostre opere non mi conoscono, le vostre azioni
non mi conoscono; benché voi diciate che mi conoscete, i vostri peccati vi
smentiscono e vi condannano. I peccatori non hanno dei giorni, perché essi
fuggono la luce, e di essi lo Spirito Santo ha detto: « i loro giorni passano
come l’ombra » (Ps. CXLIII, 14). La conoscenza in Dio è un atto
di bontà e di condiscendenza e non un atto di visione. I suoi occhi sono luce,
Egli rischiara coloro che lo guardano, ed i suoi occhi sono i giorni dei giusti
(S. Ambr.).
ff. 19, 20. – Cosa vuol dire: « … essi non saranno confusi nei tempi malvagi »? essi non
saranno confusi nei tempi di afflizioni, nei giorni di angoscia, come colui la
cui speranza è delusa. Chi è dunque colui che è confuso? Colui che dice: io non
ho trovato ciò che io speravo. E non è senza ragione, perché mettevate la
vostra speranza in voi stessi, o speravate in un uomo vostro amico. Ora, « … maledetto
colui che ripone la sua speranza in un uomo » (Gerem. XVII, 5). –
Voi siete confusi perché la vostra speranza vi ha deluso poiché riposava sulla
menzogna, poiché … ogni uomo è menzognero (Ps. CXV, II). Se al contrario
mettete la vostra speranza nel vostro Dio, voi non sarete confusi, perché Colui
nel Quale avrete riposto la vostra speranza non può essere ingannato. Ecco
perché questo giusto afferma quello che vengo a ricordarvi, e cosa ha detto,
dopo aver attraversato, senza essere confuso, dei tempi malvagi e dei giorni di
tribolazione? « Noi ci glorifichiamo delle nostre tribolazioni, sapendo bene
che la tribolazione produce la pazienza, la pazienza una virtù provata, e la
virtù provata la speranza, e che la speranza non è delusa » (Rom. V, 3).
– Perché la speranza non è delusa? Perché riposa in Dio. Così dice continuando:
« perché l’amore di Dio è stato infuso nei nostri cuori dallo Spirito-Santo,
che ci è stato dato. Poiché già lo Spirito Santo ci è stato dato, come Colui
dal Quale abbiamo ricevuto un tal pegno, potrebbe ingannarsi? » – « E nei
giorni della carestia, essi saranno saziati ». Da quaggiù, in effetti, c’è per
essi una vera sazietà; perché i giorni della vita presente sono i giorni della
carestia; e mentre gli altri hanno fame, i giusti sono saziati (S. Agost.).
– Cosa fa al contrario il malvagio, quando comincia a sentire la tribolazione?
Esternamente non ha più niente, tutto gli viene tolto; nella sua coscienza egli
non trova nessuna consolazione. Egli non ha come uscire da se stesso, all’esterno
tutto è afflizione, non ha dove rientrare in se stesso: all’interno tutto è
cattivo. E giunge a ciò che il profeta aggiunge: « … perché i peccatori
periranno ». Come, in effetti non periranno coloro che non hanno asilo da
alcuna parte? Non ci sono per essi consolazioni né all’esterno, né all’interno.
I peccatori non hanno asilo nelle cose esterne, perché non trovano la causa
delle loro tribolazioni; la loro coscienza non li consola; non sono sereni con
se stessi, perché è impossibile essere sereno per un malvagio. Ora, chiunque
sia malvagio, sta male con se stesso, è inevitabilmente lo strumento del
proprio supplizio. Colui che tortura la propria coscienza è castigo a se
stesso. Egli fugge un nemico ovunque può; ma egli stesso ove fuggirà? (S.
Agost.). Il fumo, nel momento in cui esce dal braciere, si gonfia in
vortici densi; ma più è denso, più si rivela la sua vanità. Questa massa
fluttuante che non ha appoggi, questo gonfiarsi senza solidità si dissipa più
facilmente nell’aria. Il volume del fumo, lungi dall’avere una consistenza,
piuttosto lo danneggia; ugualmente più il peccatore si eleva, più si gonfia e
si tronfia nei suoi ambiziosi desideri, più Dio si compiace nel ridimensionarlo
e farlo sparire come fumo inutile (S. Agost.).
ff. 21, 22. – Maledette ricchezze, impoverire i felici del mondo per il cattivo uso che
ne fanno: essi prendono in prestito senza mai rendere. La povertà, al
contrario, mette il giusto in questo felice stato di cui parla l’Apostolo, in
cui non avendo nulla, arricchisce gli altri. L’uno dunque non possiede nulla;
l’altro possiede. Vedete dove è l’indigenza e dove le ricchezze. Costui riceve
e non pagherà; quell’altro presta all’infelice di cui ha compassione ed ha
tutti i beni in abbondanza. Ma, se egli è povero? Anche allora è ricco. Gettate
solo un pio sguardo sulle sue ricchezze. Voi in effetti vedete la sua borsa
vuota, ma non fate attenzione alla sua coscienza, che Dio riempie.
Esteriormente non ha risorse, ma interiormente possiede la carità. E quanto,
per questa carità, non danno senza mai esaurirsi? Se in effetti esternamente ha
delle risorse, la sua carità ne disporrà, ed i suoi doni esteriori saranno
veramente quelli della sua carità. Se al contrario non trova esteriormente
nulla da dare, egli dà la sua benevolenza, dà i suoi consigli, se può; se,
infine non può aiutare né con i consigli, né con i soccorsi, egli aiuta con i
suoi auguri, e prega per l’afflitto, e forse per la maniera in cui prega è
esaudito, ed è più utile di colui che dà un pane. Costui ha sempre qualcosa da
dare con il cuore pieno di carità. Questa carità ancora si chiama buona
volontà. Dio non vi chiede null’altro che ciò che vi ha dato interiormente;
perché la buona volontà non è mai nell’impossibilità. Se, in effetti, vi manca
la buona volontà, anche quando avete tanto danaro, voi non lo date al povero;
mentre i poveri sono in grado da se stessi di aiutarsi con la loro buona
volontà, che non resta sterile nei loro mutui rapporti (S. Agost.).
– Due effetti ben diversi vengono dal fatto che il povero benedice Dio nella
sua povertà, mentre i peccatori al contrario, maledicono Dio nelle loro
ricchezze. – Qual è questa terra il cui possesso è benedetto? Non è quella che è coperta da tenebre e piena di amarezza; ma quella in cui
scorre latte e miele, vale a dire che ha la grazia della soavità, e lo
splendore della luce eterna. (S. Ambr.).
III.
— 24 – 40.
È il Signore stesso che conduce i passi
del giusto, ed è anche nel consiglio di Dio che i suoi passaggi siano regolati.
Egli non cammina che secondo le regole della volontà e dello Spirito del
Signore che lo conduce; perché non è lui che vuole, né colui che corre, ma Dio
nella sua misericordia, che veglia sui passi del suo servo, per impedire che
egli cada. Quale fortuna avere Dio stesso per guida nel cammino in cui si
procede, perché se si viene a cadere non si può essere abbattuti, mettendo Dio
la sua mano sul giusto, per impedire che la sua caduta sia mortale! (Duguet).-
Qui si sente il movimento di una madre che vedendo il suo bambino cadere, si
sforza di mettere la mano sotto di lui per attutire il più possibile l’effetto
della sua caduta.
ff. 26. – L’uomo onesto, sobrio e laborioso, guadagna il suo pane. È questo l’ordine
generale ed è sufficiente un po’ di esperienza di vita per acquisirne la
dimostrazione. Ogni impotenza di sussistere risale a quale virtù oltraggiata,
sia la giustizia e la temperanza, sia la prudenza o la forza, e se accidenti
imprevisti possono essere giustamente accusati, essi non sono che l’eccezione
di una regola troppo evidente per essere misconosciuta. La virtù nutre l’anima,
e l’anima nutre il corpo. Voi penserete forse che essa non lo faccia
splendidamente? Ne convengo, perché più l’anima si eleva e gioisce in Dio essa
stessa, meno il corpo ha dei bisogni. È questo anche uno dei segni più
infallibili della virtù, la diminuzione dei bisogni del corpo; e i saggi del
paganesimo, disdegnando le ricchezze, parlavano anzitempo il linguaggio del
Vangelo, e profetizzavano a loro modo, questa parola che apre la legge nuova: «
Beati i poveri! » (Lacord., Conf. T. V, pag. 114). – Non è il
disegno di nostro Signore il dare anche ai suoi fedeli una certezza infallibile
di non soffrire mai alcuna indigenza. Non meravigliamoci dunque di vedere che i
più fedeli servitori possano essere esposti all’indigenza. Ma perché dunque ha
promesso a coloro che cercano scrupolosamente il suo regno, che tutte le altre
cose sarebbero state date loro? Le sue parole sono dubbiose? La sua promessa è
incerta? A Dio non piace che sia così. Come nell’uomo ci sono due tipi di bene,
il bene dell’anima ed il bene del corpo, così ci sono due generi di promesse,
le une essenziali e fondamentali, che riguardano il bene dell’anima, che è
primario; gli altri accessori e accidentali, che riguardano il bene del corpo,
che è secondario. Queste promesse essenziali si compiono di per se stesse, e
l’esecuzione non manca mai; ma essendo il corpo stato formato per l’anima, chi
non vede che le promesse che gli sono fatte, devono essere necessariamente
rapportate altrove? Così il nostro Padre celeste, vedendo nei consigli della
sua Provvidenza ciò che è utile alla salvezza dell’anima, nella sua paterna
bontà dà o meno i beni temporali in rapporto a questo fine principale, con la
stessa condotta di un medico saggio e caritatevole che dispensa il nutrimento
al suo malato, concedendolo o rifiutandolo secondo i bisogni della sua salute (Bossuet,
Serm. sur les disp. a l’égard des nécess. de la vie.). – Pertanto, se
alcuni veri giusti sembrano abbandonati e cercano delle briciole di pane come
Lazzaro, essi hanno ricevuto da Dio qualcosa di meglio che non l’abbondanza dei
beni temporali, e non cambierebbero i meriti della pazienza con tutti i beni
della terra (Bellarm.).
ff. 27, 28. – È una verità spesso ripetuta nei salmi, che bisogna evitare il male e fare
il bene, perché questo è sovranamente importante, e che l’uno non è sufficiente
senza l’altro. – Dio ama la giustizia e non abbandonerà mai i Santi, ma nel
modo per cui la vita dei Santi è nascosta in Lui; così che coloro che soffrono
attualmente sulla terra sono simili ad alberi che d’inverno non hanno né foglie
né frutti; ma quando apparirà il sole nel suo spuntare, la vita che era
nascosta nelle radici si rivelerà con i frutti dell’albero. Donerà loro dunque,
perché non debba abbandonarli, ciò che amate quaggiù, una lunga vita, la
vecchiaia? Voi non riflettete che se desiderate la vecchiaia, voi desiderate
una cosa di cui vi lamenterete quando sarà giunta. Che la vostra anima non vi
dica dunque, per malvagità, debolezza o per mancanza di ragione: come è che sia
vero che il Signore ama il giudizio e non abbandonerà i suoi Santi? (S.
Agost.).
ff. 29 . – Due sono gli aspetti della giustizia: punire i malvagi e ricompensare i
buoni. Dio fa l’uno e l’altro in Dio, vale a dire: punisce severamente e
ricompensa liberamente, e per l’eternità. – Ascoltando queste parole, non vi
promette qualche vasta campagna, o la speranza in un altro mondo nel disprezzo
di questo attuale. Questa terra è la terra dei viventi, la terra dei Santi.
Questo fa dire al Profeta: « … voi siete la mia speranza e la mia parte nella
terra dei viventi » (Ps. CXLI, 6). Se tale deve essere la vostra
vita, comprendete dunque qual sia la terra che avrete in eredità: è la terra
dei viventi. Al contrario la terra ove noi siamo è la terra di coloro che
muoiono, che riceve nel suo seno coloro che ha nutrito durante la loro vita. La
terra è dunque ciò che è la vita: se la vita è eterna, è una terra eterna (S.
Agost.).
ff. 30, 31. – La bocca del giusto non parla come
quella dell’insensato, alla leggera, ma parla con gravità, premeditando ciò che
deve dire, proferendo parole di saggezza conformi alla giustizia. – In questi
versetti è da considerare tutto: 1° la saggezza, che il giusto medita prima di
parlare; – 2° la giustizia, che è l’oggetto ed il motivo delle sue parole; – 3°
la legge di Dio che è profondamente radicata nel suo cuore; – 4° la fermezza
che traspare in tutte le sue fatiche. Il peccatore, l’empio abbandonato ai suoi
lumi o alla sua passione, non può che commettere grandi peccati nel parlare.
Egli riflette poco e si preoccupa ancor meno di consultare la legge di Dio
prima di manifestare il proprio pensiero. Da qui tutti i falsi passi che fa,
sia nella vita civile, sia nella carriera della salvezza. Ciò che fa la
saggezza e la sicurezza del giusto, è che la legge di Dio è nel suo cuore. Il
profeta non dice nella sua testa, nei suoi pensieri; questa conoscenza si
limiterebbe alla speculazione e ne farebbe un sapiente. Questa legge santa è
nel cuore del giusto, egli la medita, la ama, la prende come regola delle sue
azioni e dei suoi discorsi. Questa disposizione del giusto suppone che egli sia
molto dedito alla preghiera e alla lettura dei santi libri, occupazione che fa le
delizie e la felicità della sua vita (Berthier). – La legge di
Dio è nel suo cuore, e di cosa si verve allora? « Egli non sarà abbattuto nel
suo cammino ». La parola di Dio in un cuore, lo preserva da ogni insidia; la
parola di Dio in un cuore lo preserva da ogni via cattiva; la parola di Dio in
un cuore lo preserva da ogni ambito scivoloso. Se la sua parola non esce dal
vostro cuore, Egli evidentemente è con voi (S. Agost.).
ff. 32-34. – Il peccatore osserva sovente il giusto non per edificarsi con la sua pietà
e per imitarlo, ma per tendergli insidie e trovare qualche occasione per
perderlo. – Ma Dio non abbandona i suoi. « Egli dà loro una bocca ed una
saggezza alla quale tutti i loro nemici non possono resistere né contraddire »
(Luc. XXI, 15). Dio non condannerà il giusto quando sarà
giudicati, perché o non gli permetterà che sia condannato, o almeno coronerà la
sua pazienza quando sarà condannato dai giudizi degli uomini (Dug.).
– Ma questo quando avverrà? Badate di non pensarci. È il tempo del lavoro, è il
tempo della semina, è il tempo dell’irrigazione. Sebbene lavoriate in mezzo ai
venti, quantunque lavoriate in mezzo alla pioggia, seminate sempre, non siate
pigri; l’estate verrà presto, ed allora sarete felici di aver seminato. Cosa
farò allora? « … Aspettate il Signore », ed aspettando cosa farò? « … seguite
le sue vie ». E se le seguo, quale sarà la mia ricompensa? « … Egli vi eleverà
affinché possediate la terra in eredità ». Quale terra? Io ve lo ripeto non vi
venga da pensare a nessun possedimento; si tratta di ciò che è stato detto: « …
Venite, benedetti del Padre mio, riceverete questo regno che vi è stato
preparato dall’inizio del mondo. » (Matt. XXV, 34). – E cosa
diverranno coloro che ci hanno tormentato, in mezzo ai quali abbiamo gemito,
dei quali abbiamo sopportato gli scandali? Ascoltate il seguito: « … Quando i
peccatori saranno morti voi vedrete. E quanto vicino vedremo? Voi sarete alla
destra del Cristo, essi saranno alla sua sinistra » (S. Agost.).
– « Quando il peccatore sarà perito, voi vedrete ». Questo pensiero ben
meditato è l’appoggio più stabile dell’anima cristiana, condannata a vedere
quaggiù l’insolente prosperità dei peccatori, e spesso a subire le loro
persecuzioni ed i loro oltraggi. – Sotto forme cangianti e nomi che si
succedono, la vanità dei popoli prima o dopo si mostra. Io dico prima o dopo,
perché la Provvidenza non è mai sempre visibile; se appare sempre, essa non
sparisce mai. Un’apparizione non ha luogo che in virtù di un’assenza. Dio si
nasconde e si rivela di volta in volta per essere visto meglio. Il suo silenzio
fa risaltare la sua parola, la sua sepoltura dà credito alla resurrezione. Ecco
perché vuole essere atteso, e Davide, suo Profeta, diceva eccellentemente al
popolo di Israele: « … Attendi il Signore e Lo vedrai. » E quando lo vedrà?
Ascoltate: tu lo vedrai quando i peccatori periranno. È la forza invincibile
del Cristiano: più di ogni cosa quaggiù, è nella destra di Dio. La provvidenza,
che avviluppa a governa tutto, avviluppa e governa con predilezione. Che sarà
della Chiesa, cenacolo immortale delle anime riscattate, ove nell’oscurità dei
tempi e del cambiamento, la fede, la speranza e la carità, la preghiera, tutte
le virtù e tutte le loro opere si tengono in piedi in attesa del suo giorno? Se
questo giorno viene per tutto il mondo, quanto più presto per la Chiesa e più
inevitabilmente? Quanto ogni figlio di questa Madre feconda e sublime debba ripetere
con una certezza che niente ha mai confuso, la parola di David : « Attendi il
Signore, e quando i peccatori periranno, lo vedrai » (Lacord, LXVII° Conf.).
ff. 35, 36. – Quando l’uomo del bene, umile e modesto,
vede l’orgoglioso prosperare sulla terra, circondato da ricchezze ed onori, si
turba ed è tentato di provare invidia; ma la cima del cedro ha un bel toccare
le nubi e la sua ombra estendersi lontano, per quanto questa gloria sia
effimera. « io ho visto l’empio elevato come il cedro, sono passato, e non
c’era più ». Mentre i vostri pensieri carnali vi portano a desiderare una
felicità terrestre, questa vi sembra le vera felicità, ma perché? Finché siete
in presenza del cedro, voi lo contemplate. Non siete passati, siete nel suo
stesso punto o al di sotto di lui, avanzate e passate; man mano che passate, il
cedro si allontanerà, e non lo vedrete più; Dio solo sarà davanti a voi.
Correndo allora con viva fede verso i beni spirituali, voi direte: io sono
passato, ma il cedro non c’era più, e cercate invano il suo posto. Come la
potenza, le ricchezze, un certo rango nel mondo che gli assicura il rispetto di
un gran numero di persone e l’obbedienza agli ordini che dà; questo posto voi
lo cercherete, ma non lo troverete più (S. Agost.). – Quante fortune
non vediamo più noi stessi tutti i giorni, mutate in tristi rovine e penose
macerie? E quante volte, dopo essere stati spettatori e testimoni delle
rivoluzioni del mondo e di ciò che si chiama la scena del mondo, non avete
detto: io ho visto quest’uomo elevato come i cedri del Libano; io sono passato
e non c’era più; io l’ho cercato e un altro occupava il suo posto. Quanti
esempi ne abbiamo ogni giorno di coloro che sembrano ora i più stabili, gli
eletti del secolo, o come colui che osa o possa promettersi una più felice o
durevole posterità? (Bourd. Récomp. des saints.).
ff. 37. – Custodite
l’innocenza, così come un tempo, quando eravate avaro, custodivate la vostra
borsa, come la tenevate per paura che un ladro la rubasse. Custodite ancora la
vostra innocenza per timore che il demone ve la rubi. Che sia per voi un
patrimonio sicuro, perché essa rende ricchi gli stessi poveri. « Custodite
l’innocenza, cosa vi serve il guadagnare l’oro, se perdete l’innocenza? E non
vedete ciò che è retto ». Che i vostri occhi siano retti, per non vedere solo
ciò che sia retto; che non siano cattivi, in modo che non vediate che i
malvagi; che non siano torbidi fino al punto che Dio vi sembri ingiusto, perché
favorisce gli empi e perseguita i giusti. Non notate come vedete di traverso?
Correggete i vostri occhi e non guardate se non ciò che sia retto. Ma cosa
vedere di retto? Badate a non fare attenzione alle cose presenti. Cosa vedrete
allora? « Cosa resta dei beni all’uomo pacifico? ». Quando sarete morto, voi
non sarete morto; ecco il senso di queste parole … restano dei beni. Egli avrà
qualche altra cosa anche dopo questa vita: e quest’altra cosa è la sua
discendenza, che ne sarà benedetta. Ecco perché il Signore ha detto: « Colui
che crede in me, benché muoia, vivrà » (S. Agost.). – Questi beni
riservati, questo resto, per impiegare l’espressione del Profeta, contengono un
grande senso. Al giusto resta tutto, all’empio non resta nulla. Il giusto ha
sempre davanti agli occhi questo resto prezioso che gli viene riservato come
ricompensa dei suoi lavori e risarcimento per le sue prove, e ripete con San
Paolo: « Io so a Chi mi sono affidato, ed è tanto potente da conservare il
deposito delle mie speranze fino a questo grande giorno » (II Tim., I, 12).
ff. 38-40. – Gli ingiusti e le loro ingiustizie periranno egualmente. Quelli che avranno
lasciato dietro di loro, grandi ricchezze, magnifici palazzi, splendide proprietà,
tutto perirà con loro. Solo i loro crimi sussisteranno eternamente (Dug.).
– « La salvezza dei giusti viene dal Signore, e non dal mondo degli elementi.
Il cielo e la terra passeranno. Io non affido la mia salvezza al cielo, perché
il cielo passerà e sarà distrutto, mentre Dio resta » (Ps. CI, 27). – Io affido
la mia salvezza solo a Dio, che resta e permane, che può rimettere i peccati,
affinché sia mio protettore nel giorno della tribolazione, … venga in mio
soccorso, mi liberi e mi separi dai peccatori nel giorno del giudizio, perché
io ho sperato in Lui (S. Ambr.). – Al contrario la
salvezza sarà data dal Signore ai giusti, etc. Che i giusti allora sopportino
oggi i peccatori, che il frumento sopporti la zizzania, che il grano sopporti
la paglia, perché verrà il tempo della separazione, e la buona semenza sarà
separata dalla paglia che il fuoco consumerà. La prima sarà raccolta nel
granaio, l’altra sarà gettata nelle fiamme eterne. È così che il giusto e
l’ingiusto sono stati dapprima mescolati insieme, in modo che l’ingiusto
sopravanzi il giusto, e questi sia provato; ma in seguito l’ingiusto sarà
condannato, ed il giusto coronato (S. Agost.).