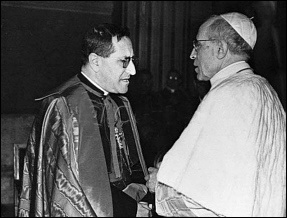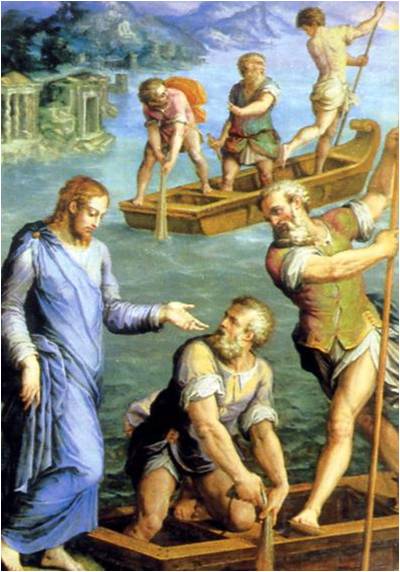Salmo 6: “DOMINE, NE IN FURORE TUO“
CHAINE D’OR SUR LES PSAUMES
ou LES PSAUMES TRADUITS, ANALYSÉS, INTERPRÉTÉS ET MÉDITÉS A L’AIDE D’EXPLICATIONS ET DE CONSIDÉRATIONS SUIVIES, TIRÉES TEXTUELLEMENT DES SAINTS PÈRES, DES ORATEURS ET DES ÉCRIVAINS CATHOLIQUES LES PLUS RENOMMÉS.
[I Salmi tradotti, analizzati, interpretati e meditati con l’aiuto delle spiegazioni e delle considerazioni seguite, tratte testualmente dai santi Padri, dagli oratori e dagli scrittori cattolici più rinomati da …]
Par M. l’Abbé J.-M. PÉRONNE,
CHANOINE TITULAIRE DE L’ÉGLISE DE SOISSONS, Ancien Professeur d’Écriture sainte et d’Éloquence sacrée.
TOME PREMIER.
PARIS
LOUIS VIVES, LIBRAIRE-ÉDITEUR
13, RUE DELAMMIE, 1878
IMPRIM.
Soissons, le 18 août 1878.
f ODON, Evêque de Soissons et Laon.
SALMO 6
In finem, in carminibus. Psalmus David. Pro octava.
[1] Domine, ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me.
[2] Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum; sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea.
[3] Et anima mea turbata est valde; sed tu, Domine, usquequo?
[4] Convertere, Domine, et eripe animam meam; salvum me fac propter misericordiam tuam.
[5] Quoniam non est in morte qui memor sit tui; in inferno autem quis confitebitur tibi?
[6] Laboravi in gemitu meo; lavabo per singulas noctes lectum meum; lacrimis meis stratum meum rigabo.
[7] Turbatus est a furore oculus meus; inveteravi inter omnes inimicos meos.
[8] Discedite a me omnes qui operamini iniquitatem, quoniam exaudivit Dominus vocem fletus mei.
[9] Exaudivit Dominus deprecationem meam; Dominus orationem meam suscepit.
[10] Erubescant, et conturbentur vehementer omnes inimici mei; convertantur, et erubescant valde velociter.
[Vecchio Testamento Secondo la Volgata Tradotto in lingua italiana da mons. ANTONIO MARTINI Arciv. Di Firenze etc.
Vol. XI
Venezia, Girol. Tasso ed. MDCCCXXXI]
SALMO VI.
Il peccatore prega pel timore del giudizio divino, e sospira di riconciliarsi con Dio. Salmo da cantare sull’istrumento musicale da otto corde.
Per la fine: Cantico, e salmo di David; per la ottava.
1. Signore, non mi riprendere nel tuo furore, e non mi correggere nell’ira tua.
2. Abbi pietà di me, perché io sono senza forze: sanami, o Signore, perché le ossa mie sono scommosse,
3. E l’anima mia è grandemente turbata; ma tu, o Signore, fino a quando?…
4. Volgiti, o Signore, e libera l’anima mia; per tua misericordia dammi salute.
5. Imperocché nella morte non è chi di te si ricordi; e nell’inferno chi mai ti confesserà? (1)
6. Mi son consumato nel gemere: laverò tutte le notti il mio letto (col pianto), il luogo del mio riposo irrigherò colle mie lagrime.
7. Per lo furore l’occhio mio si è ottenebrato, sono invecchiato in mezzo a tutti miei nemici.
8. Andate lungi da me voi tutti, che operate l’iniquità, conciossiachè il Signore ha esaudita la voce del pianto mio.
9. Il Signore ha esaudite le mie suppliche, il Signore ha accolta la mia orazione.
10. Sieno svergognati e sconturbati altamente tutti i miei nemici: sieno volti in fuga, e svergognati in un attimo.
(1) L’inferno, l’altro mondo (Levit. XVI, 30, 33), è luogo nel quale coloro che morivano si trovavano radunati (Giob. XXX, 23) prima che Gesù-Cristo avesse portato a termine la sua opera; esso non era solo per i malvagi, come l’inferno propriamente detto, ma un luogo di lamento (Giob. XXVI,5) anche per i buoni, e non era affatto, come soggiorno prima di essere ammessi in cielo, un luogo di gioia, ma di silenziosa tristezza (Sal. XXIX, 10; Is. XXXVIII, 18; Eccl. IX,10), e sotto questo aspetto non era un luogo ove Dio fosse riconosciuto o lodato, come lo è al presente sulla terra (Dallioli)
Sommario analitico
Preghiera di Davide penitente che, in occasione di una malattia perniciosa dalla quale fu colpito per punizione dei suoi peccati, ed in seguito al dolore che ne ha tratto, deplora il male che ha avuto nell’offendere Dio. Egli chiede a Dio di non giudicarlo con il rigore della sua giustizia, ma di aver pietà di lui (1), ed a supporto della sua richiesta adduce diversi motivi:
1) la sua miseria, la sua debolezza, la sua infermità, che sono l’oggetto della misericordia (2);
2) La consapevolezza che ha del suo peccato, ed il turbamento in cui lo getta questa conoscenza (2, 3);
3) La misericordia di Dio, causa unica della nostra conversione, del perdono che libera la nostra anima e della nostra salvezza.
4) Motivi derivanti dalla gloria di Dio che non possono più procurare coloro che sono morti alla vita del corpo, alla vita della grazia, alla vita eterna (5);
5) Il rigetto, la contrizione perfetta che egli ha dei suoi peccati e la penitenza che egli ne fa: – a) Contrizione interiore: « sono stremato per il gemere »; b) Contrizione esteriore: « io laverò con le mie lacrime etc. … » (6); c) Il tempo ed il luogo più favorevoli alla compunzione, « ogni notte laverò il mio giaciglio con le mie lacrime »; d) la causa, la collera di Dio che egli ha offeso, e la sua lunga perseveranza nel male (7)
6) L’effetto di questa contrizione: a) per lui il fermo proposito di non peccare più e di allontanarsi dalle occasioni a causa dell’onta di Dio (8, 9); b) in Dio, che la sua preghiera sia esaudita; c) per i suoi nemici, la loro confusione, la loro fuga e la loro conversione (10).
Spiegazioni e Considerazioni
ff. 1. – Quando sentite parlare di furore e di collera di Dio, non sospettate in Lui nessuna delle passioni proprie alla natura umana, egli impiega queste espressioni per condiscendere alla nostra debolezza; egli cerca nondimeno di conformare il suo linguaggio alla sua dignità ed a nostra utilità (S. Chrys.). – « Per voi, Dio delle schiere, voi giudicate con calma » (Sapien. XII, 18). Ora ciò che è calmo, non è turbato. La turbolenza non è dunque in Dio quando Egli giudica, riprende o castiga, ma è nei ministri dei suoi decreti, come coloro che non agiscono che secondo le sue leggi, e questa si chiama: la collera di Dio (S. Agost.). Tre sono le maniere con le quali Dio si mette in collera: come Padre, per correggere; come Signore, per punire; come Giudice, per condannare e riprovare. – Il giorno della collera di Dio è soprattutto l’ultimo giorno. Il tempo presente è il tempo della misericordia. « Voi ammassate, dice S. Paolo, un tesoro di rampogne per il giorno della collera del giusto giudizio di Dio »; giorno terribile, nel quale non vuole essere accusato nessuno di coloro che in questa vita desiderano essere guariti (S. Agost.). – Occorre pregare Dio di castigarci nel tempo e di risparmiarci nell’eternità. (S.Agost.) – Dio punisce nel suo furore in due modi: il più terribile è nei riguardi dei riprovati, che sono eternamente l’oggetto delle sue vendette; l’altro modo, anch’esso formidabile, è quando Egli permette in questa vita che i peccatori si induriscano e siano accecati sui loro crimini. – Ecco una nuova maniera di vendicarsi che non appartiene che a Dio solo: lasciare i suoi nemici a riposo, e punirli oltremodo con il loro indurimento e con il sonno letargico, che produce in loro un castigo esemplare … È l’ultimo flagello che Dio manda ai suoi nemici; è il colmo di tutti i malanni, è la disposizione più prossima all’impenitenza finale e alla definitiva ed irrimediabile rovina (Bossuet, Serm. 1^ Dim. Av.).
ff. 2.- Davide non offre il motivo che egli meriti la misericordia di Dio, ma che è infermo. – Confessa la sua infermità al Medico sovrano, mezzo infallibile per ottenere la guarigione. « Io sono infermo, voi siete medico; la mia sorte, la mia parte, è quella di essere malato; la vostra missione è quella di rendermi la salute » (S. Gerol.). – « Non sono i sani ad aver bisogno del medico, ma quelli che sono malati. Io sono venuto a chiamare i peccatori » (Mat. IX, 12). – Cause multiple di infermità sono: il peccato originale, l’inclinazione al male, i peccati commessi, la debolezza estrema nella quale essi riducono la nostra anima. « Le mie ossa sono scosse ». Per ossa bisogna intendere la forza tutta intera dell’uomo, e per il turbamento, la pena, la punizione e la vendetta che seguono il peccato (S. Chrys.). « Lo scompiglio è conseguenza naturale del peccato. Quando i venti si scatenano sul mare con violenza, essi l’agitano, lo sconvolgono fin nelle profondità, portando in superficie la sabbia che forma il suo letto. Così, quando il turbamento si impadronisce della nostra anima, tutto in noi è in preda alla tempesta, la nostra barca è in continua agitazione, tenebre fitte ci circondano, tutto in noi sembra vacillare dalle basi in mezzo a questo sovvertimento generale e a questa confusione estrema ». (S. Chrys.). – « Ma voi Signore, fino a quando? » Questo è il linguaggio dell’anima che lotta contro le malattie dell’anima che il medico ha abbandonato da tempo, alfine di fargli sentire in quale sventura essa sia precipitata da sola a causa del peccato. Non ci si preoccupa di un male che guarisce facilmente; ma al contrario più la guarigione sarà difficile, maggiormente si avrà cura di conservare la salute recuperata (S.Agost.).
ff. 3. – Rimarchiamo quest’ordine. Dio si volge verso di noi e ci riguarda con la sua grazia; poi noi ci rivolgiamo verso di Lui e la nostra anima è ghermita dal peccato. Prezioso sguardo di Dio che ci cambia in un istante, rammollisce la durezza del nostro cuore, e ci fa erompere, come a Pietro, in torrenti di lacrime per i nostri peccati. – Davide non chiede che due cose: che il Signore si volga verso di lui, e che liberi la sua anima. Ciò che i giusti ricercano con maggiore timore, è che Dio non distolga da loro gli sguardi della sua misericordia e, come conseguenza di questa prima grazia, che la loro anima sia salvata. La maggior parte degli uomini, nei loro istinti grossolani, non cercano che un’unica cosa: i godimenti della vita presente. I giusti, al contrario, non hanno che un solo desiderio, un solo oggetto che oltrepassa tutti gli altri, e questo è la salvezza dell’anima (S. Crys.).– Riconoscete la caduta della vostra natura peccaminosa e, anche dopo esserne stato risollevato, l’estremo languore, la malattia profonda che vi resta? Dio vuole che voi Gli diciate: « Guaritemi » perché in questo momento io me ne muoio e non posso nulla senza di Voi (Bossuet, Elév. XVIII, S. XVI.).
ff. 4. – « La mia anima, dice Davide, è turbata, e voi, Signore, fino a quando mi lascerete in questo turbamento? » Ed il Signore gli risponde: « fin quando potrete riconoscere per esperienza che Io sono capace di soccorrervi; perché se Io vi soccorro senza alcun ritardo, voi non sentirete la lotta; se voi non sentite questo combattimento, voi presumerete delle vostre forze, e questo orgoglio che si imporrebbe sarebbe un ostacolo invincibile alla vostra vittoria » (S. Agost. Serm. CLXIII, n° 8.).
ff.5. – Tre tipi di morte vi sono: la morte naturale, che separa il corpo dall’anima; la morte spirituale che separa l’anima dalla grazia; la morte eterna che separa il corpo e l’anima dalla gloria. Nella prima morte quasi nessuno che si ricordi di Dio; nella seconda, appena lo si incontra; nella terza non c’è alcuno che si sovvenga di Dio in maniera utile. È soprattutto della morte dell’anima che è vero dire che: coloro che ne sono affetti, non si ricorderanno di Dio, e non possono lodarlo. È vero anche dire che il tempo attuale è quello della conversione, perché all’uscita da questa vita, non resta altro da raccogliere se non ciò che si è meritato (S. Agost.). – Al momento della morte, quasi nessuno che si ricordi di Dio, ma con un castigo giustissimo e temibile, coloro che hanno dimenticato Dio durante la loro vita, non si ricordano di Lui alla morte. È l’eterno oblio di Dio al quale saranno condannati i dannati, e sciagurata è l’impotenza nella quale si troveranno, di lodare Dio. Triste necessità è l’essere eternamente senza la possibilità di vedere Dio, stare eternamente con i suoi nemici, senza amarlo in eterno, ed in eterno essere detestati da Lui, eternamente costretti a maledire Colui che è degno di tutte le benedizioni del cielo e della terra (Bossuet).
ff. 6. – Magnifico esempio di penitenza che ci dà questo Re rivestito di porpora. Non solo si affatica, ma si consuma a forza di gemere; non si contenta di piangere, ma inonda il suo letto di lacrime; ma questo non solo per due o tre giorni, ma ogni notte, e ciò che ha fatto per il passato, lo promette anche per l’avvenire (S. Chrys.). – Le notti sono tanto spesso trascorse nelle lacrime, passate oramai non più nel peccato, né nel riposo ozioso, ma nell’amarezza del cuore, nel dolore e nella penitenza. – Il letto è anche il luogo in cui riposa lo spirito malato ed indebolito, cioè ancora immerso nelle voluttà del corpo e in tutte le delizie del secolo. Le delizie egli le lava nelle lacrime, che si sforza di non arrestare. (S. Agost.). – Irrorare di lacrime il proprio letto, è cancellare con un dolore perseverante le sozzure che il peccato ha lasciato nella nostra anima e nel nostro cuore (S. Greg.). « Inonderò » dice qualcosa in più di « io laverò », perché una cosa può essere lavata anche solo in superficie, mentre una cosa inondata è interamente penetrata (S. Agost.). Nel silenzio delle notti, io risalirò con il ricordo questo cammino che ho disceso così in fretta; andrò a cercare i fiori della mia innocenza; essi sono sporchi, ma imperituri; io li bagnerò così tanto di lacrime che essi riprenderanno un po’ del loro antico splendore; la virtù rinasce nella preghiera, il pentimento è bello come l’innocenza, il profumo di Maria-Maddalena fu molto gradito a Gesù.
ff. 7. – Questo occhio è l’occhio dell’anima, questa facoltà cioè di giudicare e di ragionare, che viene ad offuscare e turbare la coscienza delle nostre colpe. Il ricordo delle colpe sempre presenti davanti ai suoi occhi ricordava allo spirito di Davide la giusta collera di Dio, e lo riempiva di ansietà, di turbamento e di sgomento (S. Chrys.). – Si tratta qui in effetti della collera di Dio, cioè dell’inizio di questa collera, dalla quale ogni peccatore si sente colpito in questa vita, perché i peccatori soffrono già in questa vita dei dolori e dei tormenti, e particolarmente la perdita dell’intelligenza della verità. – È una grande disgrazia il vivere nel peccato, è una disgrazia ancor più grande invecchiare in esso, ma la disgrazia sovrana, è il morirne. – Questi nemici sono dunque i nostri stessi vizi, oppure degli uomini che sono nostri nemici, perché non vogliono convertirsi a Dio. Perché questi uomini, benché risparmino i buoni, benché abbiano a trattare con essi senza discussioni e in apparente concordia, benché mangino insieme, abitino insieme, stiano nelle stesse città, questi uomini, in ragione dell’opposizione delle loro intenzioni, anche a loro insaputa, sono i nemici di coloro che si convertono a Dio. In effetti, gli uni amano e cercano il mondo, gli altri desiderano essere liberati dal mondo: chi non vede che i primi sono i nemici dei secondi? Perché se essi potessero, li coinvolgerebbero nelle stesse pene. È un gran beneficio divino in effetti l’essere frammischiati ogni giorno nella loro vita, nelle loro faccende senza abbandonare la strada dei Comandamenti di Dio (S. Agost.). La nostra vita nella sua interezza, è un vero combattimento, siamo continuamente assediati da mille nemici diversi che diventano più forti di noi una volta caduti nel peccato. Occorre allora fare sforzi estremi per sfuggire dalle loro mani, e non bisogna mai patteggiare con essi fino all’ultimo respiro.
ff. 8., 9. – Il vero frutto della penitenza è l’evitare tutte le occasioni di peccato, il separarsi dalla società dei malvagi, chiunque essi siano, e se necessario anche dalle nostre stesse membra (S. Chrys.). « Quale legame in effetti, dice San Paolo, possiamo avere con l’ingiustizia e l’iniquità? Quale unione tra la luce e le tenebre? Quale accordo tra Gesù-Cristo e “belial”? Quale società tra il fedele e l’infedele? Quale rapporto tra il tempio di Dio e gli idoli? » (I Cor. VI, 14-15). Dopo questi dolori, questi gemiti, questi effluvi di lacrime, è impossibile che una preghiera così fervente sia vana presso Colui che è la fonte di tutte le misericordie, perché, « il Signore – dice Davide – (Salm. XXXIII, 19) è vicino a chi ha il cuore contrito » (S. Agost.). « Egli ha esaudito la voce delle mie lacrime »: questa voce non è certo il suono esteriore delle sue parole o delle sue grida, ma è l’espressione interiore della sua anima; questi pianti non sono le lacrime che sgorgano dagli occhi, ma quelle che escono dal cuore.
ff. 10. – Due sono i frutti di questa preghiera, per cui coloro che sono stati i complici, i lusingatori, gli approvanti la nostra condotta viziosa e criminale arrossiranno: essi saranno pieni di turbamento e coperti di confusione, e se non arrossiranno qui in basso, se, lungi dall’arrossire, riusciranno con le loro beffe a far arrossire i deboli del nome di Gesù-Cristo, essi arrossiranno nel giorno della ricompensa per i giusti e del castigo per i malvagi. Il profeta aggiunge: « improvvisamente ». In effetti nel momento in cui non aspetteranno più il giorno del giudizio, quando grideranno « Ecco la pace! Allora una morte improvvisa li assalirà » (I Tessal. V, 3). Un avvenimento è sempre improvviso nel momento in cui arriva, proprio quando non si pensa che possa giungere. Noi non avvertiamo la lunghezza di questa vita per la speranza di vivere ancora; perché nulla ci sembra più rapido del tempo già passato da quando viviamo. Quando dunque arriverà il giorno del giudizio, i peccatori sentiranno che tutta la vita che passa non possa essere di lunga durata (S. Agost.). – Un altro frutto molto più prezioso è ancor questo: essi arrossiranno, saranno coperti dall’onta e dalla confusione, ma non « di questa confusione che fa cadere nel peccato », ma « di quella confusione che attira la grazia e la gloria » (Eccles. IV, 15); perché la penitenza esige la confusione ed lo sconcerto (S. Agost.). In effetti, se quelli che corrono nella carriera del vizio arrossiscono della loro condotta e tornano indietro, essi cesseranno dal commettere il male, dice San G. Crysostomo.