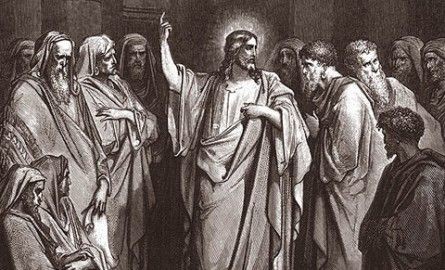DOMENICA XVIII DOPO PENTECOSTE
Incipit
In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
Introitus
Eccli XXXVI:18
Da pacem, Dómine, sustinéntibus te, ut prophétæ tui fidéles inveniántur: exáudi preces servi tui et plebis tuæ Israël [O Signore, dà pace a coloro che sperano in Te, e i tuoi profeti siano riconosciuti fedeli: ascolta la preghiera del tuo servo e del popolo tuo Israele.]
Ps CXXI: 1
Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus. [Mi rallegrai per ciò che mi fu detto: andremo alla casa del Signore].
Da pacem, Dómine, sustinéntibus te, ut prophétæ tui fidéles inveniántur: exáudi preces servi tui et plebis tuæ Israël [O Signore, dà pace a coloro che sperano in Te, e i tuoi profeti siano riconosciuti fedeli: ascolta la preghiera del tuo servo e del popolo tuo Israele.]
Oratio
Orémus.
Dírigat corda nostra, quǽsumus, Dómine, tuæ miseratiónis operátio: quia tibi sine te placére non póssumus. [Te ne preghiamo, o Signore, l’azione della tua misericordia diriga i nostri cuori: poiché senza di Te non possiamo piacerti.]
Lectio
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corinthios
1 Cor 1: 4-8
Fratres: Grátias ago Deo meo semper pro vobis in grátia Dei, quæ data est vobis in Christo Jesu: quod in ómnibus dívites facti estis in illo, in omni verbo et in omni sciéntia: sicut testimónium Christi confirmátum est in vobis: ita ut nihil vobis desit in ulla grátia, exspectántibus revelatiónem Dómini nostri Jesu Christi, qui et confirmábit vos usque in finem sine crímine, in die advéntus Dómini nostri Jesu Christi.
Omelia I
[Mons. Bonomelli: Nuovo saggio di Omelie; vol. IV, Omelia XI- Torino 1899]
“Io del continuo ringrazio il mio Dio per voi, per la grazia che vi è stata data in Gesù Cristo; perché in lui siete stati arricchiti in ogni dono di parola e di scienza, essendo stata la testimonianza di Cristo ben rassodata in voi, a talché non manchi dono alcuno a voi, che aspettate la rivelazione del Signor nostro Gesù Cristo. Il quale anche vi raffermerà fino alla fine senza colpa, nella manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo „ (I. ai Corinti, I, 4-8). La Chiesa in questa Domenica ci fa leggere nella santa Messa i cinque versetti che vi ho recitati. Essi formano l’introduzione di questa prima lettera ai fedeli di Corinto, e vengono immediatamente dopo i saluti e le parole di indirizzo con cui l’Apostolo suole cominciare tutte le sue lettere, eccettuata quella agli Ebrei. La lettera fu scritta da Efeso, dove si trovava S. Paolo, e donde era per muovere alla volta di Gerusalemme, verso la Pasqua dell’anno 56 dell’era nostra. Non occorre che vi dica dei motivi che indussero l’Apostolo a scrivere questa lettera che, dopo quella ai Romani, per l’ampiezza e per le cose in essa contenute, è la più importante, ond’è che tiene anche, dopo quella ai Romani, il primo posto. Le poche sentenze, che abbiamo da spiegare, non sono in sostanza che un augurio od una congratulazione graziosa che fa ai Corinti, con cui si apre la via a dir loro verità assai gravi e, se volete, anche amare. L’omelia d’oggi sarà forse più breve del solito; vi domando in compenso raddoppiata attenzione. – Corinto era una delle città, per floridezza di commerci, per ricchezze e per squisita coltura letteraria, scientifica ed artistica, più celebre della Grecia. S. Paolo vi si era recato da Atene ed aveva fermato la sua dimora in casa d’un certo Aquila, che poco prima vi era giunto da Roma, con Priscilla, sua moglie, perché insieme con gli altri Ebrei n’era stato cacciato con ordine generale dell’imperatore Claudio. Iddio aveva fatto conoscere a Paolo che un gran popolo egli aveva in quella città, e confortatolo a non temere e a parlare coraggiosamente (Atti Apost., XVIII, 1 seg.). Egli vi rimase per diciotto mesi continui, e vi fondò una Chiesa numerosa e fiorente; e quantunque sorgessero in essa alcuni partiti che la turbavano, e vi fossero anche scandali gravissimi e si spargessero errori, era pur sempre una Chiesa nobilissima e meritevole degli elogi dell’Apostolo. Egli, dopo il solito saluto ed augurio, così comincia: “Ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia che vi è stata data in Gesù Cristo. „ La prima cosa che l’Apostolo dice, è quella di assicurare i suoi Corinti, che si ricorda di loro dinanzi a Dio e che gli porge i più caldi ringraziamenti per loro. L’amore che ci lega ai nostri conoscenti, amici, congiunti e benefattori ce ne tien viva la memoria nell’animo, e questa è tanto forte e cara, quanto più ardente è l’amore che ci scalda per essi. È cosa troppo manifesta per dimostrarla. Ora, questo amore, se fosse vero e puro amore secondo il Vangelo, non si dovrebbe mai disgiungere dall’idea di Dio, da cui deriva ogni cosa buona e santa, e a cui sempre ritorna. Invece che accade, o dilettissimi? Amiamo i nostri cari, e il nostro amore si ferma in loro e non è mai, o troppo raramente, che si innalzi a Dio, che ci porti a pregar loro da Lui ogni bene, o a ringraziarlo di quelli che ha loro concessi. Vedete S. Paolo: egli ama teneramente i suoi Corinti, li porta nel cuore, come suoi figli: li ha ammaestrati per lunghi mesi, non volendo da loro nemmeno il pane: lontano, pensa ancora a loro, e il suo amore, amore che si accende alla luce della fede, solleva la sua mente ed il suo cuore a Dio e lui ringrazia dei benefizi largiti a quei suoi amatissimi neofiti. E un dovere, o cari, impostoci dalla gratitudine, quello di ringraziare Iddio dei favori concessi a noi; ma è cosa bella, utile e accettevole a Dio ringraziarlo anche di quelli fatti alle persone a noi care. La ragione è chiara. L’amore scambievole fa sì che godiamo dei beni concessi altrui come dei nostri, e perciò è giusto ringraziar Dio di questi come di quelli. Ecco perché S. Paolo: “Ringrazio, dice, il mio Dio per voi della grazia che vi è data in Gesù Cristo. „ E cosa nuova e quasi strana, che qui S. Paolo, alla parola Dio aggiunga mio, quasi fosse esclusivamente suo, mentre Gesù ci insegnò a dire: “Padre nostro”. Ma la difficoltà si dilegua da sé allorché si pensa che l’Apostolo usò la parola “mio” per significare l’affetto suo ardentissimo verso Dio, come facciamo noi pure allorché vogliamo esprimere un sentimento più vivo d’amore, e diciamo: Mio Dio! Mio bene! Mia vita! Del resto tanto è lungi l’Apostolo di pensare a Dio quasi fosse esclusivamente suo, che in questo luogo si volge a Dio per i suoi cari, ringraziandolo dei doni onde li ha ricolmati. E notate che S. Paolo protesta di far ciò non solo spesso, ma continuamente, “semper”, e ringrazia sempre Iddio forse perché i suoi Corinti sono forniti di scienza, ricchi di beni della terra? Oh no! Di questi beni l’Apostolo non parla, non ci pensa nemmeno, egli che chiama “fatua” la scienza del mondo e “spazzatura” tutti i beni temporali, di cui gli uomini sono sì ghiotti. Egli non apprezza che i veri beni, i beni dell’anima, il possesso della verità e della grazia: per questi beni, che i Corinti hanno ricevuto in Gesù Cristo, e per Gesù Cristo, porge continue grazie a Dio. – Dilettissimi! Noi, tutti quanti, siamo raccolti in questo tempio, abbiamo ricevute grazie elette e senza numero per i meriti di Gesù Cristo: è superfluo che io ve le accenni. Ne abbiamo ringraziato l’amoroso e generoso donatore Iddio? O forse siamo vissuti dimentichi, e al maluso delle grazie ricevute abbiamo aggiunto la ingratitudine? Non ci esca dall’animo quella bellissima immagine di S. Bernardo che scrisse: “Origine di tutte le sorgenti e di tutti i fiumi è il mare: origine di tutte le virtù e d’ogni scienza è Gesù Cristo; mercé del ringraziamento e della nostra gratitudine ritorni al suo principio questo fiume celeste dei suoi doni, affinché esso continui ad irrigare la terra (In Cantic, Ser. 13). „ E pur bellissima è l’altra sentenza d’un santo (Imitaz. di Cristo), che dice: “Mezzo efficacissimo per ottenere grazie da Dio è quello di mostrarci grati per quelle che abbiamo ricevute. „ Paolo ringrazia incessantemente Dio dei doni concessi ai Corinti: ora ne specifica due di questi doni, che sono i principali, e ai quali, come conseguenze, sono legati gli altri: “Perché in Lui (Gesù Cristo) siete stati arricchiti in ogni dono di parola e di scienza — Quod in omnibus divites facti estis in illo in omni verbo et omni scientia. „ L’espressione è dura ed oscura, e ci fa sentire la difficoltà, che Paolo ebreo aveva in vestire la verità in una lingua che non era la sua, e che conosceva imperfettamente. Egli vuol dire: “ringrazio Dio che vi ha arricchiti dei suoi doni, e particolarmente e primieramente del dono di aver udita la predicazione evangelica, che riempì la vostra mente della verace scienza, la scienza della salute”. I Corinti pochi anni prima erano immersi nel paganesimo, e paganamente vivevano, ignorando Dio, la propria origine, i propri doveri, il fine per il quale erano creati, i mezzi per giungervi e, conseguenza di tanta ignoranza, era la signoria delle passioni, la corruzione massima dei costumi, tantoché san Paolo in altro luogo ebbe a dire, che vivevano “ut bruta animalia”. Come erano usciti da tanto abbrutimento? come s’erano messi sulla via della virtù e della salvezza? quale il primo principio della loro trasformazione? La parola di verità, che avevano ricevuta da Dio per mezzo di lui, Paolo. Per essa avevano cominciato a conoscere il vero Dio, Gesù Cristo, se stessi, il loro fine: per essa avevano voltate le spalle alle brutture del paganesimo, alle grettezze della legge mosaica: per essa avevano fatto acquisto di quella scienza che vale va bene tutta la scienza dei filosofi più celebrati, che li aveva fatti entrare, come diceva S. Pietro, nella luce ammirabile del suo regno. È questo il senso ovvio delle parole di S. Paolo. Dilettissimi! Questo dono preziosissimo di udire la parola di Dio in omni verbo, e di ricevere per essa la scienza delle scienze, in omni scientia, non l’abbiamo noi come e meglio dei Corinti? Questa parola di verità si fece sentire alle nostre orecchie quando eravamo ancora tra le braccia e sulle ginocchia della madre; continuò a farcisi udire in casa, in chiesa, sui libri, nelle immagini, nei riti sacri, in mille modi, in ogni tempo, in ogni modo, perché nella società privata e pubblica in cui viviamo, tutto ci parla di Gesù Cristo, tutto ci rammenta i suoi divini insegnamenti. È dunque vero per noi, come e più che per i Corinti, che siamo stati arricchiti d’ogni istruzione e d’ogni scienza in Gesù Cristo, o per opera di Gesù Cristo. Qual uso ne abbiamo fatto? come ci siamo mostrati grati a Dio per sì alto e continuo beneficio? La risposta a voi, figliuoli carissimi. Ascoltiamo ancora l’Apostolo, che prosegue e dice: “Essendo stata la testimonianza di Cristo ben rassodata in voi — Sicut testimonium Christi confirmatum est in vobis. „ Che significa questa parola, “la testimonianza di Cristo”? Non v’è dubbio, significa l’insegnamento. la dottrina, il Vangelo di Cristo. E perché si chiama testimonianza? Gesù Cristo dice nel Vangelo (S. Giov. III, 11), che è veduto ad attestare ciò che ha veduto nel seno del Padre suo; Egli stesso è chiamato testimonio (Apoc. III, 14); gli Apostoli sono dichiarati suoi testimoni, ed essi stessi nelle loro lettere e negli Atti Apostolici si professano testimoni di ciò che videro e di ciò che udirono da Gesù Cristo; la dottrina adunque di Gesù Cristo, ripetuta dagli Apostoli, conservata ed annunziata perennemente dalla Chiesa è una testimonianza. E meritamente è chiamata testimonianza, perché come le cose delle quali gli uomini sono testimoni, non sono da loro inventate o foggiate, né loro è lecito aggiungere o levare alcun che, così il Vangelo e la dottrina di Cristo non è inventata o foggiata da Lui, né dagli Apostoli o dalla Chiesa, né altri può aggiungervi o levarvi sillaba, perché essa viene da Dio, è opera sua, tutta sua, e come Lui immutabile. L’insegnamento evangelico pertanto è la testimonianza di Gesù Cristo, degli Apostoli e della Chiesa, e passando di bocca in bocca, di libro in libro, è sempre lo stesso, né perde, né acquista, come un raggio di sole che attraversi migliaia di cristalli. Questa testimonianza o dottrina di Cristo, dice S. Paolo, ora è stabilita e rassodata in voi, o Corinti: in altre parole, ringrazio Dio che mediante la mia predicazione, la fede di Gesù Cristo è fondata e saldamente fondata in voi, e in essa avete il massimo dei doni celesti. Ponete mente a quella frase di S. Paolo: “La testimonianza, ossia la fede di Cristo, è rassodata in voi. „ È una lode, e grande, che S. Paolo fa ai Corinti, di essere saldi nella fede. La fede è la sostanza, ossia il sostegno e la base delle cose che speriamo, ed è l’argomento, cioè la ragione che ci fa tenere come certe le cose che non vediamo, nè conosciamo col solo lume della ragione; così fu definita la fede dall’Apostolo (Heb. XI, 1). Perché ammetti tu che vi è il sole, la terra, il mare? Perché li vedi! Perchè ammetti tu che due linee parallele non si possono incontrare, che un effetto deve avere la sua causa, che due aggiunti a due ti danno quattro? Perché con la ragione vedi che è così e non può essere altrimenti! Perché ammetti tu che vi è il Giappone, un fiume che si chiama Nilo, un impero che si dice Brasile, benché non li abbia mai veduti? Perché te lo affermano a voce ed in iscritto tanti testimoni, che non ti vogliono, né ti possono ingannare. La loro affermazione è il saldo appoggio della tua persuasione e certezza. Ora Gesù Cristo, gli Apostoli e tutta la Chiesa, ti annunziano un gran numero di dottrine che tu non puoi comprendere: ma essi ti assicurano che sono verità, ti danno in prova miracoli senza numero, certissimi, e che sono come la voce di Dio: perché la loro affermazione, confortata da tante e sì magnifiche prove, non basteranno a guadagnare il tuo assenso pieno e perfetto? Credi a due o tre testimoni ciò ch’essi ti dicono, affermando d’averlo veduto od udito: e non crederai a Gesù Cristo, agli Apostoli, ai martiri, alla Chiesa ciò ch’essi ti insegnano ed affermano d’aver veduto od udito? La nostra fede adunque, appoggiandosi alla parola di Gesù Cristo, degli Apostoli, dei martiri, della Chiesa, che non possono ingannarsi né possono ingannare, deve essere ferma, salda, incrollabile. Dio l’ha detto, Gesù Cristo l’ha insegnato, la Chiesa ce lo ripete; non domandiamo altro; crediamo con tutta la fermezza! Ondeggiare nel dubbio sulla verità di ciò che m’insegna Gesù Cristo per mezzo della Chiesa sarebbe un’offesa gravissima a Lui, che è la stessa verità. Dunque, o carissimi, che la nostra fede sia ferma, immobile, fondata sulla pietra, che nessuno potrà mai smuovere o spezzare, che è la Chiesa, che è Gesù Cristo stesso. Ma è da ritornare al nostro maestro, san Paolo, che continua, scrivendo: “A talché non manchi dono alcuno a voi — Ita ut nihìl vobis desit in ulla gratia. „ Se il Vangelo o, che è lo stesso, la fede sarà in voi saldamente stabilita, e tale da reggere ad ogni urto e ad ogni insidia, con essa avrete ogni altro bene, ogni altro dono. La ragione è chiara: la fede viva, robusta, diceva Cristo, può trasportare i monti, tutto ella può: “Omnia possibilia credenti”. Essa genera la speranza, accende la carità, germoglia le opere, forma i santi, crea i martiri; datemi un uomo che abbia la fede di Abramo, e lo troverete pronto ad immolare, se è necessario, il figlio: che abbia la fede di Pietro, e lo vedrete camminare sulle acque; che abbia la fede di Paolo, e lo vedrete ogni giorno morire per Cristo, ogni giorno soffrendo ed immolandosi per Lui. Con la fede viva non mancherà nulla a voi, scrive S. Paolo, a voi “che aspettate la rivelazione del Signor nostro Gesù Cristo. „ Noi tutti, che crediamo in Gesù Cristo, che cosa aspettiamo noi? Aspettiamo la rivelazione di Gesù Cristo, vale a dire la sua seconda venuta come Giudice supremo, che darà a ciascuno ciò che gli si deve in ragion delle opere sue. Con la prima sua venuta sulla terra, con la grazia che continuamente spande in noi, Gesù Cristo sparge il buon seme sulla terra: questa è opera grande sì, ma quasi sempre occulta: chi vede la fede, la grazia nei cuori? Nessuno; ne vediamo alcun poco i frutti, ma non sempre, né tutti, ed alcuna volta sono anche ingannevoli. Alla fine dei tempi verrà il supremo Seminatore, si manifesterà in tutta la grandezza della sua gloria, ed allora con Lui e per Lui, sotto gli splendori dell’infinita sua luce, si riveleranno tutte le opere nostre, buone o cattive, e si farà il giudizio, giudizio irrevocabile. Quella sarà la manifestazione per eccellenza, la manifestazione di Gesù Cristo, della sua grazia e della sua provvidenza, e la manifestazione della nostra vita, di maniera che né in cielo, né in terra rimarrà più cosa alcuna che non sia perfettamente manifesta. “Il quale (Gesù Cristo) vi confermerà fino all’ultimo, senza colpa, nella manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo. „ – È l’ultimo versetto che ci resta da spiegare. Con la sua grazia, con la sua fede fermissima, Gesù Cristo vi terrà saldi in mezzo alle prove e alle battaglie di questa vita fino alla fine, fino alla morte: “Confirmabit vos usque in finem”, serbandovi mondi d’ogni colpa, sine crimine, fino al dì della ricompensa, che avrete alla venuta di Lui. – È questo il dono della perseveranza finale, che nessuno di noi può meritare, come nessuno può meritare la prima grazia. È Dio che comincia l’opera della nostra salute, e la comincia con la sua grazia, senza alcun nostro merito: Egli la prosegue con la nostra cooperazione, ed Egli la compie, coronando in noi i frutti della sua grazia. Il compire felicemente il nostro corso e finire i nostri giorni nella grazia ed amicizia di Dio è suo dono; ma è tal dono ch’Egli, nell’immensa sua misericordia, non ricusa ad alcuno dei suoi figli, purché dal canto loro facciano ciò che possono. No, Dio non fa come gli uomini, che talvolta mettono mano ad un’opera e poi la lasciano, cominciano un edilizio e poi l’abbandonano a mezzo; Egli, quando comincia un’opera, per quanto è da sé, la continua e la conduce a perfezione: se resta incompiuta, dite pure che rimane tale contro la sua volontà, e per colpa d’altri. Cominciare un’opera e lasciarla imperfetta non è da Dio, che è la stessa perfezione, e perciò tutto vuole perfetto in cielo ed in terra. Ora è fuori di dubbio ch’Egli ha cominciato l’opera della nostra salvezza, perché siamo stati battezzati, e abbiamo tutti, quanti siamo qui raccolti, ricevuta la prima grazia: è dunque fuori di dubbio ch’Egli vuole proseguire quest’opera e compirla col dono ultimo e massimo della perseveranza. – L’avremo noi questo dono, corona di tutti gli altri? L’ultimo dì, l’ultimo istante di nostra vita saremo noi trovati “sine crimine”, senza colpa, adorni della grazia, amici e figli di Dio? Dio solo lo sa: ma noi pure sappiamo ch’Egli lo vuole, e che l’essere trovati veramente tali dipende da noi. Nessuno si affanni e si angusti, dicendo: “persevererò io sino alla fine? Morrò io nella grazia di Dio?” A che, Cristiano, ti turbi e ti consumi in questi pensieri? Getta le tue cure in Dio, come ti dice S. Pietro; Dio ti ha creato per il cielo: Dio abbonda e sovrabbonda con la sua grazia: ti ama come un padre, anzi come una madre il loro figlio: per salvarti è morto per te. Di che dunque temi? — “Temo per me, per la mia debolezza, per le mie passioni”. — E sta bene che tu tema di te, ma non mai per guisa che il timore ti affanni soverchiamente e ti opprima. Tien sempre a mente, che Dio conosce la tua debolezza più assai che non la conosca tu stesso, e pari alla debolezza sarà l’aiuto della grazia, e che è verità certa: “a nessuno che faccia dal lato suo ciò che può, il buon Dio rifiuta la sua grazia!
Graduale
Ps CXXI: 1; 7
Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus.
Alleluja
V. Fiat pax in virtúte tua: et abundántia in túrribus tuis. Allelúja, allelúja
Ps CI:16
Timébunt gentes nomen tuum, Dómine, et omnes reges terræ glóriam tuam. Allelúja. [Le genti temeranno il tuo nome, o Signore: e tutti i re della terra la tua gloria. Allelúia.]
Evangelium
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthæum.
R. Gloria tibi, Domine!
Matt. IX: 1-8
“In illo témpore: Ascéndens Jesus in navículam, transfretávit et venit in civitátem suam. Et ecce, offerébant ei paralýticum jacéntem in lecto. Et videns Jesus fidem illórum, dixit paralýtico: Confíde, fili, remittúntur tibi peccáta tua. Et ecce, quidam de scribis dixérunt intra se: Hic blasphémat. Et cum vidísset Jesus cogitatiónes eórum, dixit: Ut quid cogitátis mala in córdibus vestris? Quid est facílius dícere: Dimittúntur tibi peccáta tua; an dícere: Surge et ámbula? Ut autem sciátis, quia Fílius hóminis habet potestátem in terra dimitténdi peccáta, tunc ait paralýtico: Surge, tolle lectum tuum, et vade in domum tuam. Et surréxit et ábiit in domum suam. Vidéntes autem turbæ timuérunt, et glorificavérunt Deum, qui dedit potestátem talem homínibus”.
Omelia II
[Mons. G. Bonomelli, ut supra, Om. XII]
“Gesù, salito sopra una navicella, tragittò all’altra riva, e venne nella sua città. Ed ecco gli presentavano un paralitico, giacente sopra un letticciuolo: e Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: Abbi fiducia, o figliuolo: i tuoi peccati ti sono rimessi. Ma tosto alcuni degli scribi dicevano dentro di sé: Costui bestemmia. Allora Gesù, vedendo i loro pensieri, disse: Perché pensate voi male nei vostri cuori? È egli più facile dire: Ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: Lévati su e cammina? Affinché poi sappiate “che il Figliuol dell’uomo sopra la terra ha potere di rimettere i peccati : Tu (disse allora al paralitico) levati su, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E colui, levatosi, se ne andò a casa sua. E le turbe, veduto ciò, temettero, e glorificarono Dio, che tanto potere avea dato agli uomini „ (S . Matteo, IX, 1-8).
Gesù da Cafarnao s’era ritratto sulla sponda orientale del lago di Tiberiade o Genesaret, in luogo deserto, per riposare alcun poco coi suoi discepoli; poi, scendendo da un colle, trovato un lebbroso, l’aveva risanato; poi, sempre sulla riva orientale del lago, aveva liberato due ossessi della piccola città di Gerasa. Di là sgarbatamente licenziato da quei cittadini atterriti alla vista del miracolo operatovi, volle passare sulla riva occidentale del lago, per fare un secondo viaggio per le sinagoghe della Galilea. E qui comincia la narrazione evangelica, sulla quale la Chiesa richiama la nostra attenzione in questa Domenica XVIII dopo Pentecoste. Il fatto, e per parlare più esattamente, il miracolo registrato nell’odierno Vangelo, è assai importante, e perciò domanda e merita tutta la vostra attenzione. – “Gesù, salito sopra una navicella, tragittò all’altra riva, e venne nella sua città. „ Possiamo dire che quasi metà della sua vita pubblica Gesù la passò sulle rive di questo lago fortunato, ora facendone il giro, ed ora attraversandolo in tutti i sensi. Era il lago della Galilea, sua patria, incantevole per la sua postura, pel suo clima, per le sue rive sempre verdeggianti, per le molte e vaghe borgate e città che si specchiavano nelle azzurre sue onde. Gesù vi aveva trovati i principali suoi Apostoli e quel popolo di Galilei, dal cuor semplice, dall’anima retta, dalla tempra robusta; fiero della sua indipendenza, gli ispirava maggior fiducia del popolo di Gerusalemme, che naturalmente doveva risentire i difetti e i vizi della capitale, fiacchezza di carattere, lusso e mollezza. Approdato sulla sponda occidentale del lago (il Vangelo non dice il luogo) venne nella sua città. Parve ad alcuni, e tra questi allo stesso S. Girolamo, che l’Evangelista con quella parola sua indicasse Nazaret, patria di Gesù; ma il contesto del Vangelo e la massima parte degli interpreti, ci persuadono che la città chiamata sua è Cafarnao; la disse sua, perché Gesù vi dimorò più volte, vi predicò e vi operò non pochi miracoli, e le diede prove peculiari dell’amor suo, tantoché in un luogo del Vangelo la disse innalzata fino al cielo. Eppure ciò non tolse che Cafarnao non fosse reietta, e, come disse Cristo stesso, precipitata negli abissi; anzi furono i favori specialissimi che ricevette da Cristo, quelli che la resero più colpevole e degna di maggior riprovazione. Esempio questo della divina giustizia, che là fa sentire più terribili i suoi colpi dove maggiori furono i benefizi e le prove della divina misericordia. Sarebbe mai, o dilettissimi, che la patria nostra, l’Italia, sì favorita dal cielo, privilegiata tra tutte le nazioni, perché ha nel suo centro il Vicario di Gesù Cristo, potesse meritare il castigo, che cadde su Cafarnao, la città sua? Sarebbe mai che la fede esulasse dalle nostre contrade, come esulò da altre regioni? Io spero nella misericordia di Dio, che tanta sventura non avverrà mai, e che la luce e la forza divina che emana dalla Cattedra di Pietro, serberà sempre viva la fede nella patria nostra. Ma non mi dissimulo, che grande, tremendamente grande è il lavoro di demolizione che si è compiuto in mezzo a noi e va proseguendo in proporzioni sempre più paurose. Le scuole superiori pur troppo sono diventate centri, da cui si diffonde la indifferenza e la miscredenza: la stampa ogni dì batte in breccia la fede antica e i grandi centri del commercio e dell’industria e della vita pubblica ormai non si curano più di religione e si prepara una società senza Dio e senza morale. Non è senza terrore ch’io getto lo sguardo nell’avvenire religioso dell’Italia nostra: vi rimarranno Cattolici certamente: ma quanti? ma quali? Ohimè! forse sarà una società mista, non di Cattolici e di eretici, ma di cattolici e di indifferenti e di increduli di tutte le gradazioni! – Gesù rientrava in Cafarnao (Marco, II, 1), da cui era stato assente non molti giorni. La memoria dei miracoli operativi prima e la fama di quelli che aveva operati sulle rive del lago e dovunque si era mostrato, appena si sparse la voce del suo arrivo, trasse a Lui gran folla, che si accalcava sulla porta della casa, dov’era entrato (Marco, il, 2). Ignoriamo di chi fosse quella casa, né importa gran fatto il saperlo; piuttosto è utile una osservazione generale, che altra volta accennai e che qui giova ripetere. Tre classi di persone si formano intorno a Gesù, i discepoli, le turbe popolari e il ceto istruito e ricco, sacerdoti, capi del popolo, dottori, farisei. Lasciamo da parte i discepoli, che a poco a poco si formano alle grandi lezioni di tanto Maestro. Il popolo è sempre lo stesso da per tutto, ora come al tempo di Cristo. Esso è schietto, generoso, lasciato in balia a se stesso, avido di novità, facile, pronto a seguirle, se gli lasciano intravedere vantaggi materiali, se scuotono la sua fantasia. Nessuna meraviglia pertanto che il popolo, ammaliato dalla parola e dalla dottrina di Cristo, stupefatto alla vista dei suoi miracoli, lo acclamasse, lo seguisse per ogni dove, fino nel deserto, e pensasse a proclamarlo suo re. La terza classe di persone rappresenta l’autorità e la tradizione; essa è naturalmente gelosa di quest’uomo straordinario, che trascina dietro a sé le moltitudini, che lancia in mezzo ad esse dottrine nuove e stupende, che minaccia una trasformazione profonda sociale e religiosa, e condanna lei all’isolamento ed all’impotenza. Fate che in mezzo ad una società vecchia un uomo getti un’idea nuova e feconda, sviluppi una forza intellettuale e morale singolare; voi vedrete i rappresentanti del passato, gli uomini della vecchia società, quasi destarsi dal sonno, turbarsi, levarsi a difesa del passato, che si confonde con la propria; vedrete questi uomini del passato far opera per combattere il novatore, screditarlo, calunniarlo, e, se occorre, disfarsi di lui, senza badare sottilmente ai mezzi. Quantunque l’uomo sia fatto per il progresso, sovente resiste al progresso, ed in questa lotta tra gli uomini del passato e quelli dell’avvenire si sviluppano le forze che determinano il progresso medesimo, e lo regolano. Ordinariamente gli uomini del progresso devono soffrire, e non è raro che diventino le vittime della loro missione, e con la propria vita paghino l’ardire di romperla col passato e di spingere innanzi l’umanità. È ciò che accadde e doveva naturalmente accadere al divino Novatore per eccellenza, al Restauratore dell’umanità, l’Uomo-Dio, Gesù Cristo. E perciò noi vediamo formarsi intorno a Cristo, oltre il gruppo dei discepoli, oltre le moltitudini piene di sacro entusiasmo, la classe così detta dirigente, tenace del passato; essa lo sorveglia, lo spia, lo segue, gli muove questioni insidiose, col sofisma, con la violenza, con le minaccie e infine, con la morte, tenta di soffocare la nuova dottrina. È ciò che apparisce luminosamente dal fatto evangelico che abbiamo tra mano. Gesù era nella casa che abbiamo detto, e precisamente nella stanza superiore, che dicevasi anche cenacolo. Egli era circondato dai suoi Apostoli e da quanta gente capiva in quel luogo, pigiandosi gli altri nel cortile e sulla porta per entrare. Fra i suoi uditori erano, come al solito, parecchi dottori della legge, o scribi o farisei, con quali intendimenti, pensatelo voi. Mentre che Gesù parlava, ecco quattro uomini, che portavano sopra un lettuccio un povero paralitico, e che si sforzavano di aprirsi un passo attraverso a quella folla e presentarlo a Gesù, affinché lo risanasse. – Qui è bene completare la narrazione di S. Matteo, che vi ho riportata, con alcuni particolari interessanti e commoventi notati da S. Marco e da S. Luca [S. Marco II, 1, seg., S. Luca V, 17, seg.). Quelli che portavano il paralitico s’accorsero ch’era impresa difficile e quasi impossibile giungere a Gesù passando in mezzo a quella turba stivata pel cortile e per la scala. Che fecero? Presero il partito di portarlo su per la scala esterna che metteva sul tetto e di là calarlo nella stanza, dove Gesù si trovava. Detto fatto: portarono lassù il letto con l’infermo; levarono le tegole, sfondarono il lastrico, e con le funi calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico, innanzi a Gesù, in mezzo alla gente che lo premeva d’ogni parte. È facile immaginare ciò che avvenisse in quella stanza allorché videro calare a quel modo il letto del paralitico; la curiosità, la meraviglia, il bisbiglio, i commenti e l’aspettazione di ciò che farebbe Gesù grandissima: il momento era solenne, Gesù sospese il discorso, e vedendo la loro fede (cioè del paralitico e di quelli che l’avevano portato e calato innanzi a Lui), disse rivolto al paralitico): Figliuolo, abbi fiducia: i tuoi peccati ti sono rimessi. „ Può sembrare strano che Gesù, dopo aver vista la fede del paralitico e dei suoi portatori, dica al primo, quasi per eccitarla in lui, come se non l’avesse: “Abbi fiducia, o figliuolo — Confide, fili. „ Ma è chiaro che con quella parola: Abbi fiducia, intese solo di confermarla ed accrescerla, ed assicurarlo che i suoi voti sarebbero appagati con la pronta guarigione. — Figliuolo, allarga il cuore, sta di buon animo, ti rassicura, guarirai —; così suonano le parole del Salvatore. Quella parola poi: “Figliuolo„ che Gesù dovette pronunziare con un accento di amorevolezza tutto particolare, ci fa conoscere e sentire il cuore di Lui, e ci insegna come noi pure dobbiamo accogliere e trattare i sofferenti per raddolcire le loro pene e consolarli. Quando si pensa che Gesù, il Figlio di Dio, trattava con tanta confidenza e con sì amorosa delicatezza un paralitico, che doveva essere poverissimo, come non arrossiremo noi di trattare aspramente e con mal garbo i fratelli, che vengono a noi per chiederci aiuto, consiglio e conforto nelle loro afflizioni? “I tuoi peccati ti sono rimessi, „ disse Gesù al paralitico. Come, o Signore? Questo infelice paralitico non vi ha chiesto il perdono dei suoi peccati, e tacitamente vi domanda la guarigione del corpo, e voi date quello e non questa? Concedete ciò che non vi si chiede, e non fate cenno di ciò che vi si domanda? E poi potete voi, o Signore, concedere il perdono dei peccati a chi non si pente? Certo, Iddio, che è onnipotente, non può concedere la remissione dei peccati senza il pentimento, perché il peccato solo allora si cancella, quando l’anima, mossa dalla grazia, si stacca da essi: ma se non si stacca da essi (e non si stacca quando non se ne pente), essi rimangono, e Dio non può non respingere l’anima che ne è macchiata (Si parla qui, non del peccato originale, che come si contrae senza la nostra volontà, così senza di essa si cancella nel Battesimo. Ma l’attuale non può essere rimesso, se la volontà, mercé la grazia, non lo caccia da sé col dolore). Convien dire che il paralitico, eccitato dalla grazia, che Gesù infondeva in lui con la presenza e con la parola, fosse pentito dei suoi peccati, e forse anche con la lingua ne chiese il perdono (e l’Evangelista tace questa, come ha taciuto altre cose); e perciò Gesù poté dirgli: Ti sono rimessi i tuoi peccati. Volle poi che la guarigione dell’anima precedesse quella del corpo per farci conoscere come quella ci debba stare a cuore più di questa, e perché talvolta le infermità del corpo sono conseguenze delle infermità dell’anima, onde la cura deve cominciare da questa. Non vi può essere dubbio che in quell’istante nel quale Gesù pronunziò quelle parole: “Ti sono rimessi i tuoi peccati, „ l’anima del paralitico fu mondata dalla lebbra d’ogni peccato e rivestita dell’ornamento della grazia. È pur questa una lezione che dovremmo rammentare noi pure, allorché chiediamo favori temporali: prima di chiedere a Dio i beni della terra, dovremmo chiedere quelli ben più preziosi del cielo; prima di implorare la salute del corpo, dovremmo cercare quella dell’anima: sarebbe questo il modo di renderci più agevole il conseguimento dei beni temporali, dei quali abbiamo sì cocente desiderio. – Questo fatto del Vangelo ci fa credere che Gesù Cristo, quando risanava nel corpo, prima risanava eziandio nello spirito, e liberando gli infermi dalle malattie, prima scioglieva i peccatori dai loro lacci, sembrando troppo conveniente che chi largheggiava cotanto nel meno importante, largheggiasse più assai in ciò che sopra tutto è necessario. Se così non fosse stato, parrebbe quasi che le opere sue non fossero in perfetta armonia tra loro, curando quasi più i corpi che le anime. Udite quelle parole: “Ti sono rimessi i tuoi peccati, „ alcuni degli scribi presenti si guardarono tra loro come attoniti e scandalizzati e, fosse per un cotal rispetto verso di Lui, fosse per timore del popolo, o per altro motivo che non conosciamo, nol dissero con la lingua, ma dentro a sé lo pensarono- . ” Costui bestemmia — Hic blasphemat. „ S. Marco (I. C., vers. 7), riferita la stessa cosa, chiarendo meglio il perché del loro giudizio interno, aggiunge che dicevano, s’intende, in cuor loro: “Chi può perdonare i peccati fuorché Dio solo? „ E per se dicevano vero, perché solo l’offeso può condonare l’offesa, e se i peccati sono offese di Dio, come lo sono, evidentemente Dio solo li può rimettere. Dovevano per altro comprendere che Dio può perdonare i peccati direttamente da se stesso, e può perdonarli per mezzo di persone alle quali ne dia il potere; onde anche nell’ipotesi che Gesù Cristo non fosse stato Dio, come gli scribi tenevano, il loro giudizio: “Costui bestemmia,, era precipitato e poteva essere falso, perché, anche come semplice uomo, poteva tenere da Dio la facoltà di condonare a suo nome i peccati, come l’hanno e l’esercitano i Sacerdoti. Gesù tosto volle provare a quegli scribi, ch’Egli poteva rimettere i peccati e ch’essi gli facevano atroce ingiuria giudicandolo bestemmiatore, e la prova gliela davano essi stessi: “Gesù, dice S. Matteo, avendo conosciuto i loro pensieri, disse: Perché pensate voi male nei vostri cuori? „ Egli così mostrò che leggeva nei loro cuori e che era Dio, e che perciò poteva rimettere i peccati. Voi sapete che secondo la dottrina cattolica nessun uomo, anzi nemmeno i demoni e gli Angeli stessi possono conoscere ciò che passa nella nostra mente e nel nostro cuore, se noi non li manifestiamo, o Dio non lo fa loro conoscere: tutt’al più possono averne qualche cognizione vaga ed incerta per via di congettura, giudicando dall’esterno e dalle circostanze. Allorché pertanto Gesù mostrò di leggere con tanta sicurezza nelle loro menti e nei loro cuori, provò loro che era profeta, ch’era quel che affermava d’essere, cioè Dio, avente potere di rimettere i peccati. A questa sì franca affermazione di Cristo, che mostrava a Lui tutto essere nudo ed aperto, anche ciò che l’uomo nasconde in modo impenetrabile nel santuario dell’anima sua, pare che i farisei e gli scribi non dessero importanza, od almeno non facessero atto di meraviglia. Sembra che, come tante altre volte in simili congiunture, si chiudessero dispettosamente nel silenzio, dissimulando ogni cosa. – Lasciate, o carissimi, che richiami la vostra attenzione sopra una verità elementare di nostra fede. Gli scribi ed i farisei non ammettevano che quel Gesù, il quale loro parlava, fosse veramente Dio: era una colpa, e gravissima, dopo ciò che avevano veduto ed udito di Lui: noi per contrario sappiamo, per ragione e per fede, ch’Egli vede tutto: che nulla può sfuggire al suo sguardo divino, non uno solo dei nostri pensieri, non uno solo dei nostri affetti, sia pure rapido come il lampo: sappiamo e crediamo che a Lui dovremo rendere strettissima ragione d’ogni cosa, perché tutto rimane scritto nel libro della nostra coscienza, sotto gli occhi di Lui, testimonio e giudice infallibile: eppure che facciamo noi? Si continua ad accarezzare e fomentare quei pensieri e quegli affetti, che sappiamo essere colpevoli ed abominevoli: ad accarezzarli sotto gli occhi stessi di Dio, che li detesta, come se potessimo credere che Dio non li conosca. Ah! Se questa grande verità di fede, che l’occhio di Dio è sempre aperto sopra di noi, che scruta le nostre menti e i nostri cuori, fosse sempre viva e presente, quanti peccati cesseremmo! Come sarebbe netta la nostra coscienza, irreprensibile la nostra condotta! La sola presenza d’una persona degna di rispetto è bastevole a regolare debitamente i nostri atti esterni e l’idea della presenza di Dio non sarebbe bastevole a regolare anche gli interni? Ogni qual volta s’affacciano nella nostra mente pensieri meno che degni d’un Cristiano, e nel nostro cuore spuntano affetti che ne turbano la pace, ricordiamoci che Gesù Cristo potrebbe dire a noi come agli scribi e ai farisei: “perché pensate voi male nei vostri cuori?— Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris? „ Incalzando sempre più il suo discorso, sempre rivolto agli scribi ed ai farisei, Gesù Cristo soggiunse: “Voi vi scandalizzate delle mie parole a questo paralitico, e mi riputate un bestemmiatore; ebbene, rispondete: È più facile cosa dire: Ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: Levati su e cammina? „ Voi lo vedete: l’interrogazione era terribile, e metteva i suoi nemici in una alternativa da cui non potevano sfuggire. Egli si offriva pronto a confermare il suo potere di rimettere i peccati con un miracolo, con la guarigione istantanea nella persona del paralitico, ch’era lì disteso sul suo lettuccio, pallido, tremante sotto gli occhi di tutti. Che potevano rispondere? —No, non accettiamo il miracolo? — Era un darsi vinti, e la folla, ansiosa di vedere il miracolo, li avrebbe coperti di ingiurie e di fischi. — Sì, accettiamo? — E allora bisognava riconoscere Gesù Cristo per Messia e Figliuol di Dio, cosa che a nessun patto volevano fare. Unico partito possibile, che li salvava, non dalla sconfitta, ma dalla vergogna maggiore ch’era per loro il dover confessare la divinità di Cristo, era il silenzio, ed al silenzio si attennero. – Gesù, girati gli sguardi sulla folla e sugli scribi e farisei silenziosi, si rivolse al paralitico, che pendeva dalle sue labbra, e disse: “Affinchè sappiate che il Figliuol dell’uomo in terra ha potere di rimettere i peccati: Sorgi, piglia il tuo letticciuolo e vattene a casa tua. „ In quell’istante al suono di quelle parole onnipotenti, il paralitico sentì rifondersi nel corpo un vigore, una vita novella: le membra si distesero rinfrancate, sul volto apparve la sanità e la robustezza, gettò via le coltri, balzò in piedi, e adorato e ringraziato Gesù, come potete ben credere, diede di piglio al suo lettuccio ed andossene lieto e giulivo. La turba e gli stessi scribi e farisei, come fuor di sé per la meraviglia, guardavano ora Gesù ed ora il paralitico, e quasi non credevano ai propri occhi. Il miracolo aveva tutti i caratteri dell’evidenza; negarlo o metterlo in dubbio era follia: era chiudere gli occhi alla luce del sole. E gli scribi e i farisei si arresero? riconobbero il loro errore? Si gittarono ai piedi di Gesù, confessandolo Messia e Figliuolo di Dio? Il Vangelo di loro non dice parola, ma è agevole rilevare dal tutto l’insieme che rimasero fermi nella loro ostinazione, e pieni di dispetto e svergognati se ne partirono. Era una cecità prodigiosa, inconcepibile, è vero, ma che non deve sorprenderci. Allorché una passione qualunque, specialmente l’odio, l’interesse e l’orgoglio, per tacere delle altre, signoreggia il cuore d’un uomo, non v’è colpa, non v’è delitto, non v’è contraddizione dinanzi alla quale e gli s’arresti; l’uomo schiavo d’una passione ci presenta l’immagine dell’angelo delle tenebre, non può non vedere e non sentire la propria impotenza contro Dio, eppure l’odia non solo, ma lo combatte dappertutto e senza tregua. Deh! carissimi, guardiamoci da ogni passione, ma sopra tutto da quella che è la radice d’ogni peccato, la superbia. – Gesù Cristo disse una sentenza che non sembra scevra di difficoltà, e che vuolsi sciogliere. Dalle sue parole apparisce che sia più facile rimettere i peccati che non guarire un paralitico, perché dice: “È egli più facile dire: ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: “Levati su e cammina? „ La sua domanda è in guisa che sembra rispondere ad una negativa. Rimettere i peccati per sè è opera assai più difficile che risanare un infermo, perché per rimettere i peccati bisogna infondere la grazia, dono sopranaturale, ed è proprio di Dio solo: perché si esige il mutamento della volontà del peccatore, la quale può resistere e rendere impossibile ogni sforzo; ma allorché Gesù Cristo pronunziò quelle parole, credo io, non intese fare un confronto tra l’opera del mettere i peccati e quella del risanare il paralitico, affermando più facile quella di questa; Egli ragionava con uomini, e quali uomini! Alcuni erano grossolani, e a loro doveva sembrare impresa più difficile la guarigione del paralitico che la liberazione dai peccati; altri erano superbi ed ostinati, e non curando le cose invisibili, non potevano egualmente non curare le visibili, e segnatamente un miracolo. Perciò Cristo, pronunciando quelle parole, intese solo di mostrare col miracolo del paralitico, il quale ai presenti doveva sembrare più grande della remissione dei peccati, la sua sovrana autorità: — Voi non credete alle mie parole, al perdono dei peccati concesso a questo infelice, perché non vedete nulla: credete bene a questa guarigione miracolosa: negatela, se potete. — Ecco il senso delle parole del divin Salvatore. – L’effetto di quel miracolo sopra quelli che lo videro e quelli che l’udirono, in tutta Cafarnao fu grandissimo, e il Vangelo dice che il popolo n’ebbe timore: Turbæ tìmuerunt. È cosa naturale questo timore: quando noi vediamo un fatto che non ha la sua causa naturale, eppure è certissimo, siamo costretti a risalire alla causa prima, alla causa suprema, a Dio in una parola. Tale è il miracolo; perciò alla vista del miracolo noi ci sentiamo alla presenza d’una forza infinita, di Dio che opera sotto i nostri occhi. Ora, come non sentirci compresi di stupore ed insieme d’un sacro timore e terrore, trovandoci di fronte a Dio, Essere sovrano, Maestà infinita? Il popolo fu ripieno di timore, ma un timore che ben presto si mutò in un grido di gioia, in un inno di gloria: Glorificaverunt Deum, qui dedìt potestatem talem hominibus. Ecco due dei sentimenti naturali all’uomo innanzi a Dio, il timore, ma figliale, giacché Dio è sempre padre; la moltitudine e l’amore, che si traducono nel ringraziamento, nella lode e nella gloria, unico tributo che possiamo rendere a Dio.
Credo …
Offertorium
Orémus
Exodi XXIV:4; 5
Sanctificávit Móyses altáre Dómino, ófferens super illud holocáusta et ímmolans víctimas: fecit sacrifícium vespertínum in odórem suavitátis Dómino Deo, in conspéctu filiórum Israël. [Mosè edificò un altare al Signore, offrendo su di esso olocausti e immolando vittime: fece un sacrificio della sera, gradevole al Signore Iddio, alla presenza dei figli di Israele.]
Secreta
Deus, qui nos, per hujus sacrifícii veneránda commércia, uníus summæ divinitátis partícipes éfficis: præsta, quǽsumus; ut, sicut tuam cognóscimus veritátem, sic eam dignis móribus assequámur. [O Dio, che per mezzo dei venerandi scambii di questo sacrificio, ci rendi partecipi della tua sovrana e unica divinità, concedi, Te ne preghiamo, che, come conosciamo la verità, cosí la conseguiamo con degna condotta.]
Communio
Ps XCV:8-9
Tóllite hóstias, et introíte in átria ejus: adoráte Dóminum in aula sancta ejus. [Prendete le vittime ed entrate nel suo atrio: adorate il Signore nel suo santo tempio.]
Postcommunio
Orémus.
Grátias tibi reférimus, Dómine, sacro múnere vegetáti: tuam misericórdiam deprecántes; ut dignos nos ejus participatióne perfícias. [Nutriti del tuo sacro dono, o Signore, Te ne rendiamo grazie, supplicando la Tua misericordia di renderci degni di raccoglierne il frutto.]